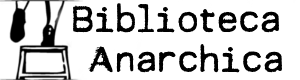Prima edizione: maggio 2015
Richard Wagner
L’arte e la rivoluzione
Introduzione
Dalle barricate di Dresda, accanto a Bakunin, all’adulazione di Ludwig II, re di Baviera, alle pance gonfie di birra dei sostenitori del teatro di Bayreuth. Posta in questi termini la traiettoria umana di Wagner potrebbe suonare condanna e orrore, e come tale suonò alle orecchie sensibili di Nietzsche facendolo passare dall’iniziale adulazione al conclusivo ribrezzo. E sarebbe valutazione ingiusta.
Ho visto troppi treni lanciati a grande velocità fermarsi per una sosta nella stessa stazione in cui sostava il mio treno, anch’esso lanciato, di poi, a folle velocità. Ma andavamo, io col mio treno, loro col loro treno, in direzioni opposte. Nel momento della sosta, per un attimo, sembrava che fossimo vicini e che anelassimo alle medesime aspirazioni rivoluzionarie, a bruciare il mondo e le sue cose, dopo, con il riaccendersi dei fuochi nelle locomotive, si scopriva facilmente che le direzioni erano contrastanti. E che vale? Forse che in quella sosta non mi è stato dato, da quel treno che pure andava in senso inverso al mio, qualcosa di importante? Forse che non si è portato via, quel treno, ora nemico ed estraneo, qualcosa parimenti importante di mio? E che cosa nel cuore dei transfughi è continuato a fermentare di quel qualcosa che mi apparteneva, tale da vedere negli occhi di qualcuno di loro, che vado incontrando qua e là, disattento o borioso che sia, un lampo di vergognosa consapevolezza? Stare a soppesare dove sta il giusto e dove l’errato è faccenda che preferisco lasciare ai farmacisti.
In Wagner non sono mai riuscito a leggere – nella sua musica intendo – quello che vi leggeva Nietzsche, almeno non solo quello. Se c’è qualcosa d’altro del semplice bilanciamento matematico delle corrispondenze e delle dissonanze, nella musica, e questo resta tutto da vedere, l’anelito alla distruzione che dal giovane Bakunin passava al giovane Wagner lo colgo qua e là. E mi chiedo, e non so darmi risposta, se questo anelito passasse al di sopra delle teste dei bevitori di birra, come la corrusca nuvolaglia di una sera d’autunno. Quasi sicuramente di sì, anche se alcuni segnali di incertezza nei finanziamenti da parte delle associazioni di bottegai e dello stesso principe dei bottegai, Ludovico, potrebbero far pensare a delle perplessità.
E poi, l’ignoranza dilagante. Ascoltare Wagner è francamente impresa ardua, meglio limitarsi a tre accordi dell’orecchiabilità popolare, questa non ha necessità di essere ascoltata, è essa che ascolta il nostro immalinconito pulsare delle arterie disfatte dal benessere e dalla cattiva alimentazione.
Le idee portanti dello scritto che presentiamo sono oggi datate, ma lo stesso accade leggendo qualsiasi testo dei rivoluzionari dell’epoca. Solo alcune piccole tracce permangono. La Grecia, ad esempio, l’idea della forza, non astrattamente considerata, ma concretamente. Una rivoluzione della debolezza, non confinerebbe pericolosamente con la logica dell’accettazione di ogni potere costituito? E dove lo prendiamo il coraggio per attaccare? Nel culto della sofferenza come espiazione dei nostri peccati? Nella mistica della santità del lavoro? Nella ricerca del soggetto rivoluzionario capace di risollevare le sorti delle nostre stravaganti ideologie?
Andiamo. Wagner metterà in musica non solo l’astuzia e il tradimento, l’avidità del denaro e l’infamia della paura, ma anche la bellezza del coraggio e della vendetta. Per raccogliere l’arma caduta dalla mano di tanti compagni colpiti non occorre forse il coraggio? oppure dovrebbero bastare i saltabeccanti accordi – rigorosamente assonanti – di tanta musica da supermercato (opportunamente rivisitata dall’ignoranza estremista che pretende vestirsi di saccente erudizione musicale)?
Non condivido un concetto di arte simile a quello qui sostenuto da Wagner, e non condivido il suo tentativo di realizzarlo attraverso lo strumento del teatro e della musica (non del melodramma, che qui non si tratta di melodrammi). Ma condivido il concetto di azione artistica totale. Che cosa sarebbe mai un attacco contro il nemico se non lo si vivesse anche (non amo le sottolineature, ma questo avverbio andrebbe sottolineato), anche, dicevo, come opera d’arte? Perché mai la qualità avrebbe diritto a definirsi, di per sé, verità e bellezza, giustizia ed eguaglianza, se non ospitasse quella totalità della vita e dell’arte, totalità inscindibile, che Wagner qui intuisce, anche se l’epoca e le sue limitazioni personali gli impedivano di esporre con chiarezza?
Lettore e compagno che prendi in mano questo opuscolo, se pensi di trovare qui un discorso su Wagner, una sorta di viatico all’ascolto delle sue opere, hai sbagliato indirizzo. Più facile è vedere in queste righe, annebbiate dalla distanza siderale che ci separa da loro, un’occasione per riflettere sulla possibilità che abbiamo oggi di trasformare la nostra vita in qualcosa di bello, al di là, ben al di là, della merda che ci circonda.
E questo potrebbe, come effetto collaterale ma non secondario, metterci anche in guardia contro la fruizione passiva e imbecille della musica.
Trieste, 22 aprile 2014
Alfredo M. Bonanno
L’arte e la rivoluzione
Quasi tutti gli artisti si lagnano al giorno d’oggi del danno causato loro dalla rivoluzione. Non sono i grandi combattimenti svoltisi per le strade o l’improvviso e violento scossone che ha fatto traballare l’edificio statale o il rapido mutar di governo ad esser messi in stato di accusa: l’impressione suscitata da questi fatti violenti di per sé è per lo più fugace e operante per breve tempo. È il carattere particolarmente insistente delle recenti convulsioni che ha inferto un colpo mortale alla produzione artistica contemporanea. Le fondamenta su cui fino ad ora si ergevano il guadagno, le comunicazioni, la ricchezza sono adesso minacciate, e una volta ristabilita la calma esteriore, una volta ricostituita la fisionomia della vita sociale, un’atroce preoccupazione, un’angoscia tormentosa penetra fin nel profondo le viscere di questa vita: il mancato incoraggiamento alle imprese paralizza il credito; chi vuol conservare non arrischia e rinuncia a un guadagno incerto, l’industria ristagna e... l’arte non ha più di che vivere.
Sarebbe crudele negare l’umana compassione alle migliaia di coloro che son colpiti da questa angustia. Se fino a poco tempo fa un artista apprezzato era avvezzo a ricavare dalla parte agiata e spensierata della società abbiente il dorato compenso per i suoi graditi lavori e a pretendere una vita ugualmente comoda e spensierata, ora è duro per lui vedersi respinto da mani angosciosamente chiuse e abbandonato al bisogno di guadagnare: egli condivide così interamente la sorte dell’operaio che deve posarsi in grembo, a sostenere lo stomaco affamato, le abili mani impiegate prima per procurare ai ricchi mille piacevoli comodità. Ha dunque ragione di lamentarsi, poiché a chi sente dolore la natura ha concesso il pianto. Se però abbia il diritto di identificarsi con l’arte stessa, di lamentare la propria miseria come miseria dell’arte, di accusare la rivoluzione come nemica capitale dell’arte, giacché non gli consente di nutrirsi a suo agio, è una questione ancora da esaminare. Prima di rispondere si dovrebbero interrogare almeno quegli artisti che con fatti e parole hanno dimostrato di amare e coltivare l’arte solo per amore dell’arte stessa, e dei quali si possa almeno dimostrare che soffrivano anche quando quegli altri stavano allegri.
La questione verte quindi intorno all’arte e alla sua essenza. Non ci proponiamo tuttavia di darne una definizione astratta, in quanto si tratta soltanto di scoprire il significato dell’arte come risultato della vita statuale, di riconoscerne il carattere sociale. Un rapido sguardo schematico ai principali momenti nella storia dell’arte europea ci servirà ottimamente e ci aiuterà a chiarire questo problema che in verità non è privo di importanza.
Se riflettiamo un poco, non possiamo fare un passo nell’ambito della nostra arte senza imbatterci nella sua connessione con l’arte dei Greci. In realtà la nostra arte moderna non è che un anello nella catena dell’evoluzione artistica di tutta l’Europa, la quale prende le mosse proprio dai Greci.
Lo spirito greco, quale si manifestò all’epoca del suo massimo splendore nello Stato e nell’arte, dopo aver superato la rozza religione naturale della patria asiatica e aver posto l’uomo libero, bello e forte, alla sommità della sua coscienza religiosa, trovò la sua congeniale espressione in Apollo, il vero dio principale e nazionale delle stirpi elleniche.
Apollo, che aveva ucciso Pitone, il drago del caos, che coi suoi dardi mortali aveva annientato i figli vanitosi di Niobe millantatrice, che per mezzo della sua sacerdotessa a Delfi rivelava ai postulanti la legge originaria dello spirito e della natura greca e a chi era in procinto di compiere un’azione esaltata porgeva così lo specchio calmo e limpido della sua più intima natura immutabilmente greca: Apollo era l’esecutore della volontà di Zeus sul suolo greco, era il popolo greco.
Non dobbiamo immaginarci Apollo, al tempo del massimo splendore dello spirito greco, come il morbido danzatore tra le Muse tramandatoci dalla sontuosa tarda scultura; Eschilo, il grande tragico, lo conosceva con i tratti della serena gravità, bello ma forte. Così lo conosceva la gioventù spartana quando con la danza e la lotta sviluppava nel corpo snello grazia e robustezza: quando il fanciullo era sollevato in groppa al cavallo e rapito dall’amante in terre lontane verso audaci avventure; quando il giovinetto entrava nella cerchia dei compagni tra i quali non poteva far valere altro che la propria bellezza e gentilezza, uniche sue ricchezze, unica sua potenza. Così lo vedeva l’ateniese quando tutti gli stimoli delle belle membra e del vivace spirito lo spingevano alla rinascita del proprio essere attraverso l’ideale espressione dell’arte; quando la voce piena e sonora si levava in coro per cantare le gesta del dio e dare a un tempo ai danzatori il brioso avvio alla danza che, con moto ardito e grazioso, rappresentava quelle gesta stesse; quando su colonne armoniosamente disposte egli inarcava il nobile tetto, ordinava l’uno sull’altro gli ampi semicerchi dell’anfiteatro e delineava le ponderate proporzioni della scena teatrale. Così lo vedeva, splendido iddio, il poeta tragico ispirato da Dioniso quando a tutti gli elementi delle arti, sbocciate spontaneamente per interiore necessità naturale dalla più bella vita umana, assegnava la parola audace e impegnativa, la sublime intenzione poetica che le univa tutte come in un punto focale per creare la più alta opera d’arte che si possa pensare: il dramma.
Le gesta degli dèi e degli uomini, i loro dolori e piaceri, quali con gravezza e serenità si trovavano espressi, eterno ritmo, eterna armonia di ogni moto, di ogni esistenza, nella profonda natura di Apollo, diventavano veri e reali; poiché tutto ciò che in essi si muoveva e viveva come si muoveva e viveva nello spettatore trovava la sua più compiuta espressione dove l’occhio e l’orecchio, lo spirito e il cuore afferravano e percepivano nella sua vera realtà, vedevano in carne e in spirito tutto quel che la fantasia non aveva più bisogno di immaginare. Queste giornate della tragedia erano feste divine poiché il dio vi si pronunciava con chiarezza: il poeta era il suo sacerdote supremo che stava veramente e in carne ed ossa in mezzo all’opera d’arte, guidava le ridde dei danzatori, univa la propria voce al coro e annunciava con parole sonanti i princìpi della scienza divina.
Questa era l’opera d’arte greca, questo Apollo trasformato in vera arte vivente, questo il popolo greco nella sua suprema verità e bellezza.
Questo popolo esuberante d’individualità in ogni sua parte, in ogni personalità, incessantemente attivo, uso a considerare la mèta di un’impresa niente altro che il punto di partenza per una nuova impresa, in perenne contrasto interno per alleanze ogni giorno mutate e per sempre nuovi conflitti, ora trionfante, ora fallito, oggi minacciato dai più gravi pericoli, domani incalzante il nemico fino a distruggerlo, in uno sviluppo libero e incessante all’interno e fuori: questo popolo affluiva dall’assemblea politica, dalla piazza del tribunale, dalla campagna, dalle navi, dai campi di battaglia, dalle regioni più remote e riempiva l’anfiteatro di trentamila uomini per veder rappresentare il Prometeo, la più profonda di tutte le tragedie, per raccogliersi davanti alla più profonda opera d’arte, per cogliere se stesso e comprendere la propria attività, per fondersi con la sua natura, la sua comunità, il suo dio, nella più stretta unità e tornare ad essere, nella calma più nobile e profonda, ciò che era stato poche ore prima nella più irrequieta eccitazione e nella più isolata individualità.
Il greco, sempre geloso della sua massima indipendenza personale e intento a perseguitare in ogni direzione il tiranno che, per quanto egli stesso saggio e nobile, poteva aspirare a dominare sulla sua libera e audace volontà; sprezzando quella femminea fiducia che all’ombra lusinghiera delle altrui cure si abbandona a un riposo pigro ed egoistico; sempre in guardia, instancabile nel respingere influssi esterni, non permettendo alla tradizione, per quanto veneranda, di dominare la vita, il pensiero e l’azione liberi e presenti, ammutoliva al richiamo del coro, si assoggettava volentieri alla sapiente convenzione dell’ordinamento scenico, obbediva di buon grado alla grande necessità la cui sentenza il poeta tragico gli annunciava dalla scena per bocca degli dèi e degli eroi. Infatti nella tragedia egli ritrovava se stesso, anzi la parte più nobile della propria natura, unita alle parti più nobili della natura collettiva dell’intera nazione; attingendo da se stesso, dalla propria intima e cosciente natura, egli si faceva dare dalla tragedia l’oracolo della Pizia, dio e sacerdote ad un tempo, uomo splendidamente divino, vivente nella comunità come la comunità viveva in lui, come una di quelle mille fibre che nella vita unica della pianta sorgono dal terreno e si sollevano nell’aria con snella struttura per produrre quell’unico fiore che diffonde il suo delizioso profumo all’eternità. Questo fiore era l’opera d’arte, il suo profumo lo spirito greco che ancora ci inebria e ci induce a confessare entusiasticamente che sarebbe meglio essere per mezza giornata un greco davanti alla tragedia che per l’eternità un dio non greco.
Col disfacimento dello Stato ateniese coincide esattamente la decadenza della tragedia. Come lo spirito comunitario si frantumò in mille direzioni egoistiche, così anche la totale opera d’arte tragica si scompose nelle singole componenti artistiche che la costituivano: sulle rovine della tragedia il commediografo Aristofane pianse la sua folle risata e ogni impulso artistico finì con l’arrestarsi davanti alle severe riflessioni della filosofia volta a studiare la causa della fugacità d’ogni bellezza e d’ogni forza umana.
Alla filosofia e non all’arte appartengono i due millenni che dal tramonto della tragedia greca sono passati fino ai nostri giorni. È vero che di tanto in tanto questa mandò i suoi strali balenanti nella notte del pensiero insoddisfatto, della ruminante follia umana; ma erano soltanto i gridi di dolore e di gioia del singolo che si salvava dal caos generale e come chi si sia smarrito provenendo da molto lontano giungeva finalmente alla solitaria fonte castalia a cui bagnava le labbra assetate senza poter porgere al mondo la rinfrescante bevanda; oppure era l’arte al servizio di uno di quei concetti o magari di quelle illusioni che opprimevano l’umanità sofferente con peso ora minore ora maggiore e incatenavano la libertà del singolo quanto del popolo intero; ma non era mai la libera espressione d’una comunità libera: poiché la vera arte è suprema libertà e soltanto la suprema libertà può esprimerla dal suo seno; non v’è ordine né comando, né scopo fuori dell’arte che possano generarla.
I Romani, la cui arte nazionale aveva presto ceduto all’influsso delle evolute arti greche, si facevano servire da architetti, scultori e pittori greci; i loro migliori ingegni si esercitavano nella retorica e nella poetica greca; ma non aprivano il grande teatro popolare agli dèi e agli eroi del mito né ai liberi danzatori e cantanti del coro sacro, ma bestie feroci, leoni, pantere e elefanti dovevano dilaniarsi nell’anfiteatro per deliziare gli occhi romani; gladiatori, schiavi allevati alla forza e alla destrezza, erano costretti a divertire le orecchie romane col loro rantolo mortale.
Questi brutali conquistatori del mondo si trovavano a loro agio soltanto nella realtà positiva, la loro fantasia riusciva ad appagarsi soltanto di realizzazioni materiali. Lasciavano che il timido filosofo, sfuggito alla vita pubblica, si dedicasse tranquillamente al pensiero astratto; in pubblico i Romani amavano abbandonarsi alla più concreta bramosia di stragi e a veder rappresentato il dolore umano in assoluta realtà fisica.
Ora quei gladiatori e quei lottatori che affrontavano le belve nel circo erano i figli di tutte le nazioni europee e i re, i nobili e i non nobili di queste nazioni erano tutti ugualmente schiavi dell’imperatore romano, il quale così dava loro la prova pratica che tutti gli uomini sono uguali, come d’altro canto i pretoriani ossequienti dimostravano molto spesso e in modo manifesto all’imperatore che anche lui stesso non era che uno schiavo.
Questa schiavitù reciproca e universale, palese e innegabile, esigeva, come tutto quel che al mondo è universale, un’espressione che la definisse. L’evidente umiliazione e il disonore di tutti, la coscienza della perdita totale di ogni dignità umana, l’inevitabile nausea degli unici godimenti materiali rimasti, ormai sopravvenuta, il profondo disprezzo di ogni propria attività e impresa, priva ormai della libertà e dello spirito artistico, la miserabile esistenza vuota di ogni forma attiva: tutto questo poteva trovare solo un’espressione che, per quanto universale come la situazione stessa, doveva essere l’esatto contrario dell’arte. L’arte è gioia di sé, dell’esistenza, della comunità: la situazione di quel tempo, alla fine del dominio universale romano, era invece disprezzo di sé, nausea dell’esistenza, orrore della comunità. Non l’arte dunque poteva essere l’espressione di questa situazione, bensì il cristianesimo.
Il cristianesimo giustifica una disonorevole, inutile e misera esistenza dell’uomo sulla terra col meraviglioso amore di Dio che non ha affatto creato l’uomo, come erroneamente credevano i bei Greci, per condurre un’esistenza gioiosa e cosciente di sé su questa terra, ma ve lo avrebbe rinchiuso come in un carcere schifoso per preparargli, dopo la morte, in compenso dell’acquisito disprezzo di sé, uno stato infinito di magnificenza comoda e inerte. Perciò l’uomo poteva, e doveva perfino, rimanere in uno stato di profonda e disumana decadenza, non doveva esercitare alcuna attività vitale, poiché questa vita maledetta era il mondo del demonio, cioè dei sensi, e ogni attività che vi avesse svolto avrebbe soltanto assecondato il diavolo, così che l’infelice che con lieta energia si fosse impadronito di questa vita avrebbe dovuto soffrire dopo la morte l’eterno martirio infernale. All’uomo non si chiedeva altro che la fede, cioè l’ammissione della propria miseria e la rinuncia a ogni attività autonoma volta a sottrarsi a quella miseria da cui lo doveva liberare solo l’immeritata grazia di Dio.
Lo storico non sa con certezza se questa sia stata anche l’opinione di quel povero galileo, figlio d’un falegname, che al vedere la miseria dei propri confratelli proclamò di non essere venuto nel mondo per portarvi la pace ma la spada, che con amorevole indignazione tuonò contro quegli ipocriti farisei che vilmente lusingavano il dominio romano per potere asservire e incatenare tanto più crudelmente il popolo sotto di sé; colui che infine predicò l’universale amore del prossimo senza poterlo assolutamente pretendere da coloro che dovevano disprezzare se stessi. Con maggiore chiarezza lo studioso distingue soltanto l’immenso zelo del fariseo Paolo, miracolosamente convertito, il quale nel convertire i pagani seguiva molto felicemente la massima: “siamo astuti come i serpenti”, ecc. Egli può giudicare anche l’evidente terreno storico del più profondo e generale decadimento dell’umanità civilizzata donde la pianta del dogma cristiano venne infine fecondata. L’onesto artista però nota alla prima occhiata che il cristianesimo né fu arte né poté in alcun modo produrre dal suo seno la vera energia vivente.
Il libero greco che si poneva in cima alla natura poté creare l’arte per la gioia che l’uomo ha di se stesso: il cristiano che rifiutava ugualmente sé e la natura poté offrire sacrifici al proprio Dio solo sull’altare della rinuncia, non poté portargli in dono le sue azioni e le sue gesta, ma ritenne di cattivarselo astenendosi da ogni autonoma e audace attività. L’arte è la suprema attività dell’uomo ben sviluppato nei sensi, in armonia con se stesso e con la natura; l’uomo deve attingere la massima gioia dal mondo sensibile se vuol farne lo strumento artistico; soltanto dal mondo sensibile infatti egli può trarre la volontà di creare l’opera d’arte. Il cristiano, se volesse veramente creare l’opera d’arte corrispondente alla sua fede, dovrebbe invece ricavare la volontà dall’essenza dello spirito astratto, della grazia di Dio, e trovare in essa lo strumento, – ma quale avrebbe potuto essere in tal caso la sua intenzione? Non certo la bellezza sensibile che per lui era la manifestazione del diavolo. E come avrebbe mai potuto lo spirito in genere produrre qualcosa di percettibile con i sensi?
Lambiccarsi il cervello è in questo caso fuori luogo: i fenomeni della storia sono la più chiara espressione del risultato ottenuto dai due opposti indirizzi. Mentre il greco per sua edificazione conveniva nell’anfiteatro per poche ore, piene del più profondo contenuto, il cristiano si rinchiudeva per tutta la vita in un monastero: là giudicava l’assemblea popolare, qua l’Inquisizione; là lo Stato si sviluppa in una sincera democrazia, qui in un assolutismo ipocrita.
L’ipocrisia è in genere il tratto più rilevante, la vera e propria fisionomia di tutti i secoli cristiani fino ai nostri giorni; e precisamente questo vizio appare tanto più in vista e sfacciatamente quanto più l’umanità, dalla sua inesauribile fonte interiore e nonostante il cristianesimo, si andò rinnovando e andò incontro alla soluzione del suo compito. La natura è così forte, così indistruttibile e feconda, che nessun potere al mondo sarebbe in grado di indebolirne la forza fecondatrice. Nelle vene malate del mondo romano si riversò il sangue sano delle fresche nazioni germaniche; pur avendo accolto il cristianesimo, l’elemento dei nuovi signori del mondo rimase un grande stimolo attivistico, il piacere di audaci imprese, l’indomabile fiducia in sé. Ma come in tutta la storia medioevale incontriamo quale tratto più caratteristico la lotta del potere temporale contro il dispotismo della Chiesa romana, così l’espressione artistica di questo mondo nuovo, anche dove cercava di manifestarsi, poté farsi valere soltanto nel contrasto, nella lotta contro lo spirito del cristianesimo: come espressione di un’unità del mondo perfettamente armonica quale era stata l’arte del mondo greco, l’arte del mondo cristiano europeo non poté manifestarsi appunto perché nel suo intimo era scissa fra la coscienza e il desiderio di vivere, tra la fantasia e la realtà, in modo inguaribile e inconciliabile. La poesia cavalleresca del Medioevo che, come l’istituzione della cavalleria stessa, doveva comporre questo dissidio, poté soltanto nelle sue creazioni più significative rivelare la menzogna di questa conciliazione: quanto più si levava in alto e quanto più era ardita, tanto più sensibile si apriva l’abisso tra la vita reale e l’esistenza immaginaria, tra l’atteggiamento rozzo e veemente di quei cavalieri nella vita fisica e il loro fin troppo delicato ed esaltante comportamento nell’immaginazione. Appunto perciò la vita reale, di costume popolare nobile in origine e tutt’altro che privo di grazia, diventò vita immonda e viziosa, perché non le era lecito alimentare l’istinto artistico con le proprie forze, con la gioia di sé e col suo concreto atteggiamento, ma per ogni attività spirituale doveva ricorrere al cristianesimo il quale per principio negava ogni gioia della vita dichiarandola condannabile. La poesia cavalleresca fu l’onesta ipocrisia del fanatismo, la follia dell’eroismo: e prese la convenzione per natura.
Solo quando l’ardore di fede della Chiesa si fu spento, quando la Chiesa si presentò apertamente soltanto come dispotismo secolare sensibilmente percettibile in unione con l’assolutismo dei tiranni da lei consacrato, non meno sensibilmente percettibile e secolare, solo allora doveva manifestarsi il così detto Rinascimento delle arti. Infine si volle veder davanti ai propri occhi, in manifestazioni sensibili, quel che per tanto tempo aveva torturato le menti, come la stessa Chiesa nella sua pompa secolare; e ciò non fu possibile se non aprendo gli occhi e restituendo ai sensi i loro diritti. Il fatto di porsi davanti agli occhi gli oggetti della fede, le trasfigurate creature della fantasia, in bellezza sensibile e con la gioia artistica di questa bellezza, costituiva la negazione totale del cristianesimo stesso: e il fatto che l’avvio a queste creazioni artistiche dovesse essere derivato dall’arte pagana dei Greci costituì la più obbrobriosa umiliazione del cristianesimo. Ciò nonostante la Chiesa fece proprio questo ridestato impulso artistico e non sdegnò in tal modo di ornarsi con le piume del paganesimo, ad essa estranee, e di presentarsi così, palesemente, come bugiarda e ipocrita.
Ma anche il potere temporale ebbe la sua parte nel fare rivivere le arti. Dopo lunghe lotte nel loro potere fortificato verso il basso, una spensierata ricchezza risvegliò nei prìncipi il desiderio di godere questa ricchezza in modo più raffinato: a questo scopo assoldarono le arti imparate dai Greci. L’arte “libera” fu al servizio dei raffinati nobili e, a guardar bene, non si saprebbe stabilire con esattezza chi sia stato più ipocrita, se Luigi XIV quando nel suo teatro di corte si faceva recitare in versi sciolti l’odio greco contro i tiranni, oppure Corneille e Racine quando in compenso dei favori ricevuti dai loro padroni mettevano in bocca ai loro eroi sulla scena l’ardore libertario e la virtù politica greca e romana.
Ma poteva veramente esserci arte dov’essa non sbocciava dalla vita come espressione d’una libera consapevole comunità ed era invece al servizio dei poteri che impedivano a quella comunità di svilupparsi liberamente, sicché doveva essere arbitrariamente trapiantata da regioni altrui? Certamente no. Eppure vedremo che l’arte, anziché liberarsi da quei padroni, sia pure rispettabili, quali erano la Chiesa spirituale e i prìncipi pieni di spirito, si vendette completamente a una padrona molto peggiore: l’industria.
Il greco Zeus, padre della vita, agli dèi che percorrevano il mondo inviava dall’Olimpo, come suo messaggero, il dio Ermete, giovane e bello. Era questi l’affaccendato pensiero di Zeus: alato si slanciava dalle alture negli abissi per annunciare l’onnipresenza del dio supremo: era anche presente alla morte dell’uomo e accompagnava le ombre dei trapassati nel tacito regno della notte. Dovunque infatti si manifestasse la grande necessità dell’ordine naturale Ermete era attivo e palese come il pensiero attuato di Zeus.
I Romani avevano il dio Mercurio, ch’essi paragonavano al greco Ermete. Ma presso di loro la sua alata operosità acquistò un significato pratico: era la nobile attività di quei trafficanti e usurai che da ogni parte confluivano nel centro del mondo romano per fornire ai grassi signori di quel mondo, contro adeguato compenso, tutti i godimenti materiali che la natura circostante non poteva offrir loro. Agli occhi del romano il commercio era al tempo stesso anche frode, considerata la sua natura e il suo modo di operare, e se quel mondo di bottegai, nella sua crescente smania di godimenti, gli pareva un male necessario, lo disprezzava però profondamente; e così Mercurio, il dio dei mercanti, divenne per lui anche il dio dei furfanti e degli imbroglioni.
Senonché questo dio disprezzato si vendicò contro gli altezzosi Romani ergendosi in vece loro a padrone del mondo: incoronate infatti il suo capo con l’aureola dell’ipocrisia cristiana, ornate il suo petto con le fredde insegne di estinti ordini cavallereschi feudali, ed eccolo qua il dio del mondo moderno, il santo e nobile dio del cinque per cento, il despota e l’organizzatore... della nostra arte contemporanea. Lo ritroverete in carne ed ossa nel bigotto banchiere inglese, la cui figlia ha sposato un fallito cavaliere dell’ordine della giarrettiera, mentre ascolta, meglio nel suo salotto piuttosto che in teatro, (ma anche qui a nessun costo nelle sante domeniche) i primi cantanti dell’opera italiana per potersi vantare di doverli pagare qui ancora più cari che là. Questo è Mercurio e questa la sua docile serva, l’arte moderna.
Questa è l’arte quale ora pervade tutto il mondo civile. La sua vera natura è l’industria, il suo fine morale il guadagno, il suo pretesto estetico il divertimento di chi si annoia. Dal cuore della nostra società moderna, dal centro del suo moto circolare, dalla speculazione monetaria in grande stile la nostra arte succhia la linfa vitale; dai resti senz’anima della convenzionalità cavalleresca medievale prende in prestito una bellezza senza cuore e di qui, non disdegnando con apparente senso cristiano neppure l’obolo del povero, si abbassa fino al proletariato svuotando i nervi, la morale e l’uomo, ovunque si riversi il veleno del suo succo vitale.
Di preferenza si è insediata nel teatro, esattamente come l’arte greca al culmine del suo splendore; e ha diritto al teatro perché è l’espressione della vita pubblica valida del nostro tempo. L’arte teatrale moderna rappresenta concretamente lo spirito dominante della nostra vita pubblica, lo esprime in una quotidiana diffusione come nessun’altra arte ha mai fatto, giacché allestisce le sue feste sera per sera in quasi tutte le città d’Europa. Così essa segna in apparenza, come arte drammatica enormemente diffusa, la fioritura della nostra civiltà, come la tragedia greca aveva segnato il punto culminante dello spirito greco: ma questa è la fioritura della putrefazione d’un vuoto, arido, innaturale ordine delle cose e delle circostanze umane.
Non è necessario qui descrivere più minutamente quest’ordine delle cose: basta esaminare onestamente il contenuto e l’effetto pubblico della nostra arte, in special modo di quella teatrale, per riconoscervi lo spirito dominante dell’opinione pubblica come in una fedele immagine riflessa. Infatti l’arte pubblica fu sempre tale immagine.
Così nella nostra pubblica arte teatrale non scorgiamo affatto il vero dramma, quest’unica indivisibile opera d’arte massima dello spirito umano: il nostro teatro offre soltanto l’incomodo spazio per l’allettante esposizione di singoli lavori artistici, o meglio artificiosi, legati appena superficialmente. Quanto poco il nostro teatro sia capace di attuare, quale vero dramma, l’intima unione di tutti i rami dell’arte nella più alta e perfetta espressione, appare già nella sua divisione nelle due specie del teatro di prosa e dell’opera, in seguito a cui al dramma recitato è tolta l’idealizzante espressione della musica, mentre all’opera è negato per principio il nocciolo e il fine supremo del vero dramma. Mentre in complesso il dramma recitato non poté mai per questo innalzarsi in un ideale slancio poetico, ma – senza ricordare qui il trascurabile influsso d’una opinione pubblica immorale – dovette scendere, non fosse altro per la povertà dei mezzi espressivi, dall’alto in basso, dall’eccitante elemento della passione a quello gelido dell’intrigo, l’opera divenne tutta un caos di confusi elementi materiali senza capo né coda, dai quali ciascuno poteva raccogliere a volontà ciò che meglio rispondeva alla sua capacità di godimento, ora il salto leggiadro d’una ballerina, ora l’audace passaggio di un cantante, qui il brillante effetto d’uno scenario, là l’eruzione sbalorditiva d’un vulcano orchestrale. O non si legge al giorno d’oggi che questa o quella nuova opera è un capolavoro perché contiene molte belle arie e bei duetti, e che la strumentazione dell’orchestra è molto brillante, ecc.? La gente non pensa nemmeno più al fine che solo giustificherebbe l’uso di mezzi così svariati: il grande fine drammatico.
Questi sono giudizi limitati ma sinceri: rivelano semplicemente che cosa importi all’ascoltatore. C’è anche un buon numero di stimati artisti i quali non negano affatto di non avere altra ambizione se non quella di accontentare quegli ascoltatori dall’orizzonte ristretto. Il loro ragionamento è questo: quando il principe arriva in teatro dopo un faticoso banchetto, il banchiere dopo un’assillante speculazione, il lavoratore dopo il pesante lavoro della giornata, tutti costoro vogliono riposare, distrarsi, divertirsi, non più affaticarsi con nuovi affanni. Il ragionamento è talmente esatto che possiamo soltanto obiettargli che sarebbe meglio impiegare a questo scopo qualunque altra cosa piuttosto del materiale e del pretesto dell’arte. Ci sentiamo però rispondere che, se non si volesse fare quest’uso dell’arte, essa cesserebbe del tutto e non potrebbe più inserirsi nella vita pubblica, cioè l’artista non avrebbe di che vivere.
In questo senso tutto è miserando, ma sincero, vero e onesto: decadimento civile, moderna ottusità cristiana!
Ma che cosa diremo in queste circostanze dell’ipocrita pretesto di certi nostri eroi dell’arte la cui fama è all’ordine del giorno, quando si danno l’aria malinconica di entusiasmo artistico, quando cercano di afferrare idee, impiegano profonde relazioni, mirano a scuotere, mettono in moto inferno e paradiso, quando agiscono insomma come quegli onesti artisti a giornata affermavano che non si debba procedere se si vuol spacciare la propria merce? Che diremo se veramente questi eroi vogliono non soltanto divertire ma mettersi nel rischio di annoiare per parere profondi, se così facendo rinunciano perfino a grandi guadagni e addirittura (cosa che può fare però soltanto chi nasce ricco) spendono quattrini per amore delle loro creazioni, compiendo così il sacrificio più grande del nostro tempo? A che scopo tutto questo spreco? Oh, c’è anche un’altra cosa oltre al denaro, ciò che tra altri godimenti oggi si può acquistare anche col denaro: la gloria! Ma quale gloria si può raggiungere con la nostra arte ufficiale? La gloria di quella stessa opinione pubblica per cui quest’arte è concepita e alla quale l’ambizioso non potrà imporsi se non sa sottomettersi alle sue volgari esigenze. Così egli inganna sé e il pubblico offrendogli la sua opera d’arte rappezzata, e il pubblico inganna lui e se stesso accogliendolo con applausi; ma questo inganno reciproco vale certamente il grande inganno della gloria moderna, tanto più che siamo molto bravi nell’adornare le nostre più egoistiche passioni di belle bugie quali “patriottismo”, “onore”, “senso della legge”, e così via.
Ma come avviene che riteniamo necessario ingannarci così palesemente a vicenda? Lo facciamo perché quei concetti e quelle virtù esistono nella coscienza delle attuali circostanze, se non nella coscienza buona certo nella cattiva. Infatti, come è certo che le cose nobili e vere esistono davvero, così è anche certo che esiste la vera arte. Gli spiriti più grandi e nobili, davanti ai quali Eschilo e Sofocle si sarebbero volentieri inchinati come fratelli, hanno innalzato da secoli la voce dal deserto; noi li abbiamo uditi e ancora abbiamo quei richiami nelle orecchie, ma dai nostri cuori volgari e vanitosi abbiamo cancellato l’eco vivente di quel richiamo; noi tremiamo davanti alla loro gloria ma ridiamo davanti alla loro arte; ne abbiamo fatto artisti eccelsi, ma abbiamo loro negato l’opera d’arte: non possono infatti creare da soli l’opera d’arte unica, vera e grande, ma hanno bisogno della nostra collaborazione. La tragedia di Eschilo e Sofocle fu opera di tutta Atene.
Che giova questa gloria degli spiriti nobili? Che ci giova se Shakespeare come secondo creatore ci rivelò l’infinita ricchezza della vera natura umana? Che ci giova se Beethoven conferì alla musica un potere poetico virile e autonomo? Chiedetelo alle miserabili caricature dei vostri teatri, chiedetelo ai luoghi comuni delle vostre musiche d’opera che si cantano per le strade, e avrete la risposta. Ma c’è proprio bisogno di chiedere? No. Lo sapete già; non volete che sia altrimenti e fingete soltanto di non sapere.
Che cosa è dunque la vostra arte, che cosa il vostro dramma? La Rivoluzione di febbraio [1848] privò i teatri parigini della pubblica partecipazione e molti di essi furono sul punto di chiudere i battenti. Dopo le giornate di giugno venne loro in aiuto Cavaignac, incaricato di mantenere l’ordine sociale costituito: ed egli chiese soccorsi per conservarli in vita. Perché? Perché con la chiusura dei teatri sarebbe aumentata la disoccupazione e con essa il proletariato. Questo è dunque l’unico interesse che lo Stato ha per il teatro! Esso vi scorge un istituto industriale, ma in secondo luogo anche un efficace diversivo per smorzare l’intelligenza, sedare i moti, combattere la minacciosa alacrità delle teste calde che con profondo malumore cova nelle strade per le quali la natura umana umiliata dovrà ritrovare se stessa, sia pure a costo di conservare le nostre... molto opportune istituzioni teatrali!
Questo si chiama parlar chiaro; e con questa schiettezza vanno di pari passo le lagnanze dei nostri artisti moderni e il loro odio contro la rivoluzione. Ma che cosa hanno queste preoccupazioni e questi lamenti in comune con l’arte?
Confrontiamo ora l’arte ufficiale dell’Europa moderna, nei suoi tratti più importanti, con l’arte ufficiale dei Greci per renderci conto con maggior chiarezza della loro peculiare diversità.
L’arte ufficiale dei Greci, quale raggiunse il momento culminante nella tragedia, fu l’espressione di quanto c’era di più profondo e di più nobile nella coscienza popolare: e ciò che vi è di più profondo e di più nobile nella nostra coscienza umana è l’esatto opposto, la negazione della nostra arte ufficiale. Per i Greci la rappresentazione di una tragedia era una festa religiosa, nel loro teatro si muovevano sulla scena gli dèi che tributavano la loro sapienza agli uomini: la nostra cattiva coscienza pone anche il teatro a un livello così basso della pubblica stima che alla polizia è affidato il compito di tutelare che il teatro si occupi di argomenti religiosi: fatto questo ugualmente caratteristico della nostra religione e della nostra arte. Nell’ampio spazio dell’anfiteatro greco il popolo intero assisteva alle rappresentazioni: nei nostri aristocratici teatri poltrisce soltanto la parte abbiente di esso. I Greci ricavavano gli strumenti dell’arte dai risultati di un’altissima cultura comune, noi da quelle della più bassa barbarie sociale. L’educazione dei Greci li avvezzava fino dalla primissima giovinezza a far di se stessi l’oggetto di attività artistica e di piacere artistico nel corpo come nello spirito: la nostra ottusa educazione, che per lo più mira al futuro guadagno industriale, ci insegna un compiacimento sciocco e al tempo stesso altezzoso della nostra incapacità artistica e ci fa cercare soltanto fuori di noi gli oggetti di un qualsiasi divertimento artistico, su per giù con lo stesso desiderio con cui il gaudente cerca il fugace piacere amoroso di una prostituta. Così il greco era insieme attore, cantante e danzatore; la sua collaborazione alla rappresentazione di una tragedia era per lui supremo godimento dell’opera stessa, e giustamente egli si sentiva onorato di avere diritto, per cultura e bellezza, a quel godimento: noi invece facciamo ammaestrare per nostro divertimento una data parte del nostro proletariato sociale che si trova in ogni classe; vanità poco pulita, civetteria e, in certe condizioni, speranza di rapidi e abbondanti guadagni formano le schiere del nostro personale teatrale. Laddove l’artista greco, oltre che col proprio godimento dell’opera d’arte, era compensato col successo e col pubblico consenso, l’artista moderno è mantenuto e... pagato. E così arriviamo a definire con precisione la differenza essenziale, e cioè che l’arte ufficiale greca era appunto arte, la nostra... artigianato artistico.
Oltre al fine della sua creazione l’artista prova piacere nella creazione stessa, nell’elaborare e dare forma alla sua materia; la sua produzione è di per sé un’attività piacevole e gratificante, non è lavoro. Per l’artigiano conta soltanto lo scopo della sua fatica, l’utile ch’egli ricava dal lavoro; la sua attività non gli dà gioia ma è soltanto peso e fatica, necessità ineluttabile ch’egli preferirebbe affidare a una macchina: egli riesce ad applicarsi al proprio lavoro solo con la costrizione; per questo non vi è presente con lo spirito, ma pensa sempre allo scopo che vorrebbe raggiungere per la via più breve possibile. Ma se lo scopo immediato dell’artigiano è soltanto la soddisfazione di un bisogno, per esempio quello di procurarsi una propria abitazione, proprie suppellettili, vestiario e via dicendo, insieme con la comodità che gli proviene da questi utili oggetti sopravverrà a poco a poco anche il desiderio di adeguare questi oggetti al suo gusto personale; dopo aver provveduto alle cose più necessarie, la sua attività, rivolta ai bisogni meno urgenti, si innalzerà spontaneamente su un piano artistico; ma nella misura in cui cede il prodotto del proprio lavoro e non gli rimane se non l’astratto valore del denaro, la sua attività non potrà mai sollevarsi sopra l’operosità della macchina: e per lui non sarà altro che fatica e triste, duro lavoro. Questa è la sorte dello schiavo dell’industria; le nostre fabbriche ci presentano oggi il quadro miserando della più profonda degradazione dell’uomo: una fatica continua che uccide lo spirito e il corpo, senza piacere e senza amore, spesso quasi senza scopo.
Anche in questo si cela il deplorevole influsso del cristianesimo. Infatti se questo pose il fine dell’uomo fuori della sua esistenza terrena e non mirò ad altro scopo che al Dio assoluto fuori dell’uomo, la vita non poté essere oggetto delle cure umane se non in rapporto ai suoi bisogni del tutto indispensabili; avendo infatti ricevuto la vita si era obbligati a mantenerla finché a Dio piacesse di liberarci del suo peso: in nessun caso però i suoi bisogni dovevano risvegliare in noi il desiderio di trattare amorosamente la materia che dovevamo impiegare per soddisfarli; soltanto lo scopo astratto di conservare la vita alla meno peggio poteva giustificare la nostra concreta attività; e così vediamo con orrore lo spirito del cristianesimo sinceramente realizzato in un cotonificio modello: in favore dei ricchi Dio si è fatto industria e questa mantiene in vita il povero lavoratore cristiano soltanto finché le celesti costellazioni del commercio provocano la generosa necessità di farlo passare in un mondo migliore.
I Greci non conoscevano affatto il vero e proprio artigianato. Essi ritenevano indegno di particolare e costante attenzione procurarsi le cosiddette necessità della vita che, a rigore, costituiscono tutte le premure della nostra vita pubblica e privata. Il loro spirito viveva soltanto in pubblico nella comunità del popolo: i bisogni di questo pubblico costituivano la loro cura e a soddisfarli pensavano il patriota, l’uomo di Stato, l’artista, non l’artigiano. Per godere la vita pubblica i Greci uscivano da una semplicità domestica senza lusso: a loro sarebbe sembrato vergognoso e meschino abbandonarsi tra le splendide pareti di un palazzo privato alla sontuosità raffinata e alla libidine che oggi costituiscono l’unico contenuto vitale degli eroi della borsa; proprio in questo infatti i Greci si distinguevano dai barbari egoisti e orientalizzati. Alla cura del corpo provvedevano i bagni comuni e i pubblici ginnasi; l’abbigliamento semplice e nobile era oggetto delle cure artistiche per lo più da parte delle donne e quando proprio si presentava la necessità del lavoro manuale, i Greci, secondo la loro natura, sapevano ricavarne il lato artistico e sollevare il lavoro sul piano dell’arte. Le più rozze faccende domestiche erano però ripudiate e lasciate... allo schiavo.
Ora questo schiavo è diventato l’amo fatale nel destino del mondo. Con la sua sola esistenza di schiavo, considerata necessaria, egli ha rivelato la nullità e fugacità di ogni forza e bellezza della particolare umanità greca e ha dimostrato nei secoli che bellezza e forza, quali elementi fondamentali della vita pubblica, possono avere durata e fortuna solo quando appartengono a tutti gli uomini.
Finora però ci siamo fermati purtroppo a questa dimostrazione. In verità la rivoluzione dell’umanità – in atto da millenni – si è manifestata quasi soltanto nello spirito della reazione: essa ha screditato l’uomo bello e libero traendolo verso la schiavitù. Lo schiavo non ha acquistato la libertà, l’uomo libero è diventato schiavo.
Per i Greci soltanto l’uomo bello e forte era considerato libero, e quest’uomo era appunto solo lui, il greco stesso: tutti quanti erano fuori dell’uomo greco, del sacerdote di Apollo, venivano considerati barbari e, quando i Greci se ne servivano, schiavi. Giustamente il non greco era in realtà barbaro e schiavo; ma era anche uomo e la sua barbarie, la sua condizione di schiavo non era nella sua natura ma nel suo destino, era il peccato della storia contro la sua natura, come oggi è peccato della società e della civiltà se i popoli più sani, nel clima più sano, sono diventati miserabili e mutilati. Ma questo peccato della storia doveva coinvolgere ben presto anche il libero greco: dove nelle nazioni non fu più viva la coscienza dell’assoluto amore del prossimo, bastò che il barbaro sottomettesse il greco perché questi, insieme con la libertà, perdesse anche la forza e la bellezza; e duecento milioni di uomini ammassati alla rinfusa nell’impero romano dovettero presto accorgersi, a denti stretti, che quando non tutti gli uomini possono essere ugualmente liberi e felici, tutti devono essere ugualmente schiavi e miserabili.
E così fino al giorno d’oggi siamo schiavi, con la sola consolazione di sapere che lo siamo: schiavi ai quali un tempo gli apostoli cristiani e l’imperatore Costantino consigliarono di rinunciare a un mondo misero per uno migliore al di là; schiavi ai quali oggi banchieri e fabbricanti insegnano a cercare lo scopo dell’esistenza nel lavoro artigianale per il pane quotidiano. Libero da questa schiavitù si sentì ai suoi tempi soltanto l’imperatore Costantino, che, quale despota pagano, avido di piaceri, disponeva della vita terrena dei suoi creduli sudditi; libero si sente oggi, per lo meno nel senso della pubblica schiavitù, soltanto chi ha denaro, perché può usare la vita a proprio piacimento per qualcosa che non sia soltanto guadagnarsi la vita. Come l’aspirazione a liberarsi dalla schiavitù generale si manifestava nel mondo romano e medievale quale desiderio di dominio assoluto, così oggi si presenta come brama di denaro; non meravigliamoci quindi se anche l’arte va in cerca di denaro, perché tutto tende alla propria libertà, al proprio dio: il nostro dio però è il denaro, la nostra religione il guadagno.
L’arte rimane tuttavia di per sé sempre ciò che è: dobbiamo dire soltanto che non esiste nella vita pubblica moderna, ma vive ed è sempre vissuta come arte unica, bella, indivisibile, nella coscienza dell’individuo. La differenza dunque è soltanto questa: presso i Greci essa esisteva nella coscienza pubblica laddove oggi esiste soltanto nella coscienza del singolo in antitesi all’incoscienza generale. Nei suoi tempi migliori l’arte era dunque presso i Greci conservatrice perché esisteva nella coscienza pubblica come espressione valida e adeguata della realtà; presso di noi la vera arte è invece rivoluzionaria perché esiste soltanto in antitesi ad essa.
Presso i Greci la compiuta opera d’arte, il dramma, era l’essenza di tutto quanto la natura greca poteva rappresentare; era, in intimo collegamento con la sua storia, la nazione stessa che nella rappresentazione dell’opera d’arte si rispecchiava, si comprendeva e nel trascorrere di poche ore si consumava, per così dire, nel proprio godimento più nobile. Ogni divisione di questo godimento, ogni dispersione delle energie riunite in un sol punto, ogni smembramento degli elementi in varie direzioni particolari doveva rivelarsi dannoso all’opera d’arte unica, come lo era allo stato stesso similmente costituito, e perciò essa poteva soltanto prosperare ma non trasformarsi. L’arte era dunque conservatrice come al tempo stesso erano conservatori gli uomini migliori dello Stato greco. Eschilo è la più significativa manifestazione di questo spirito conservatore: la sua più bella opera d’arte conservatrice è l’Orestea con la quale si contrappose da poeta al giovane Sofocle, come da uomo di Stato si era contrapposto al rivoluzionario Pericle. La vittoria di Sofocle, come quella di Pericle, avvenne nello spirito del progressivo sviluppo dell’umanità, ma la sconfitta di Eschilo segnò il primo declino dalle altezze della tragedia greca, il primo momento della dissoluzione dello Stato ateniese.
Con la successiva decadenza della tragedia l’arte cessò sempre più di essere espressione della coscienza pubblica; il dramma si scisse nelle sue componenti: retorica, scultura, pittura, musica e così via, che abbandonarono la loro unione per andare ciascuna per la propria via e svilupparsi indipendente ma solitaria ed egoista. E così avvenne che nella rinascita delle arti incontrassimo anzitutto queste arti greche isolate, quali si erano sviluppate dalla dissoluzione della tragedia: la grande opera d’arte totale dei Greci non poté in un primo momento presentarsi nella sua ricchezza al nostro spirito inselvatichito, smarrito, dubbioso di sé e smembrato: e come avremmo potuto comprenderla? Ben sapemmo invece impadronirci dei singoli mestieri artistici; come mestieri nobili infatti, al cui livello erano già discese nel mondo grecoromano, quelle arti non erano molto lontane dal nostro spirito e dalla nostra natura: lo spirito corporativo e artigiano della nuova borghesia era vivo nelle città; prìncipi e nobili si compiacevano di far costruire con maggiore garbo e abbellire i loro castelli, di fare decorare le sale con dipinti più attraenti di quanto non avesse saputo fare la rozza arte medievale. I preti adottarono la retorica sul pulpito, la musica nel coro; e il nuovo mondo dei mestieri s’insinuò validamente nelle varie arti dei Greci fin dove essi potevano capirle e ritenerle utili.
Ciascuna di queste arti, doviziosamente alimentata e coltivata per il divertimento dei ricchi, ha riempito abbondantemente il mondo coi suoi prodotti; grandi spiriti vi hanno creato opere grandiose, ma l’arte vera e propria non è ancora rinata in virtù del Rinascimento. Infatti l’opera d’arte perfetta, la grande espressione propria di una vita pubblica bella e libera, il dramma, la tragedia, sebbene di tanto in tanto si siano avuti tragedi cospicui, non è ancora rinata appunto perché non deve rinascere, ma nascere ex novo.
Soltanto la grande rivoluzione dell’umanità, il cui inizio fu un giorno frantumato dalla tragedia greca, può riconquistarci questa opera d’arte: soltanto la rivoluzione infatti può generare dalle sue fondamenta più bello, più nobile, più diffuso ciò che ha strappato allo spirito conservatore di un’epoca precedente di cultura bella ma limitata.
Soltanto la rivoluzione, non la restaurazione, può restituirci quella suprema opera d’arte. Il compito che abbiamo davanti a noi è infinitamente più grande di quello che è già stato risolto una volta. Se l’opera d’arte greca comprendeva lo spirito di una bella nazione, quella dell’avvenire deve comprendere lo spirito dell’umanità libera al di sopra di tutte le barriere di nazionalità; il carattere nazionale non potrà essere che un ornamento, un’attrattiva della varietà individuale, mai un ostacolo inibitore. Dobbiamo quindi creare qualcosa di totalmente diverso anziché ristabilire soltanto il mondo greco; è ben vero che la stolida restaurazione d’una grecità apparente nell’opera d’arte è già stata tentata – che cosa non hanno tentato finora gli artisti su ordinazione? – ma non ne è potuto derivare altro che un vano artificio: ed erano precisamente le manifestazioni di quella stessa ipocrita aspirazione che in tutta la storia ufficiale della civiltà vediamo desiderosa di evitare l’unica aspirazione giusta, l’aspirazione alla natura.
No, non vogliamo ridiventare Greci; perché ciò che i Greci non seppero – e fu proprio per questo che dovettero perire – noi lo sappiamo. La loro caduta, della quale conosciamo la causa dopo il lungo periodo di miseria e di sofferenza, ci indica chiaramente che cosa dobbiamo diventare: ci insegna che dobbiamo amare tutti gli uomini per riamare noi stessi e recuperare la gioia di noi stessi. Dalla schiavitù disonorante dei mestieri, con la loro pallida brama di lucro, vogliamo elevarci alla libera umanità artistica con la sua radiosa anima universale; di oppressi operai dell’industria vogliamo diventare tutti uomini belli e forti ai quali il mondo appartenga come fonte perenne di supremo piacere artistico.
Per giungere a questa meta ci occorre la più gagliarda forza della rivoluzione: nostra è infatti soltanto quella forza rivoluzionaria che si spinge fino alla meta, il cui raggiungimento può soltanto giustificarla di avere esercitato la sua prima attività nella dispersione della tragedia greca, nella caduta dello Stato ateniese.
Ma donde dobbiamo attingere questa forza considerato il nostro profondo indebolimento? Donde ricavare l’energia umana da opporre alla paralizzante pressione di una civiltà che rinnega interamente l’uomo contro la spavalderia d’una cultura che usa lo spirito umano soltanto come il vapore nella macchina? Donde la luce per illuminare la crudele superstizione dominante per cui quella civiltà e quella cultura varrebbe più dell’uomo vivo e reale, per cui l’uomo avrebbe valore soltanto come strumento di quei dominanti poteri astratti e non per se stesso e come uomo?
Quando il medico erudito non conosce più rimedi, ci rivolgiamo finalmente disperati... ancora alla natura. La natura, e soltanto la natura, può sbrogliare il destino del mondo. Se la civiltà, partendo dall’idea cristiana che la natura umana sia riprovevole, ha rinnegato l’uomo, si è creata un nemico che un giorno la dovrà distruggere in quanto l’uomo non vi troverà spazio: questo nemico infatti è la natura vivente ed eterna. La natura, la natura umana, annuncerà alle due sorelle, cultura e civiltà, questa legge: “Fin dove sono contenuta in voi, potrete vivere e fiorire; fin dove non sono in voi dovrete invece inaridire e trovare la morte”.
Nel misantropico progredire della civiltà andiamo comunque incontro al felice risultato di veder crescere la sua limitazione della natura in tale misura da conferire alla compressa natura immortale l’impeto necessario per scagliare lungi da sé con un solo strattone tutto il peso e ogni costrizione; e tutto questo accumulo di civiltà avrebbe insegnato alla natura a rendersi conto della propria immensa forza. Il moto di questa forza è però... la rivoluzione.
Come si manifesta allo stato presente del movimento sociale questa forza rivoluzionaria? Non si manifesta anzitutto come renitenza del lavoratore, sulla base della coscienza morale della propria laboriosità, di fronte alla viziosa pigrizia o all’immorale operosità dei ricchi? Non vuole egli forse elevare come per vendetta il principio del lavoro a unica, legittima religione della società? E costringere il ricco a lavorare come lui per guadagnarsi il pane quotidiano col sudore della fronte? Non dovremmo forse temere che l’adempimento di questa necessità, il riconoscimento di questo principio porti proprio i mestieri umilianti a conquistare alla fine il potere assoluto nel mondo e, per restare nel nostro tema, che renda l’arte per sempre impossibile?
In verità è questo il timore di molti sinceri amici dell’arte, persino di autentici filantropi ai quali importa soltanto proteggere il germe più nobile della nostra civiltà. Costoro però misconoscono la vera natura del grande movimento sociale; sono sviati dalle teorie ostentate dai nostri socialisti dottrinari i quali vorrebbero stipulare patti impossibili con la nostra società quale è attualmente costituita; sono ingannati dalla spontanea indignazione della parte più sofferente della nostra società, determinata tuttavia da un impulso naturale più profondo e nobile, quello di godere degnamente la vita, la cui conservazione materiale l’uomo non vuole più guadagnarsi faticosamente impiegando tutte le proprie energie, ma che vuol godere da uomo: a guardare bene si tratta dunque di uscire dal mestiere per andare verso un’umanità artistica, verso la libera dignità umana.
Ora l’arte ha precisamente il compito di fare riconoscere a questo impulso sociale il suo più nobile significato, di rivelargli il suo giusto indirizzo. Dal suo stato di barbarie civile la vera arte può sollevarsi a dignità soltanto appoggiandosi al nostro grande movimento sociale: l’arte e questo movimento hanno un fine comune che possono raggiungere soltanto accettandolo in comune. Questo fine è l’uomo bello e forte: possa la rivoluzione dargli la forza, l’arte la bellezza.
Non può essere compito nostro descrivere nei particolari l’andamento dell’evoluzione sociale che avverrà nella storia, né il calcolo dottrinale potrebbe a questo riguardo suggerire qualcosa all’atteggiamento storico della natura sociale dell’uomo indipendente da ogni presupposto. Niente viene fatto nella storia, ma tutto si fa da sé per interiore necessità. Le condizioni però, nelle quali un giorno il movimento sarà arrivato alla meta, non potranno che essere diametralmente opposte alle presenti poiché altrimenti tutta la storia sarebbe un groviglio irrequieto e circolare anziché il movimento necessario di una corrente che nonostante le curve, le deviazioni, le inondazioni, segue sempre la direzione principale.
In queste condizioni future possiamo riconoscere gli uomini liberati da un’ultima superstizione, dal misconoscimento della natura, da quella superstizione appunto per cui l’uomo si è considerato finora solo strumento di un fine al di fuori di lui. Quando egli abbia preso coscienza del fatto di essere l’unico fine della propria esistenza e comprenda di poter raggiungere questo fine nel modo più perfetto, soltanto in comune con tutti gli uomini, la sua professione di fede sociale non potrà che consistere in una positiva conferma della dottrina di Gesù che avvertiva: “Non preoccupatevi di che cosa mangeremo, di che cosa berremo, né di che ci vestiremo, perché tutte queste cose ve le ha date spontaneamente il vostro Padre celeste”. Questo Padre celeste non sarà altro che la ragione sociale dell’umanità che si impadronisce della natura e delle sue ricchezze per il bene di tutti. Il vizio e la maledizione delle nostre istituzioni sociali consistettero appunto nel fatto che finora oggetto di preoccupazione è stato il mantenimento puramente fisico della vita: quella preoccupazione materiale che paralizza per lo più ogni attività dello spirito e consuma il corpo e l’anima. Questa preoccupazione ha reso l’uomo debole, servile, ottuso e miserabile, ne ha fatto una creatura che non può né amare né odiare, un cittadino sempre pronto a rinunciare fino all’ultima briciola della sua libera volontà pur di alleviare in tal modo la sua preoccupazione.
Quando l’umanità fraterna abbia allontanato da sé una volta per sempre questa preoccupazione e, come i Greci allo schiavo, l’abbia accollata alla macchina, a questo futuro schiavo dell’uomo libero e creatore, che egli fino ad oggi ha servito come il feticista serve l’idolo con le proprie mani, allora tutto il suo bisogno di attività libera si manifesterà come impulso artistico. In questo modo riacquisteremo l’elemento di vita dei Greci in misura assai maggiore: ciò che per i Greci fu il risultato dell’evoluzione naturale, sarà per noi la conclusione della lotta storica; ciò che per loro fu un dono semincosciente resterà per noi scienza conquistata con la lotta, poiché ciò che l’umanità nel suo complesso veramente sa non può più andare perduto.
Solo gli uomini forti conoscono l’amore, solo l’amore afferra la bellezza, solo la bellezza forma l’arte. Il reciproco amore dei deboli può manifestarsi soltanto come solletico di voluttà; l’amore del debole per il forte è umiltà e paura; l’amore del forte per il debole è pietà e indulgenza: solo l’amore del forte per il forte è amore poiché è libera dedizione a colui che non può esercitare alcuna costrizione su di noi. In ogni clima, presso ogni popolo gli uomini potranno conquistare mediante la vera libertà la medesima forza, mediante la forza il vero amore, mediante il vero amore la bellezza: l’attività della bellezza però si chiama arte.
Noi educhiamo noi stessi e i nostri figli a quello che ci sembra lo scopo della vita. I Germani venivano educati alla guerra e alla caccia, i veri cristiani alla rinuncia e all’umiltà, il suddito dello Stato moderno viene educato al guadagno industriale perfino mediante l’arte e la scienza. Se il futuro uomo libero non avrà più come scopo della vita quello di guadagnarsi da vivere, ma una nuova fede divenuta attiva, o meglio una nuova scienza, gli assicurerà il necessario in compenso di un’attività naturale a lui congeniale, se, insomma, l’industria non sarà più la nostra padrona ma la nostra serva, porremo lo scopo della vita nella gioia di vivere e cercheremo di educare i nostri figli alla capacità di godere effettivamente questa gioia. L’educazione, prendendo le mosse dall’esercizio della forza, dal culto della bellezza fisica, diventerà puramente artistica già per l’indisturbato amore che si porta al figlio e per la gioia che dà il prosperare della sua bellezza: e ogni uomo sarà in un modo o nell’altro veramente artista. La diversità delle inclinazioni naturali porterà le arti più diverse, e in queste le più diverse tendenze, a una ricchezza insospettata; e come il sapere di tutti gli uomini finirà col trovare la sua espressione religiosa nel sapere attivo dell’umanità libera e concorde, così tutte queste arti profondamente evolute troveranno il più intelligente punto di unione nel dramma, nella stupenda tragedia umana. Le tragedie saranno le feste dell’umanità: l’uomo libero, forte e bello, sciolto da ogni convenzione ed etichetta, vi celebrerà i piaceri e i dolori del suo amore e compirà, degno e sublime, il grande sacrificio della propria morte.
Quest’arte sarà ancora conservatrice, ma in realtà e in seguito alla sua capacità di resistere e di evolversi si manterrà da sé e non pretenderà di continuare ad esistere per perseguire un fine al di fuori di sé, perché questo è il punto: quest’arte non va a caccia di denaro!
“Utopie, utopie!”, li sento esclamare, i grandi sapienti, negatori della nostra moderna barbarie politica e artistica, i così detti uomini pratici che nell’esercizio della loro pratica cercano ogni giorno di cavarsela solo con menzogne e violenze o, quando sono onesti, tutt’al più con l’ignoranza.
“Bell’ideale codesto, che però come tutti gli ideali, ci sta dinanzi e purtroppo non può essere raggiunto dagli uomini condannati ad essere imperfetti”. Così sospira il buon sognatore pensando al regno dei cieli nel quale, almeno per la sua persona, Dio riparerà all’inconcepibile errore di avere creato questa terra e gli uomini.
Essi vivono, soffrono, mentono e bestemmiano in effetti nello stato più ripugnante, nella sporca feccia d’una utopia veramente fantastica e quindi non realizzata, si affaticano e si sopraffanno in tutte le arti dell’ipocrisia per mantenere la menzogna di questa utopia dalla quale miseramente cadono ogni giorno, mutilati e storpiati dalla più volgare e frivola passione, sul nudo e piatto terreno della più disincantata verità, e considerano chimera e utopia l’unica redenzione naturale dal loro incanto, proprio come i pazienti nel manicomio prendono le loro pazze immaginazioni per verità, le verità invece per follie.
Se la storia conobbe una vera utopia, un ideale irraggiungibile, questo fu il cristianesimo. Essa infatti ha dimostrato chiaramente e continua a dimostrarlo ogni giorno che i princìpi del cristianesimo non si possono attuare. Del resto, come potevano questi princìpi diventare vivi, realizzarsi veramente nella vita, dal momento che erano contrari alla vita e rinnegavano e condannavano ciò che è vivo? Il cristianesimo ha un contenuto prettamente spirituale, anzi super-spirituale, predica l’umiltà, la rinuncia, il disprezzo per le cose terrene e in questo disprezzo l’amore fraterno: come si presenta la sua realizzazione nel mondo moderno che pure si dice cristiano e considera la religione cristiana come suo fondamento intangibile? Come superbia dell’ipocrisia, usura, rapina perpetrata ai beni della natura, egoistico disprezzo del prossimo che soffre. Donde questa netta antitesi fra l’esecuzione e l’idea? Essa deriva dal fatto che l’idea era malata, germogliata dal momentaneo rilassamento e indebolimento della natura umana, e peccava contro la natura sana dell’uomo. Quanto però sia forte, quanto inesauribile la sua ricchezza sempre rinnovellantesi, questa natura ha dimostrato proprio sotto l’universale pressione di quell’idea che, se si fosse attuata nella sua intima logica, avrebbe dovuto estirpare l’uomo dalla terra, dato che anche l’astinenza dall’amore sessuale vi era compresa come suprema virtù. Ma voi vedete che, nonostante la Chiesa onnipotente, l’uomo esiste in tale abbondanza che la vostra saggezza politica economico-cristiana non sa nemmeno che farsene di questa abbondanza, e voi andate alla ricerca di mezzi sociali micidiali per distruggerla, anzi sareste ben contenti che l’uomo fosse ammazzato dal cristianesimo affinché il Dio unico e astratto della vostra cara individualità rimanesse solo in questo mondo.
Questi sono gli uomini che gridano all’“utopia” quando il buon senso, di fronte ai loro folli esperimenti, si appella alla natura unicamente e realmente visibile e tangibile; quando alla divina intelligenza dell’uomo chiede soltanto di sostituire al nostro istinto animale la ricerca tranquilla, anche se non priva di fatica, dei mezzi di sopravvivenza. E in verità non le chiediamo per la società umana altro risultato per poter erigere su questa base il più stupendo e ricco edificio della vera, bella arte dell’avvenire!
Il vero artista che già ora ha trovato la base giusta, poiché questa esiste in eterno, è già ora in grado di lavorare all’opera d’arte dell’avvenire. Infatti fin da sempre, e così adesso, ciascuna delle arti sorelle ha manifestato in numerose creazioni la sua alta coscienza di sé. Ma perché fin da sempre, e soprattutto nel nostro stato attuale, hanno sofferto e soffrono gli entusiastici creatori di quelle nobili opere? Non è forse per il contatto con il mondo esterno, con quel mondo cioè cui quelle opere dovevano appartenere? Che cosa riempì di sdegno l’architetto quando, su ordinazione, dovette disperdere la propria energia creatrice in caserme e case di abitazione? Che cosa offrì il pittore vistosi costretto a ritrarre l’odiosa smorfia di un milionario? Che cosa offese il musicista, costretto a comporre musiche da tavola? Che cosa il poeta, forzato a scrivere romanzi da biblioteca circolante? In che cosa consisteva la loro sofferenza? Nel dover sprecare le proprie energie creative nel guadagno, nel dover fare dell’arte un mestiere! Che cosa dovrà soffrire infine il drammaturgo, intento a riunire tutte le arti nell’opera suprema, nel dramma? Dovrà soffrire tutti i dolori degli altri artisti messi insieme.
Quel che crea diventa veramente opera d’arte solo quando viene alla luce davanti al pubblico; e un’opera drammatica viene alla luce soltanto attraverso il teatro. Ma che cosa sono oggi queste istituzioni teatrali che dispongono dell’aiuto di tutte le arti? Sono imprese industriali e anche là dove Stati o sovrani offrono loro particolari dotazioni, la direzione è affidata per lo più a quegli stessi uomini che ieri facevano speculazioni in granaglie e domani dedicheranno le loro bene acquisite nozioni al traffico dello zucchero, a meno che per intendere la dignità del teatro non abbiano sviluppato le loro nozioni nei misteri dei corridoi ministeriali o di simili istituzioni. Fintanto che, in base al carattere dominante della pubblica opinione e alla necessità che il direttore di un teatro tratti col pubblico solo da abile speculatore commerciale, non si vedrà nell’istituzione teatrale altro che un mezzo per far circolare il denaro al fine di produrre interessi al capitale, è perfettamente logico che si affidi la direzione, ossia lo sfruttamento, solo a un competente in simili affari; infatti una direzione veramente artistica, tale cioè da rispondere allo scopo originario del teatro, difficilmente sarebbe in grado di perseguirne il fine moderno. Appunto perciò ogni persona intelligente capirà che, se il teatro deve seguire la sua nobile e naturale destinazione, lo si dovrà assolutamente liberare dalla necessità della speculazione industriale.
Come fare? Questa sola istituzione dovrebbe essere sottratta a un servizio cui oggi sono soggetti tutti gli uomini e tutte le loro imprese sociali? Sì, proprio il teatro deve precedere tutti gli altri in questa liberazione, poiché esso è l’istituzione artistica più larga e più influente; e prima che l’uomo possa esercitare liberamente la sua più nobile attività, l’attività artistica, come potrebbe sperare di essere libero e indipendente in campi meno elevati? Giacché il servizio dello Stato, il servizio nell’esercito, per lo meno non è più un’industria, cominciamo col liberare l’arte ufficiale poiché, come ho già accennato, proprio ad essa va affidato un compito altissimo, un’importantissima attività nel nostro movimento sociale. Più e meglio di una religione invecchiata, rinnegata dallo spirito del pubblico, più efficace e pregnante di una saggezza politica inetta e da un pezzo sfiduciata, l’arte perennemente giovane, che da se stessa e dal più nobile spirito dell’epoca può trarre i mezzi per ringiovanire, saprà assegnare alla corrente dei vivi moti sociali, che tanto spesso cozza contro orridi scogli e bassifondi, uno scopo alto e bello, lo scopo di una nobile umanità.
Se voi, amici dell’arte, tenete veramente a salvarla dalle minacciose tempeste, rendetevi conto che non solo si deve conservarla ma ancora prima portarla a vivere la sua vita vera, piena e particolare.
Se voi, onesti uomini di Stato, tenete veramente a inoculare alla prevista rivoluzione sociale, cui forse vi opponete soltanto perché, essendo scossa la vostra fede nella purezza della natura, non sapete comprendere come questa rivoluzione possa fare a meno di tramutare una situazione errata in altra molto peggiore; se, dico, tenete davvero a inoculare in questo mutamento un pegno vitale di futura moralità, aiutateci, con tutte le vostre forze, a restituire l’arte a se stessa e al suo nobile compito!
Voi, sofferenti fratelli di quella parte della società umana che nel vostro bruciante astio andate meditando come trasformarvi da schiavi del denaro in uomini liberi, cercate di comprendere il nostro compito e aiutateci ad elevare l’arte alla sua dignità affinché vi possiamo indicare come portare il mestiere sul piano dell’arte e fare del servo dell’industria l’uomo bello e cosciente che, con un sorriso d’intesa, dice alla natura, al sole e alle stelle, alla morte e all’eternità: “Anche voi siete miei e io sono il vostro padrone!”.
Se voi, ai quali mi sono appellato, foste d’accordo e uniti con noi, come sarebbe facile per la vostra volontà mettere in opera quelle semplici misure che dovrebbero produrre come conseguenza l’inevitabile prosperità del teatro, la più importante di tutte le istituzioni artistiche! Sarebbe compito dello Stato e della comunità soppesare prima i mezzi con il fine per porre il teatro in condizione di perseguire soltanto la sua più alta e vera destinazione. Questo scopo verrà raggiunto se i teatri saranno aiutati in modo che la loro amministrazione resti soltanto artistica; e nessuno ne sarà capace meglio degli artisti stessi i quali si associno al fine di creare l’opera d’arte e, mediante un’opportuna costituzione, si garantiscano la reciproca prospera attività: soltanto la più completa libertà può unirli nell’aspirazione di rispondere al fine per il quale si sono liberati dalla necessità della speculazione industriale: e questo fine è l’arte che soltanto l’uomo libero, non lo schiavo del guadagno, può comprendere.
Giudice dei loro prodotti sarà la libera opinione pubblica. Ma affinché anche questa sia pienamente libera e indipendente di fronte all’arte, bisognerebbe fare ancora un passo sulla via intrapresa: il pubblico dovrebbe avere ingresso libero alle rappresentazioni teatrali. Finché il denaro sarà necessario ai bisogni della vita, finché senza denaro non rimarrà all’uomo altro che l’aria e, a mala pena, l’acqua, la misura da prendersi non potrebbe avere altro scopo che quello di non considerare le vere rappresentazioni teatrali in cui il pubblico si riunisce come prestazioni a pagamento: aspetto che, come tutti sanno, porta al più vergognoso misconoscimento del carattere delle rappresentazioni artistiche; ma dovrebbe essere compito dello Stato o più ancora del relativo Comune indennizzare con forze unite gli artisti per le loro prestazioni complessive, non già particolari.
Dove non bastino le forze per farlo, sarebbe meglio ora e sempre lasciare morire del tutto un teatro che potrebbe continuare ad esistere soltanto come impresa industriale, almeno finché il bisogno della comunità non risulti abbastanza intenso per soddisfarlo con i necessari sacrifici umani.
Quando poi un giorno la società umana sia diventata così umanamente bella e nobile quanto non possiamo, è vero, realizzare per il solo effetto della nostra arte, ma che tuttavia possiamo sperare e dobbiamo volere in collaborazione con le immancabili grandi rivoluzioni sociali, anche le rappresentazioni teatrali saranno le prime imprese comuni in cui il concetto di denaro e guadagno scomparirà interamente; se, infatti, con le suddette premesse l’educazione diventerà sempre più artistica, un giorno saremo tutti artisti, almeno fino al punto da poterci riunire in una libera attività comune, proprio da artisti, soltanto per amore dell’arte stessa, non per un secondario scopo industriale.
L’arte ed i suoi istituti, la cui auspicata organizzazione poté essere qui accennata soltanto di sfuggita, possono diventare in tal modo i precursori e modelli di tutte le future istituzioni comunali: lo spirito che amalgama una corporazione artistica, per il raggiungimento del suo vero scopo si potrebbe recuperare in qualunque altra unione sociale che si prefigga un preciso scopo degno dell’uomo; infatti proprio il nostro futuro atteggiamento sociale, una volta raggiunto lo scopo giusto, può e deve essere soltanto di natura prettamente artistica, adeguato cioè alle nobili facoltà dell’uomo. [...]
[Luglio 1849]
L’opera d’arte dell’avvenire
1. Natura, uomo e arte
Come l’uomo si comporta verso la natura così l’arte si comporta verso l’uomo.
Quando la natura ebbe sviluppato la facoltà di poter racchiudere in sé le condizioni necessarie per l’esistenza dell’uomo, l’uomo stesso ebbe vita spontaneamente. Quando la vita umana produce dal suo stesso seno le condizioni necessarie per dar vita all’opera d’arte, questa spontaneamente nasce.
La natura genera e modella senza intenzione alcuna e involontariamente, secondo il bisogno; il che significa per necessità. La stessa necessità è la forza che genera e modella la vita umana. Solo quel che è privo d’intenzione e involontario scaturisce da un bisogno reale; e solo nel bisogno sta il fondamento della vita.
L’uomo constata la necessarietà della natura solo nella concatenazione dei suoi fenomeni: finché non l’afferra ritiene questo legame puramente arbitrario.
Dal momento in cui l’uomo si rese conto della sua diversità dalla natura – ed è proprio da questo momento che ebbe inizio la sua evoluzione come uomo nella misura in cui superando lo stato incosciente della vita animale diventò cosciente –, da quando insomma oppose se stesso alla natura e, di conseguenza, si sviluppò in lui il pensiero da quel che prima era un vago senso della sua dipendenza da essa, da quel momento ebbe origine l’errore come prima manifestazione della coscienza. Ma poiché l’errore è il padre della conoscenza, la storia della conoscenza generata dall’errore altro non è che la storia del genere umano, dal mito della preistoria al giorno d’oggi.
L’uomo errò fin dal momento in cui pose la causa dei fenomeni della natura al di là dell’essenza stessa della natura, sostituendo alla realtà materiale del fenomeno una causa immateriale, da lui immaginata arbitrariamente come umana; ritenne inoltre infinita la dipendenza della sua attività incosciente e senza scopo il comportamento intenzionale degli atti della volontà, che sono indipendenti e limitati. La conoscenza consiste nella soluzione di quest’errore, e questo altro non è che la comprensione della necessità di quei fenomeni, la cui causa ci pareva arbitraria.
In virtù di questa conoscenza la natura diviene cosciente di sé, e lo diviene anche nell’uomo, il quale solo differenziandosi dalla natura giunse a conoscere la natura stessa in quanto essa divenne per lui oggetto; ma questa differenziazione cessa nuovamente non appena l’uomo riconosce come sua l’essenza della natura, non appena riconosce una medesima necessità per tutto ciò che esiste e vive realmente, quindi per l’esistenza umana non meno che per quella della natura e di conseguenza non solo il legame dei fenomeni naturali tra loro, ma anche il legame tra lui, uomo, e la natura.
Ma se la natura, per i suoi legami con l’uomo, perviene nell’uomo alla coscienza di se stessa, e se nell’attuarsi di questa coscienza consiste la vita umana quasi quale rappresentazione, immagine della natura, è ovvio che la vita umana stessa acquisti intelligenza per mezzo della scienza, la quale a sua volta fa di questa un oggetto d’esperienza. Ora l’entrare in funzione della coscienza acquistata mediante la scienza, la rappresentazione della vita conosciuta attraverso di essa, l’immagine della sua necessità e della sua verità è l’arte. (Cioè l’arte in generale e l’arte dell’avvenire in particolare).
L’uomo non sarà mai quel che può essere e che deve essere finché la sua vita non sarà lo specchio fedele della natura, adempimento cosciente della sola necessità vera, che è necessità naturale intima, non la sottomissione a una potenza esterna, immaginaria, modellata solo sull’immaginazione e quindi non necessaria ma arbitraria. Solo l’uomo sarà veramente uomo, mentre fino ad oggi esso non è mai esistito se non in funzione della religione, della nazionalità, dello Stato. Parimenti l’arte non sarà mai quel che può e deve essere finché non sarà la fedele immagine del vero uomo e della vera vita degli uomini secondo natura, fin quando cioè non dovrà più improntare le condizioni della sua esistenza agli errori, alle vicende e alle mostruosità della nostra vita moderna.
Pertanto il vero uomo non esisterà finché la vera natura umana anziché le leggi arbitrarie dello Stato non formerà e regolerà la sua vita e non esisterà una vera arte finché le sue creazioni non saranno sottomesse alle leggi della natura anziché ai dispotici capricci della moda. Come infatti l’uomo sarà libero solo quando con intima gioia sarà diventato cosciente del suo rapporto con la natura, così l’arte sarà libera solo quando non dovrà più vergognarsi del suo rapporto con la vita. Solo nella gioiosa consapevolezza dei suoi legami con la natura l’uomo supererà la sua dipendenza da essa; ma l’arte supererà la sua dipendenza dalla vita solo legandosi alla vita di uomini sinceri e liberi.
2. Vita, scienza e arte
Se l’uomo modella la vita involontariamente secondo idee che risultano dalla sua concezione arbitraria della natura e conserva l’espressione involontaria di queste idee nella religione, queste, nella scienza, divengono per lui oggetto di una speculazione e di una ricerca arbitraria e cosciente.
Il cammino della scienza è quello che va dall’errore alla conoscenza, dall’idea alla realtà, dalla religione alla natura. Quindi all’inizio della scienza l’uomo si trova di fronte alla vita come si trovava dinanzi ai fenomeni della natura all’inizio della vita umana quando questa si differenziò dalla natura. La scienza assorbe nel suo complesso quel che d’arbitrario c’è nelle concezioni umane mentre al suo fianco la vita stessa segue nel suo insieme uno sviluppo non arbitrario e necessario. La scienza porta dunque con sé il peccato della vita e ne fa ammenda autodistruggendosi dal momento che finisce proprio nel suo contrario: nella conoscenza della natura, nel riconoscimento dell’inconscio, del non arbitrario e, di conseguenza, del necessario, del reale, del concreto. La natura della scienza è perciò finita, quella della vita infinita, allo stesso modo in cui l’errore è finito e infinita la verità. Ma vero e vivente è solo ciò che è materiale e obbedisce alle leggi della natura fisica; la sua somma vittoria, quando per sua opera giunge alla distruzione di quest’orgoglio e al riconoscimento del concreto.
Il fine della scienza è la giustificazione dell’inconscio, è la vita cosciente di se stessa, è la materialità riconosciuta come sensibile, è la scomparsa dell’arbitrio nel volere il necessario. La scienza è dunque mezzo di conoscenza, il suo procedimento è indiretto, il suo scopo è mediato, laddove la vita è immediatezza e autodeterminazione. Ora, se la soluzione della scienza è il riconoscimento dell’immediatezza della vita che si autocondiziona e pertanto della vita reale, questo riconoscimento ha la sua espressione più diretta e sincera nell’arte o, per meglio dire, nell’opera d’arte.
È vero che l’artista dapprima non procede direttamente: la sua creazione è del resto mediatrice, eclettica, arbitraria. Ma proprio là dov’è mediatore ed eclettico, il prodotto della sua attività non è ancora opera d’arte. Il suo procedimento è piuttosto quello della scienza, che avanza mediante ricerche e osservazioni ed è di conseguenza arbitraria e suscettibile d’errore. Solo là dove la scelta è già fatta, dove questa scelta fu necessaria e fu scelto quello che era necessario, là cioè dove l’artista s’è ritrovato nell’oggetto stesso come l’uomo perfetto si ritrova nella natura, là solo l’opera d’arte prende forma, è essa stessa una realtà che si autodetermina, è qualcosa d’immediato.
La vera opera d’arte, quella cioè che è immediatamente rappresentata in modo concreto nell’istante della sua più corporea manifestazione, costituisce quindi la redenzione dell’artista, la sparizione delle ultime tracce dell’arbitrio creatore, la certezza evidente di ciò che fino ad allora non era che immaginazione, la liberazione del pensiero nell’azione sensibile, l’appagamento del bisogno di vivere nella vita.
L’opera d’arte così concepita, come atto immediato di vita, è dunque la perfetta riconciliazione della scienza con la vita, la corona d’alloro che la scienza, vinta e redenta dalla sua sconfitta, offre felice a colei che riconosce sua vincitrice.
3. Il popolo e l’arte
La redenzione del pensiero e della scienza nell’opera d’arte sarebbe impossibile se la vita stessa potesse essere sottoposta alla speculazione scientifica. Se veramente il pensiero cosciente e arbitrario dominasse interamente la vita, potrebbe impadronirsi dell’istinto di vita e usarlo a un fine che non fosse la necessità del bisogno assoluto. La vita stessa sarebbe così negata per risolversi nella scienza, la quale, in realtà, nel suo sfrenato orgoglio, ha sognato un simile trionfo. Il modo come il nostro Stato è governato, la nostra arte moderna, sono i figli sterili e senza sesso di questi sogni.
I grandi errori involontari del popolo, così come si manifestarono fin dall’origine nelle sue concezioni religiose diventando i punti di partenza d’un pensiero e d’una sistematica arbitrari e speculativi nella teologia e nella filosofia, si sono ingigantiti in queste scienze, sopratutto col concorso della loro sorella adottiva, la politica. Queste hanno fatto dell’errore una potenza che pretende nientemeno di dominare il mondo e la vita diventando un’immanente divina infallibilità.
L’errore persisterebbe e sarebbe davvero ineluttabile nella sua forza di devastazione se la stessa forza vitale che l’ha generato involontariamente non finisce di fatto con l’annientarlo in virtù d’una necessità naturale immanente. Questa è tanto certa ed evidente che l’intelletto, pur estraniandosi orgogliosamente della vita, non vede altra salvezza dalla vera follia che il riconoscimento senza riserva di quest’unica certezza e evidenza. Questa forza vitale è il popolo.
Che cos’è il popolo? Prima d’ogni altra cosa è indispensabile mettersi d’accordo sulla risposta da dare a questa domanda di vitale importanza.
Il popolo è stato in ogni tempo l’insieme di tutti gli individui che formavano una comunità. Agli inizi furono la famiglia e la tribù, poi le tribù riunite in nazione dalla medesima lingua. Praticamente a causa del dominio universale di Roma che assorbì le nazioni, e teoricamente a causa del cristianesimo che ammise soltanto l’uomo non nel senso nazionale ma cristiano, il concetto di popolo s’è tanto ampliato, per non dire volatizzato, che sotto quel termine possiamo comprendere sia l’uomo in generale sia, secondo l’arbitraria concezione politica, una certa parte dei cittadini di uno Stato e precisamente quelli che non posseggono nulla.
Ma oltre a questo significato assurdo la parola popolo ha acquistato anche un significato morale indelebile, e proprio per questo avviene che in tempi torbidi e inquieti a tutti piace fare assegnamento sul popolo e tutti pretendono di avere a cuore il suo bene e nessuno vorrebbe esserne separato. E per questa ragione anche ai nostri tempi moderni il problema è stato spesso posto in termini quanto mai diversi: che è dunque il popolo? Nell’insieme di tutti quelli che fan parte dello Stato può una frazione particolare o un partito rivendicare questo termine per sé solo? Non è meglio dire che siamo tutti “popolo”, dall’ultimo pezzente al sovrano?
La risposta da dare alla domanda tenendo conto del decisivo senso universale che è alla sua base è questa: il popolo è l’insieme di tutti coloro che provano una necessità comune. Ne fan parte quindi coloro che considerano la propria sofferenza come una sofferenza comune o ne trovano le ragioni in una sofferenza comune; in altri termini tutti coloro che si attendono la fine della propria sofferenza dalla fine della sofferenza comune, e per tale ragione impegnano tutta la loro energia vitale per porre fine alla propria sofferenza ritenuta sofferenza comune; infatti è vera sofferenza solo quella che spinge all’estrema disperazione, ma solo tale sofferenza è la forza del vero bisogno, né esiste un bisogno vero che non sia un bisogno comune. Solo chi prova un bisogno vero ha il diritto di soddisfarlo; solo la soddisfazione d’un vero bisogno è necessità, e solo il popolo agisce secondo necessità e di conseguenza in modo irresistibile, vittorioso e veritiero.
E allora, chi non appartiene al popolo? Chi sono i suoi nemici?
Tutti coloro che non provano una vera necessità, tutti quelli il cui slancio vitale consiste in un bisogno che non si innalza alla forza della necessità. La loro necessità è quindi immaginaria, falsa, egoistica; essa non solo è estranea al bisogno comune, ma consiste soltanto nel bisogno di conservare il superfluo: quindi un bisogno privo di necessità e in netta antitesi con il bisogno comune.
Dove non esiste necessità non esiste vero bisogno; dove non esiste vero bisogno non esiste un’attività necessaria; dove non esiste un’attività necessaria regna l’arbitrio; dove regna l’arbitrio pullulano tutti i vizi, tutti i delitti contro la natura. Perché solo reprimendo, ripudiando e impedendo l’appagamento del vero bisogno, può trovare appagamento il bisogno immaginario e fittizio.
Ma la soddisfazione del bisogno immaginario è il lusso, creato e mantenuto a spese del necessario e in netta antitesi con esso.
Il lusso è tanto insensibile, inumano, insaziabile e egoista quanto il bisogno che lo produce e non potrà mai essere appagato nemmeno da tutti gli accrescimenti e da tutte le offerte massime della sua natura. Questo bisogno infatti, essendo innaturale, non può mai essere soddisfatto perché, essendo qualcosa di falso, non esiste per esso un contrario vero e reale che possa assorbirlo, distruggerlo e quindi soddisfarlo.
La fame vera, quella materiale, ha il suo naturale contrario nella sazietà, che la distrugge mediante l’atto del mangiare; il bisogno inutile invece, il bisogno del lusso, è già esso stesso un lusso, un superfluo. L’errore che è alla sua radice non può risolversi nella verità. Esso tortura, consuma, brucia e tormenta, mai appagato, rende invano languenti lo spirito, il cuore, i sensi, divora ogni piacere, l’allegria e la gioia di vivere; per un unico, inaccessibile momento di gioia prostra l’attività della forza vitale di migliaia di poveri, senza riuscire a saziare la propria fame neppure per un istante; tiene un intero mondo nelle ferree catene del dispotismo senza riuscire a spezzare neppure per un istante le catene d’oro di quel tiranno che è esso stesso.
Ora questo demone, questo bisogno insensato senza bisogno, questo bisogno del bisogno, questo bisogno del lusso che è il lusso stesso, regge il mondo. È l’anima dell’industria che uccide l’uomo per usarne come di una macchina; l’anima del nostro Stato, che non riconosce all’uomo altra dignità se non quella di essergli suddito; l’anima della nostra scienza deista, che dà l’uomo in pasto a un dio immateriale che è la fonte di ogni lusso dello spirito. E purtroppo è anche l’anima, la condizione della nostra arte.
Chi potrà redimerci da questa infelice condizione? La necessità, che farà riprovare al mondo il bisogno vero, quello che per sua natura è reale e che al tempo stesso può anche essere appagato.
La necessità porrà fine all’inferno del lusso; essa insegnerà agli spiriti tormentati e senza bisogni che quest’inferno racchiude in sé il bisogno semplice e puro della fame e della sete fisiche, puramente umane. A tutti noi additerà il pane che nutre, l’acqua chiara e dolce della natura. Tutti insieme ne gioiremo veramente e tutti insieme saremo veri uomini. Ma tutti uniti proclameremo anche l’alleanza della sacra necessità, e il bacio fraterno che consacrerà quest’unione sarà l’opera d’arte comune dell’avvenire. In essa il nostro grande benefattore e redentore, colui che in carne ed ossa rappresenta la necessità, il popolo, non sarà più qualcosa di particolare, di differente giacché nell’opera d’arte saremo uniti, saremo coloro che recano e indicano la necessità, coloro che conoscono l’inconscio, che vogliono l’involontario; saremo i testimoni della natura, cioè uomini felici.
4. Il popolo, forza condizionatrice dell’opera d’arte
Tutto ciò che esiste dipende dalle condizioni nelle quali esiste. Nulla esiste isolatamente: né nella natura né nella vita. Ogni cosa ha il proprio fondamento in un rapporto infinito con il tutto, quindi anche con quel che è arbitrario, non necessario, nocivo. Il nocivo esercita la sua forza per impedire il necessario, anzi deve la sua forza, la sua esistenza solo a quest’impedimento, e pertanto altro non è che l’inerzia del necessario. Se quest’inerzia fosse continua, perpetua, l’ordine naturale del mondo dovrebbe essere altro da quel che è: l’arbitrario sarebbe il necessario, il necessario il non necessario. Ma quest’impotenza è provvisoria, quindi soltanto apparente, perché la forza del necessario vive e agisce anche come sostanzialmente unica condizione dell’esistenza dell’arbitrario. Così il lusso dei ricchi deve la sua esistenza soltanto alla miseria dei poveri; ed è proprio questa che offre al lusso dei ricchi sempre nuove cose da consumare in quanto, spinto dal bisogno di alimentare la propria forza vitale, il povero la sacrifica al ricco.
Non altrimenti la forza vitale, il bisogno di vivere della natura tellurica ha alimentato varie volte quelle forze nocive, o piuttosto le possibilità d’esistenza di quelle combinazioni e di quei prodotti elementari che le impediscono di manifestarsi realmente in proporzione alla sua forza vitale e alle sue possibilità. Causa di ciò è l’abbondanza che in realtà esiste, l’enorme eccesso di forza di produzione e di sostanza vitale, l’inesauribile fertilità della forza generatrice e della materia esistenti. Il bisogno della natura è quindi infinita varietà e complessità, e la natura riesce a soddisfarlo negando per così dire la sua forza all’esclusività, all’unità che precedentemente aveva alimentato abbondantemente; in altri termini, dissolvendo l’unità nella pluralità.
Quel che è esclusivo, isolato, egoista può solo prendere, mai donare: può farsi solo generare, ma di per sé è impotente, giacché per generare sono necessari l’“Io” e il “Tu”, il risolversi dell’egoismo nel comunismo. La forza generatrice più ricca sarà dunque nella più grande molteplicità; e quando la natura della terra ebbe soddisfatto se stessa alienandosi nella più varia molteplicità, raggiunse quello stato di sazietà, di autosoddisfazione, di autoappagamento che si manifesta nella sua presente armonia. Ora essa non opera più al livello di trasformazione in massa, totale: il suo periodo di rivoluzione è terminato; essa ora è ciò che può essere, il che vuol dire quello che poteva essere e doveva diventare fin dalle origini. Non deve più fornire la propria forza vitale all’impotenza di generare, ha creato in tutti i suoi vastissimi regni infiniti la molteplicità, il maschio e la femmina, ciò che si rinnova e si rigenera eternamente ed eternamente si completa; e in quest’infinito rapporto è diventata costante, è necessariamente diventata se stessa, quello che è.
Ora nella rappresentazione di questo grande processo evolutivo della natura nell’uomo stesso è compreso anche il genere umano dal momento della sua autoseparazione della natura. Questa medesima necessità è la forza motrice della grande rivoluzione del genere umano, il medesimo appagamento concluderà questa rivoluzione.
Questa forza motrice, la vera e propria forza vitale quale predomina nella necessità vitale, è però per sua natura inconscia, involontaria; e proprio dove è tale – nel popolo – è la vera sola determinazione. I nostri demagoghi, di conseguenza, cadono in un grande errore quando sostengono che il popolo dovrebbe anzitutto sapere quello che vuole – cioè quel che dovrebbe volere secondo loro – prima ancora di essere capace e autorizzato a volerlo. Da questo errore hanno origine tutte le deplorevoli mezze misure, tutta l’impotenza, tutta la vergognosa debolezza dei recenti moti avvenuti nel mondo.
Ciò che realmente si sa altro non è se non ciò che esiste realmente e materialmente, divenuto oggetto compreso, rappresentato mediante il pensiero. Il pensiero è arbitrario finché non riesce a rappresentarsi l’oggetto materialmente presente e quello assente o trascorso che sfugge ai sensi per mezzo d’un riconoscimento assoluto del suo rapporto necessario con l’oggetto stesso; perché la coscienza di questa rappresentazione è proprio il sapere razionale. Ma il sapere, più è veritiero, e più deve riconoscersi sinceramente come unico risultato del rapporto con ciò che, realmente compiuto e perfetto, è giunto alla conoscenza sensibile, e deve pertanto avocare a sé la condizione della possibilità di sapere in quanto è fondata sulla realtà.
Ma appena il pensiero, astraendo dalla realtà, vuole costruire la realtà futura, non potrà mai produrre il sapere, ma solo manifestarsi come illusione, che si distingue però profondamente dall’incoscienza: soltanto se può compenetrarsi in modo simpatico e senza riserve nella realtà, nel bisogno reale e concreto, esso può prendere parte all’attività dell’incoscienza e solo quel che è nato dal bisogno involontario e necessario, il fatto reale, concreto, può divenire l’oggetto che soddisfa il pensiero e il sapere; infatti il cammino dell’evoluzione umana va logicamente e naturalmente dall’incoscienza alla coscienza, dal non sapere al sapere, dal bisogno alla soddisfazione di esso, e non dalla soddisfazione al bisogno, almeno non al bisogno di cui tale soddisfazione era la fine.
Perciò gli inventori non siete voi intellettuali ma il popolo che la necessità costringe all’invenzione: tutte le grandi invenzioni sono opera del popolo, laddove le invenzioni dell’intelligenza sono soltanto gli sfruttamenti, le derivazioni o meglio le frantumazioni, le mutilazioni delle grandi scoperte del popolo. Non voi avete inventato la lingua, ma il popolo; voi avete solo saputo corromperne la naturale bellezza, infrangerne la forza, distruggerne l’intimo senso e indagare a fatica su quel che aveva perduto. Non siete stati voi a inventare la religione, ma il popolo; voi avete solo saputo sfigurarne l’intima espressione, fare un inferno del cielo che era in essa, trasformare in menzogna la verità in essa manifesta. Né siete gli inventori dello Stato, che pure è opera del popolo; voi vi siete limitati a deformare la naturale unione di esseri uniti da un comune bisogno in un’accozzaglia innaturale di esseri che hanno bisogni diversi. Di una benefica unione difensiva di tutti avete fatto una malefica salvaguardia per i privilegiati; della veste a morbide pieghe che avvinceva il corpo dell’umanità avete fatto una corazza di ferro rigida e imbottita, un pezzo decorativo per un museo d’armi.
Non siete voi che date da vivere al popolo ma è il popolo che lo dà a voi; non siete voi che fate meditare il popolo, ma lui che induce voi a farlo; non voi dovete quindi istruire il popolo, ma al contrario prender lezione da esso.
Per questo mi rivolgo a voi e non al popolo, giacché per il popolo bastano poche parole, e perfino l’appello: “Fai quel che devi!” è superfluo perché il suo dovere esso lo fa da sé. Invece mi rivolgo a voi nello spirito del popolo – necessariamente però nel vostro linguaggio –, a voi intelligenti e saggi per offrirvi con tutto il buon cuore del popolo la redenzione dalla vostra beatitudine egoistica riportandovi alle sorgenti pure della natura, all’abbraccio affettuoso del popolo: là dove io, artista, l’ho trovata, dove, dopo una lunga lotta tra l’intima speranza e l’esteriore disperazione, ho acquistato la fede salda nell’avvenire.
Il popolo compirà dunque la sua opera di redenzione bastando a se stesso e al tempo stesso riscattando i propri nemici. Il suo modo di procedere sarà l’immediatezza della natura: con la necessità dell’azione elementare spezzerà quel rapporto che unico costituisce le condizioni del dominio dell’antinatura. Finché queste condizioni esisteranno, finché i nemici del popolo attingeranno il loro succo vitale sprecando la forza del popolo, finché, impotenti come sono, consumeranno la facoltà generatrice del popolo, inutile alla loro esistenza egoista, ogni interpretazione, ogni creazione, ogni trasformazione, ogni miglioramento, ogni riforma (Chi dunque nutrirà meno speranza nel successo dei suoi sforzi riformistici di chi opera a questo scopo nel modo più onesto?) a una situazione del genere sarà solo un fatto arbitrario, inutile e vano. Ma il popolo ha solo bisogno di negare con l’azione quel che in realtà è niente, vale a dire è inutile, superfluo, vano; ha solo bisogno di sapere quel che non vuole, e questo gli insegna il suo slancio vitale istintivo; ha bisogno, con la forza della sua necessità, di rendere non esistente quanto da lui non voluto, di distruggere quel che è degno di essere distrutto. Solo in questo modo il qualcosa dell’auspicato avvenire gli si presenterà da sé.
Quando saranno abolite le condizioni che consentono agli inutili di rodere le midolla del necessario, si verranno a creare di per sé le condizioni che richiameranno alla vita il vero, l’eterno; quando saranno abolite le condizioni che lasciano sussistere il bisogno del lusso, s’imporranno di per se stesse le condizioni che potranno soddisfare il necessario bisogno dell’uomo con il più largo superfluo della natura e della facoltà umana di produrre nella maniera più vasta e quindi più conveniente. Quando saranno abolite le condizioni favorevoli al dominio della moda, allora subentreranno le condizioni di un’arte vera; come per il tocco di una bacchetta magica essa fiorirà, l’arte sublime e sacrosanta, testimone della più nobile umanità, nella stessa copia e perfezione della natura, quando dalla dolorosa gestazione degli elementi scaturirono le condizioni adatte alla sua armonica configurazione, quale noi oggi la conosciamo: e come questa felice armonia della natura, anche l’arte durerà e si conserverà, perenne generatrice, come la soddisfazione più pura e completa del bisogno più nobile e autentico dell’uomo perfetto, cioè dell’uomo che è quel che può essere secondo la sua natura e che per questo deve essere e sarà.
5. Conformazione sfavorevole all’arte della vita attuale sotto il dominio dell’astrazione e della moda
Il principio, il punto di partenza e la base di tutto quel che esiste ed è immaginabile è il vero essere concreto. L’inizio e la base del pensiero umano risiedono nella percezione che l’uomo ha del proprio bisogno di vivere come bisogno di vivere comune a tutta la sua specie, che è diversa dalla natura e da tutte le specie di esseri diversi dall’uomo che la natura comprende. Il pensiero è dunque la facoltà che ha l’uomo non solo di venire a contatto con il reale sensibile mediante le sue manifestazioni, ma di distinguerne la natura per concepirlo poi nella sua connessione e rappresentarlo. Il concetto di una cosa è l’immagine della sua vera natura rappresentata nel pensiero: la rappresentazione delle immagini di tutte le cose esistenti riconoscibili in un’immagine complessiva, in cui il pensiero si raffiguri l’essenza rappresentata nel concetto di tutte le realtà nella loro connessione, è l’opera dell’attività suprema dell’anima umana, cioè l’opera dello spirito. Ora, se in quest’immagine complessa l’uomo deve comprendere anche l’immagine, il concetto della propria essenza e se addirittura quest’essenza propria rappresentata è la forza artisticamente operante in tutta l’opera d’arte del pensiero, ne deriva che questa forza e la totalità di tutte le realtà da essa rappresentate provengono soltanto dall’uomo reale e materiale e quindi, in ultima analisi, dalla sua necessità vitale e dalla condizione reale e materiale della natura da cui tale necessità vitale è suscitata. Ma quando si abbandona questo concatenamento nel pensiero, quando questo, dopo una contemplazione di se stesso ripetuta due o tre volte, vuole concepire se stesso come proprio fondamento, nel quale lo spirito non vuol più comprendere se stesso come l’ultima e la più condizionata delle attività, ma, al contrario, come la prima e la più assoluta, e quindi come fondamento e causa prima della natura, in questo caso anche il legame della necessità vien meno, la volontà agisce all’impazzata e senza freno, senza limite, liberamente, come immaginano certi metafisici, e così, attraverso la fucina del pensiero, irrompe nel mondo della realtà come un’ondata di follia.
Se lo spirito ha creato la natura, se il pensiero ha prodotto la realtà, se il filosofo ha spodestato l’uomo, neppure la natura, la realtà e l’uomo son più necessari; la loro esistenza è superflua per non dire nociva: nulla infatti è più superfluo dell’imperfetto dal momento che esiste il perfetto. La natura, la realtà e gli uomini acquistano dunque un senso, una giustificazione della loro esistenza se lo spirito, lo spirito assoluto, ragione e causa di se stesso, e, per conseguenza, legge, si serve di loro secondo la sua libera volontà assoluta e sovrana. Se lo spirito in sé è la necessità, la vita è l’arbitrio, una fantastica farsa, un vano passatempo, un capriccio frivolo, un car tel est notre plaisir dello spirito. Quindi ogni virtù puramente umana, soprattutto l’amore, è qualcosa che si può interpretare come si vuole e negare all’occasione; quindi ogni bisogno puramente umano è lusso, anzi il lusso è il bisogno propriamente detto. Così la ricchezza della natura è il non necessario e i prodotti della cultura sono il necessario; la felicità degli uomini è cosa secondaria e lo Stato astratto la cosa principale; il popolo è la materia contingente, il principe e il privilegiato sono i necessari consumatori di questa materia.
Se prendiamo la fine per il principio, la soddisfazione per il bisogno, la sazietà per la fame, il movimento e il progresso saranno concepibili solo in un bisogno artificiale, in una fame artificialmente stimolata. E questa è in verità la regola di vita di tutta la nostra cultura di oggi: la sua espressione è la moda.
La moda è lo stimolante artificiale che suscita un bisogno innaturale, là dove il naturale è assente. Ma tutto quel che deriva da un bisogno vero è arbitrario, assoluto, tirannico. La moda è perciò la tirannia più inaudita, più insensata che mai sia scaturita dalla stoltezza dell’essere umano: essa esige dalla natura assoluta obbedienza, impone al vero bisogno la negazione assoluta di se stesso in favore d’un bisogno immaginario; costringe il senso della bellezza, connaturato con l’uomo, ad adorare il brutto; gli uccide la salute per dargli il gusto della malattia; gli spezza la forza e il vigore per fargli provare il piacere della sua debolezza. Dove regna la moda più ridicola, la natura deve passare per la cosa più ridicola; dove regna l’antinatura più criminale, le manifestazioni della natura devono apparire come il supremo delitto; dove la follia prende il posto della verità, questa deve essere ritenuta una follia.
La natura della moda è la monotonia più assoluta, il suo dio è un egoista senza senso e impotente; la sua attività è perciò il cambiamento arbitrario, il mutarsi non necessario, il tendere inquieto e confuso verso quanto è l’opposto della sua essenza, che è appunto la più assoluta monotonia. La sua forza è la forza dell’abitudine. Ora l’abitudine è il despota invincibile di tutti gli esseri deboli, vili, di quelli che realmente sono senza bisogni. L’abitudine è il comunismo dell’egoismo, il vincolo tenace dell’egoismo comune che non conosce necessità, e la sua manifestazione vitale artificiale è proprio quella della moda.
La moda non è dunque un prodotto artistico di per sé, ma solo una deduzione artificiale del suo contrario, che è la natura, della quale soltanto deve in fondo alimentarsi, come il lusso delle classi privilegiate si nutre a sua volta del desiderio che le classi inferiori, lavoratrici, hanno di soddisfare i bisogni della natura. Anche l’arbitrio della moda può dunque creare solo dalla vera natura: tutte le produzioni, i suoi arabeschi, i suoi ornamenti hanno il loro prototipo solo nella natura; alla stessa stregua del nostro pensiero astratto, anche nelle sue aberrazioni peggiori essa non può, in fin dei conti, inventare altro da quello che, secondo il suo carattere primitivo, esiste fisicamente e formalmente nella natura e nell’uomo. Ma il suo procedere è altezzoso e la separa arbitrariamente dalla natura: essa infatti ordina e comanda dove ogni cosa deve essere sottomessa e obbedire. Così nelle sue rappresentazioni può solo deformare la natura, non rappresentarla; può dedurre ma non inventare poiché in verità inventare non è altro che trovare, vale a dire l’atto di scoprire, di riconoscere la natura.
L’inventare della moda è perciò solo meccanico. Ma il meccanico differisce dall’artistico in quanto va di deduzione in deduzione, da un mezzo all’altro, per produrre sempre, alla fine, soltanto un mezzo: la macchina. L’artistico invece segue il cammino nettamente opposto: getta dietro di sé ogni mezzo, prescinde da ogni deduzione per mirare, con una soddisfazione pienamente cosciente del proprio bisogno, alla fonte di tutti i mezzi e di tutte le deduzioni, cioè alla natura.
La macchina è quindi il benefattore freddo e senza cuore di un’umanità avida di lusso, che con essa ha finalmente piegato e assoggettato a sé anche l’intelligenza umana; questa, infatti, distolta dallo sforzo artistico, dall’invenzione artistica, rinnegata, disorientata, ha finito con l’esaurirsi nelle raffinatezze meccaniche, nel “farsi uno” con la macchina invece che con la natura nell’opera d’arte.
Il bisogno della moda è quindi nettamente opposto a quello dell’arte perché il bisogno dell’arte non può sussistere dove la moda è il potere legislativo della vita. In verità anche l’opera di qualche artista ispirato del nostro tempo poté mirare a suscitare solo il bisogno necessario dal punto di vista e con i mezzi dell’arte: ma comunque ogni sforzo del genere deve essere considerato inutile e vano. Nulla, infatti, è più impossibile, per lo spirito, che suscitare un bisogno. L’uomo ha ovunque e rapidamente tutti i mezzi per rispondere al bisogno che realmente esiste, ma non possiede affatto la facoltà di produrlo quando la natura si rifiuta e non ne offre le condizioni. Ma se non esiste il bisogno dell’opera d’arte, l’opera d’arte è impossibile: solo l’avvenire potrà metterci in condizione di darle vita, qualora si verifichino le condizioni del suo prodursi dalla vita stessa.
Solo dalla vita può infatti nascere il bisogno dell’arte, solo da essa l’arte può trarre soggetti e forme; ma dove la vita prende forma dalla moda, l’arte non può creare nulla da essa. Lo spirito, separandosi erroneamente dalla necessità del naturale, esercita volontariamente – e nella vita cosiddetta comune anche involontariamente – la sua influenza deformante tanto sulla materia quanto sulla forma della vita. Ne risulta che esso, resosi infelice con tale separazione, quando sente l’esigenza d’un nutrimento vero e sano tratto dalla natura e brama riconciliarsi con essa, non è più capace di trovare la forma e il soggetto della sua soddisfazione nella vita reale e attuale. Se, in altri termini, nel suo sforzo verso la redenzione, lo spirito sente il desiderio di riconoscere la natura senza riserve, potrà riconciliarsi con essa solo nella più fedele rappresentazione di lei, nell’azione presente e sensibile dell’opera d’arte, e si convince così che tale riconciliazione non si può ottenere riconoscendo e rappresentando il presente sensibile, che è la vita deformata dalla moda. Senza volerlo quindi esso deve procedere arbitrariamente nel desiderio artistico di redenzione: deve cercare la natura, che gli si offrirà spontaneamente nella vita sana, là dove potrà osservarla meno deformata e infine con una deformazione minima.
Tuttavia dovunque e in ogni tempo l’uomo ha dato alla natura l’abito, se non proprio della moda, almeno del costume. Il costume più naturale, più semplice, più nobile e bello è in verità la minima deformazione della natura, anzi è la veste umana che più le si addice: l’imitazione, la rappresentazione di tale costume, senza il quale l’artista moderno non sarebbe affatto in grado di rappresentare la natura in rapporto alla vita di oggi, è tuttavia anch’esso un procedimento arbitrario dominato da una precisa intenzione. E ciò che così è stato creato e formato con il desiderio più onesto di cercare la natura, qualora lo si ponga dinanzi alla vita pubblica di oggi, appare o incomprensibile o come una nuova invenzione della moda.
In verità, di questo modo di tendere verso la natura, proprio della vita moderna e in contrasto con essa, siamo debitori alla maniera e al suo inquieto mutare. Ma, proprio nella maniera, l’essenza della moda continua a manifestarsi anche senza volerlo; senza la necessaria relazione con la vita penetra nell’arte con la stessa arbitrarietà con cui la moda è penetrata nella vita, si confonde con la moda e domina ogni corrente artistica con una potenza simile alla sua.
Accanto al lato serio la maniera, con necessità quasi pari, mostra il proprio lato ridicolo, e insieme con l’antichità, il Rinascimento, il Medioevo, il Rococò, si mescolano costumi e vesti di popoli selvaggi di paesi da poco scoperti, simili alla moda primitiva dei Cinesi e dei Giapponesi. Tutto ciò si avvicenda, più o meno, e s’impossessa, sotto forma di “maniera”, di tutti gli stili della nostra arte. Alla stessa stregua la capricciosa maniera del giorno offre la rappresentanza del fanatismo di certe sette religiose al mondo elegante che frequenta il teatro ed è indifferente in materia di religione; oppure l’ingenua semplicità dei contadini svevi al gusto corrotto e avido di lusso del nostro mondo alla moda; oppure le sofferenze del proletariato affamato agli dèi tutelari della nostra industria. E tutto ciò senza altri effetti che quelli dello stimolante inefficace d’una maniera mutevolissima.
Qui lo spirito, nel suo sforzo artistico di riunirsi con la natura nell’opera d’arte, si vede ridotto o a riporre ogni speranza nell’avvenire o a prostrarsi nella triste pratica della rassegnazione. Comprende che non può redimersi se non in un’opera d’arte presente, tangibile, e cioè in un presente che ha bisogno d’arte o meglio che esige e produce l’arte mediante la propria verità e bellezza naturale, e di conseguenza crede nell’avvenire, cioè crede nella forza della necessità, cui è riservata l’opera d’arte dell’avvenire.
Ma nei confronti del presente lo spirito rinuncia a veder apparire l’opera d’arte, che sarebbe al livello del presente stesso e del pubblico, ambedue dominati dalla moda. La grande opera d’arte totale che dovrà sintetizzare in sé tutti i generi artistici per sfruttare ciascuno di essi come semplice mezzo e annientarlo in vista del raggiungimento del risultato globale di tutti, cioè la rappresentazione assoluta, immediata della natura umana completa, questa grande opera di arte universale lo spirito non la riconosce come l’atto, volontariamente possibile, del singolo, ma come l’opera collettiva che si può supporre solo compiuta dagli uomini dell’avvenire.
Il desiderio, che sente di potere esser appagato solo nella comunità, rinuncia alla comunità moderna, aggregato di arbitrari egoismi, per appagarsi nella solitaria comunità di se stesso con l’umanità dell’avvenire, per quanto può fare un solitario.
6. Misura dell’opera d’arte dell’avvenire
Lo spirito solitario che tende con l’arte alla propria redenzione nella natura, non è in grado di creare l’opera d’arte dell’avvenire: vi può riuscire soltanto lo spirito collettivo appagato dalla vita. Ma esso se la può immaginare e può anche pensare che questa immaginazione sia una pura illusione; da ciò lo preserva il carattere del suo tendere, che è un tendere verso la natura. Lo spirito che brama il ritorno alla natura e che, di conseguenza, è insoddisfatto nel momento presente, trova non solo nella totalità della natura, ma anche nella natura umana, che si presenta alla sua mediazione attraverso la storia, quelle immagini che possono riconciliarlo con la vita in generale. Concepisce così tutto l’avvenire in base a un’immagine che questa natura gli offre: un’immagine già rappresentata, ma entro più angusti limiti. Il pensiero di estendere questi limiti è insito nelle facoltà immaginative del suo desiderio assetato di natura.
La storia presenta due momenti principali, nettamente distinti, dell’evoluzione dell’umanità: quello nazionale ed etnico e quello non nazionale ed universale. Oggi, mentre attendiamo dall’avvenire il compimento di questa seconda fase evolutiva, vediamo nettamente nel passato il compimento della prima. Abbiamo così davvero tutti i mezzi per apprendere con entusiasmo fino a quale culmine abbia potuto svilupparsi l’uomo sotto questo influsso plastico e quasi immediato della natura, quando si è abbandonato incoscientemente a tale influsso, secondo la sua provenienza etnica, la comunità linguistica e secondo le affinità del clima e delle condizioni naturali di un comune luogo d’origine.
Nei costumi naturali di tutti i popoli, nella misura in cui essi s’informano all’uomo morale, anche in quelli più disprezzati per la loro rudezza, ci è dato conoscere la verità della natura umana nella sua piena nobiltà e vera bellezza. Nessuna religione, qualunque essa sia, ha escluso dai comandamenti di Dio una virtù, sia pure una sola, che sia di per sé compresa nei costumi naturali; lo stato civile più recente non ha mai sviluppato una sola massima di diritto veramente umana che non abbia già ricevuto nella natura dell’uomo la sua espressione più sicura, anche se purtroppo l’ha completamente deformata; e anche la cultura moderna, con superba ingratitudine, non ha mai fatto sua un’invenzione di utilità veramente generale che non avesse derivato dall’opera della naturale intelligenza dei cultori di quei costumi.
Che l’arte non è un prodotto artificiale, che il bisogno dell’arte non è stato creato arbitrariamente, ma che è proprio, originario dell’uomo naturale, vero e non degenero, chi ce lo prova meglio di quegli stessi popoli? Donde il nostro spirito potrebbe trarre una prova migliore della sua necessità se non dalla percezione di questo impulso artistico e dei frutti magnifici da esso sorti presso quei popoli che si sono evoluti secondo natura e presso il popolo in generale? Davanti a quale manifestazione avvertiamo una sensazione più umiliante dell’incapacità della nostra frivola cultura se non davanti all’arte degli Elleni? Ad essa, a quest’arte dei beniamini della natura che tutto abbraccia col suo amore, degli uomini più belli che la feconda madre felice ci abbia offerto dalle epoche, che più lontane si perdono nella notte dei tempi, alla cultura d’oggi ispirata alla moda, alla testimonianza più eloquente di ciò che può realizzare lo spirito vittorioso, alla splendida arte greca rivolgiamo lo sguardo per dedurre dalla comprensione di essa quale dovrà essere l’arte dell’avvenire.
La natura ha fatto tutto quel che poteva fare: ha prodotto i Greci, li ha nutriti nel proprio seno, li ha formati secondo la sua saggezza materna, e sempre ce li presenta con orgoglio materno, e, con materno amore, grida a tutti gli uomini: “Ecco quel che ho fatto per voi: ora voi fate quel che potete per amor vostro!”.
Dobbiamo dunque fare dell’arte ellenica l’arte umana in assoluto, dobbiamo liberarla da quelle condizioni sotto le quali essa fu solo arte ellenica e non arte umana universale; la veste religiosa, nella quale fu soltanto un’arte ellenica collettiva e deposta la quale non poté più rispondere al bisogno dell’universalità, in quanto genere d’arte egoista e particolare, ma solo al bisogno di lusso, anche se si trattava di un bel lusso – questa veste religiosa specificamente greca bisogna trasformarla nel vincolo della religione dell’avvenire, quello della universalità, per poterci fare già fin d’ora un’idea esatta dell’opera d’arte dell’avvenire.
Ma nel nostro stato presente di infelicità non possiamo stabilire questo vincolo, questa religione dell’avvenire, perché, pur essendo in gran numero ad avvertire il desiderio dell’opera d’arte dell’avvenire, siamo sempre degli isolati, dei solitari.
L’opera d’arte è la rappresentazione vivente della religione; ma le religioni non le inventa l’artista: esse si originano solo dal popolo.
Contentiamoci dunque per ora, senza alcuna vanità egoistica, senza volere cercare soddisfazione in qualche illusione dettata dall’egoismo, ma sinceramente e con dedizione amorosa alla speranza nell’opera d’arte dell’avvenire, contentiamoci di esaminare anzitutto l’essenza dei generi artistici che oggi, nel loro isolamento, costituiscono la comune essenza dell’arte del presente; ristoriamo il nostro sguardo, per quest’esame, con l’arte dei Greci e tiriamo le somme audacemente e con fiducia per giungere a una conclusione sulla grande e universale opera d’arte dell’avvenire. [...]
[4 novembre 1849]