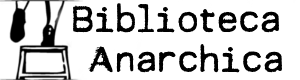Per eventuali feedback, confronti o modifiche:
taro@anche.no
madkid000@yahoo.com
Peter Gelderloos
Come la nonviolenza protegge lo stato
“E dicono che la bellezza sia nelle strade, ma quando mi guardo intorno sembra più una sconfitta”.
— Defiance, Ohio
Questo libro è dedicato a Sue Daniels (1960-2004), brillante ecologista, audace femminista, anarchica, e bellissimo e premuroso essere umano che ha cresciuto e sfidato tuttɜ coloro intorno a lei. Il suo coraggio e la sua saggezza continuano ad ispirarmi, e in questo modo il suo spirito rimane indomabile...
... e a Greg Michael (1961-2006), che ha incarnato la salute, intesa come interezza dell’essere e come instancabile ricerca contro i veleni del nostro mondo, anche nelle circostanze più malsane. Da un sacchetto di uvetta rubato dalla cucina della prigione al dispiegarsi della memoria sulla cima di una montagna, i doni che mi avete fatto sono un sollievo e un’arma, e resteranno con me finché l’ultima prigione non sarà un cumulo di macerie.
Un ringraziamento speciale a Megan, Patrick, Carl, Gopal e Sue D. per aver corretto le bozze e per avermi dato un feedback, e a Sue F., James, Iris, Marc, Edi, Alexander, Jessica, Esther e a tuttɜ coloro che sono venutɜ ai workshop per le preziose critiche che hanno dato vita a questa seconda edizione.
*****
Introduzione della versione italiana
Dopo 16 anni dalla sua pubblicazione siamo felici di poter divulgare la versione italiana di un libro che ha rappresentato, e continua a rappresentare, uno dei testi più intensi, completi e dettagliati sul dibattito violenza/nonviolenza. Un libro che crediamo che tutti i movimenti debbano dibattere: da quello per la liberazione animale a quello transfemminista, a quello per il clima e la liberazione della terra.
Ciò che vorremmo anticiparvi è che la critica del libro di Gelderloos non è rivolta alla nonviolenza di per sé. Crediamo che l’autodeterminazione sia essenziale e che la scelta individuale di scegliere una tattica anziché un’altra non sia opinabile; ogni persona ha una propria vita, un proprio background, delle proprie paure e corre dei propri rischi. Ogni persona è unica. Quella che noi (incluso Gelderloos) critichiamo è la versione patologica e dogmatica della nonviolenza. Ma cosa intendiamo con “versione patologica”? Con questo termine ci riferiamo a quel tipo di dialettica che si ostina a dipingere la nonviolenza come l’unico metodo – o quello più efficace – per raggiungere un obiettivo, indipendentemente dalla situazione. Significa adottare un atteggiamento che tenda ad ignorare e/o a dimenticare le vittorie e le sconfitte nella storia dei movimenti di liberazione; significa mistificare ed idolatrare esponenti nonviolenti come Martin Luther King, spesso citato eliminando le parti più radicali di molti dei suoi discorsi così da far emergere solo una parte di essi, quella più pacifista; significa definirsi “nonviolentɜ” come se questa fosse un’identità, un modo dogmatico di vedere quella che non è altro che una tattica; ed infine significa osteggiare ed emarginare coloro che non si conformano al dogma.
D’altra parte ci teniamo a chiarire che la nostra non è un’apologia alla violenza (a patto di riuscire davvero a definire cosa sia la violenza). Noi sosteniamo un approccio pluralistico e diversificato, una pluralità di tattiche che vadano scelte in base alla situazione in maniera strategica, sfruttando mezzi che siano coerenti con i fini, e non in maniera dogmatica ed autoritaria. Potremmo semplicemente asserire di essere contro il dogmatismo della nonviolenza e contro le falsità storiche divulgate da chi la supporta. La resistenza armata (quella che da alcune persone potrebbe essere definita come “violenta”) è stata – e rimane – un mezzo di liberazione per molte classi oppresse, l’unico mezzo che è stato in grado di far sentire minacciati gli oppressori, qualunque forma essi abbiano preso nella storia.
In questo libro troverete citazioni a dossier federali, articoli, interviste, saggi politici ma soprattutto leggerete una peculiare analisi dei movimenti di liberazione, anche nelle sue sfaccettature nonviolente. Di fatti Gelderloos, seppur mantenendo la sua ferma posizione in merito, riesce ad esaminare ogni aspetto della lotta in modo lucido e non di parte.
Con questa traduzione speriamo di dare il nostro contributo per ricollocare il ruolo che la resistenza “violenta” ha avuto (e continua ad avere) per le classi oppresse e smontare il pensiero infondato secondo cui possa esistere una tattica unica, che questa sia la violenza o la nonviolenza.
Ci auspichiamo di aprire un dibattito costruttivo e critico, ma che sarà difficilmente realizzabile se l’individuo non è disposto a mettersi in discussione. L’autocritica rimane indubbiamente la chiave per sviluppare dibattiti sani che vadano a costruire e non a distruggere.
Per finire, ci teniamo a fare un paio di precisazioni sull’autore e sul testo, che per forze linguistiche differisce dall’originale:
-
Innanzitutto, nel corso degli anni, l’autore ha pubblicato due testi non costruttivi contro il veganismo e le persone vegane. Noi prendiamo le distanze da queste posizioni che riteniamo superficiali ed infondate, riconoscendo comunque il grande lavoro relativo alla nonviolenza che Gelderloos ha portato avanti in questo tempo;
-
al fine di ottenere un tipo di linguaggio più inclusivo è stato deciso di adottare l’utilizzo della schwa, sia nella versione singolare (ə) che in quella plurale (ɜ). Dove impossibilitatɜ a neutralizzare il genere negli aggettivi plurali, li abbiamo coniugati al femminile (es. sostenitori diventa sostenitrici; anarchici diventa anarchichɜ). Tuttavia, in varie parti del testo abbiamo ritenuto fosse meglio lasciare il plurale maschile per evidenziare la predominanza di uomini cis in un determinato gruppo storico (es. soldati nazisti);
-
il termine people of color è stato sostituito dal termine persone razzializzate, in modo da non dimenticarci l’origine esterna del razzismo;
-
non è stato possibile trovare la traduzione italiana per ogni risorsa riportata a piè di pagina, per cui molte fonti sono rimaste in lingua originale;
-
alcuni link a siti web potrebbero non essere più attivi;
-
la parola “stato” (intesa come istituzione) è stata lasciata in minuscolo spontaneamente, così, come beffa.
Introduzione
Nell’agosto del 2004, alla Conferenza Anarchica Nordamericana, in Athens, nell’Ohio, ho partecipato ad un confronto sul tema “nonviolenza contro violenza”. Come da previsione, la discussione si è trasformata in un dibattito improduttivo e competitivo. Avevo sperato che a ciascuna persona fosse concessa una quantità di tempo consistente per parlare, al fine di presentare le nostre idee in modo approfondito e limitare una raffica di argomentazioni banali. Ma il facilitatore, che era anche un organizzatore della conferenza – e per di più un relatore –, ha deciso di non adottare questo approccio.
A causa dell’egemonia che lɜ sostenitrici della nonviolenza esercitano, le critiche alla nonviolenza sono escluse dai principali quotidiani, dai media alternativi e da altri forum a cui accedono individualità anti-autoritarie.[1]
La nonviolenza è mantenuta come dogma e come requisito per una completa inclusione nel movimento. Anti-autoritariɜ ed anti-capitalistɜ che suggeriscono una militanza diretta si ritrovano improvvisamente abbandonatɜ dallɜ stessɜ pacifistɜ con cui hanno protestato fino a poco prima. Una volta isolate, queste persone perdono accesso alle risorse e alla protezione dall’essere usate come capro espiatorio dai media o dalla criminalizzazione da parte del governo.
All’interno di queste dinamiche causate dall’isolamento istintivo di coloro che non si conformano alla nonviolenza, non c’è possibilità di un discorso sano e critico per valutare le strategie scelte.
In base alla mia esperienza, la maggior parte delle persone che vengono coinvolte nei movimenti radicali non hanno mai sentito argomentazioni positive – o persino negative – contro la nonviolenza. E questo succede anche nei casi in cui conoscono già bene altre questioni legate al movimento. Invece, tendono a conoscere l’aura di tabù che avvolge lɜ militanti, ad interiorizzare la paura e il disprezzo che i media corporativi riservano a chi vuole lottare davvero contro il capitalismo e lo stato, e a confondere l’isolamento imposto allɜ militanti con una sorta di isolamento autoimposto che deve essere insito nella militanza.
Moltɜ di coloro con cui ho discusso questioni simili e che sostengono la nonviolenza – e si parla di tante persone – si approcciavano alla conversazione come se fosse ovvio il fatto che l’utilizzo della violenza nei movimenti sociali fosse sia sbagliata che autodistruttiva (perlomeno finché questa si verificasse lontano da loro). Al contrario, ci sono molti solidi argomenti contro la nonviolenza a cui pacifistɜ non sono ancora riuscitɜ a controbattere.
In questo libro mostrerò come la nonviolenza, nella sua attuale manifestazione, sia basata su racconti storici distorti ed alterati. Il testo ha connessioni implicite ed esplicite con le manipolazioni delle persone bianche sulle lotte delle persone razzializzate. I metodi della nonviolenza sono incartati in dinamiche autoritarie, e i suoi risultati sono imbrigliati sul raggiungimento di obiettivi governativi a scapito di quelli popolari. Questa modalità maschera e addirittura incoraggia assunti e dinamiche di potere patriarcali. Le opzioni strategiche della nonviolenza conducono invariabilmente a vicoli ciechi. E lɜ praticanti di questa si illudono su una serie di punti chiave.
Date queste conclusioni, se i nostri movimenti vogliono avere qualche possibilità di distruggere sistemi oppressivi come il capitalismo, la supremazia bianca e costruire un mondo libero e sano, dobbiamo divulgare queste critiche e porre fine alla morsa della nonviolenza, sviluppando al contempo forme di lotta più efficaci.
Potremmo dire che lo scopo di una conversazione sia quello di convincere ed essere convintɜ, mentre lo scopo di un dibattito sia quello di vincere, e quindi silenziare l’altrə. Uno dei primi passi per il successo in qualsiasi dibattito è controllare la terminologia per avvantaggiarsi e mettere lɜ propriɜ avversariɜ in una posizione di svantaggio. Questo è esattamente quello che lɜ pacifistɜ hanno fatto presentando il discorso nonviolenza contro violenza. Tipicamente, chi sostiene la nonviolenza usa questa dicotomia con la quale la maggior parte di noi non è d’accordo, e spinge per espandere i confini della nonviolenza in modo che le tattiche che noi sosteniamo – come la distruzione della proprietà – possano essere accettate all’interno di un quadro nonviolento, evidenziando quanto noi siamo depotenziatɜ e delegittimatɜ.
Non conosco nessunə attivista, rivoluzionariə o teoricə, che sostiene solo l’uso di tattiche violente e che si oppone a qualsiasi uso di tattiche che non possano essere definite violente.
Noi sosteniamo una diversità di tattiche, ovvero combinazioni efficaci derivanti da un’intera gamma di tattiche che potrebbero portare alla liberazione da tutte le componenti di questo sistema oppressivo: la supremazia bianca, il patriarcato, il capitalismo e lo stato. Crediamo che le tattiche debbano essere scelte in base alla situazione specifica, e non basarsi su un codice morale predefinito. Pensiamo anche che i mezzi si riflettano nei fini, e non vorremmo utilizzare mezzi che possano portarci alla dittatura o a qualche altra forma di società che non rispetti la vita e la libertà. In questo senso, possiamo essere descrittɜ più accuratamente come sostenitrici di un attivismo rivoluzionario o militante piuttosto che come sostenitrici della violenza.[2]
Mi riferirò allɜ sostenitrici della nonviolenza con il termine che loro stessɜ hanno scelto di utilizzare: come attivistɜ nonviolentɜ o, in modo intercambiabile, pacifistɜ. Moltɜ praticanti preferiscono un termine o l’altro, e alcunɜ fanno addirittura una distinzione tra i due, ma nella mia esperienza le distinzioni non sono coerenti tra una persona e l’altra. Soprattutto, lɜ stessɜ pacifistɜ/attivistɜ nonviolentɜ tendono a collaborare indipendentemente dal termine scelto, quindi la differenza di etichette non è importante per le considerazioni di questo libro. In generale, utilizzando il termine pacifismo o nonviolenza, essɜ designano uno stile di vita o un metodo di attivismo sociale che evita, trasforma o esclude la violenza, cercando di cambiare la società per creare un mondo più pacifico e libero.
A questo punto potrebbe essere utile definire chiaramente la violenza, ma uno degli argomenti fondamentali di questo libro è proprio che la violenza non può essere definita in modo chiaro. Dovrei anche chiarire alcuni altri termini che compaiono di frequente. Uso la parola radicale nel uso senso letterale, per indicare una critica, un’azione o una persona che vanno alle radici di un particolare problema piuttosto che concentrarsi sulle soluzioni superficiali messe in tavola dai pregiudizi e dai poteri del momento. Questa parola non è sinonimo di estremo o di estremista, anche se i media vorrebbero farcelo credere. (Analogamente, nel caso in cui a qualcunə non fosse ancora chiaro: un’anarchicə non è qualcunə che favorisce il caos ma qualcunə che sostiene la liberazione totale del mondo attraverso l’abolizione del capitalismo, del governo e di tutte le altre forme di autorità oppressiva, da sostituire con qualsiasi altro sistema sociale, collaudato o utopico). D’altra parte, non uso la parola rivoluzione per intendere il rovesciamento degli attuali governanti da parte di un nuovo gruppo di governanti (il che renderebbe la rivoluzione anti-autoritaria un ossimoro), ma solo per indicare uno sconvolgimento sociale con effetti trasformativi estesi.
Per ribadire una distinzione cruciale: le critiche di questo libro non sono rivolte ad azioni che non esprimono un comportamento violento – come una veglia che rimane pacifica – né sono rivolte a singolɜ attivistɜ che scelgono di dedicarsi a un lavoro non combattivo, come la costruzione di forti relazioni comunitarie. Quando parlo di pacifistɜ e sostenitrici della nonviolenza, mi riferisco a coloro che vorrebbero imporre la loro ideologia all’intero movimento e dissuadere altrɜ attivistɜ dalla militanza (e dall’uso della violenza), o che non sosterrebbero altrɜ attivistɜ per le loro azioni militanti. Similmente, un’ideale attivista rivoluzionariə non sarebbe unə dedicatə ossessivamente alla lotta contro gli sbirri, o su atti illeciti di sabotaggio, ma unə che almeno abbracci e sostenga queste azioni – dove efficaci – come parte dell’ampia gamma di azioni necessarie a rovesciare lo stato e a costruire un mondo migliore.
Pur concentrandomi sullo smascheramento del pacifismo al servizio di obiettivi rivoluzionari, in questo libro includo citazioni di pacifistɜ che lavorano o hanno lavorato per riforme limitate, oltre che citazioni di persone che militano per la trasformazione totale della società. In un primo momento potrebbe sembrare che io stia costruendo un’argomentazione fittizia;
Tuttavia, includo le parole o le azioni di pacifistɜ riformistɜ solo in riferimento a campagne in cui hanno lavorato a stretto contatto con pacifistɜ rivoluzionariɜ e in cui il materiale citato abbia rilevanza per tutti i soggetti coinvolti, oppure in riferimento a lotte sociali citate come esempi per dimostrare l’efficacia della nonviolenza per raggiungere obiettivi rivoluzionari. È difficile distinguere tra pacifistɜ rivoluzionariɜ e non rivoluzionariɜ, perché loro stessɜ tendono a non fare questa distinzione. Lavorano insieme, partecipano insieme alle proteste e spesso usano le stesse tattiche nelle stesse azioni. Poiché l’impegno condiviso per la nonviolenza (e non per un obiettivo rivoluzionario) rappresenta il criterio principale per lɜ attivistɜ nonviolentɜ nel decidere con chi lavorare, questi sono i confini che utilizzerò per definire queste critiche.
La nonviolenza è inefficace
Potrei spendere molto tempo parlando di come la nonviolenza sia fallimentare. Tuttavia, potrebbe essere più utile parlare dei successi della nonviolenza. Il pacifismo sarebbe difficilmente attraente a coloro che lo sostengono se l’ideologia non avesse prodotto vittorie storiche. Esempi tipici sono l’indipendenza dell’India dal dominio coloniale britannico, i limiti alla corsa agli armamenti nucleari, il movimento per i diritti civili degli anni ’60 e il movimento per la pace durante la guerra contro il Vietnam[3]. E anche se non sono state acclamate come una vittoria, le massicce proteste del 2003 contro l’invasione statunitense in Iraq furono molto apprezzate dallɜ attivistɜ nonviolentɜ.[4]
C’è un modello di manipolazione storica e di supremazia bianca evidente in ogni singola vittoria rivendicata da attivistɜ nonviolentɜ. La posizione pacifista pretende che il successo di una lotta sia attribuito alle sole tattiche pacifiste, mentre il resto di noi crede che il cambiamento derivi dall’intero spettro di tattiche presenti in ogni situazione rivoluzionaria, a condizione che siano impiegate in modo efficace. Nessun grande conflitto sociale presenta un’omogeneità di tattiche e ideologie, tutti i conflitti presentano tattiche pacifiste e tattiche decisamente non pacifiste, ma lɜ pacifistɜ devono cancellare la storia che non è d’accordo con loro o, in alternativa, attribuire i loro fallimenti alla presenza contemporanea della lotta violenta.[5]
In India, si racconta, la gente sotto la guida di Gandhi costruì un massiccio movimento nonviolento per decenni e si impegnò in azioni di protesta, non-cooperazione, boicottaggio economico e nonviolento, scioperi della fame e atti di disobbedienza civile per rendere impraticabile l’imperialismo britannico. Essɜ subirono massacri e risposero con alcune rivolte, ma nel complesso il movimento fu nonviolento e, dopo decenni di perseveranza, il popolo indiano ottenne l’indipendenza, dando un innegabile segno di vittoria pacifista. La storia reale è più complicata, in quanto la decisione britannica di ritirarsi venne influenzata da molte pressioni. Gli inglesi persero la capacità di mantenere il potere coloniale dopo aver perso milioni di soldati e molte altre risorse durante due guerre mondiali estremamente violente, la seconda delle quali aveva particolarmente devastato la “madrepatria”. Le lotte armate dellɜ militanti arabɜ ed ebreɜ in Palestina, dal 1945 al 1948, indebolirono ulteriormente l’impero britannico e rappresentarono una chiara minaccia dato che la popolazione indiana, se ignorata per un periodo sufficientemente lungo, avrebbe potuto abbandonare la disobbedienza civile ed imbracciare le armi. Non si può escludere che questo sia stato un fattore chiave nella decisione dei britannici di abbandonare l’amministrazione coloniale diretta.
Ci rendiamo conto che questa minaccia fosse ancora più concreta quando comprendiamo che la storia pacifista del movimento per l’indipendenza dell’India sia stata un’immagine selettiva e incompleta: la nonviolenza non era universale in India. La resistenza al colonialismo britannico comprese una militanza tale da far sì che il metodo gandhiano possa essere visto più accuratamente come una delle numerose forme di resistenza popolare. Come parte di un modello inquietamente universale, lɜ pacifistɜ cancellano queste altre forme di resistenza e contribuiscono a diffondere la falsa storia secondo cui Gandhi e lɜ suɜ discepolɜ sarebbero statɜ l’unica forma di resistenza. Vengono ignoratɜ importanti leader militanti come Chandrasekhar Azad,[6] che combattè la lotta armata contro i colonizzatori britannici, e altri rivoluzionari come Bhagat Singh, che ottenne un sostegno di massa per bombardamenti e assassinii come parte di una lotta per realizzare il “rovesciamento capitalista straniero e indiano”.[7] La storia pacifista della lotta indiana non riesce a dare un senso al fatto che Subhas Chandra Bose, il candidato militante, sia stato eletto per due volte presidente del Congresso Nazionale Indiano nel 1938 e nel 1939.[8] Se Gandhi fu forse la figura più influente e popolare nella lotta per l’indipendenza dell’India, la posizione di leadership che assunse non godè sempre del sostegno costante delle masse. Gandhi perse tanto sostegno da parte dellɜ indianɜ quando “abbandonò il movimento” dopo la rivolta del 1922, tanto che quando i britannici lo rinchiusero in seguito, “non si levò in India un’ondata di protesta per il suo arresto”[9]. È significativo il fatto che la storia ricordi Gandhi più dei rivoluzionari sopracitati non perché egli rappresentasse la voce unanime dell’India, ma per tutta l’attenzione che gli fu riservata dalla stampa britannica, oltre che per essere incluso in importanti trattative con il governo coloniale britannico. Quando ci ricordiamo che “la storia è scritta dai vincitori”, sveliamo un altro strato del mito dell’indipendenza indiana.
L’aspetto più doloroso nel sentire l’affermazione da parte di pacifistɜ secondo cui l’indipendenza dell’India sia stata una vittoria raggiunta grazie alla nonviolenza, è il fatto che questa affermazione si inserisce direttamente nella montatura storica realizzata nell’interesse degli stati imperialisti e suprematisti bianchi che hanno colonizzato il Sud globale. Il movimento di liberazione in India è fallito. Gli inglesi non furono costretti a lasciare l’India. Piuttosto, gli inglesi scelsero di spostare un dominio coloniale diretto ad uno neo-coloniale.[10] Che tipo di vittoria permette alla parte perdente di dettare i tempi e i modi dell’ascesa dei vincitori? Gli inglesi redassero la nuova costituzione e affidarono il potere a successori scelti a mano. Alimentarono le fiamme del separatismo etnico, in modo da dividere l’India ed impedendole di raggiungere la pace e la prosperità, facendola dipendere dagli aiuti militari e da altre forme di sostegno da parte degli stati europei/americani. L’India è ancora sfruttata dalle multinazionali euro-americane (anche se diverse nuove multinazionali indiane, per lo più filiali, si sono unite alla depredazione), e fornisce ancora risorse e mercati agli stati imperialisti.[11] Per molti versi la povertà del suo popolo si è aggravata e lo sfruttamento è diventato più efficiente. L’indipendenza dal dominio coloniale ha dato all’India una maggiore autonomia in alcuni settori e ha certamente permesso a una manciata di indianɜ di sedere nei posti di potere, ma lo sfruttamento e la mercificazione dei beni comuni sono aumentati. Inoltre, l’India ha perso una chiara opportunità per una significativa liberazione da un oppressore straniero facilmente riconoscibile. Adesso, qualsiasi movimento di liberazione dovrebbe scontrarsi con le dinamiche confuse del nazionalismo e delle rivalità etnico-religiose per abolire un capitalismo e un governo molto più sviluppati. A conti fatti, il movimento indipendentista si è dimostrato un fallimento.
Ugualmente, la pretesa di una vittoria pacifista per porre fine alla corsa agli armamenti nucleari è alquanto bizzarra. Anche in questo caso, il movimento non fu esclusivamente nonviolento. Comprese anche gruppi che effettuarono una serie di bombardamenti e altri atti di sabotaggio o guerriglia.[12] E, ancora una volta, la vittoria è dubbia. I tanto ignorati trattati di non proliferazione arrivarono solo dopo che la corsa agli armamenti era già stata vinta, con gli Stati Uniti – indiscusso egemone nucleare – in possesso di un numero di armi nucleari superiore a quanto fosse pratico o utile. E sembra chiaro che la proliferazione continua come previsto, attualmente sotto forma di sviluppo di armi nucleari tattiche e di una nuova ondata di proposte di impianti nucleari. In realtà, l’intera questione sembra essersi chiusa più come una questione di politica interna al governo che come un conflitto tra un movimento sociale e un governo. Chernobyl e diversi disastri sfiorati negli Stati Uniti hanno dimostrato che l’energia nucleare (una componente necessaria per lo sviluppo di armi nucleari) è una sorta di responsabilità, e non ci vuole un’attivista per contestare l’utilità, anche per un governo votato alla conquista del mondo, di dirottare ingenti risorse verso la proliferazione nucleare quando si hanno già abbastanza bombe per far saltare in aria l’intero pianeta, e quando ogni singola guerra e azione segreta dal 1945 è stata combattuta con altre tecnologie.
Il movimento per i diritti civili degli Stati Uniti è uno degli episodi più importanti della storia pacifista. In tutto il mondo, la gente lo vede come un esempio di vittoria nonviolenta. Ma, come gli altri esempi qui discussi, non fu né una vittoria né tanto meno una vittoria nonviolenta. Il movimento ebbe successo nel porre fine alla segregazione giuridica e nell’espandere la piccola borghesia nera, ma queste non erano le uniche richieste della maggioranza dellɜ partecipanti al movimento.[13] Volevano la piena uguaglianza politica ed economica, e moltɜ volevano anche la liberazione sotto forma di nazionalismo nero, inter-comunalismo nero o altre forme di indipendenza dall’imperialismo bianco. Nessuna di queste richieste fu soddisfatta: né l’uguaglianza, né certamente la liberazione. Le persone razzializzate hanno ancora un reddito medio più basso, un accesso più limitato alla casa e all’assistenza sanitaria, e una salute peggiore rispetto alle persone bianche. Esiste ancora una separazione,[14] e manca di fatto anche l’uguaglianza politica.
Milioni di votanti, la maggior parte dellɜ quali nerɜ, vengono privatɜ del diritto di voto quando è conveniente per gli interessi dei governanti, e solo quattro senatori neri sono stati in carica dall’era della Ricostruzione.[15] Anche altre etnie sono state escluse dai mitici frutti dei diritti civili. Lɜ immigratɜ latinɜ e asiatichɜ sono particolarmente vulnerabili agli abusi, alle deportazioni, alla negazione dei servizi sociali per i quali pagano le tasse, al lavoro tossico e massacrante nelle fabbriche o come braccianti agricolɜ. La repressione dopo l’11 settembre ha colpito soprattutto musulmanɜ ed arabɜ. Le popolazioni native sono tenute così in basso nella scala socioeconomica da rimanere invisibili, tranne che per le occasionali manifestazioni simboliche del multiculturalismo statunitense – come la mascotte sportiva stereotipata o la bambola hula-girl – che oscurano la realtà delle persone indigene.
La proiezione comune (soprattutto da parte di progressistɜ bianchɜ, pacifistɜ, educatrici, storichɜ e funzionarɜ governativɜ) è che il movimento contro l’oppressione razziale negli Stati Uniti sia stato principalmente nonviolento. Al contrario, sebbene gruppi pacifisti come la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) di Martin Luther King Jr. avessero un potere e un’influenza considerevoli, il sostegno popolare all’interno del movimento, soprattutto tra nerɜ poverɜ, gravitò sempre più verso gruppi rivoluzionari come il Black Panther Party.[16] Secondo un sondaggio di Harris del 1970, il 66% dellɜ afroamericanɜ affermava che le attività del Black Panther Party davano loro orgoglio e il 43% affermava che il partito rappresentava il loro pensiero.[17] In realtà, la lotta militante è stata a lungo parte della resistenza nera alla supremazia bianca. Mumia Abu-Jamal documenta coraggiosamente questa storia nel suo libro del 2004, Vogliamo la libertà. Scrive: “Le radici della resistenza armata affondano nella storia afroamericana. Solo coloro che ignorano questo fatto vedono il Black Panther Party come estraneo alla nostra comune eredità storica”.[18] In realtà, i segmenti nonviolenti non possono essere distillati e separati dalle parti rivoluzionarie del movimento (anche se spesso tra loro c’era alienazione e cattivo sangue incoraggiato dallo stato). La classe media nera pacifista, incluso King, ottenne molto del suo potere dallo spettro della resistenza nera e dalla presenza della rivoluzione nera armata.[19]
Nella primavera del 1963, la campagna di Birmingham di Martin Luther King Jr. sembrò destinata a ripetere il fallimento dell’azione di Albany, in Georgia (dove nel 1961 una campagna di disobbedienza civile durata 9 mesi dimostrò l’impotenza dellɜ manifestanti nonviolentɜ nei confronti di un governo con carceri apparentemente senza fondo e dove, il 24 luglio 1962, lɜ giovani in rivolta occuparono interi isolati per una notte e costrinsero la polizia a ritirarsi dal ghetto, dimostrando che un anno dopo la campagna nonviolenta, lɜ nerɜ di Albany lottavano ancora contro il razzismo, ma avevano abbandonato la pratica nonviolenta). Poi, il 7 maggio a Birmingham, dopo le continue violenze della polizia, tremila nerɜ iniziarono a insorgere colpendo la polizia con sassi e bottiglie. Solo due giorni dopo, Birmingham, fino ad allora un bastione inflessibile della segregazione, accettò di desegregare i negozi del centro, e il presidente Kennedy appoggiò l’accordo con garanzie federali. Il giorno dopo, dopo che lɜ suprematistɜ bianchɜ locali bombardarono una casa e un’attività commerciale di nerɜ, migliaia di persone nerɜ si ribellarono di nuovo: occupando un’area di 9 isolati, distruggendo le auto della polizia, ferendo diversi sbirri (tra cui l’ispettore capo) e bruciando le attività commerciali dellɜ bianchɜ. Un mese e un giorno dopo, il presidente Kennedy chiedeva al Congresso di approvare il Civil Rights Act, ponendo fine a diversi anni di strategia per bloccare il movimento per i diritti civili.[20] Forse una delle più limitate, se non vana, vittoria del movimento per i diritti civili arrivò quando lɜ nerɜ dimostrarono che non sarebbero rimastɜ pacifichɜ per sempre. Di fronte alle due alternative, la struttura del potere bianco scelse di negoziare con lɜ pacifistɜ, e ne abbiamo visto i risultati.
L’affermazione secondo cui il movimento pacifista statunitense abbia fermato la guerra contro il Vietnam contiene la classica serie di anomalie. La critica è già stata fatta da Ward Churchill e altrɜ,[21] quindi mi limiterò a riassumere il tutto. Con imperdonabile moralismo, lɜ pacifistɜ ignorano che dai tre ai cinque milioni di vietnamitɜ morirono nella lotta contro l’esercito statunitense, che decine di migliaia di truppe statunitensi vennero uccise e centinaia di migliaia furono ferite. Altre truppe, demoralizzate da tutto lo spargimento di sangue, diventarono altamente inefficaci e ribelli.[22] Gli Stati Uniti stavano perdendo capitale politico (e stavano andando in bancarotta fiscale) a tal punto che i politici favorevoli alla guerra cominciarono a chiedere un ritiro strategico (soprattutto dopo che l’offensiva del Tet dimostrò che la guerra era “invincibile”, secondo le parole di molti dell’epoca). Il governo statunitense non fu costretto a ritirarsi a causa di proteste pacifiche, fu sconfitto politicamente e militarmente. A riprova di ciò, Churchill cita la vittoria del repubblicano Richard Nixon e la mancanza di un candidato contrario alla guerra all’interno del Partito Democratico nel 1968, al culmine del movimento contro la guerra. Si potrebbe anche aggiungere la rielezione di Nixon nel 1972, dopo quattro anni di escalation e genocidio, per dimostrare l’impotenza del movimento pacifista nel “dire la verità al potere”. In effetti, il movimento pacifista si dissolse di pari passo con il ritiro delle truppe statunitensi (completato nel 1973). Il movimento fu meno sensibile alla campagna di bombardamento più grande della storia che colpì i civili, o alla continua occupazione del Vietnam del Sud da parte di una dittatura militare addestrata e finanziata dagli USA. In altre parole, il movimento pacifista si ritirò (e premiò Nixon con la rielezione) una volta che lɜ americanɜ, e non lɜ vietnamitɜ, furono fuori pericolo. Il movimento pacifista statunitense non è riuscito a portare la pace. L’imperialismo statunitense continua e, sebbene la strategia militare scelta sia stata sconfitta dallɜ vietnamitɜ, gli Stati Uniti raggiunsero i loro obiettivi politici generali proprio a causa dell’incapacità del movimento pacifista nell’apportare cambiamenti interni.
Alcunɜ pacifistɜ sottolineeranno l’enorme numero di “obiettori di coscienza” che si rifiutarono di combattere, per conservare una parvenza di vittoria nonviolenta. Ma dovrebbe essere ovvio che la moltitudine di obiettori e di disertori non può riscattare le tattiche pacifiste. Soprattutto in una società così militarista, la probabilità che i soldati si rifiutino di combattere è proporzionale alle loro aspettative sui rischi di affrontare un’opposizione violenta che potrebbe ucciderli o mutilarli. Senza la resistenza violenta dellɜ vietnamitɜ non ci sarebbe stata la necessità di una leva obbligatoria e, senza la leva, la resistenza nonviolenta in Nord America difficilmente sarebbe esistita. Molto più significativi degli obiettori di coscienza passivi erano le crescenti ribellioni, soprattutto da parte delle truppe nere, latine e indigene all’interno dell’esercito. Il piano intenzionale del governo statunitense – in risposta alle rivolte urbane delle persone nere – di togliere i giovani neri disoccupati dalle strade per destinarli all’esercito, si ritorse contro di loro.[23]
Gli ufficiali di Washington che visitavano le basi dell’esercito erano spaventati dallo sviluppo della cultura “militante nera”… coloni locali [bianchi] erano costretti a restituire il saluto ai neo-africani [soldati neri] facendo loro il segno del “potere” [pugno alzato]... Nixon doveva far uscire le truppe dal Vietnam in fretta o rischiava di perdere l’esercito.[24]
Il sabotaggio, il rifiuto di combattere, i disordini nelle baracche e il soccorso sanitario al nemico, tutte attività svolte da soldati statunitensi, contribuirono in modo significativo alla decisione del governo americano di ritirare le truppe di terra. Come affermò il colonnello Robert D. Heinl nel giugno 1971:
Secondo ogni possibile previsione, il nostro esercito rimasto in Vietnam è in uno stato prossimo al collasso, con singole unità che evitano o rifiutano il combattimento, uccidono i loro ufficiali e sottufficiali, si drogano e si scoraggiano, quando non ammutinano. In diverse parti del Vietnam la situazione è la medesima.[25]
Il Pentagono ha stimato che il 3% degli ufficiali e dei sottufficiali uccisi in Vietnam dal 1961 al 1972 furono uccisi dalle loro stesse truppe. Questa stima non tiene nemmeno conto delle uccisioni per accoltellamento o sparo. In molti casi, i soldati di un’unità raccoglievano i loro soldi per mettere una taglia su un ufficiale impopolare. Matthew Rinaldi identifica “i neri e i latini della classe operaia” nell’esercito (che non si identificavano con il “pacifismo a tutti i costi” del movimento per i diritti civili che li aveva preceduti) come attori principali della resistenza militante che ha paralizzato l’esercito statunitense durante la guerra del Vietnam.[26]
E sebbene fossero politicamente meno significativi della resistenza militare in generale, ci furono attentati e altri atti di violenza per protestare contro la guerra a danno di campus universitari per bianchɜ, compresa la maggior parte delle università d’élite, e non dovrebbero essere ignorati a favore dellɜ pacifistɜ bianchɜ. Nell’anno 1969-1970 (da settembre a maggio), una stima moderata conta 174 bombardamenti di protesta nei campus e almeno 70 bombardamenti fuori dal campus e altri attacchi violenti contro edifici del ROTC,[27] palazzi governativi ed edifici di proprietà del governo. Inoltre, 230 proteste nei campus comportarono violenza fisica e 410 causarono danni alle proprietà.[28]
In conclusione, quella che è stata una vittoria molto limitata – il ritiro delle truppe di terra dopo molti anni di guerra – può essere chiaramente attribuita a due fattori: la resistenza violenta e prolungata dellɜ vietnamitɜ, che fece capire ai politici statunitensi di non poter vincere; e la resistenza spesso letale delle stesse truppe di terra statunitensi, causata dalla demoralizzazione per l’effettiva violenza del loro nemico e dalla militanza politica che si diffondeva dal contemporaneo movimento nero di liberazione. Il movimento statunitense contro la guerra preoccupava chiaramente i politici statunitensi,[29] ma non era certo diventato abbastanza potente da poter dire di aver “costretto” il governo a fare qualcosa. In ogni caso, i suoi elementi più forti ricorrevano a proteste violente, bombardamenti e distruzione di proprietà.
Forse confusɜ dalla loro stessa falsa storia del movimento per la pace durante la guerra del Vietnam, lɜ pacifistɜ statunitensi del XXI secolo sembrarono aspettarsi una ripetizione della vittoria (che non è mai avvenuta) nel fermare l’invasione dell’Iraq. Il 15 febbraio 2003, mentre il governo statunitense si avviava verso la guerra con l’Iraq, “le proteste in tutto il mondo da parte di milioni di attivistɜ contro la guerra hanno espresso un duro rimprovero a Washington e ai suoi alleati... L’ondata senza precedenti di manifestazioni... ha ulteriormente compromesso i piani di guerra degli Stati Uniti”, si legge in un articolo pubblicato sul sito web del gruppo nonviolento e contro la guerra United for Peace and Justice.[30] L’articolo, che gioisce per la “massiccia dimostrazione di sentimento pacifista”, prosegue affermando che “la Casa Bianca sembra essere stata scossa dall’aumento della resistenza ai suoi appelli riguardo una rapida azione militare”. Le proteste furono le più grandi della sua storia e, a parte qualche piccola zuffa, furono quasi del tutto nonviolente, e lɜ pacifistɜ ne celebrarono ampiamente la loro grandiosità e pace. Alcuni gruppi, come United for Peace and Justice, insinuarono persino che le proteste avrebbero potuto scongiurare la guerra. Naturalmente si sbagliavano di grosso e le proteste furono totalmente inefficaci. L’invasione avvenne come previsto, nonostante i milioni di persone che si opposero pacificamente. Il movimento contro la guerra non fece nulla per cambiare i rapporti di forza negli Stati Uniti. Bush ricevette un notevole capitale politico per invadere l’Iraq e non si trovò di fronte a un contraccolpo fino a quando la guerra e l’occupazione non cominciarono a mostrare segni di fallimento a causa dell’efficace resistenza armata del popolo iracheno. La cosiddetta opposizione non si manifestò nemmeno nel panorama politico ufficiale. L’unico candidato contro la guerra del Partito Democratico,[31] Dennis Kucinich, non fu mai preso sul serio come concorrente, e lui e i suoi sostenitori alla fine abbandonarono la loro posizione di superiorità morale per accettare il sostegno della maggioranza del Partito Democratico all’occupazione dell’Iraq.
Un buon caso di studio sull’efficacia della protesta nonviolenta è rappresentato dal coinvolgimento della Spagna nell’occupazione guidata dagli Stati Uniti. La Spagna, con 1.300 soldati, era uno dei partner minori della “Coalizione dei volenterosi”. Più di un milione di spagnolɜ protestarono contro l’invasione e l’80% della popolazione spagnola si oppose all’invasione,[32] ma il loro impegno per la pace finì lì. Non fecero nulla per impedire il sostegno militare spagnolo all’invasione e all’occupazione. Poiché passivɜ di fronte al potere della leadership spagnola, rimasero impotenti come ogni altrə cittadinə di qualsiasi democrazia. Non solo il primo ministro spagnolo Aznar consentì di andare in guerra, ma si previste che avrebbe vinto la rielezione... fino ai bombardamenti. L’11 marzo 2004, pochi giorni prima dell’apertura delle urne, diverse bombe piazzate da una cellula legata ad Al-Qaeda esplosero nelle stazioni ferroviarie di Madrid, uccidendo 191 persone e ferendone migliaia. A causa di questo fatto, Aznar e il suo partito persero le elezioni mentre lɜ socialistɜ – il principale partito con un programma contro la guerra – vennero elettɜ al potere.[33] La coalizione guidata dagli Stati Uniti si indebolì perdendo 1.300 soldati spagnoli e si ridusse nuovamente dopo che anche la Repubblica Dominicana e l’Honduras ritirarono le truppe. Mentre milioni di attivistɜ pacifichɜ non indebolirono in modo misurabile la brutale occupazione, poche decine di terroristi disposti a massacrare civili furono in grado di provocare il ritiro di più di migliaia di truppe di occupazione.
Le azioni e le dichiarazioni delle cellule affiliate ad Al-Qaida non suggeriscono che esse volessero una pace significativa in Iraq, né dimostrano una preoccupazione per il benessere del popolo iracheno (dato che molte persone furono fatte a pezzi), quanto piuttosto una preoccupazione per una particolare visione di come la società irachena sarebbe dovuta essere organizzata; una visione estremamente autoritaria, patriarcale e fondamentalista. E, senza dubbio, la decisione di uccidere e mutilare centinaia di persone disarmate, per quanto tale azione possa sembrare strategicamente necessaria, è legata al loro autoritarismo e alla loro brutalità, e soprattutto alla cultura intellettuale da cui proviene la maggior parte dei così detti terroristi (anche se questo è un argomento del tutto diverso). La questione diventa più complicata se confrontata con la massiccia campagna di bombardamenti degli Stati Uniti che ha intenzionalmente ucciso centinaia di migliaia di civili in Germania e in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene questa campagna sia stata molto più brutale delle bombe di Madrid, è generalmente considerata accettabile. La disparità che possiamo riscontrare tra la condanna degli attentatori di Madrid (facile) e la condanna degli ancor più sanguinari piloti americani (non così facile, forse perché tra di loro possiamo trovare i nostri stessi parenti – mio nonno, ad esempio) dovrebbe farci interrogare sulla nostra condanna del terrorismo e capire se abbia davvero a che fare con il rispetto per la vita. Poiché non stiamo combattendo per un mondo autoritario, gli attentati di Madrid non rappresentano un esempio di azione, ma piuttosto un importante paradosso. Le persone che si attengono a tattiche pacifiche (che non si sono dimostrate efficaci per porre fine alla guerra contro l’Iraq) hanno davvero a cuore la vita umana più dei terroristi di Madrid? Dopo tutto, sono statɜ uccisɜ più di 191 civili irachenɜ per ogni 1.300 truppe di occupazione presenti in Iraq. Restando su questo filone logico: se qualcunə deve morire (e l’invasione statunitense rende questa tragedia inevitabile), lɜ cittadinɜ spagnolɜ hanno più colpa dellɜ irachenɜ (proprio come lɜ cittadinɜ tedeschɜ e giapponesɜ avevano più colpa di altre vittime della Seconda Guerra Mondiale). Finora, l’unica vera resistenza si sta verificando in Iraq, dove gli Stati Uniti e i loro alleati sono più preparati ad affrontarla, anche se a caro prezzo per le vite dellɜ guerriglierɜ e dellɜ non combattenti. Alla faccia delle vittorie del pacifismo.
Sarebbe anche utile capire la portata dei fallimenti dell’ideologia pacifista. Un esempio, tanto controverso quanto necessario, è quello dell’Olocausto.[34] Per gran parte del genocidio, la resistenza militante fu pressoché assente, quindi possiamo misurare l’efficacia della sola resistenza pacifista. L’Olocausto è anche uno dei pochi fenomeni in cui la colpevolizzazione delle vittime è correttamente vista come supporto o simpatia nei confronti dell’oppressore, per cui, nella logica pacifista, le occasionali rivolte non possono essere usate per giustificare la repressione e il genocidio, come accade altrove quando lɜ pacifistɜ attribuiscono la colpa della violenza autoritaria all’audacia dellɜ oppressɜ di intraprendere un’azione contro l’autorità. Alcunɜ pacifistɜ, per suggerire che la resistenza nonviolenta può funzionare anche nelle condizioni peggiori, furono così audaci da usare esempi di resistenza ai nazisti, come la disobbedienza civile dellɜ danesi.[35] È davvero necessario sottolineare che lɜ danesi, in quanto arianɜ, affrontarono una serie di conseguenze diverse per la resistenza rispetto alle vittime principali dei nazisti? L’Olocausto fu interrotto solo dalla violenza concertata e schiacciante dei governi alleati che attaccarono lo stato nazista (anche se, ad essere onesto, si preoccuparono molto di più di ridisegnare la mappa dell’Europa che di salvare le vite di rom, ebreɜ, persone di sinistra, prigionierɜ di guerra sovietici e altrɜ. Lɜ sovietichɜ tendevano ad “epurare” lɜ prigionierɜ di guerra salvatɜ temendo che, anche se la loro resa non lɜ rendeva colpevoli, il loro contatto con lɜ stranierɜ nei campi di concentramento lɜ avesse ideologicamente contaminatɜ). Le vittime dell’Olocausto, tuttavia, non furono del tutto passive. Un gran numero di loro si attivò per salvare vite umane e sabotare la macchina di morte nazista. Yehuda Bauer, che si occupa esclusivamente di vittime ebree dell’Olocausto, documenta con enfasi questa resistenza. Fino al 1942, “i rabbini e altri leader... consigliavano di non prendere le armi”, ma non consigliavano la passività. Piuttosto, “la resistenza era nonviolenta”.[36] Chiaramente, ciò non rallentò il genocidio e non indebolì i nazisti in modo misurabile. A partire dal 1942, lɜ ebreɜ cominciarono a resistere in modo violento, anche se troviamo ancora molti esempi di resistenza nonviolenta. Nel 1943, lɜ cittadinɜ danesi aiutarono la maggior parte dellɜ settemila ebreɜ del Paese a fuggire nella neutrale Svezia. Nello stesso anno, il governo, la chiesa e la popolazione della Bulgaria fermarono la deportazione dellɜ ebreɜ da quel Paese.[37] In entrambi i casi, lɜ ebreɜ liberatɜ furono protettɜ dalla forza militare e tenutɜ al sicuro dai confini di un Paese che non era sotto la diretta occupazione tedesca, in un momento in cui la guerra cominciava ad apparire cupa per i nazisti. (A causa del violento assalto dei sovietici, i nazisti trascurarono temporaneamente i piccoli tentativi di rovesciamento dei loro piani da parte di Svezia e Bulgaria). Nel 1941, lɜ abitanti di un ghetto di Vilnius, in Lituania, organizzarono un’imponente protesta quando i nazisti e le autorità locali si prepararono a deportarli.[38] Questo atto di disobbedienza civile può aver ritardato di poco la loro deportazione, ma non salvò nessuna vita.
Alcuni leader dello Judenrat – i consigli ebraici istituiti dai nazisti per governare i ghetti in conformità con gli ordini nazisti – si adattarono a quest’ultimi nel tentativo di non agitare le acque nella speranza che il maggior numero possibile di ebreɜ fossero ancora vivɜ alla fine della guerra (tutt’oggi moltɜ pacifistɜ negli Stati Uniti credono che agitare o provocare un conflitto, significhi fare qualcosa di sbagliato).[39] Bauer scrive: “Alla fine, la strategia fallì, e coloro che provarono ad applicarla scoprirono con orrore di essere diventatɜ complici nel piano omicida dei nazisti”.[40] Altri membri del Consiglio ebraico furono più coraggiosi e rifiutarono apertamente di collaborare con i nazisti. A Lvov, in Polonia, il primo presidente del Consiglio si rifiutò di collaborare e fu puntualmente ucciso e sostituito. Come sottolinea Bauer, i sostituti furono molto più accondiscendenti (anche se nemmeno l’obbedienza li salvò, poiché furono tutti destinati ai campi di sterminio; nell’esempio specifico di Lvov, il sostituto obbediente fu ucciso comunque per il solo sospetto di resistenza). A Borszczow, in Polonia, il presidente del consiglio si rifiutò di obbedire agli ordini nazisti e fu spedito nel campo di sterminio di Belzec.[41] I membri del Consiglio utilizzarono una varietà di tattiche che si rilevarono chiaramente più efficaci. A Kovno, in Lituania, finsero di rispettare gli ordini nazisti, ma in segreto fecero parte della resistenza. Nascosero con successo lɜ bambinɜ deportatɜ e fecero uscire di nascosto dal ghetto giovani uomini e donne per poterlɜ farlɜ combattere con lɜ partigianɜ. In Francia, “entrambe le sezioni [del consiglio] fecero parte della clandestinità e furono in costante contatto con lɜ resistenti... essɜ contribuirono in modo significativo a salvare la maggior parte dellɜ ebreɜ del Paese”.[42] Anche nei casi in cui non presero parte personalmente alla resistenza violenta, moltiplicarono immensamente la loro efficacia sostenendo coloro che invece ne presero parte.
E poi ci furono lɜ guerriglierɜ urbanɜ e lɜ partigianɜ che combatterono violentemente contro i nazisti. Nei mesi di aprile e maggio del 1943, lɜ ebreɜ del ghetto di Varsavia si sollevarono con armi di contrabbando, rubate o fatte in casa. Settecento giovani, uomini e donne, combatterono per settimane, fino alla morte, mettendo in ginocchio le migliaia di truppe naziste e distruggendo altre risorse necessarie sul precario fronte orientale. Sapevano che sarebbero statɜ uccisɜ anche se fossero statɜ pacifichɜ. Ribellandosi violentemente, vissero le ultime settimane di vita in libertà e resistenza rallentando la macchina da guerra nazista. Un’altra ribellione armata scoppiò nel ghetto di Bialystok, in Polonia, il 16 agosto 1943, e continuò per settimane.
La guerriglia urbana, come gruppo composto da ebreɜ sionistɜ e comunistɜ a Cracovia, riuscì a far esplodere treni di rifornimento e ferrovie, a sabotare fabbriche di produzione bellica e ad assassinare funzionari governativi.[43]
Gruppi ebraici e altri gruppi partigiani in Polonia, Cecoslovacchia, Bielorussia, Ucraina e nei Paesi baltici realizzarono atti di sabotaggio sulle linee di rifornimento tedesche e combatterono le truppe delle SS. Secondo Bauer, “nella Polonia orientale, in Lituania e nell’Unione Sovietica occidentale, almeno 15.000 partigianɜ ebreɜ combatterono e almeno altrɜ 5.000 ebreɜ disarmatɜ convissero con loro nei boschi, protettɜ per tutto o in parte dallɜ combattenti”.[44] In Polonia, un gruppo di partigianɜ guidatɜ dai fratelli Belsky salvò più di 1.200 uomini, donne e bambinɜ ebreɜ, in parte eseguendo uccisioni per rappresaglia contro coloro che avevano catturato o consegnato lɜ fuggitivɜ. Gruppi partigiani simili in Francia e in Belgio sabotarono infrastrutture belliche, assassinarono funzionari nazisti e aiutarono le persone a fuggire dai campi di sterminio. Una banda di comunistɜ ebreɜ in Belgio fece deragliare un treno che deportava delle persone ad Auschwitz e ne aiutò diverse centinaia a fuggire. Durante una ribellione nei campi di sterminio di Sobibor nell’ottobre 1943, lɜ resistenti uccisero diversi ufficiali nazisti e permisero a quattrocento dellɜ seicento detenutɜ di fuggire.[45] La maggior parte di queste fu rapidamente uccisa, ma circa sessanta sopravvissero per unirsi ai gruppi partigiani. Due giorni dopo la rivolta, Sobibor fu chiusa. Unə ribelle a Treblinka nell’agosto 1943 distrusse il campo di sterminio, che non fu più ricostruito. Lɜ partecipanti – in un’altra insurrezione ad Auschwitz nell’ottobre 1944 – distrussero uno dei crematori.[46] Queste rivolte violente rallentarono l’Olocausto. In confronto, le tattiche nonviolente (e i governi alleati, i cui bombardieri avrebbero potuto facilmente raggiungere Auschwitz e gli altri campi) non riuscirono a chiudere o a distruggere un solo campo di sterminio prima della fine della guerra. Nell’Olocausto e in altri esempi meno estremi – dall’India a Birmingham –, la nonviolenza non riuscì a dare sufficiente potere allɜ suɜ praticanti, mentre l’uso di una varietà di tattiche portò di fatto dei risultati. In parole povere, se un movimento non è una minaccia, non può cambiare un sistema basato sulla coercizione centralizzata e sulla violenza[47] e se quel movimento non esercita il potere per far sì che diventi una minaccia, non può distruggere tale sistema. Nel mondo di oggi, i governi e le corporazioni detengono un monopolio del potere, il cui elemento principale è la violenza. A meno che non riusciremo a cambiare i rapporti di potere (e, preferibilmente, distruggendo l’infrastruttura e la cultura del potere centralizzato), coloro che attualmente beneficiano della violenza strutturale onnipresente, che controllano i militari, le banche, le burocrazie e le imprese, continueranno a comandare. L’élite non può essere persuasa da appelli alla propria coscienza. Gli individui che cambiano idea e trovano una moralità migliore saranno licenziati, incriminati, ricollocati, richiamati, assassinati. Spesso, le persone che lottano non per una riforma simbolica, ma per una completa liberazione – il recupero del controllo sulle proprie vite e il potere di negoziare le proprie relazioni con le persone e il mondo che ci circonda – scopriranno che la nonviolenza non funziona. Ci troviamo di fronte ad una struttura di potere che si auto-perpetua, immune agli appelli, alla coscienza e abbastanza forte da asfaltare disobbedienti e non collaborativɜ. Dobbiamo recuperare le storie di resistenza per capire perché abbiamo fallito in passato e come abbiamo conseguito i limitati successi che abbiamo ottenuto. Dobbiamo accettare che tutte le lotte sociali, tranne quelle condotte da un popolo completamente pacificato e quindi inefficace, includono una diversità di tattiche. Rendersi conto che la nonviolenza non ha mai prodotto vittorie storiche verso obiettivi rivoluzionari apre la porta a considerare altri gravi mancanze da parte della nonviolenza.
La nonviolenza è razzista
Non ho intenzione di scambiare insulti, ed uso l’epiteto razzista solo dopo aver fatto un’attenta considerazione.
La nonviolenza è una posizione intrinsecamente privilegiata nel contesto moderno. Oltre al fatto che lə tipicə pacifistə è chiaramente biancə ed appartenente alla classe media, il pacifismo stesso come ideologia deriva da un contesto privilegiato. Esso ignora che la violenza sia già qui presente, che la violenza sia una parte strutturalmente integrante ed inevitabile della corrente gerarchia sociale. E ad essere maggiormente affette da questa violenza sono tutte le persone razzializzate.
Il pacifismo presuppone che le persone bianche che sono cresciute in periferia e che hanno visto tutti i loro bisogni primari soddisfatti, possano consigliare alle persone oppresse, molte delle quali appartengono a minoranze etniche, di soffrire pazientemente sotto una forza inconcepibilmente più grande, fino a quando il Grande Padre Bianco non si mostrerà influenzato dalle richieste del movimento o fino a quando lɜ pacifistɜ non raggiungeranno quella leggendaria “massa critica”.
La comunità nera nelle colonie interne degli Stati Uniti non può difendersi contro la brutalità della polizia o impadronirsi dei mezzi di sopravvivenza per liberare se stessa dalla servitù economica.
Devono aspettare che sufficienti persone nere che abbiano già ottenuto un maggior privilegio economico (lɜ “schiavɜ* domestichɜ” dell’analisi di Malcolm X)[48] e persone bianche coscienziose si riuniscano tutte insieme per tenersi mano nella mano e cantare canzoni. A quel punto, come credono, il cambiamento arriverà sicuramente. Le persone nell’America Latina devono soffrire pazientemente, come dellɜ verɜ e propriɜ martiri, mentre lɜ attivistɜ bianchɜ negli Stati Uniti “portano testimonianze” e scrivono al Congresso. Le persone in Iraq non devono rispondere alle violenze. Solo se rimangono civili le loro morti saranno numerate e compiante dallɜ pacifistɜ bianchɜ, che uno di questi giorni organizzeranno una protesta abbastanza grande da fermare la guerra.
Le popolazioni indigene devono aspettare giusto un po’ più a lungo (diciamo 500 anni) sotto la falce del genocidio, estinguendosi lentamente in terre marginali, finché... A dire la verità, non sono una priorità al momento, quindi forse dovrebbero organizzare un paio di dimostrazioni per conquistarsi l’attenzione e la simpatia dei potenti.
O magari potrebbero scioperare o ingaggiare in azioni di non cooperazione di tipo Gandhiano. Ma aspetta – la maggior parte di loro è già disoccupata, non cooperante, completamente esclusa dal funzionamento del sistema.
La nonviolenza dichiara che lɜ indianɜ d’America avrebbero potuto combattere Colombo, George Washington e tutti gli altri macellai genocidi con dei sit-in; dichiara che Cavallo Pazzo, avendo attuato una resistenza violenta, era entrato a far parte del ciclo di violenza ed era “tanto crudele quanto” Custer.
La nonviolenza dichiara che lɜ africanɜ avrebbero potuto fermare la tratta dellɜ schiavɜ con scioperi della fame e petizioni, e che tuttɜ quellɜ che si ammutinavano peccavano tanto quanto i loro rapitori; che l’ammutinamento, una forma di violenza, portava a maggiore violenza e così la resistenza conduceva ad una maggior schiavitù.
La nonviolenza si rifiuta di riconoscere che questo metodo può funzionare solo per persone privilegiate che hanno uno status protetto dalla violenza, come perpetratori e beneficiari di una gerarchia violenta. Lɜ pacifistɜ devono sapere, almeno nel loro subconscio, che la nonviolenza è una posizione assurdamente privilegiata, così fanno un frequente utilizzo delle minoranze prendendo attivistɜ razzializzatɜ fuori dai loro contesti e utilizzandolɜ selettivamente come portavoce della nonviolenza... Gandhi e Martin Luther King Jr. vengono trasformati in rappresentanti di tutte le persone razzializzate. Anche Nelson Mandela lo era, finché lɜ pacifistɜ bianchɜ non si resero conto che Mandela utilizzava la nonviolenza in modo selettivo e che in realtà era coinvolto in attività di liberazione come bombardamenti e la preparazione alla rivolta armata.[49]
Anche Gandhi e King convenivano che fosse necessario sostenere i movimenti di liberazione armata (citando due esempi, quelli rispettivamente in Palestina e in Vietnam) dove non vi fosse un’alternativa nonviolenta, chiaramente dando priorità agli obiettivi rispetto a tattiche specifiche. Ma ad oggi lɜ pacifistɜ – per lo più bianchɜ – cancellano questa parte della storia e ricreano la nonviolenza in modo che si adatti al loro livello di comfort, anche mentre rivendicano l’esempio di Martin Luther King Jr. e Gandhi.[50] Si ha l’impressione che se Martin Luther King Jr. andasse sotto mentite spoglie a una di queste veglie pacifiste, non gli sarebbe permesso di parlare. Come lui ha sottolineato:
A parte bigotti e contrari, sembra essere una malattia anche tra quellɜ bianchɜ a cui piace considerarsi “illuminatɜ”. Mi riferisco in particolare a coloro che consigliano “Aspetta!” e a coloro che dicono di simpatizzare con i tuoi obiettivi ma non possono perdonare i tuoi metodi di azione diretta nel perseguimento di tali obiettivi. Mi stupisco delle persone che osano credere di avere qualche diritto paternalistico di impostare un orario per la liberazione di altre persone. Devo dire che negli ultimi anni sono stato gravemente deluso da tali “moderatɜ” bianchɜ. Sono spesso propenso a pensare che siano più un ostacolo per il progresso della comunità nera rispetto al White Citizens Counselor [sic] o al Ku Klux Klanner.[51]
E va aggiunto che le persone bianche privilegiate sono state determinanti nella nomina di attivisti come Gandhi e King a posizioni di leadership su scala nazionale. Tra lɜ attivistɜ bianchɜ e, non a caso, tra la classe dirigente dei suprematisti bianchi, la marcia su Washington dell’era dei diritti civili è associata prima di tutto al discorso “I Have a Dream” di Martin Luther King Jr.
Per lo più assente dalla coscienza bianca, ma almeno altrettanto influente per le persone nere, era la prospettiva di Malcolm X, come egli articola nel suo discorso di critica alla leadership della marcia:
Era la base là fuori in strada. Ha spaventato a morte l’uomo bianco, ha spaventato a morte la struttura del potere bianco a Washington DC. Ero lì. Quando hanno scoperto che questo compressore nero stava per scendere sulla capitale chiamarono... Questi leader nazionali neri che rispettate e gli dissero “annullatelo”. Kennedy disse: “Guardate, state lasciando che questa cosa vada troppo oltre”. E il vecchio Tom disse: “Capo, non posso fermarlo perché non sono stato io ad avviarlo”. Vi sto dicendo quello che hanno detto. Hanno detto: “Non sono neanche parte di esso, ancor meno nella sua testa. Dissero: “Questɜ nerɜ stanno facendo di testa loro. Ci stanno correndo davanti”. E quella vecchia volpe scaltra disse “se voi tuttɜ non ci siete in mezzo, vi ci metto io. Vi ci metterò a capo. Lo approverò. Lo accoglierò… Questo è quello che hanno fatto alla marcia su Washington. Si unirono... ne divennero parte, presero il sopravvento. E come ne presero il sopravvento, perse la sua militanza. Smise di essere una massa arrabbiata, smise di essere furente, smise di essere intransigente. Smise proprio di essere una marcia. Divenne un picnic, un circo. Niente più che un circo, con tanto di clown. [...]
No, è stato un tutto esaurito... Hanno controllato il tutto così strettamente, dissero a quellɜ nerɜ a che ora andare in città, dove fermarsi, che cartelli portare, che canzone cantare, che tipo di discorsi fosse consentito fare e quali non fossero consentiti, e poi gli dissero di andarsene dalla città al tramonto.[52]
Lo scopo finale della marcia era quello di investire ingenti risorse del movimento, in un momento critico, in un ultimo evento di pacificazione. Detto con le parole di Bayard Rustin, uno dei capi organizzatori della marcia, “si comincia ad organizzare una marcia di massa facendo una brutta supposizione. Supponi che tuttɜ quellɜ che vengono abbiano la mentalità di unə bambinə di tre anni”.[53]
Lɜ dimostranti ricevono dei cartelli di protesta già fatti con slogan approvati dal governo; i discorsi di molti leader della protesta, incluso quello del presidente della SNCC John Lewis, furono censurati per eliminare minacce di lotta armata e critiche al disegno di legge del governo sui diritti civili; e come Malcolm X ha già raccontato, alla fine alla folla fu comandato di andarsene il prima possibile.
Sebbene goda di relativamente poca attenzione nelle storie tradizionali, il personaggio di Malcolm X fu estremamente influente sul movimento di liberazione nera, e fu riconosciuto come tale dal movimento stesso e dalle forze di governo incaricate di distruggere il movimento. In una nota l’FBI affrontò la necessità di impedire l’ascesa di un “messia” nero come parte del suo Programma di controspionaggio. Secondo L’FBI, Malcolm X potrebbe essere stato tale “messia”; oggi è considerato il martire del movimento”.[54]
Il fatto che Malcolm X fu additato dall’FBI come una delle principali minacce, solleva la possibilità di un coinvolgimento dello stato nel suo assassinio;[55] certamente altrɜ attivistɜ nerɜ non pacifistɜ, individuatɜ dall’FBI come organizzatrici del movimento, furono presɜ di mira per essere eliminatɜ, con mezzi tra i quali l’assassinio.[56]
Nel mentre a Martin Luther King Jr. fu concessa la sua celebrità e influenza fino a quando iniziò a diventare più radicale, parlando di rivoluzione anticapitalista e sostenendo la solidarietà con la lotta armata delle persone vietnamite.
In effetti, lɜ attivistɜ bianchɜ, in particolare quellɜ interessatɜ a minimizzare il ruolo dellɜ militanti e della lotta armata, assistirono lo stato nell’assassinio di Malcolm X (e rivoluzionariɜ simili).
Essɜ eseguono la parte più pulita del lavoro, facendo scomparire la sua memoria e cancellandolo dalla storia.[57]
E nonostante le loro assurde e sproporzionate professioni di devozione nei suoi confronti (dopotutto c’erano alcune persone che presero parte al movimento per i diritti civili), allo stesso modo aiutarono ad assassinare Martin Luther King Jr., sebbene nel suo caso fu utilizzato un metodo più orwelliano (assassinare, riformulare e cooptare).
Darren Parker, un attivista nero e consulente di gruppi di base scrive “le critiche hanno contribuito alla mia comprensione della nonviolenza”.
Il numero di volte in cui le persone citano King è una delle cose più scoraggianti per la maggior parte delle persone nere, perché sanno quanto la sua vita fosse incentrata sulla lotta razziale... e quando leggi effettivamente King, tendi a chiederti perché le parti critiche sulle persone bianche, che sono la maggior parte delle cose che ha detto e scritto, non vengano mai citate.[58]
In questo modo si evitano le critiche di King al razzismo che risultano più fastidiose (per lɜ bianchɜ),[59] e le sue prescrizioni cliché per un attivismo nonviolento vengono ripetute fino alla nausea, consentendo allɜ pacifistɜ bianchɜ di incassare un’autorevole risorsa culturale per confermare il loro attivismo nonviolento e impedire il riconoscimento del razzismo insito nella loro posizione associandosi ad una figura nera non controversa.
La revisione della storia da parte dellɜ pacifistɜ per rimuovere esempi di lotte militanti contro la supremazia bianca non può essere separata da un razzismo che è insito nella posizione pacifista.
È impossibile rivendicare sostegno, tanto meno solidarietà, per le persone razzializzate nelle loro lotte quando gruppi inevitabilmente significativi come il Black Panther Party, l’American Indian Movement, i Brown Berets e i Vietcong sono attivamente ignorati a favore di un omogeneo quadro di lotta antirazzista che riconosce solo quei segmenti che non contraddicono la visione relativamente confortevole della rivoluzione preferita soprattutto dallɜ bianchɜ radicali.
Le rivendicazioni di sostegno e solidarietà diventano ancora più pretenziose quando lɜ pacifistɜ bianchɜ redigono regole di tattiche considerate accettabili e le impongono a tutto il movimento, negando l’importanza dell’etnia, del background di classe e di altri fattori contestuali.
Il punto non è che lɜ attivistɜ bianchɜ – per essere antirazzistɜ – debbano sostenere acriticamente qualsiasi gruppo di resistenza asiatico, latino, indigeno o nero che si presenti. Tuttavia, c’è un universalismo eurocentrico nell’idea che partecipiamo tuttɜ alla stessa lotta omogenea e che lɜ bianchɜ nel cuore dell’impero possano indicare alle persone razzializzate e alle persone nelle (neo)colonie il modo migliore per resistere.
Le persone più colpite dal sistema di oppressione dovrebbero essere in prima linea nella lotta contro quella particolare oppressione,[60] eppure il pacifismo produce ancora e ancora organizzazioni e movimenti di bianchɜ che illuminano il cammino e aprono la strada per salvare le persone razzializzate, perché l’imperativo della nonviolenza prevale sul rispetto fondamentale della fiducia che le persone si liberino da sé.
Ogni volta che lɜ pacifistɜ bianchɜ si occupano di una causa che colpisce le persone razzializzate, e i metodi di resistenza delle persone che vengono colpite non si conformano alla particolare definizione di nonviolenza in uso, lɜ attivistɜ bianchɜ si pongono come insegnanti e guide, creando una dinamica che è decisamente coloniale.
Naturalmente, questa è in gran parte una funzione della bianchezza (una visione del mondo socialmente costruita ed insegnata a tutte le persone identificate dalla società come “bianche”).
Lɜ attivistɜ bianchɜ militanti possono incorrere in problemi simili quando mancano di rispetto allɜ alleatɜ razzializzatɜ dettando il metodo di lotta appropriato e ortodosso.
The Weather Underground e altri gruppi militanti bianchi degli anni ’60 e ’70 hanno svolto un lavoro orribile nell’estendere la solidarietà al movimento di liberazione nera, esprimendo sostegno ma negando qualsiasi aiuto materiale, in parte perché si consideravano un’avanguardia e i gruppi neri come concorrenti ideologici.
Altre organizzazioni bianche, come il Liberation Support Movement, usarono il loro sostegno per esercitare il controllo sui movimenti di liberazione anticoloniali con cui affermavano di agire in solidarietà,[61] alla stessa maniera con cui opera un’agenzia di aiuti governativi.
È interessante notare che, anche tra lɜ attivistɜ bianchɜ militanti, il razzismo incoraggia la passività. Uno dei problemi dei Weather Underground è che affermarono di combattere al fianco delle persone nere e vietnamite, ma questa era solo una facciata: condussero bombardamenti innocui e simbolici e azioni con alte probabilità di mettere a rischio la propria vita. Oggi, lɜ loro veteranɜ non sono mortɜ o imprigionatɜ (ad eccezione di tre vittime di un incidente di fabbricazione di esplosivi e coloro che lasciarono Weather per combattere al fianco dei membri della Black Liberation Army); loro vivono comodamente come accademichɜ e professionistɜ.[62]
Oggi, lɜ militanti anarchichɜ bianchɜ nel Nord America presentano le stesse tendenze. Moltɜ di coloro che più parlano a riguardo, disdegnano le lotte di liberazione in corso, denunciandole come “non anarchiche”, piuttosto che sostenere i loro elementi più antiautoritari. Il risultato è che questɜ anarchichɜ hardcore (e, allo stesso tempo, da poltrona) non riescono a trovare una resistenza reale (e pericolosa) degna del loro appoggio, quindi si attengono a posizioni militanti e alla violenza della spaccatura ideologica.
Un sistema suprematista bianco punisce la resistenza delle persone razzializzate più duramente della resistenza di quelle bianche. Anche lɜ attivistɜ bianchɜ che si sono resɜ conto delle dinamiche del razzismo trovano difficile rinunciare al privilegio che ne deriva, quello della sicurezza socialmente garantita. Di conseguenza, coloro che sfidano la supremazia bianca in modo diretto e militante ci sembreranno minacciosɜ. Mumia Abu-Jamal scrive:
“I riconoscimenti delle lotte delle persone nere della fine del XX secolo, sono stati assegnati ai veterani della lotta per i diritti civili incarnata dal martire Martin Luther King Jr. elevato dalle élite bianche e nere alle vette dell’accettazione sociale, il messaggio di tolleranza cristiana del dottor King e la sua dottrina del porgere l’altra guancia calmavano la psiche bianca. Per lɜ americanɜ abituatɜ al comfort il dottor King era, soprattutto, una sicurezza. Il Black Panther Party era l’antitesi del personaggio di King. Il Partito non era un gruppo per i diritti civili... ma praticava il diritto umano all’autodifesa... Il Black Panther Party faceva sentire molte cose allɜ americanɜ (bianchɜ), ma la sicurezza non era una di quelle cose.[63]
Lɜ pacifistɜ bianchɜ (e anche quellɜ pacifistɜ nerɜ borghesɜ) temono l’abolizione totale del sistema suprematista bianco e capitalista. Predicano la nonviolenza alle persone in fondo alla gerarchia razziale ed economica proprio perché la nonviolenza è inefficace, e qualsiasi rivoluzione lanciata “da quelle persone”, purché rimanga nonviolenta, non sarà in grado di spodestare completamente bianchɜ e ricchɜ dalle loro posizioni privilegiate.
Anche i ceppi di nonviolenza che cercano di abolire lo stato mirano a farlo trasformandolo (e convertendo le persone al potere); quindi, la nonviolenza richiede che lɜ attivistɜ tentino di influenzare la struttura del potere, il che richiede che vi si avvicinino, e che le persone privilegiate, che hanno un migliore accesso al potere, manterranno il controllo di qualsiasi movimento come guardianɜ e intermediariɜ che consentono alle masse di “dire la verità al potere.”
Nel novembre 2003, lɜ attivistɜ della School of the Americas Watch (SOAW) organizzarono un dibattito contro l’oppressione durante la loro veglia pacifista annuale fuori dalla base militare di Fort Benning (che ospita la School of the Americas, una scuola di addestramento militare fortemente connessa alle violazioni dei diritti umani in America Latina).
Lɜ organizzatrici della discussione ebbero difficoltà a convincere lɜ partecipanti bianchɜ della classe media (di gran lunga il gruppo demografico dominante alla veglia esplicitamente nonviolenta) a concentrarsi sulle dinamiche oppressive (come il razzismo, il classismo, il sessismo e la transfobia) all’interno dell’organizzazione e tra lɜ attivistɜ associatɜ agli sforzi antimilitaristi di SOAW. Invece, le persone presenti alla discussione, in particolare quelle pacifiste bianche più anziane, continuavano a tornare a forme di oppressione praticate da qualche forza esterna: la polizia che controllava la veglia o i militari che soggiogavano le persone in America Latina.
Fu abbastanza evidente che l’autocritica (e il miglioramento) fosse un’opzione indesiderabile; l’alternativa preferibile era concentrarsi sui difetti di un’altra entità violenta, sottolineando la propria vittimizzazione da parte delle forze del potere statale (e, quindi, la superiorità morale rispetto ad esse). Alla fine, un certo numero di veteranɜ attivistɜ nerɜ che parteciparono alla discussione furono in grado di spostare l’attenzione sulle molte forme di razzismo all’interno dell’ambiente anti-SOA che impedivano di attrarre più sostegno da parte di popolazioni non privilegiate. Forse la loro critica maggiore, nell’evidenziare il razzismo di cui furono testimoni, fu proprio contro la pratica del pacifismo dell’organizzazione. Parlarono contro l’atteggiamento privilegiato dellɜ pacifistɜ bianchɜ nei confronti dell’attivismo e criticarono l’atteggiamento casuale, divertente e celebrativo della protesta, con le sue pretese di essere rivoluzionario, persino di essere una protesta.
Una donna nera venne particolarmente irritata per un’esperienza che aveva avuto mentre prendeva un autobus per la veglia di Fort Benning con altrɜ attivistɜ anti-SOA. Durante una conversazione con un’attivista biancə, affermò di non sostenere la pratica della nonviolenza. Quell’attivista poi le disse che era “sull’autobus sbagliato” e che non apparteneva alla protesta. Quando ho raccontato questa storia e le altre critiche mosse da persone nere durante la discussione a un elenco di ex detenutɜ affiliatɜ alla SOAW (dopo aver scontato una pena detentiva massima di sei mesi completamente volontaria, si diedero l’onorifico titolo di “prigionierɜ di coscienza”), un’attivista bianca per la pace mi ha scritto di essere sorpresa che una donna nera si opponga ideologicamente alla nonviolenza, nonostante Martin Luther King Jr. e l’eredità del movimento per i diritti civili.[64]
Al di là del loro uso frequente e manipolativo delle persone razzializzate come prestanome e mansuete portavoce, lɜ pacifistɜ seguono un quadro tattico e ideologico formulato quasi esclusivamente da teorici bianchi. Mentre lɜ attivistɜ rivoluzionariɜ hanno difficoltà a trovare teorichɜ bianchɜ che abbiano qualcosa di rilevante da dire riguardo ai metodi della lotta militante, lɜ insegnanti del pacifismo sono principalmente bianchɜ (per esempio: David Dellinger, i Berrigan, George Lakey, Gene Sharp, Dorothy Day e A.J. Muste). Un articolo che sposa la nonviolenza pubblicato in modo abbastanza appropriato su The Nation, sbandiera il nome di Gandhi, ma cita principalmente attivistɜ e studiosɜ bianchɜ per articolare una strategia più precisa.[65] Un altro articolo sulla nonviolenza, consigliato da un’attivista pacifista anti-SOA ad attivistɜ non pacifistɜ che dubitavano della profondità strategica del pacifismo, si basa esclusivamente su fonti bianche.[66] Un libro popolare tra lɜ pacifistɜ statunitensi afferma che “l’America è stata più spesso l’insegnante che lo studente dell’ideale nonviolento”.[67]
Lɜ pacifistɜ farebbero bene anche a esaminare il colore della violenza. Quando menzioniamo rivolte, chi immaginiamo? Lɜ attivistɜ bianchɜ che commettono la distruzione di proprietà come forma di disobbedienza civile possono estendere, generalmente senza perderla, la copertura protettiva della “nonviolenza”. Le persone razzializzate impegnate nella distruzione di proprietà e politicamente motivate, a meno che non rientrino strettamente nella rubrica di una protesta organizzata da attivistɜ bianchɜ, sono bandite nel regno della violenza, viene loro negata la considerazione come attivistɜ e non vengono descrittɜ come coscienziosɜ.
Il razzismo del sistema giudiziario, una componente importante e violenta della nostra società, sebbene raramente considerata prioritaria dallɜ pacifistɜ per l’opposizione, ha avuto un impatto importante sulla psiche americana. Violenza e criminalità sono concetti quasi intercambiabili (si consideri quanto lɜ pacifistɜ si sentano a proprio agio nell’usare la terminologia della moralità statalista – ad esempio, “giustizia” – come propria), e uno scopo principale di entrambi i concetti è stabilire la colpa. Proprio come lɜ criminali meritano repressione e punizione, le persone che usano la violenza meritano le inevitabili violente conseguenze; questo è parte integrante della posizione pacifista. Possono negare di credere che chiunque meriti che venga usata la violenza contro di loro, ma un argomento comune tra lɜ pacifistɜ è che lɜ rivoluzionariɜ non dovrebbero usare la violenza perché lo stato la userà per “giustificare” la repressione violenta. Ebbene, secondo chi è giustificata questa repressione violenta, e perché coloro che affermano di essere contro la violenza non provano a smettere di giustificarla? Perché lɜ attivistɜ nonviolentɜ cercano di cambiare la moralità della società nel modo in cui essa vede l’oppressione o la guerra, ma accettano la moralità della repressione come naturale e intoccabile?
Questa idea delle inevitabili conseguenze repressive della militanza spesso va oltre l’ipocrisia, fino a incolpare apertamente le vittime e ad approvare la violenza repressiva. Le persone razzializzate che sono oppresse ogni giorno dalla polizia e dalla violenza strutturale, sono sconsigliate di rispondere con la violenza perché ciò giustificherebbe la violenza di stato già mobilitata contro di loro.
Il victim blaming (la colpevolizzazzione della vittima) era una parte chiave del discorso e della strategia pacifista negli anni ’60 e ’70, quando moltɜ attivistɜ bianchɜ aiutarono a giustificare le azioni statali e neutralizzare ciò che sarebbe potuto diventare un attentato anti-governo a causa di una violenta repressione di stato dei movimenti neri e di altri movimenti di libertà, come gli assassinii attuati dalla polizia verso gli organizzatori dei Panthers, Fred Hampton e Mark Clark. Piuttosto che sostenere e aiutare i Panthers, lɜ pacifistɜ bianchɜ trovavano più di moda affermare che “provocarono la violenza” e che “se l’erano cercata”.[68]
Più recentemente, alla già citata conferenza anarchica, ho accusato il movimento pacifista statunitense di meritare di condividere la colpa della morte di tre milioni di vietnamitɜ per essere stato così accomodante nei confronti del potere statale. Un pacifista, anarchico e pacificatore cristiano ha risposto alla mia accusa affermando che la colpa era di Ho Chi Minh e della leadership vietnamita (mi aspettavo che dicesse solo l’esercito americano, ma no!) per aver praticato la lotta armata[69] (o questo pacifista ritiene che il popolo vietnamita non sia stato in grado di aver compiuto da solo il popolarissimo passo verso la resistenza violenta, o lo incolpa anche lui). Si ha l’impressione che se più rom, ebreɜ, gay e altrɜ avessero resistito violentemente all’Olocausto, lɜ pacifistɜ avrebbero trovato conveniente attribuire anche quel piccolo fenomeno all’assenza di un’opposizione esclusivamente pacifista.
Predicando la nonviolenza e abbandonando alla repressione statale coloro che non ascoltano obbedienti, lɜ attivistɜ bianchɜ che pensano di essere preoccupatɜ per il razzismo stanno in realtà mettendo in atto una relazione paternalistica e svolgendo l’utile ruolo di pacificare le persone oppresse. La pacificazione, attraverso la nonviolenza, delle persone razzializzate si interseca con la preferenza delle strutture di potere della supremazia bianca per disarmare lɜ oppressɜ. I celebri leader dei diritti civili, incluso King, furono fondamentali per la strategia del governo nell’isolare e distruggere attivistɜ nerɜ militanti e manipolare il resto per sostenere un’agenda indebolita e filogovernativa incentrata sulla registrazione degli elettori. Infatti, la NAACP e il Southern Christian Leadership Council (SCLC) furono pagati dal governo per i loro servizi,[70] e lo Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) dipendeva in gran parte dalle donazioni di ricchɜ benefattrici liberali, che perse quando adottò una posizione più militante, fattore che contribuì al suo collasso.[71]
Un secolo prima, una delle principali attività del Ku Klux Klan negli anni successivi alla guerra civile, era quello di disarmare l’intera popolazione nera del Sud rubando qualsiasi arma riuscissero a trovare tra le persone nere appena “liberate”, spesso con l’assistenza della polizia. In effetti, il Klan ha agito in gran parte come una forza paramilitare per lo stato nei tempi dei disordini, e sia il KKK sia le forze di polizia degli Stati Uniti hanno radici nelle pattuglie dell’anteguerra, che terrorizzarono regolarmente le persone nere come forma di controllo in ciò che potrebbe essere descritto come il metodo originario di profilazione razziale.[72] Oggi, con la sicurezza della gerarchia razziale assicurata, il KKK è passato in secondo piano, la polizia conserva le loro armi e lɜ pacifistɜ che si considerano alleatɜ esortano le persone nere a non riarmarsi, ostracizzando coloro che lo fanno.
Una generazione dopo il fallimento del movimento per i diritti civili, la resistenza nera ha dato vita all’hip-hop che le forze culturali tradizionali come l’industria discografica, i produttori di abbigliamento e i media a scopo di lucro (ovvero le aziende di proprietà di bianchɜ) capitalizzano e acquistano. Queste forze culturali capitaliste, che sono state protette dal disarmo delle persone nere e arricchite dalla loro schiavitù in evoluzione, diventano pacifiste e denunciano la prevalenza di canzoni che parlano di sparare (alle spalle) degli sbirri. Lɜ artistɜ hip-hop legatɜ alle principali etichette discografiche abbandonano in gran parte l’esaltazione della violenza antistatale e la sostituiscono con un aumento della più modaiola violenza contro le donne. La comparsa della nonviolenza, nel caso di persone nere che non si armano o che sostengono la lotta contro la polizia, è infatti il riflesso del trionfo di una violenza precedente.
La massiccia violenza interpersonale del KKK ha creato un cambiamento materiale che è mantenuto dalla violenza sistematizzata e meno visibile della polizia. Allo stesso tempo, il potere culturale delle élite bianche, a sua volta acquisito e preservato attraverso ogni sorta di violenza economica e governativa, viene utilizzato per cooptare la cultura nera per favorire la celebrazione di alcuni degli stessi costrutti ideologici che giustificavano in primo luogo il rapimento, la riduzione in schiavitù e il linciaggio delle persone nere, incanalando la rabbia di generazioni di abusi in cicli di violenza all’interno delle stesse comunità nere, piuttosto che permettere che essa fomenti la violenza contro le autorità fin troppo meritevoli. Nella dinamica di potere descritta in questo breve riassunto storico, e in tante altre storie di oppressione razziale, le persone che insistono sulla nonviolenza tra lɜ oppressɜ, se devono avere un ruolo, finiscono per svolgere le veci della supremazia bianca, che lo vogliano o no.
Robert Williams ha fornito un’alternativa a questa eredità del disarmo. Purtroppo, la sua storia è esclusa dalla narrativa dominante che si trova nei libri di testo scolastici approvati dallo stato e, se lɜ sostenitrici della nonviolenza hanno qualcosa da dire al riguardo, è anche esclusa dall’auto-narrazione del movimento e dalla comprensione della sua stessa storia. A partire dal 1957, Robert Williams ha armato il gruppo del NAACP a Monroe, nella Carolina del Nord, per respingere gli attacchi del Ku Klux Klan e della polizia. Williams influenzò la formazione di altri gruppi armati di autodifesa, inclusi i Deacons for Defence and Justice, che crebbero fino ad includere cinquanta gruppi in tutto il Sud che proteggevano le comunità nere e lɜ attivistɜ per i diritti civili.[73] Sono esattamente questo tipo di storie che lɜ pacifistɜ bianchɜ ignorano o cancellano. La nonviolenza nelle mani delle persone bianche è stata e continua ad essere un’impresa coloniale. Le élite bianche istruiscono lɜ nativɜ su come gestire le loro economie e governi, mentre lɜ dissidenti bianchɜ istruiscono lɜ nativɜ su come gestire la loro resistenza. Il 20 aprile 2006, un co-fondatore di Food Not Bombs (FNB), il gruppo antiautoritario a maggioranza bianca che serve cibo gratis nei luoghi pubblici attraverso un centinaio di gruppi (principalmente in Nord America, Australia ed Europa), ha inviato una richiesta di supporto per il nuovo gruppo della FNB in Nigeria:
Questo marzo il co-fondatore di Food Not Bombs Keith McHenry e il volontario locale nigeriano Yinka Dada hanno visitato le persone che soffrono all’ombra delle raffinerie di petrolio della Nigeria. Nonostante le condizioni nella regione siano terribili, le bombe non sono un buon modo per migliorarle. La crisi in Nigeria ha contribuito a far raggiungere al petrolio la cifra record di 72 dollari al barile. È comprensibile che le persone siano frustrate dal fatto che i profitti delle loro risorse stiano arricchendo le aziende straniere mentre il loro ambiente è inquinato e vivono in povertà. Food Not Bombs offre una soluzione nonviolenta.[74]
La richiesta di sostegno di Food Not Bombs ha condannato le azioni della milizia ribelle MEND – Movimento per l’Emancipazione del Delta del Niger – che cerca l’autonomia per il popolo Ijaw e la fine della distruttiva industria petrolifera (mentre FNB “ha accolto con favore l’annuncio di nuovi posti di lavoro da parte del presidente nigeriano Olusegun Obasanjo nella Regione del Delta” dai proventi petroliferi). Il MEND aveva rapito diversɜ dipendenti di compagnie petrolifere straniere (statunitensi ed europee) per chiedere la fine della repressione governativa e dello sfruttamento aziendale (gli ostaggi sono stati rilasciati illesi).
Curiosamente, pur condannando il rapimento, Food Not Bombs ha omesso di menzionare il bombardamento – da parte dell’esercito nigeriano sotto il presidente Obasanjo – di diversi villaggi Ijaw ritenuti sostenitori del MEND. E mentre non ci sono prove che la “soluzione nonviolenta” che dicono di “offrire” farà qualcosa per liberare lɜ nigerianɜ dallo sfruttamento e dall’oppressione che subiscono, se la nonviolenza fosse attuata tra lɜ nigerianɜ, ciò eviterebbe sicuramente la “crisi” del governo e farebbe calare i prezzi del petrolio il che, suppongo, renderebbe le cose più pacifiche in Nord America.
Di fronte alla totale repressione del sistema suprematista bianco, all’evidente inutilità del processo politico e agli spudorati sforzi di un’élite dissidente per sfruttare e controllare la rabbia dellɜ oppressɜ, non dovrebbe sorprendere che «le persone colonizzate trovino la loro libertà attraverso la violenza», per usare le parole di Frantz Fanon, il medico proveniente da Martinica e autore di una delle opere più importanti sulla lotta al colonialismo.[75]
La maggior parte dellɜ bianchɜ ha abbastanza privilegi e libertà d’azione da poter scambiare queste catene generosamente lunghe e imbottite di velluto per libertà, quindi ci agitiamo comodamente all’interno dei parametri della società democratica (i cui confini sono composti da forze razziali, economiche, sessuali e strutture governative). Alcunɜ di noi si sbagliano ulteriormente nel presumere che tutte le persone affrontino queste stesse circostanze aspettandosi che le persone razzializzate esercitino privilegi che in realtà non hanno. Ma al di là della necessità strategica di attaccare lo stato con tutti i mezzi a nostra disposizione, quellɜ di noi che si trovano di fronte alle quotidiane intimidazioni, al degrado e alla subordinazione della polizia non hanno forse considerato l’effetto edificante del reagire con forza? Frantz Fanon scrive, a proposito della psicologia del colonialismo e della violenza nel perseguimento della liberazione, “A livello individuale, la violenza [come parte della lotta di liberazione] è una forza purificatrice. Libera lə nativə dal suo complesso di inferiorità... e dalla sua disperazione e inerzia; lə rende impavidə e ripristina il rispetto di sé”.[76]
Ma le persone fautrici della nonviolenza che provengono da ambienti privilegiati, con comodità materiali e psicologiche garantite e protette da un ordine violento, non crescono con un complesso di inferiorità violentemente martellato in loro. L’arroganza dellɜ pacifistɜ nel credere di poter dettare quali forme di lotta sono morali ed efficaci per le persone che vivono in circostanze molto diverse e molto più violente è sbalorditiva. Lɜ bianchɜ di periferia che insegnano allɜ bambinɜ del campo profughi di Jenin o dei campi di sterminio colombiani sulla resistenza hanno una sorprendente somiglianza, diciamo, con gli economisti della Banca mondiale che dettano le “buone” pratiche agricole allɜ agricoltori indianɜ che hanno ereditato tradizioni agricole secolari. E il rapporto benevolo delle persone privilegiate con i sistemi globali di violenza dovrebbe sollevare seri interrogativi sulla sincerità delle persone privilegiate, in questo caso lɜ bianchɜ, che sposano la nonviolenza. Per citare ancora Darren Parker: “L’apparenza di uno spirito nonviolento è molto più facile da ottenere quando non si è il destinatario diretto dell’ingiustizia, e questa può infatti semplicemente rappresentare una distanza psicologica. Dopotutto, è molto più facile “amare il tuo nemico” quando non è in realtà il tuo nemico.”[77]
Sì, le persone nere, quelle povere e quelle provenienti del Sud del mondo hanno sostenuto la nonviolenza (sebbene in genere tali pacifistɜ provengano da strati più privilegiati delle loro comunità); tuttavia, solo attraverso un senso di superiorità altamente attivo lɜ attivistɜ bianchɜ possono giudicare e condannare le persone oppresse che non lo fanno. È vero, indipendentemente dal privilegio, dovremmo essere in grado di fidarci della nostra analisi. Ma quando tale analisi si basa su una dubbia superiorità morale e un’interpretazione opportunamente selettiva di ciò che costituisce la violenza, è probabile che la nostra autocritica si sia addormentata sul lavoro. Quando comprendiamo che le persone privilegiate traggono benefici materiali dallo sfruttamento delle persone oppresse, e che questo significa che beneficiamo della violenza usata per reprimerle, non possiamo sinceramente condannarle per essersi ribellate violentemente contro la violenza strutturale che ci privilegia (coloro che hanno mai condannato la resistenza violenta di persone cresciute in circostanze più oppressive di loro dovrebbero pensarci la prossima volta che mangiano una banana o bevono una tazza di caffè).
Spero si capisca bene che il governo per sopprimere la resistenza usa forme di repressione più violente contro le persone nere che contro quelle bianche. Quando negli anni ’70 i tradizionalisti Oglala e l’American Indian Movement si alzarono nella riserva di Pine Ridge per affermare la loro indipendenza e per organizzarsi contro il bullismo endemico del “governo tribale” imposto, il Pentagono, l’FBI, i marescialli statunitensi e il Bureau of Indian Affairs istituirono un vero e proprio programma di controinsurrezione che provocò violenze quotidiane e dozzine di morti. Secondo Ward Churchill e Jim Vander Wall, “Il principio dell’autodifesa armata era diventato, per lɜ dissidenti, una necessità di sopravvivenza”.[78]
Lɜ unichɜ sostenitrici della nonviolenza che io abbia mai sentito rifiutare persino la legittimità dell’autodifesa erano bianchɜ, e sebbene possano sostenere il loro Oscar Romeros, loro e le loro famiglie non hanno visto la loro sopravvivenza minacciata a causa del loro attivismo.[79]
Faccio fatica a credere che la loro avversione alla violenza abbia tanto a che fare con i principi quanto con il privilegio e l’ignoranza.
E al di là della semplice autodifesa, se gli individui hanno affrontato la possibilità di dover combattere per sopravvivere o per migliorare la propria vita dipende in gran parte dal colore della loro pelle e dal loro posto nelle varie gerarchie di oppressione nazionali e globali. Sono queste esperienze che la nonviolenza ignora trattando la violenza come una questione morale o una scelta. L’alternativa culturalmente sensibile all’interno del pacifismo è che lɜ attivistɜ privilegiatɜ permettano, o addirittura sostengano, la resistenza militante nel Sud del mondo, e possibilmente nelle colonie interne degli stati euro/americani, sostenendo quindi la nonviolenza solo con persone con un simile background privilegiato. Questo tipo di formulazione presenta un nuovo razzismo, suggerendo che i combattimenti e la morte siano condotti da persone razzializzate negli stati più apertamente oppressivi del Sud del mondo, mentre lɜ cittadinɜ privilegiatɜ dei centri imperiali possono accontentarsi di forme di resistenza contestualmente più appropriate come manifestazioni di protesta e sit-in.
Un’analisi antirazzista, d’altra parte, richiede alle persone bianche di riconoscere che la violenza contro la quale le persone razzializzate devono difendersi ha origine nel “Primo Mondo” bianco. Pertanto, un’adeguata resistenza contro un regime che fa la guerra contro lɜ colonizzatɜ in tutto il mondo, significa portare la guerra a casa, costruire una cultura antiautoritaria, cooperativa e antirazzista tra lɜ bianchɜ, attaccare le istituzioni dell’imperialismo, ed estendere il sostegno nella resistenza alle persone oppresse senza indebolire la sovranità della loro lotta. Tuttavia, lɜ pacifistɜ non assolutistɜ che ammettono un po’ di relativismo culturale sono in genere meno propensɜ a sostenere la rivoluzione armata quando i combattimenti si avvicinano a casa. Il pensiero è che lɜ palestinesi, ad esempio, possono impegnarsi in una lotta militante perché vivono sotto un regime violento, ma per lɜ residenti brutalizzatɜ del ghetto urbano più vicino, formare unità di guerriglia sarebbe “inappropriato” o “irresponsabile”. Questa è la tendenza del “non farlo nel mio cortile” che è alimentata dal riconoscimento che una rivoluzione lì sarebbe entusiasmante, ma una rivoluzione qui priverebbe lɜ attivistɜ privilegiatɜ del loro comfort. È presente anche la paura latente dell’insurrezione razziale, che viene placata solo quando è subordinata ad un’etica nonviolenta. Le persone nere che marciano sono fotogenichɜ. Le persone nere con le pistole evocano i violenti rapporti sui crimini nei notiziari notturni. Lɜ indianɜ d’America che tengono una conferenza stampa sono lodevoli. Lɜ indianɜ d’America pronti e in grado di riprendersi la loro terra sono un po’ inquietanti.
Pertanto, il sostegno e la familiarità dei popoli bianchi per lɜ rivoluzionariɜ razzializzatɜ sul fronte interno è limitato allɜ martiri inerti: i morti e lɜ carceratɜ.
La contraddizione nel pacifismo apparentemente rivoluzionario è che la rivoluzione non è mai sicura, ma per la stragrande maggioranza dellɜ suɜ praticanti e sostenitrici, il pacifismo significa stare al sicuro, non farsi male, non alienare nessunə, non dare a nessunə una pillola amara da ingoiare. Nel fare il collegamento tra il pacifismo e l’autoconservazione dellɜ attivistɜ privilegiatɜ, Ward Churchill cita un’organizzatore pacifista durante l’era del Vietnam che denunciò le tattiche rivoluzionarie del Black Panther Party e di Weather Underground perché “queste tattiche sono una cosa davvero pericolosa per tuttɜ noi... corrono il rischio molto reale di portare lo stesso tipo di repressione violenta [come si è visto nell’assassinio di Fred Hampton da parte della polizia] su tuttɜ noi”.[80] O, per citare David Gilbert, che sta scontando un ergastolo per le sue azioni come membro della Weather Underground che ha poi sostenuto il Black Liberation Army, “Lɜ bianchɜ avevano qualcosa da proteggere. Era comodo essere al culmine di un movimento moralmente prestigioso per il cambiamento mentre lɜ nerɜ subivano le principali perdite nella lotta.”[81]
Il desiderio pacifista di sicurezza continua ancora oggi. Nel 2003, un’attivista nonviolentə rassicurò un giornale di Seattle sul carattere delle proteste pianificate. “Non sto dicendo che non sosterremmo la disobbedienza civile”, ha detto Woldt, “ha fatto parte del movimento per la pace in cui si sono impegnate le persone della chiesa, ma non ci occupiamo di danni alla proprietà o di qualsiasi cosa che crei conseguenze negative per noi”.[82]
E su una lista per una campagna ambientalista radicale nel 2004, unə studentə di giurisprudenza e attivista, dopo aver avviato una discussione aperta sulle tattiche, ha vietato la menzione di tattiche non pacifiste e ha chiesto una stretta adesione alla nonviolenza sulla base del fatto che i gruppi non-pacifisti “vengano annientati”.[83]
Un’altrə attivista (e, per inciso, uno dellə altrə studentə di giurisprudenza nella lista) ha concordato, aggiungendo: “Penso che avere una discussione sulle tattiche violente in questa lista sia giocare con il fuoco e stia mettendo tuttɜ a rischio”. Era anche preoccupatə, “due di noi affronteranno la camera stellare del comitato etico dell’Ordine dellɜ avvocatɜ in un futuro prossimo”.[84] Naturalmente, le persone militanti devono capire che c’è un grande bisogno di cautela quando discutiamo di tattiche, specialmente via e-mail, e che affrontiamo l’ostacolo di creare sostegno per azioni che hanno maggiori probabilità di farci molestare o imprigionare, anche se tutto ciò che facciamo è discuterne. Tuttavia, in questo esempio, lɜ due studentɜ di giurisprudenza non stavano dicendo che il gruppo avrebbe dovuto discutere solo di tattiche legali o tattiche ipotetiche, stavano dicendo che il gruppo avrebbe dovuto discutere solo di tattiche nonviolente. Dal momento che era stata pubblicizzata come una discussione per aiutare il gruppo a creare un terreno ideologico comune, questo era un modo manipolativo di usare le minacce della repressione del governo per impedire al gruppo anche solo di prendere in considerazione qualcosa di diverso da una filosofia esplicitamente nonviolenta.
A causa del forte interesse personale delle persone bianche nel prevenire rivolte rivoluzionarie nel proprio cortile, c’è stata una lunga storia di tradimento da parte dellɜ pacifistɜ bianchɜ che hanno condannato e abbandonato alla violenza di stato gruppi rivoluzionari. Piuttosto che “mettersi in pericolo” per proteggere i membri dei movimenti di liberazione neri, marroni e rossi (una protezione che il loro privilegio avrebbe potuto conferire adeguatamente, a causa di quanto sarebbe stato costoso per il governo uccidere lɜ bianchɜ ricchɜ nel mezzo di tutti i dissensi provocati dalle pesanti perdite in Vietnam), lɜ pacifistɜ coscienziosɜ ignorarono la brutalizzazione, l’imprigionamento e l’assassinio dellɜ Black Panthers, dellɜ attivistɜ dell’American Indian Movement e di altrɜ. Peggio ancora, incoraggiarono la repressione statale e affermarono che lɜ rivoluzionariɜ se la meritavano impegnandosi nella resistenza militante (oggi, affermano che la sconfitta definitiva dei gruppi liberazionisti, facilitata dallɜ pacifistɜ, è la prova dell’inefficacia delle tattiche di tali gruppi).
Il venerato pacifista David Dellinger ammette che “uno dei fattori che induce lɜ rivoluzionariɜ seriɜ e lɜ abitanti scoraggiatɜ dei ghetti a concludere che la nonviolenza non possa essere sviluppata in un metodo adeguato alle loro esigenze è proprio questa tendenza dellɜ pacifistɜ a schierarsi, nei momenti di conflitto, con lo status quo.”[85]
David Gilbert conclude che “l’incapacità di sviluppare la solidarietà con lɜ nerɜ e con altre lotte di liberazione all’interno degli Stati Uniti (nativɜ americanɜ, chicanɜ/messicanɜ, portoricanɜ) è uno dei numerosi fattori che causò il crollo del nostro movimento a metà degli anni ’70”.[86] Mumia Abu-Jamal chiede se lɜ radicali bianchɜ fossero davvero prontɜ a intraprendere una rivoluzione, una che non premiasse lɜ bianchɜ.[87]
All’inizio, la nonviolenza sembra una chiara posizione morale che ha poco a che fare con la “razza”. Questa si basa sul presupposto semplicistico che la violenza sia innanzitutto qualcosa che noi scegliamo. Ma quali persone in questo mondo hanno il privilegio di scegliere la violenza e quali persone vivono in circostanze violente, che lo vogliano o meno? In generale, la nonviolenza è una pratica da persone privilegiate, che nasce privilegiata, che nasce dall’esperienza delle persone bianche, e non sempre ha senso per chi non ha il privilegio bianco o per chi non ha il privilegio della violenza per lɜ bianche che cercano di distruggere il regime di privilegio e di oppressione.
Molte persone razzializzate hanno anche fatto ricorso alla nonviolenza, che in alcune circostanze è stata un modo efficace per rimanere al sicuro di fronte alla discriminazione violenta, cercando al contempo riforme limitate che non cambiano in definitiva la distribuzione del potere nella società. L’uso della nonviolenza da parte delle persone razzializzate è stato generalmente un compromesso con la struttura del potere bianco. Riconoscendo che la struttura di potere bianca preferisce che lɜ oppressɜ siano nonviolentɜ, alcune persone hanno scelto tattiche nonviolente per evitare repressioni estreme, massacri o addirittura genocidi. I movimenti di liberazione delle persone razzializzate che perseguono pacificamente obiettivi rivoluzionari hanno tendenzialmente utilizzato una forma di nonviolenza meno assoluta, più conflittuale e pericolosa, rispetto al tipo di nonviolenza conservata oggi in Nord America [n.d.t. e in Europa]. Anche in questo caso, la pratica della nonviolenza è spesso sovvenzionata dallɜ bianchɜ al potere,[88] utilizzata da dissidenti bianchɜ o da funzionariɜ governativɜ per manipolare il movimento a loro vantaggio, e di solito abbandonata da ampie porzioni della popolazione a favore di tattiche più militanti. L’uso della nonviolenza per preservare il privilegio bianco, all’interno del movimento o della società in generale, è ancora oggi comune.
A ben vedere, la nonviolenza si rivela invischiata in dinamiche di etnia e di potere. L’etnia di appartenenza è essenziale per la nostra esperienza di oppressione e di resistenza. Una componente di lunga data del razzismo è stata la presunzione che gli europei, o i coloni europei in altri continenti, sapessero cosa fosse meglio per le persone che consideravano “meno civilizzate”. Le persone che lottano contro il razzismo devono inequivocabilmente porre fine a questa tradizione e riconoscere che l’imperativo per ogni comunità di essere in grado di determinare la propria forma di resistenza sulla base delle proprie esperienze lascia qualsiasi priorità data al pacifismo nella polvere. Inoltre, il fatto che gran parte delle violenze subite dalle persone razzializzate in tutto il mondo abbiano origine nella struttura di potere che privilegia le persone bianche dovrebbe dare a quest’ultime una maggiore urgenza nello spingere i limiti del livello di militanza considerato accettabile nelle comunità bianche. In altre parole, per quellɜ di noi che sono bianchɜ, diventa nostro dovere costruire una nostra cultura militante di resistenza e, contrariamente al ruolo di insegnanti storicamente attribuito allɜ bianchɜ, abbiamo molto da imparare dalle lotte delle persone razzializzate. Lɜ radicali bianchɜ devono educare lɜ altrɜ bianchɜ sul motivo per cui le persone razzializzate sono giustificate a ribellarsi violentemente e perché anche noi dovremmo usare una diversità di tattiche per liberarci, lottare in solidarietà con tuttɜ coloro che hanno rifiutato il loro posto come lacchè o schiavɜ dell’élite e porre fine a questi sistemi globali di oppressione e sfruttamento.
La nonviolenza è statalista
In parole povere, la nonviolenza assicura il monopolio statale sulla violenza. Gli stati – e le burocrazie centralizzate che proteggono il capitalismo, preservano un ordine patriarcale e suprematista bianco e attuano l’espansione imperialista – sopravvivono assumendo il ruolo di unico fornitore legittimo di forza violenta all’interno del loro territorio. Ogni lotta contro l’oppressione richiede un conflitto con lo stato. Lɜ pacifistɜ fanno il lavoro dello stato pacificando in anticipo l’opposizione.[89] Gli stati, da parte loro, scoraggiano la militanza all’interno dell’opposizione e incoraggiano la passività. Acunɜ pacifistɜ nascondono questo rapporto sostenendo che il governo sarebbe felice di vederlɜ abbandonare la loro disciplina nonviolenta e cedere alla violenza, che il governo addirittura incoraggerebbe la violenza dellɜ dissidenti e che moltɜ attivistɜ che esortano alla militanza provochino il governo.[90] Quindi, sostengono, sono lɜ attivistɜ militanti a fare il gioco dello stato. Sebbene in alcuni casi il governo degli Stati Uniti si sia servito di infiltratɜ per incoraggiare i gruppi di resistenza a prendere le armi o a pianificare azioni violente (ad esempio, nei casi di Molly Maguires e del tentato assalto al tribunale[91] da parte di Jonathan Jackson), è necessario fare una cruciale distinzione. Il governo incoraggia la violenza solo quando è certo che essa possa essere contenuta e non possa sfuggire di mano. In ultima analisi, far sì che un gruppo di resistenza militante agisca prematuramente o cada in una trappola elimina il potenziale violento del gruppo garantendo una facile condanna all’ergastolo o permettendo alle autorità di eludere il processo giudiziario e di uccidere lɜ radicali più rapidamente. Nel complesso, e in quasi tutti gli altri casi, le autorità pacificano la popolazione e scoraggiano la ribellione violenta.
C’è una chiara ragione per tutto ciò. Contrariamente alle vuote affermazioni dellɜ pacifistɜ, secondo le quali esse – in qualche modo – si rafforzerebbero tagliando fuori la maggior parte delle loro opzioni tattiche, i governi di tutto il mondo riconoscono che l’attivismo rivoluzionario senza vincoli rappresenta la più grande minaccia in grado di cambiare la distribuzione del potere nella società. Sebbene lo stato si riservi sempre il diritto di reprimere chi vuole, i moderni governi “democratici” trattano i movimenti sociali nonviolenti con obiettivi rivoluzionari come minacce potenziali, piuttosto che reali. Essi spiano questi movimenti per rimanere sempre al corrente dei loro sviluppi, e usano un approccio carota-e-bastone per indirizzare tali movimenti verso canali del tutto pacifici, legali e inefficaci. I gruppi nonviolenti possono anche essere sottoposti a pestaggi, ma tali gruppi non sono destinati all’eliminazione (se non da parte di governi in regressione o di governi che stanno affrontando un periodo di emergenza che minaccia la loro stabilità).
D’altra parte, lo stato tratta i gruppi militanti (quegli stessi gruppi che lɜ pacifistɜ considerano inefficaci) come minacce reali e cerca di neutralizzarli con operazioni di contro-insurrezione e di guerra interna altamente sviluppate. Centinaia di organizzatrici sindacali, anarchichɜ, comunistɜ e contadinɜ militanti sono statɜ uccisɜ nelle lotte anticapitalistiche della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo.
Durante le lotte di liberazione dell’ultima generazione, i paramilitari sostenuti dall’FBI uccisero sessanta attivistɜ e sostenitrici dell’American Indian Movement (AIM) nella sola riserva di Pine Ridge, e l’FBI, la polizia locale e agenti assoldati uccisero decine di membri del Black Panther Party, Republic of New Afrika, dell’Esercito di Liberazione Nero e di altri gruppi.[92]
Durante il periodo del COINTELPRO furono mobilitate vaste risorse per infiltrare e distruggere le organizzazioni rivoluzionarie militanti. Qualsiasi accenno di organizzazione militante da parte di popoli colonizzati, portoricani, e altri all’interno della sfera d’influenza territoriale degli Stati Uniti è tuttora oggetto di una violenta repressione. Prima dell’11 settembre, l’FBI aveva nominato lɜ sabotatrici e lɜ piromani dell’Earth Liberation Front (ELF) e dell’Animal Liberation Front (ALF) come le maggiori minacce terroristiche domestiche, nonostante questi due gruppi avessero ucciso esattamente zero persone. Sin dopo gli attentati al World Trade Center e al Pentagono, l’ELF e l’ALF sono rimasti una priorità per la repressione governativa, come testimoniano gli arresti di oltre una dozzina di presunti membri dell’ELF/ALF, l’accordo di moltɜ di questɜ prigionierɜ a diventare informatrici dopo che unə di loro morì in un suicidio sospetto e tuttɜ loro vennero minacciatɜ con l’ergastolo, e l’incarcerazione di diversi membri di un noto gruppo animalista per aver perseguitato un’azienda di vivisezione con un boicottaggio aggressivo – che il governo definì “terrorismo animalista”.[93] E in un momento in cui la sinistra si scandalizzava per il fatto che la polizia e l’esercito spiassero i gruppi pacifisti, molta meno attenzione veniva data alla continua repressione da parte del governo del movimento di liberazione portoricano, incluso l’assassinio da parte dell’FBI del leader machetero Filiberto Ojeda Rios.[94]
Ma non dobbiamo dedurre le opinioni e le priorità dell’apparato di sicurezza dello stato dalle azioni dei suoi agenti. Possiamo fidarci della loro parola. I documenti COINTELPRO dell’FBI – resi pubblici solo perché nel 1971 alcunɜ attivistɜ si introdussero in un ufficio dell’FBI in Pennsylvania e li rubarono – dimostrano chiaramente che uno dei principali obiettivi dell’FBI fosse quello di mantenere passivɜ lɜ potenziali rivoluzionariɜ. In un elenco di cinque obiettivi relativi ai gruppi nazionalisti e di liberazione nera, negli anni ’60, l’FBI incluse il seguente:
Prevenire la violenza da parte dei gruppi nazionalisti neri. Questo è di primaria importanza ed è, ovviamente, un obiettivo della nostra attività investigativa; dovrebbe essere anche un obiettivo del Programma di Controspionaggio [nel gergo governativo originale, questa frase fa riferimento ad una specifica operazione, delle quali ve ne erano migliaia, e non al programma generale]. Attraverso il controspionaggio dovrebbe essere possibile individuare lɜ potenziali sovversivɜ e neutralizzarlɜ prima che esercitino il loro potenziale violento.[95]
Nell’identificare le “neutralizzazioni” riuscite in altri documenti, l’FBI usa questo termine per includere lɜ attivistɜ che furono assassinatɜ, imprigionatɜ, incastratɜ, screditatɜ o perseguitatɜ fino a quando non cessarono di essere politicamente attivɜ. Il documento elenca anche l’importanza di prevenire l’ascesa di un “messia” nero. Dopo aver notato che Malcolm X avrebbe potuto ricoprire questo ruolo – divenuto invece il martire del movimento – il rapporto nominò tre leader neri che avrebbero avuto il potenziale per diventare quel messia. Uno dei tre “potrebbe essere un concorrente molto valido per questa posizione se dovesse abbandonare la sua presunta obbedienza alle dottrine bianche e liberali (la nonviolenza)” [parentesi nell’originale]. Il comunicato spiega anche la necessità di screditare lɜ nerɜ militanti agli occhi della “comunità Negra responsabile” e della “comunità bianca”. Questo dimostra sia come lo stato possa contare su una istintiva condanna della violenza da parte dellɜ pacifistɜ, sia come queste ultime facciano effettivamente il lavoro sporco dello stato non riuscendo a usare la loro influenza culturale per rendere la resistenza militante alla tirannia “rispettabile”. Al contrario, lɜ pacifistɜ sostengono che la militanza allontani le persone, e non fanno nulla per cercare di contrastare questo fenomeno.
Un altro dossier dell’FBI, stavolta sull’attivista del Movimento Indiano d’America John Trudell, mostra la stessa convinzione da parte della polizia politica dello stato che lɜ pacifistɜ siano una sorta di dissidenti inertɜ che non rappresentano ancora una minaccia per l’ordine costituito. “TRUDELL ha la capacità di riunirsi con un gruppo di pacifistɜ e in poco tempo far loro urlare e gridare “d’accordo!”. In breve, è un agitatore estremamente efficiente.[96] Il governo dimostra costantemente che preferisce scontrarsi con un’opposizione pacifica. Molto più recentemente, un promemoria dell’FBI inviato alle forze dell’ordine locali in tutto il Paese, e successivamente divulgato alla stampa, chiarisce chi il governo identifica come estremistə e chi mette in cima alla lista per la neutralizzazione.
Il 25 ottobre 2003 sono previste marce e manifestazioni di massa contro l’occupazione in Iraq a Washington, DC e a San Francisco, California... esiste la possibilità che degli elementi della comunità dellɜ attivistɜ possano intraprendere atti violenti, distruttivi o di disturbo...
Tra le tradizionali tattiche di dimostrazione con cui lɜ manifestanti attirano l’attenzione sulle loro cause vi sono marce, striscioni e forme di resistenza passiva come i sit-in... Gli elementi estremisti potrebbero attuare tattiche più aggressive che possono includere vandalismo, molestie fisiche ai delegati, sconfinamenti, formazione di catene o scudi umani, barricate improvvisate, dispositivi utilizzati contro le unità di polizia a cavallo, e l’uso di armi – come proiettili e bombe artigianali.[97]
La maggior parte del rapporto si concentra su questi elementi estremisti chiaramente identificati come attivistɜ che impiegano una diversità di tattiche rispetto allɜ attivistɜ pacifistɜ, lɜ quali non sono identificatɜ come una minaccia importante.
Secondo il documento, lɜ estremistɜ presentano le seguenti caratteristiche identificative.
Lɜ estremistɜ possono essere prontɜ a difendersi contro gli agenti delle forze dell’ordine durante una manifestazione. Le maschere (antigas, occhiali, sciarpe, subacquee, filtranti e occhiali da sole) possono servire a minimizzare gli effetti dei gas lacrimogeni e dello spray al peperoncino, oltre che a nascondere la propria identità. Lɜ estremistɜ possono anche utilizzare scudi (coperchi di bidoni della spazzatura, lastre di plexiglass, camere d’aria di pneumatici di camion, ecc.) e dispositivi per la protezione del corpo (indumenti a strati, elmetti e cappelli rigidi, attrezzature sportive, giubbotti di salvataggio, ecc.) per proteggersi durante i cortei. Lɜ attivistɜ possono anche utilizzare tecniche di intimidazione come la videoregistrazione e l’assembramento di agenti di polizia per impedire l’arresto di altrɜ manifestanti. Dopo le manifestazioni, lɜ attivistɜ sono solitamente riluttanti a collaborare con le forze dell’ordine. Raramente portano con sé documenti di identificazione e spesso si rifiutano di divulgare informazioni su di sé o su altrɜ manifestanti...
Le forze dell’ordine dovrebbero prestare attenzione a questi possibili indicatori di attività di protesta e segnalare qualsiasi atto potenzialmente illegale alla più vicina Joint Terrorism Task Force dell’FBI.[98]
Quanto è triste che il segno distintivo di un’“estremista” sia la volontà di difendersi dagli attacchi della polizia, e quanta responsabilità hanno lɜ pacifistɜ nell’aver determinato questa situazione?
In ogni caso, disconoscendo e persino denunciando lɜ attivistɜ che utilizzano una pluralità di tattiche, lɜ pacifistɜ rendono tali militanti vulnerabili alla repressione che le agenzie di polizia vogliono chiaramente usare contro di loro.
Come se non fosse abbastanza scoraggiare la militanza e condizionare lɜ dissidenti all’uso della nonviolenza attraverso la repressione violenta dellɜ indisciplinatɜ, il governo oltretutto inietta il pacifismo nei movimenti di ribellione in maniera più diretta.
Due anni dopo l’invasione dell’Iraq, l’esercito americano fu sorpreso a interferire ancora una volta con i media iracheni (l’interferenza precedente comprendeva il bombardamento di media ostili, la pubblicazione di false storie e la creazione di agenzie mediatiche in lingua araba completamente nuove, come al-Hurriyah, le quali sarebbero state gestite dal Dipartimento della Difesa come parte delle loro operazioni psicologiche).
Questa volta il Pentagono pagò per inserire nei giornali iracheni articoli che esortavano all’unità (contro lɜ insortɜ) e alla nonviolenza.[99] Gli articoli furono scritti come se lɜ autrici fossero irachenɜ, nel tentativo di contenere la resistenza militante e di manipolare lɜ irachenɜ per indurlɜ verso forme diplomatiche di opposizione che sarebbero state più facili da cooptare e controllare.
L’uso selettivo del pacifismo da parte del Pentagono in Iraq può servire da parabola per le origini più ampie della nonviolenza. In particolare, essa proviene dallo stato. Una popolazione conquistata viene educata alla nonviolenza attraverso il rapporto con una struttura di potere che ha rivendicato il monopolio sul diritto di usare la violenza. È l’accettazione, da parte dellɜ esautoratɜ, della convinzione statalista che le masse debbano essere spogliate delle loro capacità naturali di azione diretta, compresa la propensione all’autodifesa e all’uso della forza – pena la discesa nel caos – in una spirale di violenza, nel farsi del male e nell’oppressione reciproca.
Tale è la tutela del governo e la libertà della schiavitù. Solo un popolo addestrato ad accettare di essere governato da una struttura di potere violenta può davvero mettere in discussione il diritto e il bisogno di qualcunə di difendersi con la forza dall’oppressione. Il pacifismo è anche una forma di impotenza appresa, attraverso la quale lɜ dissidenti conservano la benevolenza dello stato, dimostrando di non avere usurpato poteri che lo stato rivendica in via esclusiva (come la legittima difesa).
In questo modo, unə pacifista si comporta come un cane ben addestrato che viene picchiato dal padrone: invece di mordere il suo aggressore, abbassa la coda e segnala la sua innocuità, rassegnandosi alle percosse nella speranza che cessino.
In modo più diretto, Frantz Fanon descrive le origini e la funzione della nonviolenza all’interno del processo di decolonizzazione quando scrive:
La borghesia colonialista introduce quella nuova idea che è, più precisamente, una creazione della realtà coloniale: la nonviolenza. Nella sua forma più semplice, questa nonviolenza significa per l’élite intellettuale ed economica del paese colonizzato che la borghesia ha i suoi stessi interessi... La nonviolenza è un tentativo di risolvere il problema coloniale attorno a un tavolo di velluto verde, prima che sia stato compiuto un atto deplorevole… prima che sia stato versato del sangue. Ma se le masse, senza aspettare che le sedie vengano disposte intorno al suddetto tavolo, ascoltassero la propria voce e cominciassero a scatenare rivolte e incendiare edifici, vedremmo l’élite e i partiti nazionalisti borghesi precipitarsi dai colonialisti per esclamare: “È una cosa molto seria! Non sappiamo come andrà a finire; dobbiamo trovare una soluzione, un qualche tipo di compromesso”.[100]
Questo consenso di fondo nei confronti della violenza dello stato, unito allo shock per gli “oltraggi” della ribellione con la forza, induce lɜ pacifistɜ a fare affidamento sulla violenza dello stato per proteggersi. Per esempio, lɜ organizzatrici pacifistɜ esentano la polizia dai “codici di nonviolenza” che sono comuni nelle proteste di questi tempi; non tentano di disarmare la polizia che protegge lɜ manifestanti pacifichɜ dalle contro-dimostranti arrabbiatɜ e favorevoli alla guerra. In pratica, la morale pacifista dimostra che per lɜ radicali sia più accettabile affidarsi alla violenza del governo per proteggersi piuttosto che difendersi da solɜ.
È abbastanza ovvio perché le autorità vogliono che lɜ radicali rimangano vulnerabili.
Ma perché anche lɜ pacifistɜ vogliono ciò? Allɜ sostenitrici della nonviolenza non sono mancate le occasioni per imparare cosa succede allɜ radicali indifesɜ. Prendiamo ad esempio la manifestazione del 1979 contro la supremazia bianca a Greensboro, nella Carolina del Nord. Un assortimento di lavoratrici bianchɜ e nerɜ, organizzatrici sindacali e comunistɜ, accettando la premessa che il disarmo e il monopolio della polizia sulla forza violenta avrebbero garantito la pace, decisero di non portare armi per proteggersi.
Il risultato fu un evento oggi noto come il Massacro di Greensboro. La polizia e l’FBI collaborarono con il Klan e il partito nazista locali per aggredire lɜ manifestanti, che contavano sulla protezione della polizia. Mentre la polizia era opportunamente assente, i suprematisti bianchi attaccarono la marcia e spararono a 13 persone, uccidendone cinque. Quando la polizia tornò sul posto, picchiò e arrestò alcunɜ manifestanti e lasciò che i criminali razzisti tagliassero la corda.[101]
Nel caos di qualsiasi situazione rivoluzionaria, i paramilitari di destra come il Ku Klux Klan sono più che felici di eliminare lɜ radicali. La Legione Americana ha recentemente dichiarato “guerra” al movimento anti-guerra.[102] I precedenti di linciaggio ai danni dellɜ organizzatrici anarchichɜ del lavoro da parte di questa organizzazione, suggeriscono i mezzi che useranno quando la loro amata bandiera sarà minacciata.[103]
Il dibattito tra il pacifismo e la diversità delle tattiche (compresa l’autodifesa e il contrattacco) potrebbe essere deciso se l’attuale movimento antiautoritario si svilupperà fino al punto di rappresentare una minaccia, quando le agenzie di polizia consegneranno le loro liste nere e i paramilitari di destra linceranno tuttɜ lɜ “traditrici” su cui riusciranno a mettere le mani. Questa situazione si è verificata anche in passato, soprattutto negli anni ’20 e, in misura minore, in risposta al movimento per i diritti civili. Speriamo solo che, se il nostro movimento rappresenterà ancora una volta una minaccia, saranno pochɜ le persone che si lasceranno condizionare da un’ideologia che ci rende pericolosamente vulnerabili. Nonostante questa storia di repressione, lɜ sostenitrici della nonviolenza si affidano spesso alla violenza dello stato, non solo per essere protettɜ, ma anche per raggiungere i propri obiettivi.
Se anche questo affidamento non porti sempre a veri e propri disastri come il massacro di Greensboro, non può di certo discolpare la posizione nonviolenta.
Lɜ pacifistɜ che sostengono di astenersi dalla violenza hanno sì aiutato a porre fine alla segregazione nelle scuole e nelle università di tutto il Sud ma, in ultima istanza, furono le unità armate della Guardia Nazionale che permisero allɜ primɜ studentessɜ nerɜ di entrare in queste scuole proteggendolɜ dai tentativi di espulsione con la forza o da cose peggiori.
Se lɜ pacifistɜ non sono in grado di difendere le proprie conquiste, che cosa faranno quando non avranno dalla loro la violenza organizzata della polizia e della Guardia Nazionale? (Per inciso, lɜ pacifistɜ ricorderebbero la desegregazione come un fallimento per la nonviolenza se le famiglie nere avessero avuto bisogno di chiamare i Deacons for Defense – anziché la Guardia Nazionale – per proteggere lɜ loro figliɜ che entravano in quelle scuole per solɜ bianchɜ?). La desegregazione istituzionale è stata ritenuta favorevole alla struttura del potere suprematista bianco perché disinnescava una crisi, aumentava le possibilità di cooptazione della leadership nera e snelliva l’economia, il tutto senza negare la gerarchia razziale così tanto fondamentale per la società statunitense.
Così, la Guardia Nazionale fu chiamata a contribuire alla desegregazione delle università. Non è così difficile immaginare una serie di obiettivi rivoluzionari che la Guardia Nazionale non sarebbe mai stata chiamata a proteggere.
Mentre lɜ pacifistɜ che protestano contro il militarismo statunitense non potranno mai far sì che la polizia o la Guardia Nazionale si limitino ad applicare la legge – eliminando le armi vietate dai trattati internazionali o chiudendo le scuole militari che addestrano i soldati alle tecniche di tortura – il governo trae comunque beneficio dal permettere a queste inutili dimostrazioni di avere luogo.
Permettere la protesta nonviolenta migliora l’immagine dello stato. Che lo vogliano o meno, lɜ dissidenti nonviolentɜ svolgono il ruolo di una leale opposizione in una messinscena che drammatizza il dissenso e crea l’illusione che il governo democratico non sia elitario o autoritario.
Lɜ pacifistɜ dipingono lo stato come benigno, dando all’autorità la possibilità di tollerare una critica che in realtà non minaccia il suo funzionamento. Una colorata, coscienziosa e passiva protesta davanti a una base militare non fa altro che migliorare l’immagine pubblica delle forze armate, perché sicuramente solo un esercito giusto e umano tollererebbe proteste fuori dal suo cancello. Una tale protesta è come un fiore infilato nella canna di un fucile. Non impedisce all’arma di sparare.
Ciò che la maggior parte dellɜ pacifistɜ non sembra capire è che la libertà di parola non ci dà potere e non equivale alla libertà. La libertà di parola è un privilegio[104] che può essere – e viene – tolto dal governo quando serve ai suoi interessi.
Lo stato ha il potere incontrastato di toglierci i nostri “diritti” e la storia dimostra che questo potere viene esercitato con regolarità.[105] Anche nella vita di tutti i giorni possiamo provare a dire quello che vogliamo a capi, giudici o poliziottɜ, e a meno che non siamo servilmente a loro congeniali, onestà e libertà di parola porteranno a conseguenze dannose. In situazioni di emergenza sociale, le limitazioni alla “libertà di parola” diventano ancora più pronunciate. Si pensi allɜ attivistɜ imprigionatɜ per essersi espressɜ contro la leva nella prima guerra mondiale e le persone arrestate nel 2004 per aver impugnato cartelli di protesta in occasione di eventi in cui parlava Bush. La libertà di parola è libera solo finché non è una minaccia e non comporta la possibilità di sfidare il sistema. La massima libertà di parola che ho avuto è stata nella “Security Housing Unit” (isolamento di massima sicurezza) della prigione federale. Potevo urlare e gridare quanto volevo, anche imprecare contro le guardie, e a meno che non escogitassi un modo particolarmente creativo per farli arrabbiare intenzionalmente, mi lasciavano in pace. Nulla importava: le pareti erano solide come la roccia e le mie parole erano aria fritta.
La cooperazione che è possibile solo con lɜ dissidenti pacifichɜ aiuta ad umanizzare i politici responsabili di politiche mostruose. In occasione delle massicce proteste contro la Convenzione Nazionale Repubblicana (RNC) del 2004 a New York, il sindaco di New York Bloomberg diede delle medagliette speciali allɜ attivistɜ nonviolentɜ che dichiararono che sarebbero statɜ pacifichɜ.[106] Bloomberg ottenne punti politici per essere stato attento e indulgente, anche se la sua amministrazione represse il dissenso durante tutta la settimana di proteste.
Lɜ pacifistɜ ottennero un ulteriore vantaggio: chiunque indossasse la medaglietta avrebbe avuto degli sconti a dozzine di spettacoli di Broadway, hotel, musei e ristoranti (a dimostrazione di come la parata passiva della nonviolenza venga sfruttata come spinta all’economia e baluardo dello status quo). Come disse il sindaco Bloomberg, “non è divertente protestare a stomaco vuoto”. E le proteste anti-RNC a New York furono poco più che questo: divertimento. Divertimento per lɜ studentessɜ universitariɜ, lɜ propagandistɜ democratichɜ e lɜ attivistɜ del Partito Verde nell’andare in giro a sfoggiare cartelli spiritosi insieme a progressistɜ “illuminatɜ” che la pensassero come loro. Un’enorme quantità di energia venne spesa con settimane di anticipo (da parte della sinistra istituzionale e delle forze dell’ordine) per cercare di allontanare ed escludere attivistɜ più militanti. Qualcunə con molte risorse distribuì migliaia di volantini il fine settimana prima della convention, sostenendo la stupida pretesa che la violenza – ad esempio una rivolta – avrebbe migliorato l’immagine di Bush (quando in realtà, una rivolta – anche se non avrebbe certamente aiutato i Democratici –, avrebbe intaccato l’immagine di Bush in quanto leader e “unificatore”). L’opuscolo avvertiva anche che chiunque sostenesse tattiche conflittuali era probabilmente un agente di polizia. La marcia si concluse e la gente si disperse nel punto più isolato e meno conflittuale possibile di una città piena di edifici: Il Grande Prato di Central Park (in modo appropriato, altrɜ manifestanti si riversarono nel “prato delle pecore”). Ballarono e festeggiarono fino a notte fonda, scandendo mantra illuminanti come “Siamo bellɜ!”.
Nel corso della settimana, la Marcia dei Poveri fu ripetutamente attaccata dalla polizia che effettuò arresti mirati ad attivistɜ che indossavano maschere o che si rifiutavano di essere perquisitɜ. Lɜ partecipanti alla marcia accettarono di essere nonviolentɜ perché la marcia comprese molte persone – come immigratɜ e persone non bianche – che lɜ organizzatrici della marcia avevano apparentemente considerato più suscettibili di arresto. Ma quando lɜ attivistɜ – pacificamente – accerchiarono gli agenti di polizia per tentare di scoraggiare gli arresti, vennero esortatɜ ad ignorare gli arresti e a continuare a muoversi, mentre i “peacekeepers” della marcia e la polizia gridavano alla folla messaggi identici (“Andate avanti!” “Attenetevi al percorso della marcia!”). Ovviamente, tutti i tentativi di conciliazione e allentamento delle tensioni fallirono e la polizia fu tanto violenta quanto decise di esserlo.
Il giorno dopo, Jamal Holiday, un nero residente a New York e proveniente da un contesto sociale disagiato venne arrestato per “aggressione” per essersi autodifeso da un detective della polizia di New York in borghese, uno dei tanti che, senza aver ricevuto alcuna provocazione, avevano guidato i loro motorini contro la folla pacifica della manifestazione, ferendo diverse persone (e travolgendo il mio piede). Questo successe alla fine della manifestazione, quando moltɜ dellɜ partecipanti alla marcia, compresɜ lɜ presuntɜ “vulnerabili”, diventarono piuttosto contrariatɜ dalla passività dellɜ leader della marcia e la continua brutalità della polizia. A un certo punto, una folla di manifestanti che erano statɜ appena aggreditɜ dalla polizia iniziò ad urlare contro un organizzatore che urlava loro attraverso un megafono di allontanarsi dalla polizia (non c’era nessun posto dove andare) perché stavano “provocando” i poliziotti.
La risposta all’arresto di Holiday mostra un’ipocrisia che privilegia la violenza dello stato rispetto al diritto delle persone di difendersi. Gli stessi segmenti pacifisti del movimento che sollevarono un polverone per lɜ manifestanti pacifichɜ che la polizia arrestò in massa il 31 agosto (giorno riservato alle proteste in stile disobbedienza civile) rimasero in silenzio e non supportarono Holiday mentre egli subiva la violenza straziante e prolungata del sistema penale.
A quanto pare, per lɜ pacifistɜ, proteggere un presunto attivista violento da una violenza molto più grande rischierebbe di offuscare eccessivamente la loro presa di posizione contro la violenza.
Lɜ attivistɜ nonviolentɜ non si limitano ad avallare la violenza dello stato con il loro silenzio: spesso la giustificano a gran voce.
Lɜ organizzatrici pacifistɜ non perdono occasione per dichiarare il divieto della “violenza” all’interno delle loro proteste, perché tale violenza “giustificherebbe” la repressione da parte della polizia, che viene percepita come inevitabile, neutrale e irreprensibile. Le proteste del 1999 contro l’OMC a Seattle ne sono un tipico esempio.
Sebbene la violenza della polizia (in questo caso, l’uso di tecniche di tortura contro lɜ manifestanti pacifichɜ che bloccarono il sito del summit) abbia preceduto la distruzione “violenta” delle proprietà da parte dei black bloc, tuttɜ – dallɜ pacifistɜ ai media aziendali – incolparono i Black Bloc delle cariche della polizia.
Forse la lamentela maggiore fu che lɜ anarchichɜ non gerarchicamente organizzatɜ rubarono i riflettori alle ricche ONG che necessitavano invece di un’aura di autorità per continuare a ricevere donazioni.
Ufficialmente fu affermato che la violenza delle proteste avesse demonizzato l’intero movimento, anche se persino il presidente in persona, Bill Clinton, dichiarò da Seattle che una minoranza violenta fu l’unica responsabile dei tumulti.[107]
In effetti, la violenza di Seattle ha incuriosito e attirato più persone nuove al movimento di quante ne siano state attratte dalla tranquillità di ogni successiva mobilitazione di massa. I media aziendali non spiegarono – e non lo faranno mai – le motivazioni dellɜ attivistɜ, ma bensì la violenza, la manifestazione visibile della passione e del furore, dell’impegno militante in un mondo altrimenti assurdo, e motivarono migliaia di persone a fare quella ricerca per conto proprio. Ecco perché Seattle è considerata dagli antistorici come l’“inizio” o la “nascita” del movimento antiglobalizzazione. Allo stesso modo, un articolo di The Nation sostiene la nonviolenza e si lamenta del fatto che la violenza di Seattle e di Genova (dove la polizia italiana sparò e uccise Carlo Giuliani) “abbia creato immagini negative sui media e abbia fornito una scusa per una repressione ancora più dura”[108]. Mi dilungherò un attimo qui per fare presente che lo stato non è un ente passivo. Se vuole reprimere un movimento o un’organizzazione non aspetta un pretesto, ma lo costruisce. L’American Indian Movement non era un’organizzazione violenta – la stragrande maggioranza delle sue tattiche erano pacifiche – ma i membri non si limitavano alla nonviolenza, praticavano l’autodifesa armata e l’occupazione con la forza degli edifici governativi, spesso con grandi risultati. Per “giustificare” la repressione contro l’AIM, l’FBI produsse i “Dog Soldier Teletypes”, i quali venivano spacciati per comunicati dell’AIM in cui si parlava della presunta creazione di squadre del terrore per assassinare turistɜ, agricoltori e funzionari governativi.[109]
Questi comunicati facevano parte di una campagna generale di disinformazione dell’FBI, che permise al governo la libera falsa incarcerazione e l’omicidio di diversɜ attivistɜ e sostenitrici dell’AIM.
A proposito di tali campagne, l’FBI afferma: “È irrilevante che esistano o meno i fatti a sostegno dell’accusa... [L’azione di disturbo attraverso i media] può essere compiuta senza che vi siano fatti che la sostengano”.[110] Se, agli occhi del governo, è irrilevante che un’organizzazione ritenuta una minaccia per lo status quo abbia o non abbia commesso un atto violento, perché lɜ sostenitrici della nonviolenza continuano a insistere sul fatto che la verità li renderà liberɜ?
Il già citato articolo di The Nation richiede una rigorosa adesione alla nonviolenza da parte di tutto il movimento, mentre critica il rifiuto di un’altra organizzazione pacifista a condannare apertamente lɜ attivistɜ che usano una diversità di tattiche. L’autore lamenta: “È impossibile controllare le azioni di chiunque partecipi a una manifestazione, naturalmente, ma sforzi più vigorosi per assicurare [sic] la nonviolenza e prevenire comportamenti distruttivi sono possibili e necessari. Impegnarsi al 95% alla nonviolenza non è sufficiente”. Senza dubbio, un impegno “più vigoroso” alla nonviolenza significa che lɜ leader attivistɜ debbano utilizzare più spesso la polizia come forza di pace (per arrestare le persone “problematiche”). Questa tattica è stata sicuramente già applicata dallɜ pacifistɜ (in effetti, la prima volta che venni aggredito durante una protesta, non fu da parte della polizia, ma da un maresciallo di pace che cercò di spingermi verso il marciapiede mentre io e altrɜ stavamo occupando un incrocio per evitare che la polizia dividesse il corteo e potesse potenzialmente arrestare in massa il segmento più piccolo. In particolare, la mia resistenza ai leggeri tentativi del maresciallo di pace di spingermi indietro mi fece notare dalla polizia, la quale stava sorvegliando il lavoro dei suoi delegati, e dovetti rintanarmi tra la folla per evitare di essere arrestato o aggredito con più forza).
Qualcunə riesce a immaginare dellɜ attivistɜ rivoluzionariɜ che dichiarano di dover essere più vigorosɜ nell’assicurarsi che ogni partecipante colpisca un poliziotto o lanci un mattone contro una finestra?
Al contrario, la maggior parte dellɜ anarchichɜ e dellɜ altrɜ militanti si fecero in quattro per collaborare con lɜ pacifistɜ e per garantire che nelle manifestazioni comuni le persone contrarie al confronto – che temevano la brutalità della polizia o che erano particolarmente vulnerabili alle sanzioni legali – potessero avere uno “spazio sicuro”. Il pacifismo va di pari passo con gli sforzi per centralizzare e controllare il movimento. Il concetto è intrinsecamente autoritario e incompatibile con l’anarchismo perché nega alle persone il diritto all’autodeterminazione nel condurre le proprie lotte.[111]
Il pacifismo si affida alla centralizzazione e al controllo (con una leadership in grado di compiere “sforzi vigorosi” per “prevenire comportamenti distruttivi”), preserva lo stato all’interno del movimento e conserva le strutture gerarchiche per aiutare i negoziati con lo stato (e la sua repressione).
La storia dimostra che se un movimento non ha unə leader, lo stato lə inventa. Lo stato eliminò violentemente i sindacati antigerarchici dell’inizio del XX secolo, mentre negoziava con i sindacati gerarchici, li elevava e ne comprava la leadership.
I regimi coloniali nominarono “capi” in società senza stato che ne erano privi, sia per imporre il controllo politico in Africa sia per negoziare trattati ingannevoli in Nord America. Inoltre, i movimenti sociali senza leader sono particolarmente difficili da reprimere. Le tendenze del pacifismo alla negoziazione e alla centralizzazione facilitano gli sforzi dello stato di manipolare e cooptare i movimenti sociali ribelli; inoltre, rendono più facile reprimere un movimento, se si decide che è necessario farlo. Ma la visione pacifista del cambiamento sociale proviene da un punto di vista privilegiato, in cui la piena repressione da parte dello stato non è un timore reale. Un saggio sulla nonviolenza strategica che mi è stato caldamente raccomandato da alcunɜ conoscentɜ pacifistɜ include un diagramma. Lɜ attivistɜ nonviolentɜ sono a sinistra, i loro avversari, presumibilmente reazionari, sono a destra, e i terzi indecisi sono al centro.[112]
Tutti e tre i segmenti sono ugualmente schierati attorno a un’autorità “decisionale” apparentemente neutrale. Si tratta di una visione assolutamente ingenua e privilegiata del governo democratico, in cui tutte le decisioni sono decise a maggioranza con, nel peggiore dei casi, una violenza limitata praticata solo per un recalcitrante conservatorismo e riluttanza a cambiare lo status quo. Il diagramma ipotizza una società senza gerarchie di razza e di classe, senza élite privilegiate, potenti e violente. Senza media corporativi controllati dagli interessi dello stato e del capitale, pronti a gestire le sensibilità dellɜ cittadinɜ. Una società di questo tipo non esiste in nessuna delle democrazie industriali e capitaliste.
All’interno di un simile modello di potere sociale, la rivoluzione è un gioco morale, una campagna di sensibilizzazione che può essere vinta dalla “capacità di soffrire in modo dignitoso” [per esempio, lɜ studentessɜ contro la segregazione che fecero sit-in alle mense “per solɜ bianchɜ” subendo attacchi verbali e fisici], di attrarre simpatia e sostegno politico”.[113]
In primo luogo, questo modello presuppone un’analisi dello stato che è molto caritatevole e molto simile a come esso potrebbe descriversi nei testi di educazione civica delle scuole pubbliche.
In questa analisi, il governo è un’autorità decisionale neutrale e passiva che risponde alle pressioni dell’opinione pubblica. Nel migliore dei casi è equo, nel peggiore è afflitto da una cultura di conservatorismo e ignoranza. Ma non è oppressivo nella sua struttura. In secondo luogo, questo modello mette lɜ pacifistɜ nella posizione di fare pressioni e negoziare con un’autorità decisionale che, in realtà, è consapevolmente vincolata dall’interesse personale, disposta a infrangere qualsiasi legge scomoda che possa aver stabilito e strutturalmente integrata e dipendente dai sistemi di potere e oppressione che hanno galvanizzato il movimento sociale in prima istanza. I governi moderni, che hanno studiato a lungo i metodi di controllo sociale, non considerano più la pace come una condizione sociale predefinita, interrotta solo da agitatori esterni, poiché ora hanno capito che la condizione naturale del mondo (il mondo che loro hanno creato, dovrei dire) è il conflitto: la ribellione al loro dominio è inevitabile e continua.[114] L’arte di governare è diventata l’arte di gestire il conflitto in modo permanente. Finché lɜ ribelli continueranno a portare rami d’ulivo e una visione ingenua della lotta, lo stato saprà di essere al sicuro. Ma gli stessi governi i cui rappresentanti dialogano gentilmente o respingono bruscamente lɜ scioperanti coscienziosɜ, spiano costantemente la resistenza e addestrano agenti alla contro-insurrezione – tecniche di guerra tratte dalle guerre di sterminio condotte per sottomettere le colonie ribelli, dall’Irlanda all’Algeria. Lo stato è pronto a usare questi metodi contro di noi.
Anche quando il governo si ferma al limite di forme di repressione sterminatrici, la sofferenza dignitosa smette di essere divertente, e lɜ pacifistɜ che non hanno dedicato a pieno il loro futuro alla rivoluzione, dichiarando guerra allo status quo, perdono la lucidità della convinzione (hanno forse fatto qualcosa per “meritare” o “provocare” la repressione?), e se ne tirano fuori. Si pensi alla protesta di Seattle del 1999 e le successive mobilitazioni di massa del movimento anti-globalizzazione: lɜ attivistɜ di Seattle furono trattatɜ in modo brutale, ma tennero duro, reagirono, e moltɜ si rafforzarono grazie a questa esperienza.
Lo stesso vale per lɜ manifestazioni di Quebec City contro l’Area di Libero Commercio delle Americhe (FTAA). All’estremo opposto, la repressione da parte della polizia delle proteste anti-FTAA del 2003 a Miami fu del tutto immeritata, anche secondo gli standard legalistici.[115]
Lɜ manifestanti furono brutalizzatɜ e molte persone iniziarono ad essere spaventate dall’idea di partecipare ad altre proteste, compresɜ lɜ attivistɜ aggreditɜ sessualmente dalla polizia mentre erano sotto custodia.
Nelle proteste ancora più passive a Washington DC – le manifestazioni annuali contro la Banca Mondiale, per esempio – la resistenza nonviolenta, che consistette in un blocco orchestrato, arresto, incarcerazione e rilascio, non fu incoraggiante, ma tediosa e caratterizzata da un numero sempre più esiguo di persone. Non ebbero certo successo nell’attirare l’attenzione dei media o nell’influenzare le persone con lo spettacolo di una sofferenza dignitosa, anche se in tutti i casi i criteri usati dallɜ organizzatrici pacifistɜ per accertare la vittoria fu una combinazione di nient’altro che il numero dellɜ partecipanti e l’assenza di scontri violenti con autorità o proprietà.
In ultima analisi, lo stato può utilizzare la nonviolenza per sconfiggere anche un movimento rivoluzionario che altrimenti sarebbe diventato abbastanza potente da avere successo.
In Albania, nel 1997, la corruzione del governo e il collasso economico fecero sì che un gran numero di famiglie perdesse tutti i propri risparmi. In risposta, il “Partito Socialista ha indetto una manifestazione nella capitale, sperando di diventare il leader di un movimento di protesta pacifico”.[116] Ma la resistenza si era diffusa ben oltre il controllo di qualsiasi partito politico.
La gente iniziò ad armarsi, a bruciare o bombardare banche, stazioni di polizia, edifici governativi e uffici dei servizi segreti; e a liberare le prigioni. “Gran parte dei militari disertò, unendosi agli insorti o fuggendo in Grecia”. Il popolo albanese era pronto a rovesciare il sistema che li opprimeva, il che avrebbe dato loro la possibilità di creare nuove organizzazioni sociali. “A metà marzo, il governo, compresa la polizia segreta, è stato costretto a fuggire dalla capitale.” Poco dopo, diverse migliaia di truppe dell’Unione europea occuparono l’Albania per ripristinare l’autorità centrale. I partiti dell’opposizione, che per tutto il tempo avevano negoziato con il governo per trovare una serie di condizioni che inducessero lɜ ribelli al disarmo e convincessero il partito al potere a dimettersi (in modo da poter ascendere al potere), furono determinanti nel permettere all’occupazione di pacificare lɜ ribelli, condurre le elezioni e ripristinare lo stato.
Allo stesso modo, Frantz Fanon descrive i partiti di opposizione che denunciarono la ribellione violenta nelle colonie come entità spinte dal desiderio di controllare il movimento.
“Dopo le prime scaramucce, i leader ufficiali si disfano rapidamente dell’azione militante, che etichettano come infantilismo.” Poi, “gli elementi rivoluzionari che si affiliano a loro saranno rapidamente isolati. I leader ufficiali, avvolti nei loro anni di esperienza, disconosceranno senza pietà questɜ avventurierɜ e anarchichɜ’”. Come spiega Fanon, a proposito dell’Algeria in particolare e delle lotte anticoloniali in generale, “la macchina del partito si mostra in opposizione a qualsiasi innovazione” e i leader “sono terrorizzati e preoccupati dall’idea che potrebbero essere travolti da un vortice di cui non riescono nemmeno a immaginare la natura, la forza e la direzione”.[117]
Anche se questi leader politici di opposizione, in Albania, Algeria o altrove, generalmente non si identificano come pacifisti, è interessante notare come svolgano un ruolo simile.
Da parte loro, lɜ verɜ pacifistɜ sono più propensɜ ad accettare gli ingannevoli rami d’ulivo dei politici pacificatori rispetto alle offerte di solidarietà delle rivoluzionarie armate.
L’alleanza e la fraternizzazione standard tra pacifistɜ e leader politici progressisti (che consigliano la moderazione) servono a fratturare e controllare i movimenti rivoluzionari. È in assenza di una significativa penetrazione pacifista nei movimenti popolari che i leader politici non riescono a controllare questi movimenti e vengono rifiutati e amputati in quanto sanguisughe elitarie. È quando la nonviolenza viene tollerata dai movimenti popolari che questi movimenti vengono paralizzati.
Alla fine, lɜ attivistɜ nonviolentɜ si affidano alla violenza dello stato per proteggere le loro conquiste, e non si oppongono alla violenza dello stesso quando questa viene usata contro lɜ militanti (anzi, spesso la incoraggiano). Negoziano e collaborano con la polizia armata durante le loro manifestazioni. E, anche se lɜ pacifistɜ onorano lɜ loro “prigionierɜ di coscienza”, per quella che è la mia esperienza, tendono a ignorare la violenza del sistema carcerario nei casi in cui lə prigionierə abbia commesso un atto di resistenza violenta o addirittura di vandalismo (per non parlare di un reato apolitico). Mentre stavo scontando una condanna a sei mesi di carcere per un atto di disobbedienza civile, lɜ pacifistɜ di tutto il Paese mi inondarono di sostegno. Ma, nel complesso, dimostrano una mancanza di preoccupazione per la violenza istituzionalizzata che avvolge i 2,2 milioni di vittime della guerra al crimine del governo. Sembra che l’unica forma di violenza a cui essɜ si oppongono sistematicamente sia la ribellione contro lo stato.
Il segno della pace stesso è la metafora perfetta per questa funzione. Invece di alzare il pugno, lɜ pacifistɜ alzano l’indice e il medio per formare una V. La V significa vittoria ed è il simbolo dei patrioti che esultano per la pace che segue una guerra trionfale. In ultima analisi, la pace che lɜ pacifistɜ difendono è quella dell’esercito vincitore, dello stato incontrastato che ha vinto tutte le resistenze e monopolizzato la violenza a tal punto che la violenza non deve più essere visibile.
È una Pax Americana.
La nonviolenza è patriarcale
Il patriarcato è una forma di organizzazione sociale che dà origine a ciò che comunemente riconosciamo come sessismo. Ma va oltre al pregiudizio individuale o sistemico contro le donne: è, prima di tutto, la falsa categorizzazione di tutti gli individui in due generi inflessibili (uomo e donna), affermati entrambi come naturali e morali (molte persone perfettamente in salute non soddisfano i requisiti fisiologici per rientrare in nessuna di questi due, e molte culture non occidentali hanno riconosciuto – ed è ancora così, a meno che non siano state distrutte nel tempo – l’esistenza di più di due sessi e generi). Il patriarcato definisce ruoli netti (economici, sociali, emotivi, politici) per uomini e donne ed afferma (falsamente) la loro naturalità e moralità. Sottoposte al patriarcato, le persone che rifiutano o non rientrano in questi ruoli di genere vengono neutralizzate da violenza ed ostracismo. Le fanno sentire brutte, sporche, spregevoli, prive di valore. Il patriarcato è dannoso per tuttɜ e viene riproposto e replicato da chi vive al suo interno. Fedele al suo nome, colloca gli uomini nella posizione dominante mentre le donne in quella di sottomissione. Attività e caratteristiche tradizionalmente attribuite al “potere” o al privilegio, appartengono per lo più agli uomini,[118] conferendogli quasi esclusivamente l’abilità e il diritto di esercitare violenza.
Con il genere, così come con l’etnia, la nonviolenza è una posizione intrinsecamente privilegiata. Invece che autodifendersi, ritiene sia meglio soffrire e subire una violenza fino a che non si riesca a radunare persone a sufficienza per potersi opporre pacificamente (o provare a “modificare” la natura di qualsiasi aggressione che minacci l’individuo). La maggior parte delle persone che sostengono la nonviolenza presentano questa non solo come una pratica politica ristretta, ma come una filosofia che merita di penetrare fra i tessuti sociali per sradicare la violenza in tutte le sue manifestazioni, non ponendo la giusta attenzione verso le aggressioni del patriarcato. Dopotutto nelle guerre, nelle rivoluzioni sociali e nella vita quotidiana, donne e persone transgender sono i primi bersagli della violenza patriarcale.
Se prendiamo questa filosofia al di fuori del panorama politico impersonale e la inseriamo in un contesto più realistico, la nonviolenza implicherebbe l’immoralità da parte di una donna di difendersi da un aggressore o di imparare l’autodifesa. Implicherebbe che per una moglie abusata sia meglio trasferirsi piuttosto che radunare un gruppo di donne per picchiare e cacciare il marito abusivo.[119]
La nonviolenza sottolinea quindi che sia meglio che qualcunə si lasci stuprare piuttosto che conficcare una matita nella giugulare del suo violentatore (perché fare ciò contribuirebbe ad incoraggiare future molestie). Il pacifismo non risuona nella quotidianità delle persone, a meno che queste non vivano in qualche stravagante bolla di tranquillità da cui tutte le forme di violenza reattiva pandemica della civiltà siano state scacciate dalla violenza sistemica e meno visibile delle forze di polizia e dei militari.
Da un altro punto di vista, la nonviolenza si potrebbe considerare appropriata per il patriarcato. Del resto, la sua abolizione richiederebbe forme di resistenza che empatizzino con un’indole di riconciliazione.[120] Il concetto occidentale di giustizia, basato su leggi e punizioni, è radicalmente patriarcale. I primi codici giuridici consideravano la donna come proprietà e le leggi vennero scritte per gli uomini padroni che venivano abituati a non confrontarsi con le proprie emozioni; gli “errori” venivano presi in considerazione attraverso sanzioni e condanne piuttosto che con un riavvicinamento. Per di più, il patriarcato non viene sorretto esclusivamente da una potente élite contro cui dover combattere, ma da chiunque.
Poiché la distribuzione del potere all’interno del patriarcato è più diffusa e capillare che nello stato o nel capitalismo (un generale uomo che ha una posizione importante in un consiglio di amministrazione di una multinazionale ha, rispetto allo stato e al capitalismo, un potere significativo che non deriva specificamente dal patriarcato e che non è differente rispetto a quello di tutti gli altri uomini, tranne forse per il modello comportamentale di “mascolinità”), combattere contro chi detiene il potere o contro i più imputabili, gioca un ruolo meno importante. Le persone devono quindi coltivare e costruire una cultura che permetta a chiunque di identificarsi nei diversi generi, instaurando relazioni interpersonali sane che permettano di guarire dai traumi generazionali. Tutto ciò è perfettamente compatibile sia con le preparazioni di autodifesa per donne e persone transgender, sia con attacchi alle istituzioni economiche, culturali e politiche che incarnano il patriarcato o che sono responsabili di rappresentarne le forme brutali.
Uccidere un poliziotto che ha violentato transgender che vivevano di prostituzione; dare fuoco all’ufficio di una rivista che vende consapevolmente standard di bellezza che incoraggiano la bulimia e l’anoressia; rapire il presidente di una compagnia che gestisce traffico di donne – nessuna di queste azioni ostacolano la costruzione di una società giusta. È piuttosto chi è potente e trae deliberatamente profitto dal patriarcato che impedisce l’emergere di una cultura e di una mentalità sana.
Valutare quindi le proprie relazioni, affiancarle ad un’assidua opposizione verso le istituzioni che diffondono invece legami di sfruttamento e di violenza ed attaccare gli esempi più eclatanti e probabilmente incorreggibili del patriarcato, è uno dei migliori modi per istruire sul bisogno di un’alternativa per poterlo sopraffare. Ma la pratica pacifista che vieta l’uso di qualsiasi altra strategia non lascia altre opzioni se non quella di proteggersi dalla violenza.
Nel caso di uno stupro o di altre forme di molestia contro le donne, la nonviolenza implica le stesse lezioni che il patriarcato ha insegnato per millenni: elogiare la passività, il “porgere l’altra guancia”, una “sofferenza dignitosa” fra gli oppressi. In uno dei più chiari scritti che definisce la preservazione e l’applicazione del patriarcato – l’Antico Testamento – tramite comandamenti, parabole e leggi, consiglia alle donne di soffrire per le loro ingiustizie e pregare affinché dio intervenga (questa descrizione è estremamente simile alla fiducia che lɜ pacifistɜ hanno delle aziende che diffondono immagini di “sofferenze dignitose”, motivando le autorità ad incrementare la giustizia). Dal momento che il patriarcato descrive una violenza unilaterale da parte degli uomini, le donne interrompono questa dinamica re-imparando la loro inclinazione alla violenza.[121]
Per ribadire ciò, le donne che rivendicano la facoltà e il diritto di usare violenza non metterebbero fine al patriarcato, ma è una condizione che deve necessariamente esistere per dare il via ad una liberazione di genere, oltre che essere una forma di emancipazione e protezione. Femministɜ pacifistɜ e riformistɜ hanno spesso accusato lɜ attivistɜ militanti di essere sessistɜ. In molti casi specifici, queste accuse sono state valide. Ma la polemica viene spesso estesa fino ad affermare che l’uso di un attivismo violento sia di per sé sessista, maschile, o comunque privilegiato.[122]
Laina Tanglewood precisa, “alcunɜ ‘femministɜ’ critichɜ verso l’anarchia considerano gli atti di militanza sessisti e non inclusivi verso le donne... in realtà è proprio questa una posizione sessista”.[123] Un’altrə anarchicə fa notare, “Di fatto la mascolinizzazione della violenza, con la sua accompagnatrice sessista, la femminilizzazione della passività, è in debito con la presunzione di chi non include una rivoluzione e l’annientamento dello stato nella loro concezione di cambiamento”.[124] Analogamente, chi è che ha un’idea di libertà che non includa l’abilità delle donne di difendersi? Per poter rispondere alla presunzione secondo la quale le donne possano essere protette solo da grosse strutture sociali, l’attivista Sue Daniels ci ricorda che “Una donna può combattere un aggressore da sola... non è una questione di forza – ma di preparazione”.[125]
The Will to Win! Women and Seld-Defense, un opuscolo anonimo, aggiunge:
È ridicolo che ci siano così tanti consultori e organizzazioni di supporto per le donne stuprate, attaccate e abusate ma così poca preparazione e prevenzione per impedire che ciò accada. Dobbiamo rifiutare di essere vittime e respingere l’idea secondo cui dovremmo sottometterci ai nostri aggressori per impedire altre violenze. La verità è che arrendersi ai propri assalitori agevola future violenze verso altrɜ.[126]
L’idea di per sé che la violenza sia maschile o che l’attivismo rivoluzionario escluda inevitabilmente donne, persone queer e trans è, come le premesse di nonviolenza, improntata in un suprematismo bianco transepocale.
Le donne nigeriane che occupano e sabotano giacimenti petroliferi vengono ignorate così come le donne martiri delle rivolte palestinesi; persone trans e queer che lottarono durante i moti di Stonewall; le innumerevoli migliaia di donne che combatterono con i Vietcong nella guerra del Vietnam; le rappresentanti donne native-americane della resistenza al genocidio europeo e statunitense; Mujeres Creando (Donne che Creano), un gruppo di femministe anarchiche in Bolivia; le suffragette inglesi che si ribellarono agli sbirri. Sono state dimenticate anche le donne leader appartenenti alle Pantere Nere, allɜ Zapatistɜ, al Weatherman e ad altri gruppi di attivistɜ. L’idea che la ribellione escluda in qualche modo le donne è assurda, non reggerebbe neanche la storia dei bianchi del “Primo Mondo” perché anche le forme di patriarcato più efficaci non potrebbero mai prevenire un movimento di resistenza contro le oppressioni da parte di persone trans, donne e individui razzializzati.
Lɜ avvocatɜ della nonviolenza che fanno un’eccezione per l’autodifesa – perché riconoscono quanto sbagliato sia affermare che le persone oppresse non possano o non dovrebbero difendersi – non possiedono strategie praticabili contro la violenza sistemica. È autodifesa contrastare un marito abusivo ma non far esplodere fabbriche che emettono diossine rendendo tossico il latte materno? Come vi sembra, invece, una campagna organizzata per distruggere le corporazioni che possiedono queste fabbriche responsabili del rilascio di sostanze nocive?
È autodifesa uccidere un generale che invia i suoi soldati in guerra e che in seguito violenteranno donne? Oppure lɜ pacifistɜ dovrebbero rimanere sulla difensiva, combattendo solo gli attacchi individuali e sottomettendosi alla loro inevitabilità finché le “tattiche” nonviolente convertano i poteri forti facendo così chiudere le fabbriche tossiche? Oltre che a proteggere il patriarcato dall’opposizione, la nonviolenza agevola le dinamiche al suo interno. Una delle maggiori premesse dell’attivismo anti-oppressione attuale (nato da un comune desiderio di promuovere movimenti più forti ed evitare lotte interne nate principalmente da dinamiche oppressive che invalidavano le difficoltà delle generazioni precedenti) è quella secondo cui le gerarchie d’oppressione esistono, si riflettono nel comportamento di tuttɜ e vanno affrontate dall’interno così come dall’esterno. Ma il pacifismo prolifera nel negarsi autocritiche.[127] Moltɜ sono familiari con lo stereotipo celebrativo di autocompiacimento dellɜ attivistɜ della nonviolenza che “incarnano il cambiamento che (loro) desiderano nel mondo”,[128] a tal punto che nelle loro menti si percepiscono come rappresentanti di tutto ciò che c’è di bello e giusto. Un sostenitore di un’organizzazione pacifista ha sottolineato, in risposta alle critiche sul suo privilegio, che il loro leader – bianco e uomo – non avrebbe potuto avere alcun privilegio, né bianco né maschile, perché era una “brava persona”, come se la supremazia bianca e il patriarcato fossero realtà a cui si può decidere di associarsi o meno.[129] In questo contesto, quindi, una leadership maschile che viene riconosciuta come personificazione dell’idea nonviolenta – magari risultato delle numerose partecipazioni a scioperi della fame e sit-in – quanto facilmente può essere denunciata per i suoi comportamenti oppressivi, transfobici o per molestie sessuali?
Il modo pacifico di evitare autocritiche è funzionale, non solo caratteristico. Quando la tua strategia di vittoria comprende l’“acquisire e mantenere una posizione di vantaggio morale”[130] è necessario ritrarsi come individui morali, mentre lɜ nemichɜ come immorali. Portare alla luce dinamiche bigotte e oppressive fra i leader e i membri di un gruppo è controproducente per la strategia scelta. Quante persone sanno che Martin Luther King Jr. trattò Ella Baker (che fu ampiamente responsabile della fondazione della “Southern Christian Leadership Conference” [SCLC], mentre King era ancora un organizzatore inesperto) come la sua segretaria? Egli rise in faccia a diverse donne dell’organizzazione quando suggerirono posizioni di autorità equamente distribuita; disse che la funzione naturale delle donne fosse la maternità e che sfortunatamente erano “forzate” a ricoprire ruoli come “insegnanti” e “leader”.[131] Quante persone sanno che King rimosse Bayard Rustin dalla sua organizzazione perché gay?[132]
Ma allora perché questi episodi vennero oscurati mentre cresceva il mito di King che veniva idolatrato? Per lɜ attivistɜ rivoluzionariɜ, però, la vittoria arriva accrescendo il potere e aggirando le strategie dello stato. Questa rotta richiede una continua determinazione e autocritica.[133]
Spesso poi, sono proprio le già esistenti supposizioni maschiliste a dipingere lɜ attivistɜ militanti come sessistɜ.
Per esempio, è un dato di fatto che le donne furono escluse dagli incarichi superiori nella SCLC[134] di King, mentre invece (come Elaine Brown) ricoprivano le maggiori cariche nel Black Panther Party (BPP). Eppure è il BPP, e non la SCLC, ad essere trattato come esempio di machismo. Ed è Kathleen Cleaver a controbattere, “Nel 1970, il Black Panther Party prese una posizione ufficiale rispetto alla liberazione delle donne. Mi chiedo se il Congresso degli Stati Uniti d’America abbia affrontato la questione”.[135] Frankye Malika Adams, un’altra Panther, disse: “Sono le donne che dirigono il BPP. Non ho idea di come abbiano potuto pensare che si possa trattare di una fazione maschile”.[136]
Nel portare alla luce una storia più veritiera sul Black Panther Party, Mumia Abu-Jamal documenta quello che, per certi versi, fu un “partito di donne”.
Nonostante ciò il sessismo persistette tra le Pantere, così come in qualsiasi altro ambiente rivoluzionario e settori della società patriarcale di oggi. Il patriarcato non può essere distrutto in una notte, ma può essere gradualmente sconfitto da gruppi che intervengono per poterlo distruggere. Lɜ attivistɜ devono riconoscerlo come nemico primario, espandere i movimenti rivoluzionari a donne, persone queer e transgender, lasciare che loro dirigano, valutino e riformulino le battaglie. Un’analisi concreta mostra come non importino le nostre intenzioni, c’è ancora molto da fare per sottrarre dalle mani degli uomini il controllo dei movimenti e trovare così modi costruttivi e sani di gestire modelli tossici nelle relazioni – sociali o romantiche – tra i membri del movimento.
Che fossero militanti o pacifiste, quasi la totalità delle discussioni strategiche a cui ho partecipato erano dominate prevalentemente da uomini. Invece di pensare che le donne e le persone transgender siano in qualche modo incapaci di partecipare ad una vasta gamma di soluzioni tattiche (o addirittura discuterne), è meglio ricordarsi delle voci di chi ha combattuto violentemente, con grande audacia, efficientemente – e da rivoluzionariɜ. A tal proposito:
Mujeres Creando è un gruppo anarco-femminista boliviano. Proteggono manifestanti dalla violenza della polizia durante le proteste. Fanno graffiti durante le campagne per sensibilizzare sul tema della povertà. Durante la loro azione più agguerrita, si armarono di bombe motolov e candelotti di dinamite per aiutare un gruppo di agricoltori indigeni a prendere il controllo di una banca, affinché i bancari si scusassero per il debito che stava facendo patire la fame ai contadini e alle loro famiglie. In un’intervista, Julieta Paredes, membro fondatore, spiegò le origini del gruppo:
“Mujeder Creando è una follia creata da tre donne [Julieta Paredes, Maria Galindo e Monica Mendoza] durante l’arrogante, omofoba e totalitaria Sinistra boliviana degli anni ‘80... la differenza fra noi e chi parla di abbattere il capitalismo è che tutte le loro proposte in nome di una nuova società nascono dal patriarcato della Sinistra. In quanto femministe di Mujeres Creando, vogliamo una rivoluzione e un reale cambiamento del sistema... l’ho detto e lo ripeto, non siamo anarchiche grazie a Bakukin o al CNT, ma piuttosto grazie alle nostre nonne, e questa è una bellissima scuola anarchica.“[137]
Sylvia Rivera, una donna trans e drag queen[138] puertoricana, parlò della sua partecipazione ai moti di Stonewall del 1969, scatenati dall’irruzione da parte della polizia nello Stonewall Bar del quartiere Greenwich Village di New York, attaccando lɜ clienti queer e trans.
“Ne avevamo abbastanza. Avevamo fatto veramente tanto per gli altri movimenti. Era arrivato il momento.
Prima fu il turno dei senzatetto gay – che vivevano nel parco di Sheridan Square fuori dal bar – poi le drag queen e tuttɜ lɜ altrɜ... Sono contenta di aver partecipato alla rivolta di Stonewall. Ricordo di quando qualcunə lanciò una bomba motolov e pensai: “Mio dio, sono arrivatɜ lɜ rivoluzionariɜ. Finalmente c’è la rivoluzione!” Ho sempre creduto che avremmo reagito. Lo sapevo e basta. Non sapevo però che sarebbe stato quella notte. Sono fiera di me, per esserci stata. Ci sarei rimasta male se avessi perso quel momento perché lì ho visto il mondo cambiare, per me e la mia comunità. Abbiamo davanti ancora una lunga strada da percorrere.”[139]
Ann Hansen è una rivoluzionaria canadese che ha vissuto sette anni in prigione per essere stata coinvolta negli anni ‘80 nei gruppi di azione diretta di Wimmin’s Fire Brigade, e furono responsabili (insieme ad altre azioni) del bombardamento della fabbrica Litton (produttori di componenti per missili da crociera) e di una catena di negozi erotici che vendevano video ritraenti stupri. Secondo Hansen:
“Ci sono tante forme di azione diretta, alcune più efficienti rispetto ad altre, a seconda dei diversi periodi storici e in concomitanza con altre forme di protesta, ovvero azioni dirette che aprono strade di resistenza difficilmente controllate dallo stato e che rendono i cambiamenti più efficaci. Sfortunatamente, le persone nei movimenti indeboliscono le proprie azioni perché non comprendono o supportano le possibili diverse strategie... Ci stanno pacifizzando.”[140]
Emma Goldman – l’anarchica russa più famosa d’America che partecipò nel 1982 al tentato omicidio del boss Henry Clay Frick, sostenitore della Rivoluzione Russa e uno dei primi oppositori del governo di Lenin – scrive dell’emancipazione femminile, “La storia ci dice che ogni categoria oppressa ha conquistato la sua liberazione grazie alle proprie fatiche. È necessario che le donne imparino la lezione, capendo che la loro libertà giungerà fino a dove arriverà il loro potere di raggiungerla”.[141] Mollie Steimer fu un’altra immigrata russo-americana e anarchica. Sin da giovane lavorò con il Frayhayt, un giornale di New York anarchico in lingua yiddish. La sua testata dichiarò: “L’unica guerra giusta è quella della rivoluzione sociale.” Dal 1918 in poi, Steimer fu arrestata e incarcerata continuamente per essersi opposta alla Prima Guerra Mondiale e per aver supportato la Rivoluzione Russa che al tempo, prima del consolidamento del leninismo, aveva degli importanti componenti anarchici. Durante un processo disse, “Per la realizzazione di quest’idea [l’anarchismo], dedicherò tutte le mie energie e, se necessario, darò la mia vita.”[142] Steimer fu rimpatriata in Russia e imprigionata dai Sovietici per aver supportato prigionierɜ anarchichɜ. Anna Mae Pictou-Aquash fu una donna Mi’kmaq e un’attivista dell’American Indian Movement (AIM). Dopo aver insegnato, assistito lɜ giovani nativɜ e lavorato con le comunità nativo-americane e afro-americane di Boston,[143] entrò nell’AIM e prese parte all’occupazione di Wounded Knee nella riserva di Pine Ridge nell’anno 1973, che durò 71 giorni. Nel 1975, nel periodo in cui la brutale repressione da parte dello stato e dei paramilitari ingaggiati dall’FBI uccisero 60 membri dell’AIM e chi li sosteneva, Pictou Aquash assistette ad una sparatoria dove due agenti dell’FBI morirono. A Novembre del 1975 venne dichiarata fuggitiva per aver evitato di presentarsi alla corte d’appello con accusa di utilizzo di esplosivi. A Febbraio del 1976 fu trovata morta, con un proiettile dietro la nuca; il medico legale classificò la causa di decesso come “esibizionismo”.
Dopo la sua morte, si scoprì che l’FBI minacciò più volte di ucciderla se non gli avesse venduto lɜ altrɜ attivistɜ dell’AIM. Pictou Aquash viene ricordata come un’attivista e rivoluzionaria senza peli sulla lingua.
“Quei bianchi pensano che questo paese gli appartenga, non capiscono che lo stanno comandando solo perché sono numericamente di più rispetto a noi. Tutto il paese è cambiato a causa di una sola manciata di schifosi e pezzenti pellegrini che arrivarono nel 1500. Posso radunarla anche io, una manciata di schifosɜ indianɜ, e fare la stessa cosa. Io voglio essere una di loro.”[144]
Rote Zora (RZ) fu un gruppo tedesco di partigianɜ femministɜ e anti-imperialistɜ. Insieme allɜ alleatɜ di Revolutionary Cells, realizzarono più di duecento attacchi – la maggior parte bombardando – tra gli anni ‘70 e ‘80 del ‘900. Presero di mira i fotografi pornografici, multinazionali che sfruttavano minori, edifici del governo, aziende che vendevano donne come mogli, schiave del sesso e domestiche, aziende farmaceutiche e così via. In un’intervista anonima, i membri di Rote Zora spiegarono che: “Nel 1974, le donne di RZ hanno iniziato bombardando la Corte Suprema di Karlsruhe perché volevamo l’abolizione della ‘208’ (la legge contro l’aborto).”[145] Quando venne loro chiesto se gli attacchi danneggiassero il movimento, i membri risposero:
Zora 1: Con danneggiare il movimento – si intende l’attuazione di una repressione. Le azioni non ci fanno del male! Invece è il contrario, possono supportarlo in modo diretto. I nostri attacchi ai trafficanti di donne, per esempio, hanno aiutato a smascherare la loro attività, a compromettere le loro iniziative, e ora devono fare i conti con la resistenza delle donne se vogliono continuare con il loro business. Questi “brav’uomini” sanno che dovranno aspettarsi la resistenza. Ci ha rafforzatɜ.
Zora 2: Per molto tempo la strategia di una contro-rivoluzione ha iniziato a dividere e isolare lɜ radicali dal resto del movimento, indebolendolo. Negli anni ‘70 abbiamo capito cosa significa quando i settori della Sinistra adottano la propaganda dello stato e quando iniziano a presentare chi, intransigentemente, è in una posizione di difficoltà come i responsabili delle persecuzioni di stato, di distruzione e repressione. Non solo confondono la causa con l’effetto, ma giustificano implicitamente il terrorismo di stato. Si indeboliscono da solɜ, restringendo sempre di più la loro struttura di protesta e resistenza...
L’intervista continuò poi con la seguente domanda:
“Come possono le donne non-autonome e non-radicali capire quello che volete voi? Le azioni armate fanno spaventare e ‘scappare via’.”
Zora 2: Forse è spaventoso se viene messa in discussione la realtà di tutti i giorni. Le donne che sin da piccole vengono tartassate dall’idea che devono essere delle vittime, diventano insicure quando messe a confronto con la realtà, ovvero che le donne non sono né vittime né pacifiche. È una provocazione, e le donne che con rabbia riconoscono la loro impotenza possono sentirsi rappresentate dalle nostre azioni. Come qualsiasi atto di violenza verso una donna crea un’allerta fra tutte le altre, le nostre azioni contribuiscono – anche se puntano ad un solo individuo responsabile – allo sviluppo di un clima dove “La resistenza è possibile!”.[146]
Esiste però una fitta quantità di opere letterarie femministe che negano ci siano stati traguardi (storicamente importanti) di emancipazione tramite forze militanti e altri movimenti, offrendo invece la visione di un tipo di femminismo di stampo pacifista. Lɜ femministɜ pacifistɜ mettono sotto accusa il sessismo e il machismo di alcune organizzazioni militanti, ma dovremmo prenderne tuttɜ atto a prescindere. Le argomentazioni contro la nonviolenza e a favore di una diversità di tattiche non dovrebbero essere sinonimo di un apprezzamento verso le strategie di gruppi militanti del passato (per esempio, l’atteggiamento machista del Weather Underground o l’anti-femminismo delle Brigate Rosse).[147] Afferrare con serietà le diverse critiche non dovrebbe impedirci di riconoscere l’ipocrisia dellɜ femministɜ che con orgoglio denunciano comportamenti sessisti dei militanti ma nascondendo il tutto quando si tratta di pacifistɜ – come con la storia di Ghandi che apprese la nonviolenza da sua moglie, senza menzionare però le disturbanti dinamiche patriarcali della loro relazione.[148] Alcunɜ femministɜ vanno oltre critiche specifiche e cercano invece di creare una connessione metafisica fra il femminismo e la nonviolenza: questa è la dimostrazione della “femminilizzazione della passività” menzionata prima.
In un articolo pubblicato nel Berkeley Journal Peace Power, Carol Flinders cita uno studio degli scienziati dell’UCLA dove si sostiene che le donne non siano ormonalmente programmate a rispondere al pericolo con un meccanismo di reazione attacco-e-fuga, assegnato invece agli uomini, ma piuttosto con un comportamento di “passiva protezione”: quando minacciate, secondo questo studio, le donne “calmano il bambino, nutrono tutti, allentano la tensione e si connettono con altre femmine.”[149] Questa specie di scienza ridicola è stata per molto tempo lo strumento preferito dal patriarcato per provare l’esistenza di una differenza naturale fra uomo e donna, e le persone sono tutte troppo propense a dimenticare basilari principi matematici per arrendersi ad un mondo così ben categorizzato. In particolare, dividere in maniera arbitraria l’umanità in due gruppi (uomo e donna) basandosi su un numero molto limitato di caratteristiche produce inevitabilmente diverse categorie di “normalità”. Chi non sa che una media non esprime – anzi, oscura – la diversità in uno dei due gruppi è incline a considerarle come uniche categorie normali, continuando così a far sentire innaturale e anomalo chi invece non rientra dell’ordinarietà.
Ma Flinders non si ferma qui con l’implicita transfobia ed essenzialismo di genere[150] che l’UCLA studia. Continua ad indagare sul “nostro remoto passato pre-umano: fra gli scimpanzé, la nostra parentela più vicina, i maschi sorvegliano il territorio entro il quale i piccoli vengono nutriti dalle femmine... per questo motivo è raro che si trovino in prima linea; solitamente sono più impegnate a prendersi cura della progenie.”
Flinders sostiene che ciò implica “l’assenza di propensione da parte delle donne di affrontare uno scontro diretto” e che “tendono ad arrivare alla nonviolenza da diversi punti di vista e persino a viverla in modo differente.”[151] Così Flinders commette un’altra gaffe scientifica, utilizzando termini particolarmente sessisti. Prima di tutto, il determinismo evoluzionario che lei sceglie di utilizzare non è né attento né si può dimostrare. La sua popolarità deriva dalla praticità di riuscire a crearsi un alibi destinato alle strutture sociali oppressive della storia. Persino all’interno di queste dubbie strutture, Flinders fa delle affermazioni discontinue e lacunose. Gli umani non si sono evoluti dagli scimpanzé; anzi, entrambe le specie derivano dallo stesso predecessore.
Gli scimpanzé si stanno evolvendo sempre più, tanto quanto gli umani, ed entrambe le specie hanno avuto l’opportunità di sviluppare capacità d’adattamento che divergono dal loro antenato comune. Noi, in quanto umani, non siamo in alcun modo legati alla divisione di genere fra gli scimpanzé, così come loro non sono legati alla nostra propensione a sviluppare quantità innumerevoli di vocaboli per offuscare la verità del mondo che li circonda. Inoltre, lungo lo stesso cammino che l’ha portata ad affermare la presenza di una tendenza femminile verso la nonviolenza, Flinders si imbatte nella retorica del ruolo naturale delle donne, quello di consolare lɜ bambinɜ e dar loro da mangiare – lontano dal fronte. Dimostra coraggiosamente, seppur per errore, che lo stesso sistema di credenze che ritiene le donne pacifiche, afferma anche che loro debbano cucinare e crescere lɜ figliɜ. Il nome di questo sistema è patriarcato.
Un altro articolo di una femminista accademica smentisce subito l’essenzialismo. Nel secondo paragrafo di “Feminism and Nonviolence: A Relational Model,” Patrizia Longo scrive:
Anni di ricerche... ci suggeriscono che nonostante le potenziali problematiche coinvolte, le donne partecipano costantemente ad azioni di nonviolenza. Ciononostante, non scelgono la nonviolenza perché vogliono migliorare loro stesse attraverso ulteriori sofferenze, ma perché questa strategia rientra nei loro valori e possibilità.[152]
Nel vincolare le donne alla nonviolenza, sembra che lɜ femministɜ pacifistɜ debbano forzare la nostra definizione di “valori e possibilità” delle donne, ovvero definire quali caratteri siano essenzialmente femminili, bloccandole in un ruolo che viene falsamente chiamato naturale, lasciando fuori chi non vi rientra. È difficile dire quantɜ femministɜ oggi accettino le premesse dell’essenzialismo, ma sembrerebbe che un vasto numero di truppe militanti di femministɜ non accettino l’idea che il femminismo e la nonviolenza siano o debbano intrecciarsi. In un forum, dozzine di persone che si identificano come femministe hanno risposto alla domanda, “Esiste un legame fra la nonviolenza e il femminismo?” La maggioranza dellɜ intervistatɜ, alcunɜ pacifistɜ e moltɜ no, hanno espresso la convinzione secondo cui lɜ femministɜ non hanno bisogno di sostenere la nonviolenza. Un messaggio lo riassume:
C’è ancora una notevole pressione da parte del femminismo che lega le donne alla nonviolenza. Ma ci sono anche moltɜ femministɜ, me compresə, che non vogliono vedersi automaticamente associatɜ ad un approccio (ovvero la nonviolenza) solo per via dei nostri genitali o del nostro femminismo.[153]
La nonviolenza è strategicamente inferiore
Lɜ attivistɜ nonviolentɜ che tentano di apparire strategichɜ spesso evitano qualsiasi autentica strategia con intrepide semplificazioni come “La violenza è il cavallo di battaglia del governo. Dobbiamo seguire il percorso di minor resistenza e colpirli dove sono deboli.”[154] È ora di fare la distinzione tra strategia e slogan, e diventare un po’ più sofisticatɜ.
Innanzitutto, cominciamo con alcune definizioni (gli usi che fornirò per i seguenti termini non sono universali, ma se li usiamo in modo coerente saranno più che sufficienti per i nostri scopi). Una strategia non è un obiettivo, uno slogan o un’azione. La violenza non è una strategia, e nemmeno la nonviolenza.
Questi due termini (violenza e nonviolenza) sono apparentemente dei confini posti intorno a un insieme di tattiche. Un insieme limitato di tattiche limiterà le opzioni disponibili per le strategie, ma le tattiche dovrebbero sempre scaturire dalla strategia e la strategia dall’obiettivo. Purtroppo, al giorno d’oggi, sembra che le persone facciano il contrario, mettendo in atto tattiche per reazione abituale o attuando tattiche in una strategia senza avere più che una vaga consapevolezza dell’obiettivo. L’obiettivo è la destinazione. È la condizione che denota la vittoria. Naturalmente, ci sono obiettivi immediati e obiettivi finali. Può essere più realistico evitare un approccio lineare e immaginare l’obiettivo finale come un orizzonte, la destinazione più lontana immaginabile, che cambierà con il tempo man mano che i punti di passaggio un tempo lontani diventano chiari, emergono nuovi obiettivi e non si raggiunge mai uno status statico o utopico. Per lɜ anarchichɜ che desiderano un mondo privo di gerarchie coercitive, l’obiettivo finale oggi sembra essere l’abolizione di un insieme di sistemi interconnessi che includono lo stato, il capitalismo, il patriarcato, la supremazia bianca e forme di civiltà ecocida. Questo obiettivo finale è molto lontano – così lontano che moltɜ di noi evitano di pensarci perché potrebbero scoprire di non credere che sia possibile. Concentrarsi sulle realtà immediate è vitale, ma ignorare la meta assicura che non ci arriveremo mai.
La strategia è il percorso, il piano di gioco per raggiungere l’obiettivo. È la sinfonia coordinata di mosse che porta allo scacco matto. Lɜ aspiranti rivoluzionariɜ negli Stati Uniti, e probabilmente anche altrove, sono molto negligenti quando si tratta di strategie. Hanno un’idea approssimativa dell’obiettivo e sono profondamente coinvoltɜ nelle tattiche, ma spesso rinunciano del tutto alla creazione e all’attuazione di una strategia valida. Da un certo punto di vista, lɜ attivistɜ nonviolentɜ sono in genere avvantaggiatɜ rispetto a quellɜ rivoluzionariɜ, in quanto spesso dispongono di strategie ben sviluppate per perseguire obiettivi a breve termine. Il compromesso tende a essere l’esclusione totale di obiettivi intermedi e a lungo termine, probabilmente perché gli obiettivi a breve termine e le strategie dellɜ pacifistɜ li incasellano in vicoli ciechi che sarebbero altamente demoralizzanti se venissero riconosciuti. Infine, abbiamo le tattiche, che sono le azioni o i tipi di azioni che producono risultati. Idealmente, questi risultati hanno un effetto composto, creano slancio o concentrano la forza lungo le linee tracciate dalla strategia. Scrivere lettere è una tattica. Lanciare un mattone contro una finestra è una tattica. È frustrante che tutte le controversie sulla “violenza” e sulla “nonviolenza” siano semplicemente battibecchi sulle tattiche, quando le persone, per la maggior parte, non hanno nemmeno capito se i nostri obiettivi siano condivisi e se le nostre strategie siano compatibili o controproducenti. Di fronte al genocidio, all’estinzione, all’imprigionamento e all’eredità di millenni di dominazione e degrado, tradiamo lɜ alleatɜ o rinunciamo a partecipare alla lotta per questioni insignificanti come rompere le finestre o armarsi? Questo fa ribollire il sangue!
Per tornare alla nostra analisi fredda e ragionata di queste questioni, vale la pena notare che obiettivi, strategie e tattiche sono correlate su un piano comune, ma la stessa cosa può essere vista come un obiettivo, una strategia o una tattica a seconda dell’ambito di osservazione. Esistono molteplici livelli di grandezza e la relazione tra gli elementi di una particolare catena di obiettivi-strategie-tattiche esiste ad ogni livello. Un obiettivo a breve termine può essere una tattica a lungo termine. Supponiamo che l’anno prossimo vogliamo aprire una clinica gratuita; questo è il nostro obiettivo. Decidiamo di adottare una strategia illegale (basandoci sulla valutazione che possiamo costringere i poteri locali a concederci un po’ di autonomia o che possiamo passare sotto il loro radar e occupare bolle di autonomia preesistenti), e le tattiche che scegliamo potrebbero includere l’occupazione abusiva di un edificio, la raccolta di fondi informali, la formazione in assistenza sanitaria popolare (non professionale). Ora supponiamo di voler rovesciare lo stato nel corso della nostra vita. Il nostro piano d’attacco potrebbe essere quello di costruire un movimento popolare militante sostenuto da istituzioni autonome in cui le persone si identificano e che lottano per proteggersi dall’inevitabile repressione governativa. A questo livello, l’apertura di cliniche gratuite è solo una tattica, una delle tante azioni che costruiscono il potere secondo le linee indicate dalla strategia, che presume di tracciare il percorso per raggiungere l’obiettivo della liberazione dallo stato. Avendo già criticato la tendenza dellɜ pacifistɜ ad unificarsi sulla base di tattiche comuni piuttosto che di obiettivi comuni, lascerò da parte lɜ pacifistɜ liberali e favorevoli all’establishment e supporrò caritatevolmente una certa somiglianza di obiettivi tra attivistɜ nonviolentɜ e rivoluzionariɜ. Facciamo finta che tuttɜ noi vogliamo una liberazione completa. Rimane una differenza di strategie e tattiche. Chiaramente, l’insieme delle tattiche a disposizione dellɜ attivistɜ nonviolentɜ è inferiore, in quanto essɜ possono utilizzare solo circa la metà delle opzioni aperte allɜ attivistɜ rivoluzionariɜ. In termini di tattiche, la nonviolenza non è altro che una severa limitazione delle opzioni totali. Per far sì che la nonviolenza sia più efficace dell’attivismo rivoluzionario, la differenza dovrebbe risiedere nelle strategie, in una particolare disposizione di tattiche che raggiunga una potenza ineguagliabile a patto di evitare tutte le tattiche che potrebbero essere definite “violente”.
I quattro principali tipi di strategia pacifista sono il gioco della morale, l’approccio lobbistico, la creazione di alternative e il disimpegno generalizzato. Le distinzioni sono arbitrarie e, in casi specifici, le strategie pacifiste mescolano elementi di due o più di questi tipi. Dimostrerò che nessuna di queste strategie conferisce un vantaggio allɜ attivistɜ nonviolentɜ. In realtà, tutte sono deboli e poco lungimiranti.
Il gioco della morale cerca di creare un cambiamento lavorando sulle opinioni delle persone. In quanto tale, questa strategia manca completamente il punto. A seconda della variante specifica – educare ad occupare una posizione morale di rilievo diverse tattiche si rivelano utili, anche se, come vedremo, non portano da nessuna parte. Un’incarnazione di questa strategia è quella di educare le persone, diffondere informazioni e propaganda, cambiare l’opinione delle persone e ottenere il loro sostegno in una campagna. Ciò può significare educare le persone riguardo la povertà e influenzarle ad opporsi alla chiusura di un rifugio per senzatetto, o potrebbe significare educare le persone circa le oppressioni del governo e influenzarle a sostenere l’anarchia (è importante notare cosa si intende per “sostegno” in questi due esempi: sostegno verbale e mentale. L’educazione può incoraggiare le persone a donare denaro o a unirsi a una protesta, ma raramente incoraggia le persone a cambiare le loro priorità di vita o a correre rischi sostanziali). Le tattiche utilizzate per questa strategia educativa includono la tenuta di discorsi e forum; la distribuzione di opuscoli e altri testi informativi; l’utilizzo di media alternativi e aziendali per focalizzare e diffondere informazioni sul problema; e organizzare proteste e raduni per catturare l’attenzione della gente e aprire uno spazio di discussione sul tema. La maggior parte di noi ha familiarità con queste tattiche, poiché si tratta di una strategia comune per ottenere un cambiamento. Ci viene insegnato che l’informazione è la base della democrazia e, senza esaminare il vero significato di questa affermazione, pensiamo che significhi che possiamo creare un cambiamento facendo circolare idee supportate da fatti. Questa strategia può essere efficace per ottenere vittorie minime e fugaci, ma si scontra con diverse barriere fatali che impediscono di fare progressi seri nel perseguimento di qualsiasi obiettivo a lungo termine.
La prima barriera è il controllo da parte delle élite di un sistema di propaganda altamente sviluppato che può decimare qualsiasi sistema di propaganda concorrente che lɜ attivistɜ nonviolentɜ potrebbero creare. Il pacifismo non riesce nemmeno ad evitare di essere cooptato e annacquato: come possono lɜ pacifistɜ aspettarsi di espandersi e reclutare? La nonviolenza si concentra sul cambiamento dei cuori e delle menti, ma sottovaluta l’industria culturale e il controllo dell’opinione da parte dei media.
La manipolazione cosciente e intelligente delle abitudini e delle opinioni organizzate delle masse è un elemento importante della società democratica. Coloro che manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono un governo invisibile che è il vero potere in controllo del nostro Paese.[155]
La citazione qui sopra, scritta nel 1928, è tratta dall’importante libro di Edward Bernays, Propaganda. Bernays non era un teorico marginale della cospirazione; in realtà, era parte integrante del governo invisibile che descrive.
Tra i clienti di Bernays figurano General Motors; United Fruit; Thomas Edison; Henry Ford; i Dipartimenti di Stato, Salute e Commercio degli Stati Uniti; Samuel Goldwyn, Eleanor Roosevelt; l’American Tobacco Company e Procter & Gamble. Ha diretto i programmi di pubbliche relazioni per tutti i presidenti degli Stati Uniti, da Calvin Coolidge nel 1925 a Dwight Eisenhower alla fine degli anni Cinquanta.[156]
Da allora, l’industria delle relazioni pubbliche ha solo continuato a crescere, anche grazie al contributo di Bernays. Sia che si tratti di una campagna locale di base o di una più ampia lotta per la rivoluzione, la macchina della propaganda può mobilitarsi per contrastare, screditare, frammentare o affossare qualsiasi minaccia ideologica. Si pensi alla recente invasione statunitense dell’Iraq. Avrebbe dovuto essere un modello per il successo di questa strategia. Le informazioni c’erano: i fatti che sfatavano le menzogne sulle armi di distruzione di massa e il legame tra Saddam Hussein ed Al-Qaeda erano disponibili già mesi prima dell’invasione. La gente c’era: le proteste prima dell’invasione sono state immense, anche se il coinvolgimento dellɜ partecipanti alla protesta raramente è andato oltre quello verbale e simbolico, come ci si aspetterebbe da una strategia educativa.
I media alternativi erano presenti – grazie ad Internet hanno raggiunto un numero particolarmente elevato di americanɜ. Tuttavia, la maggioranza dell’opinione pubblica negli Stati Uniti (che è ciò che una strategia educativa cerca di catturare) non si è rivolta contro la guerra fino a quando i media aziendali hanno iniziato a divulgare regolarmente informazioni sulla falsità delle ragioni per andare in guerra e, soprattutto, sui costi crescenti dell’occupazione. E, in piena conformità con la loro natura, i media aziendali non hanno divulgato queste informazioni fino a quando segmenti significativi dell’élite hanno iniziato a opporsi alla guerra – non perché la guerra fosse sbagliata o perché fossero stati educati e illuminati, ma perché si erano resi conto che stava diventando controproducente per gli interessi e il potere degli Stati Uniti.[157] Anche in queste circostanze ideali, lɜ attivistɜ nonviolentɜ che utilizzavano una strategia educativa non sono riuscitɜ a superare i media corporativi. In quello che può essere meglio descritto come un ambiente sociale stupefacente, la ripetizione infinita e il controllo quasi totale dell’informazione da parte dei media sono molto più potenti di argomentazioni solide e ben studiate, supportate dai fatti. Spero che tuttɜ lɜ pacifistɜ capiscano che i media aziendali sono agenti dell’autorità tanto quanto le forze di polizia o i militari.
Di fronte a ciò, moltɜ attivistɜ si rivolgono ai media alternativi. Sebbene diffondere e radicalizzare ulteriormente i media alternativi sia un compito importante, non può, tuttavia, essere la spina dorsale di una strategia. È evidente che, sebbene i media alternativi possano essere uno strumento efficace in determinate circostanze, non possono competere con i media aziendali, soprattutto a causa delle gravi disuguaglianze di scala. I media alternativi sono tenuti sotto controllo da una serie di fattori coercitivi legali e di mercato. Far arrivare informazioni a milioni di persone è costoso, e non esistono sponsor in grado di finanziare in massa la stampa rivoluzionaria. Il paradosso è che non ci saranno lettrici fedeli che si abboneranno e finanzieranno un vero e proprio media radicale di massa finché la popolazione generale sarà indottrinata e allontanata dalle fonti di notizie radicali e sedata da una cultura di indulgenza. Oltre alle pressioni del mercato esiste il problema della regolamentazione e dell’intervento del governo. Le onde radio sono dominio dello stato, che può chiudere o indebolire le stazioni radio radicali che riescono a trovare fondi.[158] I governi di tutto il mondo – guidati, ovviamente, dagli Stati Uniti – hanno anche preso l’abitudine di reprimere i siti web radicali, sia imprigionando lɜ webmaster con accuse fasulle, sia sequestrando le attrezzature e chiudendo i server con il pretesto di un’indagine anti-terrorismo[159].
La seconda barriera che ostacola l’educazione alla rivoluzione è una disparità strutturalmente rafforzata nell’accesso all’istruzione. La maggior parte delle persone non è attualmente in grado di analizzare e sintetizzare le informazioni che mettono in discussione le mitologie integrali su cui si basano le loro identità e visioni del mondo. Questo vale per tutte le classi sociali. È più probabile che le persone provenienti da ambienti poveri siano sottoistruite, tenute in un ambiente mentale che scoraggia lo sviluppo del vocabolario e delle capacità analitiche. L’eccessiva istruzione delle persone provenienti da ambienti benestanti le trasforma in scimmie ammaestrate; sono addestrate a usare l’analisi solo per difendere o migliorare il sistema esistente, mentre sono inguaribilmente scettiche e derisori nei confronti di idee rivoluzionarie o verso chi suggerisce che il sistema attuale sia marcio fino al midollo.
Indipendentemente dalla classe economica, la maggior parte delle persone negli Stati Uniti risponderà alle informazioni e alle analisi radicali con il sillogismo, il moralismo e la polemica. Saranno più suscettibili allɜ opinionistɜ che sostengono saggezza convenzionale con slogan familiari, piuttosto che a chi presenta fatti e analisi impegnative. Per questo motivo, lɜ attivistɜ che adottano un approccio educativo tendono a sminuire il messaggio, in modo da poter trarre vantaggio anche loro da cliché e luoghi comuni. Tra gli esempi abbiamo lɜ attivistɜ contrariɜ alla guerra che dichiarano che “la pace è patriottica” perché sarebbe troppo difficile spiegare i problemi del patriottismo nell’attuale terreno semiologico (per non parlare di minare quel terreno) e lɜ disturbatrici culturali che cercano di trovare “memes” radicali.[160]
Un terzo ostacolo è costituito da un falso presupposto sulla potenza delle idee. L’approccio educativo sembra presupporre che la lotta rivoluzionaria sia una gara di idee, che ci sia qualcosa di potente in una idea il cui tempo sia giunto. Alla base c’è un gioco di moralità, che ignora come un buon numero di persone che sta dalla parte dell’autorità sappia bene cosa sta facendo, soprattutto negli Stati Uniti. A causa dell’ipocrisia dei nostri tempi, le persone che beneficiano del patriarcato, della supremazia bianca, del capitalismo o dell’imperialismo (quasi l’intera popolazione del Nord globale) amano giustificare la loro complicità con i sistemi di dominazione e oppressione con una serie di bugie altruistiche. Ma un’abile oratricǝ scoprirà che la maggior parte di queste persone, quando viene messa alle strette, non avrà un’epifania – reagiranno con una difesa primordiale dei mali che li privilegiano. In genere, le persone bianche rivendicheranno il merito delle meraviglie della civiltà e insisteranno sul fatto che la loro ingegnosità le autorizza a godere dei benefici della schiavitù e del genocidio; le persone ricche affermeranno di avere più diritto di possedere una fabbrica o un centinaio di acri di proprietà immobiliare più di quanto unǝ poverǝ abbia diritto a cibo e riparo; gli uomini scherzeranno sul fatto di essere il sesso forte e di avere il diritto storicamente garantito di stuprare; lɜ cittadinɜ statunitensi affermeranno in modo bellicoso di avere diritto al petrolio, alle banane o al lavoro altrui, anche quando non potranno più offuscare la natura delle relazioni economiche globali. Dimentichiamo che per mantenere l’attuale struttura di potere, un buon numero di tecnici, siano essi accademici, consulenti aziendali o pianificatori governativi, devono costantemente elaborare strategie per continuare ad aumentare il loro potere e la loro efficacia. Le illusioni democratiche possono arrivare solo fino a un certo punto e, alla fine, l’educazione porterà relativamente poche persone privilegiate a sostenere veramente la rivoluzione. A certi livelli le persone privilegiate sanno già cosa stanno facendo e quali sono i loro interessi. Le contraddizioni interne emergeranno quando la lotta si avvicinerà a casa, mettendo in discussione i privilegi su cui si basano la loro visione del mondo e le loro esperienze di vita e minacciando la possibilità di una rivoluzione confortevole e illuminata. Le persone hanno bisogno di qualcosa di più dell’istruzione per impegnarsi in una lotta dolorosa e prolungata che distrugga le strutture di potere che hanno incapsulato le loro stesse identità. L’educazione non necessariamente farà sì che le persone sosterranno la rivoluzione e, anche se lo facesse, non costruirà il potere. Contrariamente alla massima dell’era dell’informazione, l’informazione non è potere. Ricordiamo che Scientia est potentia (conoscenza è potere) è la frase d’ordine di chi è già al timone dello stato. L’informazione di per sé è inerte, ma guida l’uso efficace del potere; ha quella che gli strateghi militari chiamerebbero un “effetto moltiplicatore di forza”. Se abbiamo un movimento sociale con zero forza iniziale, possiamo moltiplicare quella forza per quante volte desideriamo e avere ancora un grosso e grasso zero. Una buona istruzione può guidare gli sforzi di un movimento sociale con potere, così come un’informazione utile guida le strategie dei governi, ma l’informazione in sé non cambia nulla. Far circolare pigramente informazioni sovversive nell’attuale contesto non fa altro che dare al governo più opportunità di mettere a punto la propria propaganda e le proprie strategie di dominio. Le persone che cercano di educare alla rivoluzione è come se gettassero benzina su un fuoco di una prateria e si aspettassero che il giusto tipo di carburante impedirà al fuoco di bruciarli (d’altra parte, l’educazione può essere esplosivamente efficace se integrata in altre strategie. In effetti, molte forme di educazione sono necessarie per costruire un movimento militante e per cambiare i valori sociali gerarchici che attualmente ostacolano un mondo libero e cooperativo. I movimenti militanti devono condurre una grande quantità di attività di sensibilizzazione per spiegare perché stanno lottando con forza per la rivoluzione e perché hanno rinunciato ai mezzi legali. Ma le tattiche militanti aprono possibilità di educazione che la nonviolenza non potrà mai cogliere. A causa dei suoi principi imperativi, i media aziendali non possono ignorare un attentato con la stessa facilità con cui possono ignorare una protesta pacifica.[161]
E anche se i media diffamano queste azioni, più immagini di dura resistenza le persone ricevono dai media, più l’illusione narcotizzante della pace sociale viene interrotta. La gente inizierà a vedere che il sistema è instabile e che il cambiamento è effettivamente possibile, superando così il più grande ostacolo al cambiamento creato dalle democrazie capitaliste guidate dai media. Rivolte e insurrezioni hanno ancora più successo nel creare rotture in questa narrazione dominante di tranquillità. Naturalmente, per educare le persone è necessario molto di più. Alla fine, dobbiamo distruggere i media aziendali e sostituirli con media interamente dal basso. Le persone che utilizzano una varietà di tattiche possono essere molto più efficaci in questo senso, impiegando una serie di mezzi innovativi per sabotare giornali e stazioni radiotelevisive aziendali; dirottare i punti vendita dei media aziendali e diffondere una trasmissione anticapitalista; difendere i media popolari e punire le agenzie responsabili della loro repressione; o espropriare denaro per finanziare e aumentare notevolmente le capacità dei media radicali.)[162]
Il mantenimento della posizione di superiorità morale, che è una variante più apertamente moralistica di questo tipo di strategia, presenta una serie di punti deboli leggermente diversi, ma si scontra con lo stesso vicolo cieco.
A breve termine, occupare la posizione di superiorità morale può essere efficace, ed è facile da fare quando i tuoi avversari sono politici bianchi suprematisti, sciovinisti e capitalisti. Lɜ attivistɜ possono usare proteste, veglie e varie forme di denuncia e abnegazione per smascherare l’immoralità del governo, in particolare o in generale, e proporsi come giusta alternativa. Lɜ attivistɜ anti-guerra “Plowshares” utilizzano spesso questo approccio.
Come tipo di strategia per il cambiamento sociale, l’occupazione dell’alta morale è indebolita dal problema critico dell’oscurità, che è difficile da superare a causa della stessa barriera corporativa e mediatica di cui si è parlato in precedenza. Inoltre, nelle democrazie guidate dai media, che trasformano la maggior parte della politica in una gara di popolarità, è improbabile che le persone vedano un gruppo minuscolo e oscuro come morale o imitabile. Tuttavia, l’approccio della “superiorità morale” evita la sfida di educare una popolazione non istruita basandosi su valori morali già esistenti e semplificando la lotta rivoluzionaria al perseguimento zelante di pochi principi. Un gruppo che si concentra sull’occupazione dell’altopiano morale attrae anche potenziali reclute con qualcosa che i media aziendali non possono offrire: chiarezza esistenziale e senso di appartenenza. Lɜ pacifistɜ di Plowshares e lɜ scioperanti contro la guerra sono spesso membri a vita. Tuttavia, i media aziendali non sono l’unica istituzione che produce conformità sociale. Le chiese, le logge Elks e le truppe dei boy scout occupano questa nicchia e, data l’enfasi che i gruppi moralmente elevati pongono sulla resa alla cultura e ai valori di gruppo, c’è poco discorso critico o valutazione delle moralità coinvolte; quindi, avere una moralità più realistica o equa conferisce pochi vantaggi effettivi. Ciò che conta di più è l’elevazione di un particolare vantaggio, e queste istituzioni morali mainstream sono molto più forti dei gruppi pacifisti in termini di accesso alle risorse. In altre parole, sono più in alto e più visibili nella società, quindi vinceranno in modo schiacciante la competizione per le nuove reclute. A causa dell’atomizzazione e dell’alienazione della vita moderna, ci sono molti vuoti non colmati da queste istituzioni morali, e moltɜ abitanti solitariɜ di periferia ancora alla ricerca di un senso di appartenenza, ma lɜ pacifistɜ radicali non saranno mai in grado di conquistare più che una minoranza di questɜ. Quellɜ che riusciranno a conquistare saranno più forti dei membri di un movimento che mira semplicemente a educare. Le persone si impegneranno a fondo per lottare per una causa in cui credono, per combattere per un leader morale o un ideale. Ma un movimento moralista ha un potenziale maggiore rispetto a un movimento basato sull’educazione di rafforzarsi e di diventare pericoloso (cioè di abbandonare infine il suo pacifismo). Guai però allɜ suɜ alleatɜ. Un tale movimento mostrerà un autoritarismo e un’ortodossia di massa e sarà particolarmente incline al fazionalismo. Sarà anche facilmente manipolabile. Forse non c’è esempio migliore del cristianesimo, che si è evoluto da movimento di opposizione a potente arma dell’Impero Romano, da culto pacifista alla religione più patologicamente violenta e autoritaria che l’umanità abbia mai concepito.
In entrambe le varianti dell’approccio “giocarsela-sulla-morale” della strategia pacifista, lo scopo è quello di indurre la maggioranza di una società a unirsi o a sostenere un movimento (possiamo lasciare da parte le risibili pretese di illuminare o svergognare le autorità per indurle a sostenere la rivoluzione). Entrambe le varianti si trovano di fronte a scarse probabilità di coinvolgere questa maggioranza a causa degli efficaci controlli strutturali sulla cultura all’interno delle società moderne. Nell’improbabile possibilità che queste probabilità vengano superate, nessuna delle due varianti sarebbe funzionalmente in grado di conquistare nulla più che una maggioranza. Anche se l’educazione diventasse uno strumento più efficace con le persone privilegiate, non funzionerebbe contro l’élite e la classe esecutiva, che ricevono forti incentivi. Sono culturalmente legate al sistema.
Nel migliore dei casi, strategie di questo tipo porteranno ad una maggioranza oppositiva ma passiva, che la storia ha dimostrato essere facile da controllare per una minoranza armata (ad esempio nel colonialismo). Tale maggioranza potrebbe sempre passare a qualche altro tipo di strategia che implichi la lotta e la vittoria, ma senza alcuna esperienza o anche solo familiarità morale intellettuale con la resistenza reale, la transizione sarebbe difficile. Nel frattempo, il governo potrebbe fare ricorso a falle facilmente sfruttabili insite nella strategia del giocarsela-sulla-morale, e un movimento apparentemente rivoluzionario si limiterebbe ad una battaglia orribilmente scorretta, cercando di conquistare cuori e menti senza distruggere le strutture che hanno avvelenato quei cuori e quelle menti.
L’educazione e la costruzione di un ethos liberatorio sono necessari per sradicare completamente le relazioni sociali gerarchiche, ma esistono istituzioni concrete come i tribunali, le scuole pubbliche, i campi di addestramento e le aziende di pubbliche relazioni che sono strutturalmente immuni ai “cambiamenti di cuore” e che intervengono automaticamente nella società per indottrinare le persone alla morale che sostiene i rapporti sociali gerarchici e la produzione e il consumo capitalistici.
Negare a noi stessɜ mezzi non pacifici per rafforzare il movimento e indebolire o sabotare queste strutture ci lascia in una barca che affonda, con un piccolo secchio per raccogliere l’acqua che entra da un buco largo tre metri, fingendo che presto saremo abbastanza in alto nell’acqua per salpare verso il nostro obiettivo. Sembra di aspettare una manna dal cielo e non dovrebbe essere considerata una strategia. In una battaglia a breve termine per evitare che una nuova miniera di carbone o un inceneritore di rifiuti arrivino nel quartiere, è possibile elaborare una strategia mediatica efficace all’interno di vincoli pacifisti (soprattutto se la campagna educativa include informazioni su come la miniera danneggerà lɜ privilegiatɜ in quella zona). Ma per ottenere cambiamenti duraturi, strategie di questo tipo di solito non riescono nemmeno a portare al vicolo cieco che inevitabilmente creano.
Lɜ aspiranti rivoluzionariɜ esemplificano l’inefficacia della nonviolenza nella costruzione del potere quando affrontano la loro lotta come un gioco di moralità, e anche quando adottano un approccio lobbistico. Le lobby sono state introdotte nel processo politico da istituzioni che avevano già un potere significativo (per esempio, le corporazioni). Lɜ attivistɜ possono costruire il proprio potere organizzando proteste e dimostrando l’esistenza di un corpo elettorale (su cui i loro lobbisti fanno leva), ma questo modo per incanalare il potere per le lobby è molto più debole rispetto al freddo e duro denaro delle corporazioni. Pertanto, le lobby “rivoluzionarie” sono impotenti rispetto alle opposte lobby dello status quo. Il lobbismo porta anche a un movimento gerarchico e depotenziato. La grande maggioranza sono persone che firmano petizioni, raccolgono fondi o tengono cartelli di protesta, mentre una minoranza istruita e ben vestita che cerca udienza presso i politici e le altre élite detiene tutto il potere.
I lobbisti finiscono per identificarsi più con le autorità che con chi li elegge – corteggiando il potere, se ne innamorano e il tradimento diventa probabile. Se i politici si scontrano con un lobbista moralmente onesto e intransigente, gli negheranno semplicemente un’udienza, togliendo il tappeto da sotto i piedi alla sua organizzazione. Le lobby di attivistɜ hanno più successo quando sono disposte a compromettere il proprio collegio elettorale (la politica rappresentativa in una democrazia è l’arte di svendere un collegio elettorale mantenendone la fedeltà). Alcuni gruppi che cercano di fare pressione sulle autorità non nominano lobbisti specializzati, evitando così di sviluppare una leadership elitaria che sarà cooptata dal sistema; tuttavia, si sono comunque messi nella posizione di mobilitare la pressione per indurre il sistema a cambiare.
Lɜ attivistɜ nonviolentɜ che utilizzano la strategia di lobbying tentano di creare una realpolitik passiva per esercitare una qualche influenza. Ma l’unico modo per fare leva contro lo stato nel perseguire interessi diametralmente opposti ai suoi è quello di minacciare l’esistenza dello stato stesso. Solo una tale minaccia può indurre lo stato a riconsiderare gli altri interessi, perché l’interesse primario dello stato è l’auto-perpetuazione.
Nella sua storia interpretativa della rivoluzione messicana e della ridistribuzione delle terre, John Tutino sottolinea che “solo lɜ ribelli più persistenti e spesso violentɜ, come lɜ zapatistɜ, ricevettero la terra dai nuovi leader del Messico. La lezione era chiara: solo chi minacciava il regime otteneva la terra; quindi chi cercava la terra doveva minacciare il regime”.[163] Tutto ciò accadeva sotto un governo presunto alleato dellɜ rivoluzionariɜ agrariɜ messicanɜ. Cosa pensano di ottenere lɜ pacifistɜ da governi il cui elettorato privilegiato è dichiaratamente quello degli oligarchi aziendali? Frantz Fanon ha espresso lo stesso sentimento in modo simile per quanto riguarda l’Algeria:
Quando nel 1956... il Front de Liberation Nationale, in un famoso volantino, affermava che il colonialismo allenta la sua presa solo quando il coltello è alla sua gola, nessunǝ algerinǝ trovò questi termini troppo violenti. Il volantino esprimeva solo ciò che ogni algerinǝ sentiva nel cuore: il colonialismo non è una macchina pensante, né un corpo dotato di facoltà di ragionamento. È violenza allo stato naturale, e cederà solo di fronte a una violenza maggiore.[164]
Le lezioni dell’Algeria e della rivoluzione messicana valgono per tutta la storia. La lotta contro l’autorità sarà violenta, perché l’autorità stessa è violenta e l’inevitabile repressione è un’escalation di quella violenza. Anche il “buon governo” non ridistribuirà il potere verso il basso a meno che non sia minacciato di perdere tutto il suo potere. L’attività di lobbying per il cambiamento sociale è uno spreco di scarse risorse per i movimenti radicali. Immaginatevi se tutti i milioni di dollari e le centinaia di migliaia di ore di volontariato da parte di progressisti e persino di radicali che sono andati a fare lobbying per qualche legge o per sconfiggere la rielezione di qualche politico, andassero invece a finanziare centri sociali autogestiti, cliniche gratuite, gruppi di supporto per carceratɜ, centri di risoluzione dei conflitti comunitari e scuole gratuite? Potremmo davvero gettare le basi per un serio movimento rivoluzionario. Invece, un’enorme quantità di sforzi viene sprecata.
Inoltre, lɜ attivistɜ che utilizzano l’approccio lobbistico non si rendono conto che fare richieste all’autorità è una strategia sbagliata. Lɜ attivistɜ nonviolentɜ impiegano tutte le loro energie per costringere le autorità ad ascoltare le loro richieste quando potrebbero usare questa energia per costruire il potere, per costruire una base da cui dichiarare loro guerra. Se avranno successo, che cosa avranno ottenuto? Al massimo, il governo borbotterà delle scuse, perderà un po’ la faccia e soddisferà la richiesta sulla carta (anche se, in realtà, si limiteranno a fare i salti mortali per nascondere il problema). Dopo di che, lɜ attivistɜ perderanno lo slancio e l’iniziativa. Dovranno mettersi sulla difensiva, cambiare direzione e riadattare la loro campagna per evidenziare che la riforma è fraudolenta. I membri disillusi della loro organizzazione si tireranno fuori, e il pubblico in generale percepirà l’organizzazione come lamentosa e impossibile da soddisfare (non c’è da stupirsi che molte organizzazioni attiviste orientate alle lobby rivendichino la vittoria al più vuoto dei compromessi).
Consideriamo, ad esempio, la School of the Americas Watch (SOAW). Per più di una dozzina di anni, l’organizzazione ha utilizzato proteste passive annuali, documentari e campagne educative per costruire lobby per convincere i politici a sostenere una proposta di legge per la chiusura della School of the Americas (SOA), una scuola dell’esercito che ha addestrato decine di migliaia di ufficiali e soldati latinoamericani che sono stati complici della maggior parte delle peggiori violazioni dei diritti umani e atrocità nei loro rispettivi paesi. Nel 2001, il SOAW aveva quasi ottenuto un sostegno sufficiente dal Congresso per far passare una legge che chiudesse la SOA. Avvertendo il pericolo, il Pentagono si limitò a presentare un disegno di legge alternativo che “chiudeva” la SOA e la riapriva immediatamente con un nome diverso. I politici scelsero la via più facile e approvarono il disegno di legge del Pentagono. Per anni a seguire, la SOAW non riuscì a riconquistare l’appoggio di molti politici che sostenevano di voler aspettare per vedere se la “nuova” scuola fosse un miglioramento. Se la SOAW riuscirà mai a chiudere la scuola, qualunque sia il suo nome, l’esercito potrà semplicemente estendere le sue operazioni di addestramento alla tortura ad altre basi militari e programmi in tutto il Paese, oppure trasferire la maggior parte del lavoro a consulenti militari all’estero. Se ciò dovesse accadere, il SOAW si ritroverebbe senza una strategia valida, senza aver fatto alcun passo avanti circa il militarismo statunitense.[165] Quando mai il governo degli Stati Uniti ha lasciato che una legge o un trattato gli impedisse di fare ciò che voleva?
Al contrario, se lɜ radicali cambiassero il loro approccio per combattere direttamente il militarismo statunitense, e se potessero costituire una minaccia reale senza mai avvicinarsi a un tavolo di negoziazione, i funzionari governativi spaventati comincerebbero a redigere compromessi e a legiferare riforme nel tentativo di evitare la rivoluzione. La decolonizzazione, la legislazione sui diritti civili e quasi tutte le altre riforme importanti sono state conquistate in questo modo. Lɜ radicali non dovrebbero mai chiudersi in se stessɜ o garantire il tradimento stando in una lobby o sedendosi al tavolo delle trattative. Rifiutandosi di essere placatɜ, lɜ rivoluzionariɜ conducono una trattativa più dura rispetto a coloro il cui obiettivo è la pura contrattazione. Anche quando perdono, i movimenti militanti tendono a provocare riforme. Le Brigate Rosse in Italia alla fine non ebbero successo, ma costituirono una tale minaccia che lo stato italiano istituì una serie di misure sociali e culturali progressiste di vasta portata in campo sociale e culturale (ad esempio, l’espansione dell’istruzione pubblica e della spesa sociale, il decentramento di alcune funzioni governative, l’ingresso del Partito Comunista nel governo, la legalizzazione della contraccezione e dell’aborto) nel tentativo di sottrarre sostegno alla base dei militanti attraverso il riformismo.[166]
L’approccio di costruzione dell’alternativa impiega una componente importante di una strategia rivoluzionaria, ma sottovaluta tutte le componenti complementari necessarie per il successo. L’idea è che, creando istituzioni alternative, si possa creare una società autonoma e dimostrare che il capitalismo e lo stato sono indesiderabili.[167]
In realtà, mentre la costruzione di queste alternative è della massima importanza per creare e sostenere un movimento rivoluzionario e per gettare le basi per le società liberate che verranno dopo la rivoluzione, è assolutamente assurdo pensare che il governo se ne starà lì seduto e ci lascerà costruire esperimenti scientifici che dimostreranno la sua obsolescenza. Gli eventi argentini legati al crollo economico del 2001 (ad esempio, l’appropriazione delle fabbriche) hanno ispirato molto i movimenti antiautoritari. Lɜ anarchichɜ nonviolentɜ (moltɜ dellɜ quali accademichɜ) che favoriscono la strategia di creare pacificamente istituzioni alternative, utilizzano un’interpretazione annacquata degli eventi argentini per infondere un po’ di vita alla loro strategia, che altrimenti sarebbe stata debole. Ma le fabbriche occupate in Argentina sono sopravvissute in uno dei due modi: o diventando legalmente riconosciute e recuperate in un’economia capitalista, semplicemente una forma più partecipativa di società di corporazione; o costruendo barricate – respingendo i tentativi di sgombero da parte della polizia con bastoni e fionde e costruendo alleanze con le assemblee militanti di quartiere, in modo che le autorità temessero una diffusione del conflitto in caso di inasprimento delle loro tattiche. E il movimento delle fabbriche è sulla difensiva. La sua pratica e la sua teoria sono in conflitto perché, in generale, non è diretto verso l’obiettivo di sostituire il capitalismo diffondendo alternative controllate dallɜ lavoratrici. La principale debolezza dellɜ operaiɜ radicali è stata l’incapacità di espandere il loro movimento attraverso l’espropriazione delle fabbriche dove i dirigenti sono ancora al comando.[168] Un tale percorso lɜ porrebbe in un conflitto con lo stato più grande di quello a cui sono attualmente preparatɜ ad affrontare. Certo, stanno fornendo un esempio importante e stimolante, ma finché riusciranno a rilevare solo fabbriche già abbandonate, non avranno creato un modello per sostituire effettivamente il capitalismo.
Alla Conferenza anarchica nordamericana del 2004, l’oratore Howard Ehrlich ha raccomandato allɜ anarchichɜ di oggi di agire come se la rivoluzione fosse già qui e di costruire il mondo che vogliamo vedere. Tralasciando l’insensatezza di questo consiglio per le persone in prigione, per lɜ indigenɜ che devono affrontare il genocidio, per lɜ irachenɜ che cercano di sopravvivere sotto occupazione, per lɜ africanɜ che muoiono di diarrea semplicemente perché privatɜ di acqua potabile, e la maggior parte delle altre popolazioni del mondo, mi chiedo come abbia fatto Ehrlich a non accorgersi della lunga storia di repressione governativa di spazi autonomi al servizio dei movimenti rivoluzionari.
Ad Harrisonburg, in Virginia, abbiamo allestito un centro comunitario anarchico, abbiamo permesso allɜ senzatetto di dormire lì durante l’inverno e abbiamo fornito gratuitamente cibo e vestiti. Nel giro di sei mesi la polizia ci ha fatto chiudere, usando una serie creativa di leggi urbanistiche e di codici edilizi.[169] Negli anni ’60, la polizia si interessò attivamente a sabotare il programma delle Pantere Nere che forniva la colazione gratuita allɜ bambinɜ. Come possiamo costruire istituzioni alternative se non siamo in grado di proteggerle dalla repressione?
Come potremo trovare terreni su cui costruire strutture alternative se tutto in questa società ha unǝ proprietariǝ? E come possiamo dimenticare che il capitalismo non è senza tempo, che una volta tutto era “alternativo” e che l’attuale paradigma si è sviluppato e ampliato proprio per la sua capacità di conquistare e consumare quelle alternative? Ehrlich ha ragione sul fatto che dobbiamo iniziare a costruire istituzioni alternative ora, ma sbaglia a de-enfatizzare l’importante lavoro di distruzione delle istituzioni esistenti e di difesa di noi stessɜ e dei nostri spazi autonomi nel processo. Anche se mescolata con metodi nonviolenti più aggressivi, una strategia basata sulla costruzione di alternative che si limiti al pacifismo non sarà mai abbastanza forte da resistere alla violenza zelante che le società capitaliste impiegano quando conquistano e assorbono società autonome.
Finalmente, abbiamo l’approccio strategico nonviolento della disobbedienza generalizzata. Questa tende ad essere la più tollerante delle strategie nonviolente, spesso ammette la distruzione di proprietà e la resistenza fisica simbolica, sebbene anche le campagne nonviolente più disciplinate di nonviolenza e disobbedienza rientrino in questa tipologia. Il recente film La quarta guerra mondiale[170] si colloca ai margini militanti di questa concezione della rivoluzione, evidenziando le lotte di resistenza dalla Palestina al Chiapas e nascondendo opportunamente i segmenti significativi di quei movimenti impegnati nella lotta armata, probabilmente per comodità del pubblico statunitense. Le strategie di disobbedienza cercano di bloccare il sistema attraverso scioperi, blocchi, boicottaggi e altre forme di disobbedienza e rifiuto. Sebbene molte di queste tattiche siano estremamente utili quando si costruisce una vera pratica rivoluzionaria, la strategia stessa presenta una serie di lacune.
Questo tipo di strategia può solo creare pressione e leva, ma non può riuscire a distruggere il potere o a consegnare il controllo della società al popolo. Quando una popolazione si impegna in una disobbedienza generalizzata, i potenti devono affrontare una crisi. L’illusione della democrazia non funziona: questa è una crisi. Le autostrade sono state bloccate e gli affari si sono fermati, ma le persone al potere controllano ancora un grande surplus e non rischiano di morire di fame a causa dello sciopero. Controllano tutto il capitale del Paese, anche se una parte di esso è stato messo fuori uso dalle occupazioni. Soprattutto, hanno ancora il controllo dell’esercito e della polizia (le élite hanno imparato molto di più a mantenere la lealtà dei militari dopo la Rivoluzione russa e, negli ultimi decenni, le uniche defezioni militari significative si sono verificate quando l’esercito ha affrontato una resistenza violenta e il governo sembrava essere in punto di morte. La polizia, da parte sua, è sempre stata una fedele servitrice). Possono usare i militari per sfondare qualsiasi barricata nonviolenta, riprendere qualsiasi fabbrica occupata e impadronirsi del prodotto del loro lavoro se lɜ ribelli cercano di condurre un’economia autonoma. In definitiva, i potenti possono arrestare, torturare e uccidere tuttɜ lɜ ribelli, spingere il movimento alla clandestinità e ristabilire l’ordine nelle strade. Una popolazione ribelle che fa sit-in o lancia sassi non può opporsi a un esercito a cui è stata data libertà di usare tutte le armi del suo arsenale. Ma a porte chiuse, i leader del Paese sono d’accordo sul fatto che questi metodi non siano preferibili, se non come ultima ultima risorsa. Il loro utilizzo distruggerebbe l’illusione della democrazia per anni, spaventerebbe gli investitori e danneggerebbe l’economia. Così vincono lasciando che lɜ ribelli dichiarino vittoria: sotto la pressione dei leader economici e militari, il presidente e alcuni politici eletti si dimettono (o, meglio ancora, fuggono in elicottero); i media aziendali la definiscono una rivoluzione e iniziano a strombazzare le credenziali populiste del presidente sostituto (che è stato scelto dalle imprese e dai militari); e lɜ attivistɜ del movimento popolare, se si sono limitatɜ alla nonviolenza invece di prepararsi all’inevitabile escalation di tattiche, perdono proprio quando sono finalmente alle porte della rivoluzione.
Nella sua lunga storia, questo tipo di strategia non è riuscita a far sì che la classe dei proprietari, dei gestori e degli esecutori disertasse e fosse disobbediente, perché i loro interessi sono sempre stati diametralmente opposti a quelli di chi partecipa alla disobbedienza. Ciò che le strategie di disobbedienza sono riuscite a fare, più e più volte, è stato destituire determinati regimi di governo, anche se questi vengono sempre sostituiti da altri regimi costituiti tra le élite (a volte moderati riformisti e a volte la stessa leadership del movimento di opposizione). Questo è accaduto in India al momento della decolonizzazione e in Argentina nel 2001; con Marcos nelle Filippine e con Milosevic in Serbia (quest’ultimo esempio, e le analoghe “rivoluzioni” in Georgia, Ucraina e Libano, dimostrano l’inefficacia della disobbedienza generalizzata nel consegnare effettivamente il potere sociale al popolo; tutti questi colpi di stato popolari sono stati in realtà orchestrati e finanziati dagli Stati Uniti per installare politici più favorevoli al mercato e agli Stati Uniti).[171]
Non è nemmeno corretto dire che i vecchi regimi siano stati “costretti a mollare”. Di fronte alla crescente disobbedienza e alla minaccia di una vera e propria rivoluzione, scelgono di cedere il potere a nuovi regimi del capitalismo e dello stato. Quando non hanno la possibilità di trasferire il potere, si tolgono i guanti e tentano di brutalizzare e dominare il movimento, che non è in grado di difendersi e sopravvivere senza un’escalation di tattiche. Questo è ciò che è successo al movimento sindacale antiautoritario statunitense negli anni ’20.
Le strategie di disobbedienza generalizzata tentano di bloccare il sistema, ma anche in questo caso sono meno efficaci delle strategie militanti. Nello stesso contesto richiesto per la disobbedienza generalizzata – un movimento di ribellione ampio e ben organizzato – se non limitiamo il movimento alla nonviolenza ma sosteniamo invece una diversità di tattiche, esso sarà tremendamente più efficace. In termini di chiusura del sistema non c’è paragone tra la pace e il blocco totale di una linea ferroviaria e la distruzione della stessa. Quest’ultima provoca un’ostruzione più duratura, costa di più per essere riparata, richiede una risposta più drammatica da parte delle autorità e danneggia maggiormente il morale e l’immagine pubblica delle stesse. Far esplodere una linea ferroviaria (o utilizzare una forma di sabotaggio meno drammatica e meno minacciosa, se la situazione sociale suggerisce che questa sarà più efficace) spaventerà e farà irritare le persone contrarie al movimento di liberazione più di quanto non faccia un blocco pacifico, e le indurrà anche a prendere il movimento più seriamente, invece di liquidarlo come una seccatura (naturalmente, coloro che praticano una diversità di tattiche hanno la possibilità di effettuare un blocco pacifico o un atto di sabotaggio, a seconda di come valutano la reazione dell’opinione pubblica).
Sebbene sia in qualche modo utile per lɜ lavoratricɜ, una strategia di disobbedienza generalizzata non ha alcuna rilevanza per le popolazioni già emarginate – come le molte nazioni indigene destinate all’espulsione o allo sterminio – perché la loro partecipazione non è vitale per il funzionamento dello stato aggressore. Gli Ache dell’Amazzonia non pagano tasse da trattenere e non fanno lavori da cui scappare. La campagna genocìda contro di loro non si basa sulla loro cooperazione o meno. Le persone che le autorità vorrebbero vedere morire e basta non possono fare leva sulla disobbedienza.
Come abbiamo visto, i principali tipi di strategie nonviolente, a lungo termine, si scontrano tutti con insormontabili vicoli ciechi. Le strategie basate sul gioco morale fraintendono il modo in cui lo stato mantiene il controllo. Pertanto sono cieche di fronte alle barriere poste dai media e dalle istituzioni culturali, e non offrono alcuna risposta alla capacità delle minoranze armate di controllare le maggioranze disarmate. L’approccio lobbistico spreca risorse nel tentativo di fare pressione sul governo affinché agisca in contraddizione con i propri interessi. Le strategie incentrate sulla costruzione di alternative ignorano la capacità dello stato di reprimere i progetti radicali e il talento del capitalismo nell’assorbire e corrompere le società autonome. Le strategie di disobbedienza generalizzate aprono la porta alla rivoluzione, ma negano ai movimenti popolari le tattiche necessarie per espropriare il controllo diretto dell’economia, ridistribuire la ricchezza e distruggere l’apparato repressivo dello stato.
La visione a lungo termine che mostra l’inefficacia di questi tipi di strategia nonviolenta rende poco probabile anche una strategia militante, visto che oggi la maggior parte delle comunità anarchiche negli Stati Uniti è probabilmente del tutto impreparata a difendersi dallo stato. Ma è nella nostra organizzazione quotidiana che lɜ antiautoritariɜ possono strategicamente superare la passività e promuovere la militanza, cambiando così le prospettive delle lotte future. Le strategie nonviolente impediscono questo lavoro. Ci svantaggiano anche nelle interazioni con la polizia e i media, due esempi che vale la pena approfondire.
La nonviolenza è parte integrante delle strategie di polizia comunitaria e di controllo della folla. Le tattiche del pacifismo, come molte delle tattiche delle moderne forze dell’ordine per il controllo delle folle, sono progettate per ridimensionare le situazioni potenzialmente insurrezionali. Nel suo recente libro sulla storia e lo sviluppo delle moderne forze di polizia statunitensi, Our Enemies in Blue, Kristian Williams documenta come la crisi degli anni ’60 e ’70 abbia dimostrato alle forze di polizia come i loro metodi di gestione dell’insurrezione popolare (come le rivolte urbane e le proteste militanti) non facessero altro che incoraggiare una maggiore resistenza e una maggiore violenza da parte dellɜ resistenti.[172]
La resistenza si è rafforzava, la polizia prendeva il controllo e il governo doveva inviare militari (erodendo ulteriormente l’illusione della democrazia e aprendo la possibilità di una vera ribellione). Negli anni successivi, la polizia sviluppò strategie di community policing[173] per migliorare la propria immagine e controllare le organizzazioni comunitarie potenzialmente sovversive sviluppando tattiche di controllo della folla che enfatizzassero un ridimensionamento delle situazioni. Le descrizioni di queste tattiche rispecchiano esattamente le raccomandazioni pacifiste per la conduzione delle proteste. La polizia consente forme minori di disobbedienza, mantenendo la comunicazione con lɜ leader della protesta, sullɜ qualɜ esercita pressioni in anticipo per far sì che la protesta si autogestisca. Gli “sceriffi della pace”, i collegamenti con la polizia e i permessi per i cortei sono tutti aspetti di questa strategia di polizia, il che mi porta a chiedermi se lɜ pacifistɜ abbiano elaborato queste idee indipendentemente, in funzione della loro mentalità implicitamente statalista, o se fossero così entusiastɜ del loro nemico da assorbire completamente i suoi suggerimenti su come come condurre la resistenza. In ogni caso, finché continueremo a tollerare una leadership nonviolenta, la polizia ci terrà esattamente dove vuole. Ma se rifiutiamo la cooperazione con la polizia possiamo organizzare proteste dirompenti quando sono necessarie e combattere per gli interessi della nostra comunità o della nostra causa senza compromessi.
La nonviolenza porta anche a strategie mediatiche sbagliate. I codici di condotta nonviolenti per le azioni di protesta contraddicono la regola numero uno delle relazioni con i media: rimanere sempre sul messaggio. Lɜ attivistɜ nonviolentɜ non hanno bisogno di utilizzare codici di nonviolenza per mantenersi pacifichɜ. Lo fanno per imporre la conformità ideologica e per affermare la loro leadership sul resto dellɜ protestanti. Lo fanno anche come assicurazione, in modo che se qualche elemento incontrollabile dovesse agire in modo violento durante una protesta, sarebbero in grado di difendersi dalla demonizzazione da parte dei media. Tirano fuori il codice della nonviolenza come prova di non essere responsabili della violenza e si prostrano davanti all’ordine regnante. A questo punto, hanno già perso la guerra mediatica. Lo scambio tipico è qualcosa del genere:
Reporter: Che cosa ha da dire sulle vetrine infrante durante la protesta di oggi?
Manifestante: La nostra organizzazione ha un impegno alla nonviolenza ben pubblicizzato. Condanniamo le azioni dellɜ estremistɜ che stanno rovinando questa protesta mettendo in cattiva luce le persone benintenzionate che si preoccupano di salvare le foreste, di fermare la guerra e di bloccare gli sfratti.
Lɜ attivistɜ raramente ottengono più di due righe di citazioni o più di dieci secondi nei media aziendali. Lɜ attivistɜ nonviolentɜ esemplificatɜ in questa scenetta sprecano la loro fugace attenzione mettendosi sulla sulla difensiva; rendendo il loro problema secondario rispetto alle preoccupazioni dell’élite (distruzione di proprietà da parte di manifestanti); ammettendo apparentemente al pubblico debolezza, fallimento e disorganizzazione (assumendosi simulatamente la responsabilità di altrɜ manifestanti e lamentando al contempo l’incapacità di controllarlɜ); e, oltretutto, pugnalare alle spalle lɜ alleatɜ in pubblico e dividere il movimento.[174] Questo confronto sarebbe dovuto apparire in questo modo:
Reporter: Che cosa ha da dire sulle vetrine infrante durante la protesta di oggi?
Manifestante: In confronto alla violenza della deforestazione, della guerra, di questi eventi… [Inserire fatti potenti sul tema]
Se pressatɜ o interpellatɜ dalle forze dell’ordine, lɜ attivistɜ potrebbero insistere sul fatto di non essere statɜ personalmente responsabili della distruzione delle proprietà e non possono commentare le motivazioni di coloro che l’hanno fatto (ma è meglio non parlare con i membri dei media aziendali come se fossero esseri umani, perché raramente si comportano in questo modo. Lɜ attivistɜ dovrebbero rispondere solo con dichiarazioni concise che affrontino con tatto la questione; altrimenti, è probabile che i redattori pubblichino citazioni insensate o che censurino le informazioni rilevanti). Se lɜ attivistɜ riescono a mantenere l’attenzione sulla questione reale, possono sfruttare le successive opportunità per ripulire il proprio nome e ribadire il problema in questione (con tattiche quali la scrittura di lettere all’editore o la protesta contro le accuse diffamatorie dei media). Ma se sono più preoccupatɜ di ripulire il proprio nome piuttosto che affrontare il problema, diventano inutili.
In prima analisi, una visione militante della rivoluzione sembra più impraticabile di una visione nonviolenta, ma questo è dovuto al fatto che è realistica. Le persone devono capire che il capitalismo, lo stato, la supremazia bianca, l’imperialismo e il patriarcato costituiscono una guerra contro i popoli di questo pianeta. E la rivoluzione è un’intensificazione di questa guerra. Non possiamo liberare noi stessɜ e il mondo in cui vogliamo vivere se pensiamo a un cambiamento sociale radicale con azioni come dire la verità al potere, conquistare cuori e menti, o qualsiasi altra parata passiva. Milioni di persone muoiono ogni anno su questo pianeta per la mancanza di acqua potabile, perché i governi e le multinazionali che hanno usurpato il controllo dei beni comuni non hanno trovato un modo per trarre profitto dalle vite di queste persone, le lasciano morire. Milioni di persone muoiono ogni anno perché alcune multinazionali e i loro governi alleati non vogliono permettere la produzione di farmaci generici contro l’AIDS e di altre medicine. Pensate che alle istituzioni e alle élite che detengono il potere di vita o di morte su milioni di persone importi qualcosa delle nostre proteste? Ci hanno dichiarato guerra e noi dobbiamo rendergliela. Non perché siamo arrabbiatɜ (anche se dovremmo esserlo), non per vendicarci e non perché agiamo d’impulso, ma perché valutiamo la possibilità di libertà contro la certezza della vergogna derivante dal vivere sotto qualsiasi forma di dominio che ci troviamo ad affrontare nel nostro particolare angolo di mondo; perché ci rendiamo conto che alcune persone stanno già combattendo, spesso da sole, per la loro liberazione, e che hanno il diritto di farlo e che noi dovremmo sostenerle; e perché ci rendiamo conto che le prigioni sovrapposte che imprigionano il nostro mondo sono così astutamente costruite che l’unico modo per liberarci è combattere, distruggere queste prigioni e sconfiggere i carcerieri con ogni mezzo necessario.
Rendersi conto che si tratta di una guerra può aiutarci a decidere cosa fare e ad elaborare strategie efficaci per il lungo periodo. Quellɜ di noi che vivono in Nord America, in Europa e in alcune altre parti del mondo vivono nell’illusione della democrazia. Il governo finge educatamente di non farci mai del male, anche se sfidassimo la sua autorità, ma questa è una facciata sottile. Nel suo discorso annuale al Congresso, il 3 dicembre 1901, il presidente Theodore Roosevelt, parlando del nemico del momento, dichiarò: “Dovremmo combattere con implacabile efficienza non solo contro lɜ anarchichɜ, ma contro tuttɜ lɜ simpatizzanti attivɜ e passivɜ dellɜ anarchicɜ”.[175] Cento anni dopo, nel settembre 2001, il presidente George W. Bush annunciò: “O siete con noi, o siete con i terroristi”.[176]
Oltre a mostrare quanto poco sia cambiato il nostro governo in un secolo, questa citazione pone una domanda interessante. Naturalmente possiamo rifiutare la richiesta di Bush di dichiarare fedeltà alla Casa Bianca se non ci schieriamo con Osama bin Laden poiché altrimenti dovremmo dichiarare fedeltà alla Casa Bianca. Ma se insistiamo sulla slealtà, allora, a prescindere dalle nostre affiliazioni personali, dobbiamo tenere a mente che Bush ci ha giudicatɜ terroristɜ e il Dipartimento di Giustizia ha dimostrato che potrebbe perseguirci come tali nella sua campagna contro lɜ attivistɜ ambientalistɜ radicali che ha etichettato come “ecoterroristɜ”;[177] sfruttare la Task Force sul terrorismo per spiare lɜ dissidenti; ed esercitare potere con vessazioni, repressioni e deportazioni di musulmanɜ e immigratɜ, che è stata la principale attività di “sicurezza” interna del governo dopo l’11 settembre. Potremmo riconoscere con orgoglio che “terrorista” è stata per decenni l’etichetta scelta dai governi per lɜ combattenti per la libertà e certamente questo onore è precoce, visto lo stato del nostro movimento. Ma la resistenza pacifica negli Stati Uniti non si sente a proprio agio nel ruolo di combattente per la libertà. Invece di riconoscere la guerra che già esiste, ci siamo spostatɜ sul lato sicuro della dicotomia di Bush – che lo ammettiamo o meno – e la nonviolenza è stata la nostra scusa.
Il generale Frank Kitson, un influente teorico britannico dell’esercito, della polizia e del controllo sociale le cui strategie sono state diffuse e adottate da pianificatori statali e agenzie di polizia negli Stati Uniti, suddivide i disordini sociali in tre fasi: preparazione, nonviolenza e insurrezione.[178]
La polizia lo sa e fa il possibile per trattenere lɜ dissidenti e le masse sfiduciate nelle prime due fasi. Moltɜ di questɜ dissidenti non lo capiscono. Non capiscono cosa ci vuole per ridistribuire il potere nella nostra società e impediscono a loro stessɜ e allɜ loro alleatɜ di andare fino in fondo. È evidente che lo stato abbia più paura dei gruppi militanti che di quelli nonviolenti, e io ho usato ciò come prova del fatto che i gruppi militanti siano più efficaci. Lo stato capisce che deve reagire con più forza ed energia per neutralizzare i movimenti rivoluzionari militanti. Ho sentito alcunɜ attivistɜ nonviolentɜ capovolgere questo fatto per sostenere che i tentativi nonviolenti di rivoluzione sono più efficaci perché quelli militanti saranno selvaggiamente repressi (e in altri capitoli ho citato questɜ attivistɜ per dimostrare come la loro preoccupazione principale sia la loro sicurezza). È vero che il cammino verso la rivoluzione immaginato dallɜ attivistɜ militanti è molto più pericoloso e difficile di quello immaginato dallɜ pacifistɜ, ma ha anche il vantaggio di essere realistico, a differenza della fantasia pacifista. Ma questo gioco di prestigio logico merita di essere esaminato.
Lɜ pacifistɜ sostengono di essere più efficaci perché hanno maggiori probabilità di sopravvivere alla repressione. Il loro ragionamento è che lɜ militanti danno allo stato una scusa per eliminarlɜ (la scusa è l’autodifesa contro un nemico violento), mentre gli stati non sono in grado di usare una violenza schiacciante contro lɜ pacifistɜ perché non ci può essere alcuna giustificazione. L’ingenuo presupposto su cui si basa questo ragionamento è che i governi siano governati dall’opinione pubblica e non viceversa. Superando i sofismi della nonviolenza, possiamo facilmente stabilire il fattore che determina se la repressione del governo sarà una misura popolare nel tribunale dell’opinione pubblica. Questo fattore è la legittimità popolare – o la sua mancanza – di cui gode il movimento di resistenza. Non ha nulla a che vedere con la violenza o la nonviolenza. Se il popolo non vede un movimento di resistenza come legittimo, se sventola la bandiera con tuttɜ lɜ altrɜ, esulterà anche quando il governo compierà massacri. Ma se la popolazione simpatizza con il movimento di resistenza, allora la repressione governativa stimolerà una maggiore resistenza. Il massacro di un gruppo pacifico di Cheyenne e Arapaho a Sand Creek portò solo applausi da parte dellɜ cittadinɜ bianchɜ dell’Unione; simile fu la risposta nazionale alla repressione di innocuɜ “comunistiɜ” negli anni ‘50. Ma nei momenti di massima popolarità, i tentativi britannici di reprimere l’Esercito Repubblicano Irlandese (IRA) non fecero altro che accrescere il sostegno all’IRA e più vergogna ai britannici, sia in Irlanda che a livello internazionale. Nell’ultimo scorso decennio, i tentativi serbi di reprimere l’Esercito di liberazione del Kosovo hanno avuto lo stesso effetto.
Il governo è in grado di reprimere sia i gruppi nonviolenti che quelli militanti senza provocare un contraccolpo fintanto che ha il controllo del terreno ideologico. I gruppi nonviolenti possono operare con meno indipendenza culturale e sostegno popolare, perché tendono a mirare più in basso e a rappresentare una minaccia minore, mentre un gruppo militante, per la sua stessa esistenza, rappresenta una sfida diretta al monopolio statale della forza. I gruppi militanti capiscono che devono vincere lo stato e, finché non contribuiscono a creare un’ampia cultura di resistenza (o se non nascono da tale cultura), saranno isolati e in fuga. I gruppi pacifisti, d’altra parte, hanno la possibilità di rinunciare al confronto con il potere statale e fingere di essere impegnati in un processo di trasformazione magica dello stato attraverso il “potere dell’amore”, la loro “testimonianza nonviolenta”, la diffusione sui media immagini strazianti di pupazzi di cartone o qualche altra sciocchezza. La prevalenza o la scarsità del pacifismo rappresenta un buon barometro della debolezza del movimento. Un forte sostegno popolare permette un movimento radicale di sopravvivere alla repressione; se un movimento ha costruito un sostegno popolare per la lotta militante contro lo stato, allora esso è molto più vicino alla vittoria.
Uno stato decide di reprimere attivistɜ e movimenti sociali quando percepisce gli obiettivi dellɜ dissidenti come minacciosi e raggiungibili. Se l’obiettivo è la presa o la distruzione del potere statale e gli agenti dello stato pensano che ci sia una qualche possibilità di avvicinarsi a questo obiettivo, reprimeranno o distruggeranno il movimento, indipendentemente dalle tattiche adottate. La violenza incoraggia la repressione? Non necessariamente. Esaminiamo alcuni casi di studio e confrontiamo la repressione dei Wobblies con quella dellɜ anarchichɜ italianɜ immigratɜ o dei minatori degli Appalachi. Tutti e tre i casi si sono svolti nello stesso periodo, tra la Prima guerra mondiale e gli anni Venti, negli Stati Uniti.
L’Industrial Workers of the World (IWW) – i membri erano conosciuti come “Wobblies” – fu un sindacato anarchico che mirava all’abolizione del lavoro salariato. Al suo apice, nel 1923, l’IWW contò circa quasi mezzo milione di iscrittɜ e sostenitrici attivɜ. All’inizio il sindacato era militante: alcunɜ leader dell’IWW incoraggiavano il sabotaggio. Tuttavia, il sindacato non rifiutò mai completamente la nonviolenza e le sue tattiche principali furono la formazione interna, la protesta, le “lotte per la libertà di parola” e la disobbedienza civile. L’organizzazione in superficie e la struttura centralizzata dell’IWW ne fecero un facile bersaglio per la repressione governativa. In risposta alle pressioni dello stato, l’organizzazione non prese nemmeno posizione contro la Prima Guerra Mondiale: “Alla fine, la leadership decise di non incoraggiare esplicitamente lɜ iscrittɜ a violare la legge [opponendosi alla leva]. Il modo in cui furono trattatɜ successivamente da parte dei funzionari federali e statali, tuttavia, rende tutto come se lo avessero fatto”.[179] Il sindacato assecondò anche le richieste da parte dello stato, abolendo un opuscolo di un discorso di Elizabeth Gurley Flynn del 1913 che incoraggiava al sabotaggio. L’IWW ritirò dalla circolazione libri e pamphlet simili e “rinunciò ufficialmente all’uso del sabotaggio da parte dei suoi membri”.[180] Naturalmente nessuna di queste azioni salvò il sindacato dalla repressione, perché fu identificato dal governo come una minaccia da neutralizzare. L’obiettivo dell’IWW (l’abolizione del lavoro salariato attraverso la graduale riduzione della settimana lavorativa) era una minaccia per l’ordine capitalistico, e la dimensione del sindacato gli permetteva di far circolare queste idee pericolose e di realizzare scioperi significativi. Un centinaio di Wobblies di Chicago furono processatɜ nel 1918, oltre ad esponenti dell’IWW di Sacramento e Wichita; il governo lɜ accusò di sedizione, incitamento alla violenza e sindacalismo criminale. Tuttɜ furono condannatɜ. Dopo l’incarcerazione e altre repressioni (compresi i linciaggi di esponenti dell’IWW in alcune città), “la forza dinamica del sindacato andò perduta; non riuscì mai più a riconquistare il movimento operaio americano”.[181] Lɜ Wobblies si adattarono al potere statale e si pacificarono. Rinunciarono a tattiche violente, e questo fu un passo avanti verso la loro repressione. Furono imprigionatɜ, picchiatɜ, linciatɜ. Il governo lɜ represse a causa del loro radicalismo e della popolarità della loro visione. La rinuncia alla violenza impedì loro di difendere tale visione. Lɜ militanti anarchichɜ italianɜ immigratɜ nel New England sopravvissero alla repressione governativa almeno quanto lɜ Wobblies, anche se i loro ranghi erano molto più piccoli e le loro tattiche più eclatanti – bombardarono le case e gli uffici di diversi funzionari governativi e tentarono di assassinare il procuratore generale degli Stati Uniti A. Mitchell Palmer.[182] Lɜ più militanti tra lɜ anarchichɜ italianɜ furono lɜ galleanistɜ,[183] che si lanciarono nella guerra di classe. A differenza dellɜ Wobblies, essɜ si organizzarono apertamente contro la prima guerra mondiale organizzando proteste, tenendo discorsi e pubblicando alcuni dei testi più intransigenti e rivoluzionari contro la guerra in giornali come Cronaca Sovversiva (che il Dipartimento di Giustizia dichiarò “il giornale più pericoloso pubblicato in questo Paese”).[184] In effetti, moltɜ di loro furono uccisɜ dalla polizia durante le proteste contro la guerra. Lɜ galleanistɜ sostennero energicamente l’organizzazione dei lavoratori nelle fabbriche del New England e furono lɜ principali sostenitrici di alcuni grandi scioperi. Si organizzarono anche contro l’ondata di fascismo negli Stati Uniti. Ma lɜ galleanistɜ lasciarono il loro segno più profondo con il loro rifiuto di accettare la repressione governativa.
Eseguirono decine di bombardamenti nelle città del New England e a Milwaukee, New York, Pittsburgh, Philadelphia, Washington e altrove, per lo più in risposta all’arresto o all’uccisione di compagnɜ da parte dalle forze dello stato. Alcuni di questi attacchi furono campagne ben coordinate che prevedevano più attacchi simultanei.
Il più grande fu l’attentato a Wall Street del 1920, in risposta alle incriminazioni di Sacco e Vanzetti (che non erano coinvolti nella rapina di Braintree per la quale furono giustiziati, anche se probabilmente giocarono un ruolo di supporto in alcuni degli attacchi). Quell’atto uccise 33 persone, causò danni per 2 milioni di dollari e distrusse, tra le altre cose, la House of Morgan, l’edificio di J.P. Morgan, capitale della finanza americana. I federali organizzarono una massiccia indagine, ma non catturarono mai nessunǝ. Paul Avrich stabilì che l’attentato fu di un galleanista solitario, Mario Buda, che fuggì in Italia e continuò il suo lavoro finché non fu arrestato dal regime di Mussolini.[185]
Il governo intraprese grandi sforzi per reprimere lɜ anarchichɜ italianɜ, ma con un successo parziale. Le forze governative ne uccisero alcunɜ con azioni di polizia o esecuzioni giudiziarie e ne imprigionarono più di una dozzina, ma a differenza dellɜ Wobblies, lɜ galleanistɜ evitarono di essere arrestatɜ in massa. Ciò fu dovuto, in parte, alle forme di organizzazione decentralizzate che la concezione italiana della rivoluzione militante fece loro adottare. E va notato che lɜ galleanistɜ furono particolarmente espostɜ al rischio di repressione governativa perché, a differenza di moltɜ Wobblies, potevano essere presɜ di mira da azioni xenofobe e minacciatɜ di deportazione (in effetti, circa 80 di loro furono deportatɜ, mentre lɜ altrɜ riuscirono a rimanere molto attivɜ).[186] La risposta inflessibile dellɜ galleanistɜ alla repressione di stato ebbe, perlomeno, qualche risultato misurabile nello scoraggiare la repressione (oltre a far sì che sia il governo sia i padroni delle fabbriche avessero paura di fare qualcosa per incitare ulteriormente i loro lavoratori, per evitare che si unissero allɜ bombarolɜ anarchichɜ). Con la minaccia di pacchi-bomba, forzarono il prodigo detective del Bureau of Investigation, che era stato determinante nel rintracciare e arrestare moltɜ dellɜ loro compagnɜ nel 1918, a nascondersi per poi lasciare del tutto il Bureau nel 1919.[187] Le uniche conseguenze che ottennero gli agenti governativi responsabili di reprimere lɜ Wobblies furono le promozioni.
Tra il 1919 e il 1920, l’apice della paura rossa si abbattè sullɜ anarchichɜ italianɜ, che tuttavia rimasero attivɜ e intransigenti e che non si ritirarono così rapidamente come lɜ Wobblies. Nell’ottobre 1920, Cronaca Sovversiva, il giornale che fungeva da punto di riferimento per moltɜ dellɜ galleanistɜ, fu infine soppresso dalle autorità e il fulcro dell’attività anarchica dellɜ immigratɜ italianɜ tornò in Italia, dove moltɜ dellɜ attivistɜ fuggirono o furono deportatɜ.
La fine del loro movimento negli Stati Uniti non fu comunque la fine del loro movimento nel suo complesso e per diversi anni questɜ anarchichɜ furono avversariɜ chiave di Mussolini, che, come i suoi colleghi americani, lɜ temeva e dava priorità alla loro repressione (in effetti, il nuovo direttore del Bureau of Investigation, J. Edgar Hoover, fornì ai fascisti informazioni preziose con lo scopo specifico di distruggere lɜ anarchichɜ italianɜ).[188] Alcunɜ dellɜ anarchichɜ italianɜ in esilio parteciparono alla guerra civile spagnola nel 1936. Sebbene l’anarchismo italiano negli Stati Uniti “non si sia mai ripreso” dopo il 1920, “lɜ anarchichɜ non sono affatto scomparsɜ dalla scena”.[189] Con un’attenzione internazionale, organizzarono l’opposizione alle dittature comuniste e fasciste in ascesa (furono in “prima linea nella lotta antifascista” nelle Little Italy di tutti gli Stati Uniti),[190] e trasformarono la campagna di sostegno di Sacco e Vanzetti in una causa mondiale.
Lungi dall’essere figure universalmente alienanti, Sacco e Vanzetti ottennero l’appoggio delle comunità italiana e il sostegno di personalità pubbliche negli Stati Uniti e in Europa, nonostante l’incarcerazione e il loro continuo appello alla rivoluzione violenta e alle campagne di bombardamenti contro le autorità. Lɜ loro sostenitrici all’esterno non li delusero. Dal 1926 al 1932, lɜ anarchichɜ compirono altri attacchi prendendo di mira il giudice, il governatore, il boia e la persona che, chiamando la polizia, fece arrestare i due. Nessunǝ di loro fu mai catturatǝ. Anche lɜ anarchichɜ italianɜ continuarono ad agitarsi e a diffondere le loro idee – il successore di Cronaca Sovversiva, L’Adunata dei Refrattari, fu pubblicato per altri 40 anni, fino agli anni ‘60.
La guerra delle miniere del 1921 in West Virginia offre un altro esempio di risposta del governo alle tattiche militanti. Quando i proprietari delle miniere repressero gli sforzi dei minatori di formare sindacati – licenziando i membri del sindacato e facendo entrare i crumiri – lɜ ribelli degli Appalachi risposero con la forza. Aprirono il fuoco aperto contro i crumiri e uccisero diversi uomini dell’azienda carbonifera e i deputati mandati a reprimerlɜ. Col tempo, si sviluppò un guerriglia e poi una guerra vera e propria. In diverse occasioni, la polizia e gli uomini della compagnia aprirono il fuoco sugli accampamenti dei minatori, prendendo di mira donne e bambinɜ. Nel massacro più famoso uccisero a colpi di pistola Sid Hatfield, che, in qualità di sceriffo, si era battuto contro la repressione attuata dagli sgherri della compagnia. Migliaia di minatori armati formarono un esercito e marciarono su Logan, in West Virginia, per rimuovere (e impiccare) lo sceriffo del luogo, che fu particolarmente attivo nel reprimere i minatori del sindacato. L’esercito degli Stati Uniti rispose con migliaia di truppe, persino con bombardamenti aerei in quella che divenne nota come la Battaglia di Blair Mountain. Dopo la battaglia, i minatori del sindacato fecero marcia indietro. Ma nonostante la partecipazione a uno dei più grandi atti di ammutinamento armato del secolo, pochissimi di loro furono condannatɜ a pene detentive serie – la maggior parte dellɜ ribelli non ricevette alcuna punizione –, il governo si allentò un po’ e permise la sindacalizzazione delle miniere (il loro sindacato esiste ancora oggi).[191]
Più di recente, gli strateghi della polizia che hanno scritto sul movimento anarchico hanno osservato: “La raccolta di informazioni tra le fazioni più radicali – spesso più violente – è particolarmente difficile... La natura stessa dei sospetti e dei miglioramenti della sicurezza operativa del movimento rendono le infiltrazioni difficili da gestire”.[192] Quindi le affermazioni secondo cui i gruppi nonviolenti abbiano più probabilità di sopravvivere alla repressione non sembrano fondate. Se si esclude la tendenza dellɜ pacifistɜ di arrendersi in anticipo, in modo da non costituire mai una minaccia di cambiamento, sembra che in realtà sia vero il contrario.
Consideriamo alcuni punti attuali riguardanti la cosiddetta resistenza nonviolenta all’occupazione degli Stati Uniti dell’Iraq, una delle questioni più urgenti del momento. Per il pacifismo la vittoria consiste nell’evitare o diminuire la violenza, quindi naturalmente lɜ pacifistɜ non possono affrontare direttamente la violenza. Ogni vera resistenza all’occupazione militare porterebbe a un aumento della violenza prima della liberazione e della possibilità di una vera pace: la situazione deve peggiorare prima di migliorare. Se la resistenza irachena verrà superata, la situazione apparirà più pacifica ma, in realtà, la violenza spettacolare della guerra si sarà trasformata nella violenza minacciata, invisibile e banale di un’occupazione di successo, e il popolo iracheno sarà molto più lontano dalla liberazione. Tuttavia, lɜ attivistɜ nonviolentɜ sono inclini a fraintendere questa pace apparente come una vittoria, così come interpretarono il ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam, anche se un regime sostenuto dagli Stati Uniti continuava a occupare il Vietnam del Sud e anche se i bombardamenti si intensificarono.
Ciò che lɜ attivistɜ nonviolentɜ non riescono a capire è che la resistenza più importante, probabilmente l’unica resistenza significativa all’occupazione dell’Iraq, è la resistenza portata avanti dallo stesso popolo iracheno che, nel complesso, ha scelto la lotta armata.[193] Lɜ americanɜ che condannano questo fatto senza avere alcuna conoscenza personale di cosa significhi organizzare la resistenza in Iraq non fanno altro che ostentare la loro ignoranza. Le persone negli Stati Uniti che affermano di essere contro la guerra usano la nonviolenza come una scusa per evitare la loro responsabilità nel sostenere la resistenza irachena. Inoltre, ripetono a pappagallo la propaganda dei media e fingono che tutti i gruppi di resistenza iracheni siano composti da fondamentalisti autoritari e patriarcali, la resistenza irachena contiene invece una grande diversità di gruppi e ideologie, dato accessibile a chiunque voglia conoscere davvero la situazione. La nonviolenza, in questo caso, rappresenta un ostacolo più grande della paura della repressione governativa se vogliamo costruire relazioni di solidarietà e diventare alleatɜ critichɜ dei gruppi di resistenza più liberatori. Condannarli tutti fa sì che gli unici gruppi che ottengano un sostegno esterno siano quelli autoritari, patriarcali e fondamentalisti. L’approccio del movimento contro la guerra degli Stati Uniti nei confronti della resistenza irachena non è semplicemente una cattiva strategia: rivela una totale mancanza di strategia, ed è qualcosa che dobbiamo correggere.
Le strategie della nonviolenza non possono sconfiggere lo stato, ma tendono a riflettere una mancanza di comprensione della natura stessa dello stato. Il potere dello stato si auto-perpetua, e sconfiggerà i movimenti di liberazione con ogni mezzo a sua disposizione. Se i tentativi di rovesciare una tale struttura di potere sopravvivono alle prime fasi di repressione, l’élite trasformerà il conflitto in un conflitto militare, e le persone che usano tattiche nonviolente non possono sconfiggere un esercito. Il pacifismo non può difendersi da uno sterminio intransigente. Come spiega uno studio sulla rivoluzione nelle società moderne:
Durante la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi non conoscevano la resistenza passiva (quando si verificava), ma oggi le forze armate sono molto più preparate ad affrontare la nonviolenza, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Chi sostiene la nonviolenza – ricorda uno specialista militare britannico – “è incline a trascurare il fatto che i suoi principali successi furono ottenuti contro avversari il cui codice morale era fondamentalmente simile, e la cui spietatezza fu in tal modo contenuta... L’unica impressione che sembra aver fatto su Hitler fu quella di eccitare il suo impulso a calpestare ciò che, per la sua mente, era spregevole debolezza...”. Se accettiamo la premessa dellɜ rivoluzionariɜ nerɜ in questo Paese, cioè che viviamo in una società razzista, difficilmente ci si può aspettare una minore spietatezza…
Potrebbe essere interessante cercare di descrivere il corso di un’insurrezione nonviolenta... In realtà, sono già stati condotti esperimenti di “difesa civile” con giochi di ruolo. In un esperimento di trentuno ore a Grindstone Island, nella provincia dell’Ontario, in Canada, nell’agosto 1965, trentuno “difensori” nonviolenti affrontarono sei uomini “armati” che rappresentavano un “governo canadese di destra” sostenuto dagli Stati Uniti, “che aveva occupato gran parte del territorio canadese...”. Alla fine dell’esperimento, tredici dei difensori erano “morti”. I partecipanti conclusero che “l’esperimento era stato una sconfitta per la nonviolenza”.[194]
La storia della sua pratica mi porta alla stessa conclusione: la nonviolenza non può difendersi dallo stato, tanto meno rovesciarlo. Il potere rivendicato della nonviolenza è un’illusione che dà allɜ suɜ praticanti sicurezza e capitale morale per compensare l’incapacità di vincere.
La nonviolenza è illusoria
Ward Churchill ha affermato che il pacifismo è patologico. Direi che, come minimo, l’avanzamento della nonviolenza come pratica rivoluzionaria nell’attuale contesto dipende da una serie di illusioni. Da dove cominciare?
Spesso, dopo aver dimostrato che le vittorie della nonviolenza non erano affatto vittorie – se non per lo stato – mi sono scontrato con la semplicistica contro-argomentazione secondo cui, poiché una particolare lotta militante o un atto di violenza non ha avuto successo, la “violenza” fosse ugualmente inefficace. Non ricordo di aver mai detto che l’uso della violenza assicurasse la vittoria. Spero che tuttɜ possano vedere la differenza tra mostrare i fallimenti delle “vittorie” pacifiste e mostrare i fallimenti delle lotte militanti che nessunǝ ha mai rivendicato come vittorie. Non è opinabile affermare che i movimenti sociali militanti siano riusciti a cambiare la società, o addirittura a diventare la forza prevalente nella società. Per ribadire questo concetto: chiunque dovrebbe ammettere che le lotte che utilizzano una varietà di tattiche (compresa la lotta armata) possono avere successo. La storia è piena di esempi: rivoluzioni in Nord e Sud America, Francia, Irlanda, Cina, Cuba, Algeria, Vietnam e così via. Non è poi così controverso affermare che i movimenti militanti antiautoritari siano riusciti per un certo periodo a liberare aree e a creare cambiamenti sociali positivi in quelle aree. Tra i casi c’è la collettivizzazione nella guerra civile spagnola e nell’Ucraina di Makhno, la zona autonoma nella provincia di Shinmin creata dalla Federazione Comunista Anarchica Coreana e il temporaneo respiro conquistato per i Lakota da Cavallo Pazzo e dallɜ suɜ guerrierɜ. Ciò che è discutibile, per alcunɜ, è se i movimenti militanti possano vincere e sopravvivere a lungo termine rimanendo antiautoritari. Per sostenere in modo convincente questa possibilità, lɜ pacifistɜ dovrebbero dimostrare come l’uso della violenza contro un’autorità faccia inevitabilmente assumere caratteristiche autoritarie. Questo è qualcosa che lɜ pacifistɜ non hanno fatto e non possono fare.
Spesso lɜ pacifistɜ preferiscono caratterizzarsi come giustɜ piuttosto che difendere logicamente la loro posizione. La maggior parte delle persone che hanno ascoltato le argomentazioni della nonviolenza hanno assistito alla formulazione o all’assunzione che la nonviolenza sia il percorso di chi è deditǝ e disciplinatǝ, e che la violenza sia invece la “via d’uscita facile”, un cedimento alle emozioni di base.[195] Questo è assolutamente insensato. La nonviolenza è la via d’uscita più facile. Le persone che scelgono di impegnarsi nella nonviolenza hanno un futuro molto più confortevole di quelle che scelgono di impegnarsi nella rivoluzione. Unǝ prigionierǝ del movimento di liberazione dellɜ nerɜ mi disse che quando si unì alla lotta (da adolescente, per giunta), sapeva che sarebbe finitǝ in prigione o mortǝ. Moltɜ dellɜ suɜ compagnɜ sono mortɜ. Per aver continuato la lotta dietro le mura del carcere, questa persona è stata rinchiusa in isolamento da più tempo di quanto io sia vivo. Si confronti con le recenti, comode, morti commemorate di David Dellinger e Phil Berrigan. Lɜ attivistɜ nonviolentɜ possono dare la vita alla loro causa, e alcuni l’hanno fatto, ma, a differenza dellɜ attivistɜ militanti, non si trovano di fronte a un punto di non ritorno dopo il quale non è possibile tornare a una vita comoda. Possono sempre salvarsi compromettendo la loro totale opposizione, e la maggior parte di loro lo fa.
Oltre a riflettere un’ignoranza della realtà delle diverse conseguenze di certe azioni politiche, la convinzione che la lotta non pacifista sia la via d’uscita più facile si tinge spesso di razzismo.
Coloro che hanno scritto il saggio “Why Nonviolence?” fanno del loro meglio per evitare di parlare di razza, ma nella sezione domande e risposte forniscono una risposta velata alle critiche che sostengono il pacifismo come razzista, dipingendo le “persone oppresse” (quelle nere) come arrabbiate e guidate dagli impulsi. “D: Esigere un comportamento nonviolento da parte di persone oppresse nei confronti dei loro oppressori è insensato e ingiusto! Hanno bisogno di esprimere la loro rabbia!”[196] La risposta del saggio a queste critiche artificiose sulla nonviolenza include le tipiche ed illusorie fallacie già discusse: la risposta consiglia a persone molto più oppresse di loro di avere pazienza con condizioni che non possono comprendere; consigliano alle persone razzializzate di agire in modo “nobilitante e pragmatico”; essɜ evitano le critiche di razzismo facendo il nome di una persona razzializzata, e concludono minacciando tacitamente che l’attivismo militante delle persone razzializzate comporterà l’abbandono e il tradimento da parte dellɜ potenti “alleatɜ” bianchɜ. Per intenderci:
Quanto all’ingiustizia, se gli oppressi potessero desiderarla, non sarebbero più oppressi. Non esiste una strada senza dolore verso la liberazione. Data l’inevitabilità della sofferenza, è nobilitante e pragmatico presentare la disciplina nonviolenta e la sofferenza (come fece Martin Luther King, Jr.) come imperativi. “Agire la rabbia” in un modo che costa un gruppo di alleatɜ è un lusso che i movimenti seri non possono permettersi.[197]
Lɜ pacifistɜ si illudono di considerare l’attivismo rivoluzionario come impulsivo, irrazionale e derivante unicamente dalla “rabbia”. In realtà, l’attivismo rivoluzionario, in alcune sue manifestazioni, ha una spiccata vena intellettuale. Dopo le rivolte di Detroit del 1967, una commissione governativa scoprì che lǝ tipicǝ rivoltosǝ (oltre ad essere orgogliosǝ della propria “razza” e ostile allɜ bianchɜ e allɜ nerɜ della classe media) “è sostanzialmente più informatǝ sulla politica rispetto allɜ negrɜ che non sono statɜ coinvoltɜ nelle rivolte”.[198] George Jackson si formò in carcere e sottolineò nei suoi scritti la necessità per lɜ nerɜ militanti di studiare il loro rapporto storico con gli oppressori e di imparare i “principi scientifici” della guerriglia urbana.[199] Le Pantere lessero Mao, Kwame Nkrumah e Frantz Fanon e chiesero ai nuovi membri di istruirsi sulle teorie politiche alla base della loro rivoluzione.[200] Quando fu catturato e processato, l’anarchico rivoluzionario neo-africano Kuwasi Balagoon rifiutò la legittimità del tribunale e proclamò il diritto delle persone nere a liberarsi in una dichiarazione da cui moltɜ pacifistɜ potrebbero trarre insegnamento.
Prima di diventare un rivoluzionario clandestino sono stato organizzatore di inquilinɜ e sono stato arrestato per aver minacciato con un machete un sovrintendente di un edificio coloniale di 270 chili, che aveva fisicamente impedito la consegna dell’olio in un edificio in cui non vivevo, ma che avevo aiutato ad organizzare. Essendo un organizzatore del Community Council on Housing, ho partecipato non solo all’organizzazione degli scioperi dellɜ inquilinɜ, ma ho anche fatto pressione sui proprietari dei quartieri poveri perché facessero riparazioni e mantenessero il riscaldamento e l’acqua calda, ho ucciso topi, ho rappresentato lɜ variɜ inquilinɜ in tribunale, ho impedito sfratti illegali, ho affrontato gli sceriffi, ho contribuito a trasformare gli affitti in risorse per le riparazioni e in proprietà collettive da parte dellɜ inquilinɜ e ho manifestato ogni volta che le esigenze di questɜ erano in pericolo... Poi ho cominciato a rendermi conto che con tutti questi sforzi non riuscivamo a tamponare il problema...
I rituali legali non hanno alcun effetto sul processo storico di lotta armata delle nazioni oppresse. La guerra continuerà e si intensificherà e, per quanto mi riguarda, preferirei essere in prigione o nella tomba piuttosto che fare qualsiasi cosa che non sia combattere l’oppressore del mio popolo. La Nuova Nazione Africana e le Nazioni Native Americane sono colonizzate all’interno degli attuali confini degli Stati Uniti, così come le Nazioni Portoricane e Messicane sono colonizzate all’interno e all’esterno degli Stati Uniti. Noi abbiamo il diritto di resistere, di espropriare denaro e armi, di uccidere il nemico del nostro popolo, di bombardare e di fare qualsiasi altra cosa ci aiuti a vincere, e vinceremo.[201]
In confronto, l’analisi strategica e tattica dell’attivismo nonviolento è piuttosto semplicistica, raramente si eleva al di sopra del rigurgito di cliché triti e ritriti. La quantità di studiosi preparativi necessari per portare a termine con successo azioni militanti, rispetto a quella richiesta per le azioni nonviolente, contraddice anche la percezione che l’azione rivoluzionaria sia impulsiva.
Le persone disposte a riconoscere la violenza della rivoluzione (è fuorviante parlare di scelta della violenza, perché la violenza è insita nella rivoluzione sociale e nello status quo oppressivo che la precede, che si usino o meno mezzi violenti) hanno maggiori probabilità di comprendere i sacrifici coinvolti. Qualsiasi conoscenza di ciò che lɜ rivoluzionariɜ si preparano e affrontano dimostra la farsa crudelmente ignorante della proclamazione pacifista secondo cui la violenza rivoluzionaria sia impulsiva.
Come già detto, gli scritti di Frantz Fanon sono stati tra i più influenti per lɜ rivoluzionariɜ nerɜ negli Stati Uniti durante il movimento di liberazione delle persone nere. L’ultimo capitolo del suo libro I dannati della terra tratta interamente di “guerra coloniale e disturbi mentali”, dei traumi psicologici derivanti dal colonialismo e dalla “guerra totale” condotta dai francesi contro lɜ combattenti algerinɜ[202] (una guerra che, devo sottolineare, costituisce gran parte del libro di testo utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra di controinsurrezione e nelle guerre di occupazione fino al momento attuale). Chi combatte per la rivoluzione sa a cosa va incontro, nella misura in cui l’orrore di queste cose può essere conosciuto. Ma lɜ pacifistɜ lo sanno?
Un’altra illusione, espressa dallɜ pacifistɜ che vogliono apparire militanti e potenti, è che questɜ combattono solo in modo nonviolento. È una sciocchezza. Stare sedutɜ e bloccare le armi non è lottare, è una capitolazione recalcitrante.[203] In una situazione che coinvolge un prepotente o un apparato di potere centralizzato, reagire fisicamente scoraggia gli attacchi futuri perché aumenta i costi dell’oppressione sostenuti dall’oppressore. La mite resistenza della nonviolenza non fa altro che rendere più facile la continuità di questi attacchi. Alla prossima protesta, ad esempio, osservate quanto la polizia sia riluttante a recintare gruppi militanti come i black bloc e sottoporli tuttɜ a un arresto di massa.[204]Gli sbirri sanno che avranno bisogno di unǝ o due poliziottɜ per ogni manifestante e che alcunɜ di loro finiranno per essere gravemente feritɜ. Lɜ pacifistɜ, invece, possono essere asserragliatɜ da un numero relativamente piccolo di poliziottɜ, che possono poi entrare nella folla a loro piacimento e portare via lɜ manifestanti zoppicanti unǝ per unǝ.
La Palestina è un altro esempio. Non c’è dubbio che lɜ palestinesi siano un fastidio per lo stato israeliano e che quest’ultimo non si preoccupi del benessere del popolo palestinese. Se quest’ultimo non avesse reso così costosa l’occupazione israeliana e ogni successiva aggressione, tutte le terre palestinesi sarebbero state confiscate, ad eccezione di alcune riserve per contenere il numero necessario di operaiɜ in eccesso per integrare l’economia israeliana, e lɜ palestinesi sarebbero un lontano ricordo in una lunga serie di popoli estinti. La resistenza palestinese, compresi gli attentati suicidi, ha contribuito a garantire la sopravvivenza del suo popolo contro un nemico molto più potente.
La nonviolenza illude ulteriormente se stessa e lɜ propriɜ seguaci con l’affermazione “la società è sempre stata violenta. È la nonviolenza che è rivoluzionaria”.[205] In pratica, la nostra società onora e commemora sia la violenza a favore dello stato che il rispettabile pacifismo dissidente. L’attivista che ha affermato che la nostra società è già favorevole alla violenza può fare il nome di Leon Czolgosz (l’anarchico che ha assassinato il presidente McKinley) in un articolo ospite del giornale aziendale locale e sapere che un pubblico mainstream risponderà a quel personaggio violento con una condanna. Nel frattempo, lo stesso attivista fa riferimento a pacifisti come King e Gandhi per dare alle sue convinzioni un’aura di rispettabilità agli occhi del mainstream.[206] Se la società è già favorevole alla violenza su tutta la linea, e il pacifismo è abbastanza rivoluzionario da sfidare fondamentalmente la nostra società e le sue oppressioni radicate, perché Czolgosz merita l’odio e Gandhi l’approvazione?
Lɜ pacifistɜ si illudono anche sulla decenza dello stato e, inconsciamente, sulla quantità di protezione che i loro privilegi gli garantiranno. Lɜ studenti/studentesse che guidarono l’occupazione di Piazza Tienanmen nella “Pechino autonoma” pensavano che il loro governo “rivoluzionario” non avrebbe aperto il fuoco su di loro se fossero rimastɜ un’opposizione pacifica e leale. “La quasi totale incomprensione da parte dellɜ alunnɜ sulla natura della legittimità sotto il potere burocratico e l’illusione che si potesse negoziare con il Partito, lɜ lasciò indifesɜ sia per quanto riguarda i mezzi teorici per descrivere il loro impegno, sia per quanto riguarda la pratica ristretta della disobbedienza civile che adottarono”.[207] Così, quando studenti e studentesse che si erano messɜ a capo del movimento rifiutarono di armarsi (a differenza di moltɜ altrɜ delle periferie operaie, che erano meno istruitɜ e più furbɜ), l’intero movimento fu vulnerabile e Pechino Autonoma fu schiacciata dai carri armati dell’Esercito Popolare di Liberazione. Lɜ alunnɜ della Kent State rimasero ugualmente scioccatɜ, anche se mentre lo stesso governo che aveva ucciso un misero numero di loro massacrava milioni di persone in Indocina senza conseguenze o esitazioni.
In fin dei conti, la nonviolenza ha tutta la profondità intellettuale di una battuta mediatica. Il pacifismo richiede un termine molto vago, ampio, carico e non analitico – la violenza – per assumere una precisione scientifica. Dopo tutto, non il razzismo, non il sessismo, non l’omofobia, non l’autoritarismo, ma la violenza deve essere l’asse critico delle nostre azioni. Perché mai dovremmo fare promesse antirazziste prima di una marcia, o subordinare la partecipazione a un movimento al rispetto delle donne, delle persone queer e trans, quando possiamo fare promesse di nonviolenza molto meno divisive? La probabilità che la maggior parte dellɜ sostenitrici dei codici della nonviolenza non si siano mai postɜ questa domanda, dimostra in modo evidente la limitazione del pensiero pacifista. Quindi lɜ pacifistɜ ignorano le divisioni reali, come il privilegio delle persone bianche, e fanno invece distinzioni infondate e potenzialmente razziste/classiste tra il tagliare una serratura durante una manifestazione preannunciata per permettere allɜ manifestanti di condurre un’irruzione in una base militare e il rompere una finestra sotto la copertura di una sommossa per permettere ad un’abitante del ghetto di ottenere cibo e denaro per prendersi cura della propria famiglia. È significativo che lɜ pacifistɜ non facciano la distinzione critica tra la violenza personale strutturale, istituzionale e sistematicamente permessa dallo stato (intendendo per stato, in senso lato, le funzioni dell’economia e del patriarcato) e la violenza sociale individualizzata di tipo “criminale” o la violenza sociale collettiva di tipo “rivoluzionario”, volta a distruggere la violenza ben più grande dello stato. Fingere che tutta la violenza sia uguale è molto comodo per lɜ privilegiatɜ antiviolenza che traggono vantaggio dalla violenza dello stato e che hanno invece molto da perdere dalla violenza della rivoluzione.
Entrare di nascosto in una base militare, versare il proprio sangue sulle cose e prendere a martellate i missili, ci viene detto, non è violento, ma far saltare in aria lo stabilimento della Litton Systems (dove venivano prodotti i componenti dei missili da crociera) sarebbe stato violento anche se nessunǝ si fosse feritǝ. Perché? La risposta abituale è che una bomba minaccia le persone, mentre le vecchie suore bianche con il martello non lo fanno, oppure che quando lɜ attivistɜ usano una bomba, non possono garantire che le persone non si facciano male. La prima argomentazione ignora due fatti: ciò che viene considerato minaccioso è in gran parte determinato da pregiudizi preesistenti nei confronti di certe etnie e classi, e per la maggior parte della popolazione mondiale al di fuori del Nord America, un missile non funzionante è molto meno minaccioso di un missile funzionante, non importa quante bombe debbano esplodere nel Nord globale per raggiungere questo obiettivo. Non c’è dubbio che il bombardamento possa distruggere i missili meglio del martellamento. Il secondo argomento, come ho sottolineato, ignora la possibilità di vittime al di fuori del Nord America. Una bomba assicura che una fabbrica non sia in grado di produrre missili molto meglio di quanto non faccia un martello, e i missili in possesso di stati imperialisti uccidono molte più persone delle bombe (o dei martelli) in possesso di gruppi di guerriglia urbana. Ma questa considerazione è così lontana dalla mente dellɜ pacifistɜ che le suore a cui alludo hanno basato gran parte della loro difesa processuale sull’affermazione di non aver causato alcun danno reale, ma solo simbolico, all’impianto missilistico in cui si erano infiltrate.[208] Possono essere davvero considerate nonviolente?
Possono essere considerate veramente nonviolente, dopo aver deliberatamente sprecato l’opportunità di smantellare un’importante strumento di guerra?
In un seminario che ho tenuto sui limiti della nonviolenza, ho condotto un piccolo esercizio per dimostrare quanto sia vaga l’idea di violenza. Ho chiesto a chi partecipava, che comprendeva sostenitrici della nonviolenza e sostenitrici di una diversità di tattiche, di alzarsi e, mentre leggevo lentamente un elenco di varie azioni, di camminare verso un punto se consideravano l’azione violenta e verso un altro punto se consideravano l’azione nonviolenta. Le azioni comprendevano cose come l’acquisto di vestiti prodotti in una fabbrica di sudore, il consumo di carne, l’uccisione di un cervo da parte di un lupo, l’uccisione di qualcuno che sta per far esplodere una bomba tra la folla, e così via. Quasi mai c’è stato un accordo perfetto tra di loro, e molte delle azioni che consideravano violente le consideravano anche morali, mentre alcunɜ consideravano immorali anche alcune azioni non violente. La lezione conclusiva dell’esercizio:
Ha davvero senso basare gran parte della nostra strategia, delle nostre alleanze e del nostro coinvolgimento nell’attivismo su un concetto che è così confuso che nessuna persona può essere d’accordo su cosa significhi?
Gli sforzi per definire effettivamente la violenza portano a due risultati. O la violenza viene definita letteralmente come qualcosa che provoca dolore o paura, e non può essere considerata una cosa immorale perché include attività naturali come partorire o mangiare altri esseri viventi per rimanere in vita, oppure la violenza viene definita con una preoccupazione morale per i risultati, nel qual caso anche l’inazione o l’essere inefficaci di fronte a una violenza maggiore deve essere considerata violenta.[209] Entrambe le definizioni escludono la nonviolenza: la prima perché la violenza è inevitabile e normale, la seconda perché la nonviolenza deve essere considerata violenta se non riesce a porre fine a un sistema di violenza, e anche perché tutte le persone privilegiate devono essere considerate complici della violenza, indipendentemente dal fatto che si considerino o meno pacifiste. Ma lɜ pacifistɜ si illudono ancora che la violenza sia sufficientemente definita da poter fingere che l’uso della violenza abbia conseguenze psicologiche certe e inevitabili.
Todd Allin Morman, scrivendo su Social Anarchism, si ispira a Erich Fromm per fare una distinzione netta tra “autorità razionale” e “autorità irrazionale”. Morman afferma che “l’anarchismo è contro tutte le forme di autorità irrazionale e favorisce al suo posto l’autorità razionale”.[210] L’autorità irrazionale si basa sull’esercizio del potere sulle persone, mentre l’autorità razionale è definita come influenza volontaria sulla base dell’esperienza e della competenza.
“È impossibile impiegare la violenza per promuovere un ordine anarchico superiore, perché la violenza riproduce necessariamente atteggiamenti psicologici che sono antitetici ai fini della rivoluzione anarchica”. In genere, egli sostiene che dovremmo entrare in rivoluzione in modo pacifico, perché se non lo facciamo, non faremo altro che “ricostituire lo stato in una nuova... forma”. Ma perché è possibile smettere di essere violenti ora, prima della rivoluzione, ma non dopo! Perché ci viene detto che saremmo inevitabilmente e impotentemente diventatɜ autoritariɜ dopo una rivoluzione violenta, anche se siamo incoraggiatɜ a rompere gli schemi psicologici della nostra società violenta e a rinunciare alla lotta militante! Morman non risponde su come possa vedere gli esseri umani deterministicamente alla fine di una frase, mentre tratta gli esseri umani come agenti liberi all’inizio della stessa frase.
Sospetto che sia perché accademici come Morman hanno paura di ciò che accadrebbe loro se non rinunciassero alla rivoluzione militante (che è rinunciare alla rivoluzione nel suo complesso); preferiscono invece affermare la loro “autorità razionale” e fingere di contribuire a un processo che in qualche modo renderà lo stato obsoleto. Naturalmente, il nostro principale contributo teorico come anarchichɜ è che lo stato è obsoleto fin dalla sua nascita, ma detiene e acquisisce comunque potere. Il sillogismo di Fromm, o almeno l’interpretazione di Morman, non coglie il punto che per un’“autorità irrazionale”, l’“autorità razionale” sia irrilevante, priva di significato e di potere.
Mi sembra che sarebbe molto più facile porre fine agli schemi psicologici della violenza e del dominio una volta distrutte le istituzioni sociali, gli organismi politici e le strutture economiche appositamente costituite per perpetuare il dominio coercitivo. Ma lɜ sostenitrici della nonviolenza suonano audacemente l’invito alla ritirata, dichiarando che dovremmo curare i sintomi mentre la malattia è libera di diffondersi, di difendersi e di votarsi gli aumenti di stipendio. Morman afferma: “La violenza è in grado di attaccare solo le manifestazioni fisiche delle relazioni sociali che perpetuano lo stato. Non si possono uccidere queste relazioni sociali con un’aggressione fisica”.[211] Tralasciando il fatto che questo punto è palesemente falso in relazione alla lotta delle culture indigene contro l’invasione straniera e l’imperialismo (in questi casi, uccidere o sfrattare il colonizzatore è effettivamente uccidere il colonialismo, se può essere fatto prima che l’occidentalizzazione abbia avuto luogo), accettiamo il ristretto eurocentrismo di Morman e concentriamoci sulle società in cui oppressore e oppresso appartengono alla stessa nazione o cultura. Egli ha appena stabilito che la violenza può distruggere le manifestazioni fisiche ma non quelle psicologiche dell’oppressione. Qualsiasi persona ragionevole procederebbe raccomandando una lotta rivoluzionaria che contenga attività sia distruttive che creative – la violenza contro gli oppressori e i loro apparati accompagnata dalla simultanea cura e guarigione della propria comunità. Morman e le migliaia di pacifistɜ che la pensano come lui dichiarano invece che dovremmo concentrarci sulla liberazione psicologica evitando la lotta fisica. Come non vedano il parallelo simultaneo con l’argomentazione che hanno appena fatto, ovvero che le azioni psicologiche non possono distruggere le manifestazioni fisiche dello stato, è sconcertante.
Forse credono che le relazioni sociali di oppressione siano indipendenti e creino le strutture fisiche dell’oppressione di sana pianta, ma questo è semplicistico. Le relazioni sociali e le strutture fisiche non possono essere completamente separate (nella realtà, piuttosto che nella filosofia, perché questi termini sono solo dispositivi analitici che rendono più facile parlare di aspetti diversi della stessa cosa), e chiaramente si evolvono in tandem. Le strutture fisiche e le relazioni sociali sono reciprocamente dipendenti e si rafforzano a vicenda.
Morman si aggrappa anche a un’idea totalitaria di rivoluzione. “Il rivoluzionario promuove un insieme di relazioni sociali e distrugge quelle vecchie, non con l’insegnamento, l’esempio o l’argomentazione ben ragionata, ma con il potere, la paura e l’intimidazione: i contrafforti dell’autorità irrazionale”.[212] Questa argomentazione suggerisce che una rivoluzione non pacifista debba essere condotta contro persone filosoficamente devianti o politicamente scorrette – persone che credono alle cose sbagliate (questo è il modo in cui un partito politico vede la rivoluzione). Ma c’è più di un asse per la lotta di liberazione. Può essere culturale, per lottare per l’espulsione di un colonizzatore straniero e dei partiti politici borghesi che hanno assunto le caratteristiche di quel colonizzatore (come descritto da Fanon), o può essere strutturale, per distruggere le strutture di potere centralizzate e le istituzioni gerarchiche senza prendere di mira nessuna persona reale, se non quelle che scelgono di combattere dalla parte del potere. Dopo una rivoluzione che distrugge tutte le strutture del capitalismo – sequestrando tutte le fabbriche, ridistribuendo tutte le terre, bruciando tutto il denaro – le persone che sono filosoficamente capitaliste non hanno bisogno di essere epurate o intimidite con un’autorità irrazionale. Senza un apparato militare per implementare il capitalismo o un apparato di polizia per proteggerlo, esse – come persone – sono abbastanza innocue, e impareranno a fare qualcosa di creativo con la loro vita o moriranno di fame senza rendersi conto che non possono più pagare qualcunǝ che faccia lǝ schiavǝ per loro. La tipica costruzione pacifista-anarchica di Morman si basa su una visione politica eurocentrica della rivoluzione, in cui un partito rivoluzionario prende il potere e impone la sua visione di libertà a tuttɜ lɜ altrɜ nella società attraverso un apparato centralizzato. In realtà, è la società stessa – nella sua forma attuale, un insieme artificiale di persone che non hanno interessi comuni non coercitivi a lavorare insieme – che deve essere distrutta. Un movimento rivoluzionario militante può distruggere la gravità centrale del governo che tiene insieme le polarità di massa in un unico stato-nazione. A quel punto, non avremo più bisogno di un’ideologia razionale e “ben ragionata” per tenere tuttɜ insieme, perché le società si divideranno in unità organiche più piccole. Lɜ rivoluzionariɜ non avranno bisogno di usare la violenza per convincere tuttɜ a comportarsi in un certo modo, perché non ci sarà bisogno di conformità in un intero paese.
Il ragionamento di Morman si basa anche su presupposti culturali occidentali che non riescono ad apprezzare alcuna ragione per la violenza che non sia al servizio della dominazione. Questi presupposti hanno molto a che fare con il totalitarismo intrinseco della cultura occidentale (che si manifesta anche nelle inclinazioni stataliste del pacifismo, che privilegia la violenza di stato e ostracizza attivamente la violenza della ribellione). L’idea che l’uso della “violenza” costituisca automaticamente un’autorità irrazionale non ha senso dal punto di vista dei valori culturali che non ritraggono necessariamente la violenza come strumento al servizio del dominio. Secondo i Mande, Mangala il creatore uccise Farrow come sacrificio per salvare ciò che restava della creazione. Al contrario, nella mitologia greca, Crono cercò di uccidere suo figlio e successivamente Zeus divorò la sua amante, Metis, per mantenere il loro potere. Questa dinamica è presente in tutte le mitologie occidentali. L’uso della violenza è calcolato, per ottenere il potere e il controllo coercitivo, o appassionato, nel qual caso la motivazione sia quasi sempre la gelosia che nasce dal desiderio di possedere un altro essere. Questi schemi non sono universali a tutte le culture.
Inoltre, non sono universali per tutte le situazioni. La violenza collettiva e coordinata per stabilire un nuovo insieme di relazioni sociali che devono essere preservate attraverso la violenza, o la rivoluzione attraverso l’acquisizione di istituzioni centralizzate, costituisce la creazione o il mantenimento di un’autorità coercitiva. Ma queste non sono le uniche due opzioni per il cambiamento sociale. Abbiamo già visto Frantz Fanon descrivere la violenza come una “forza purificatrice” quando viene usata da popolazioni ridotte al suolo e disumanizzate dalla colonizzazione per liberarsi (e le dinamiche del colonialismo si applicano oggi alle popolazioni indigene, alle colonie vere e proprie dalle Hawaii alle Samoa e alle aree occupate dal Kurdistan all’Iraq, mentre dinamiche simili si applicano alle popolazioni delle neocolonie dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina e alle “colonie interne” discendenti dalle popolazioni schiave negli Stati Uniti. In breve, queste dinamiche si applicano ancora a centinaia di milioni di persone e non sono affatto obsolete). Fanon aiutò il FLN (Fronte di Liberazione Nazionale) in Algeria e lavorò in un ospedale psichiatrico, specializzandosi nella psicologia delle persone colonizzate e gli effetti psicologici delle loro lotte di liberazione. In altre parole, si trova in una posizione migliore rispetto ad Erich Fromm per valutare la psicologia della violenza nel perseguimento della liberazione dal punto di vista della maggioranza della popolazione mondiale – non quindi il punto di vista di un partito politico istruito che cerca di rifare il mondo a sua immagine e somiglianza, ma il punto di vista di persone sottomesse a un sistema così violento da poter reagire con la forza o da poter scaricare quella violenza in modo sociopatico lɜ unɜ contro lɜ altrɜ. Parlando della colonizzazione e della resistenza ad essa, Fanon scrive: “È un luogo comune che i grandi sconvolgimenti sociali diminuiscano la frequenza della delinquenza e dei disturbi mentali”.[213]
Per aggiungere altro a quello che sta diventando un lungo elenco, la nonviolenza si illude di ripetere che i mezzi determinino i fini, come se non si fosse mai verificata una trasformazione in cui le condizioni finali fossero fondamentalmente diverse dai mezzi che le hanno determinate. Dopo la guerra di Nuvola Rossa del 1866, ad esempio, lɜ Lakota non scesero in un’orgia di violenza perché commisero una qualche trasgressione morale/psicologica uccidendo i soldati bianchi. Al contrario, godettero di quasi un decennio di relativa pace e autonomia fino a quando Custer non invase le Black Hills per trovare l’oro.[214]
Ma invece di adattare i mezzi (le nostre tattiche) alla situazione che ci troviamo ad affrontare, dovremmo prendere le nostre decisioni in base a condizioni che non sono nemmeno presenti, agendo come se la rivoluzione fosse già avvenuta e noi vivessimo in quel mondo migliore.[215] Questa rinuncia totale alla strategia dimentica che nessuna delle due lodate figure della nonviolenza, Gandhi e King, credeva che il pacifismo fosse una panacea applicabile a tuttɜ.
Martin Luther King Jr. riconosceva che “coloro che rendono impossibile una rivoluzione pacifica rendono solo inevitabile una rivoluzione violenta”.[216] Dato l’accresciuto consolidamento dei media (il presunto alleato e strumento di moralizzazione dell’attivista nonviolentǝ)[217] e l’aumento dei poteri repressivi del governo, possiamo davvero credere che un movimento pacifista possa superare il governo su una questione in cui il compromesso è inaccettabile per gli interessi dominanti?
A chiudere l’elenco delle illusioni comuni c’è l’affermazione, fin troppo frequente, che la violenza allontani le persone. Questa affermazione è clamorosamente falsa. I videogiochi e i film violenti sono i più popolari. Anche le guerre palesemente false ottengono il sostegno di almeno la metà della popolazione, spesso con l’osservazione che l’esercito statunitense sia troppo umano e moderato nei confronti dei suoi nemici. D’altra parte, le veglie a lume di candela sono alienanti per la maggior parte delle persone che non vi partecipano, che si affrettano e sorridono da sole. Votare è alienante per le milioni di persone che sanno bene di non partecipare e per alcune delle molte persone che partecipano in mancanza di opzioni migliori. Mostrare un presunto “amore” per il “tuo nemico” è alienante per le persone che sanno che l’amore è qualcosa di più profondo, più intimo, di una superficiale faccina da distribuire a sei miliardi di sconosciutɜ contemporaneamente.[218] Il pacifismo è alienante anche per le milioni di americanɜ di classe inferiore che esultano silenziosamente ogni volta che un poliziotto o (soprattutto) un agente federale viene ucciso.[219]
La vera domanda è: chi è alienatǝ dalla violenza, e da quale tipo di violenza? Un’anarchicǝ scrive:
“Anche se lo fossero, che importa se le classi medie e alte sono alienate dalla violenza? Hanno già avuto la loro rivoluzione violenta e noi la stiamo vivendo proprio ora. Inoltre, l’idea che le classi medie e alte siano alienate dalla violenza è completamente falsa... esse sostengono la violenza in continuazione, che si tratti di scioperi, brutalità della polizia, prigioni, guerre, sanzioni o pene capitali. Ciò a cui si oppongono veramente è la violenza diretta a eliminare loro e i loro privilegi.”[220]
La violenza sconsiderata che sottopone le persone a rischi inutili senza nemmeno sforzarsi di essere efficace o di avere successo, molto probabilmente alienerà le persone – soprattutto quelle che già devono sopravvivere sotto la violenza dell’oppressione – ma la lotta per la sopravvivenza e la libertà spesso conquistano la simpatia. Di recente ho avuto la fortuna di entrare in corrispondenza con il prigioniero dell’Esercito di Liberazione Nero Joseph Bowen, che venne rinchiuso dopo che il poliziotto che cercò di ucciderlo morì. “Joe-Joe” si guadagnò il rispetto degli altri detenuti dopo che, nel 1973, insieme a un altro detenuto, assassinò il direttore e il vicedirettore e ferì il comandante delle guardie della prigione di Holrnesburg in Filadelfia in risposta all’intensa repressione e alla persecuzione religiosa. Nel 1981, quando un tentativo di fuga di massa nel carcere di Graterford, che aveva aiutato a organizzare, fu sventato e si trasformò in una situazione con ostaggi, i media prestarono grande attenzione alle terribili condizioni delle prigioni della Pennsylvania. Durante i cinque giorni di stallo, decine di articoli uscirono sul Philadelphia Inquirer e sulla stampa nazionale, facendo luce sulle rimostranze dei prigionieri e sottolineando il fatto che queste persone che non avevano nulla da perdere avrebbero continuato a lottare contro la repressione e le cattive condizioni. Alcuni articoli dei media corporativi espressero persino simpatia verso Joe-Joe,[221] ed alla fine il governo acconsentì a trasferire dozzine di ribelli in un’altra prigione. Piuttosto che causare una tempesta, preferirono essere tattici. Infatti, a seguito dell’assedio, Bowen turbò così tanto le scale del potere politico che i politici si misero sulla difensiva e avviarono investigazioni riguardo alle condizioni della prigione di Graterford. In questi molti esempi, inclusɜ lɜ zapatistɜ nel 1994 e i minatori degli Appalachi nel 1921, possiamo vedere come le persone iniziano a farsi rispettare esattamente quando iniziano a prendere le armi per schierarsi contro l’oppressione.
Da quando è uscita la prima edizione di questo libro, sono stato avvicinato da molte persone non attiviste che mi hanno detto di aver apprezzato i sentimenti qui contenuti. Mentre lɜ attivistɜ potrebbero pensare che queste persone siano apatiche nei confronti degli attuali movimenti sociali perché non vi hanno mai partecipato, mi è stato detto più volte che volevano essere coinvoltɜ ma non sapevano come, perché gli unici sforzi di organizzazione che vedevano ruotavano intorno a proteste pacifiche, che non sembravano inclusive per loro e ovviamente non avrebbero ottenuto alcun risultato. Un operaio mi ha raccontato che, dopo l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti, è saltato in macchina e ha guidato per due ore fino a Washington per partecipare ad una protesta, non conoscendo nessun’altrǝ coinvoltǝ. Quando è arrivato e ha visto una folla pacifica ammassata dalla polizia in una gabbia di protesta, ha fatto dietrofront ed è tornato a casa.
ll ruolo frequente dellɜ attivistɜ nonviolentɜ nel controllare o sabotare i movimenti rivoluzionari e la loro incapacità di proteggere lɜ attivistɜ rivoluzionariɜ dalla repressione dello stato, così come la loro acquiescenza alle “vittorie” più vuote, suggeriscono un secondo fine all’attivismo nonviolento. Mi sembra che il motivo più comune sia per lɜ pacifistɜ quello di avvalersi di un’alta posizione morale e di alleviare il sostanziale senso di colpa in cui incorrono riconoscendo i molti sistemi di oppressione in cui sono coinvoltɜ ma che non riescono ad affrontare in modo significativo. Ward Churchill suggerisce che lɜ pacifistɜ bianchɜ vogliono proteggersi dalla repressione consegnando il loro attivismo al portamento, a fare da portavoce e a formulare l’organizzazione sociale di un mondo post-rivoluzionario, mentre le persone razzializzate in tutto il mondo subiscono tutte le conseguenze della lotta per quel mondo.[222] Questo è ben lontano dal ruolo di solidarietà che lɜ pacifistɜ bianchɜ si immaginano di svolgere.
L’attivismo nonviolento contro la School of the Americas (SOA) ne è un buon esempio. L’organizzazione contro la SOA comprende una delle più grandi campagne di disobbedienza civile della storia recente e ha attirato la partecipazione e il sostegno di numerosɜ pacifistɜ di spicco. Durante il mio coinvolgimento nell’attivismo contro la SOA, ho concepito la disobbedienza civile e la pena detentiva come un mezzo per dimostrare la mancanza di coraggio e la natura farsesca e autoritaria del processo democratico, e favorire l’escalation verso un movimento veramente rivoluzionario che si rivolge a tutti gli aspetti del capitalismo e dell’imperialismo, non solo alla SOA. Quanto sarebbe ridicolo fare una campagna per la chiusura di una scuola militare quando numerose altre istituzioni, anzi l’intera struttura statale capitalista, lavorano per gli stessi scopi? Ma dopo la conclusione della mia pena detentiva, ho visto che per la maggioranza pacifista del “movimento” anti-SOA, la disobbedienza civile era fine a se stessa, utilizzata per fare leva sulle pressioni del Congresso e sul reclutamento di nuovɜ partecipanti, nonché per alleviare il senso di colpa indotto dal privilegio e accedere alla rettitudine morale di coloro che hanno messo i loro soldi al posto della bocca, per così dire. Ha permesso loro di affermare che, incorrendo in una pena detentiva relativamente facile di sei mesi o meno, stavano “testimoniando” e “solidarizzando con lɜ oppressɜ” in America Latina.[223]
Con tutte le sue fanfare, la nonviolenza è decrepita. La teoria nonviolenta si basa su un gran numero di manipolazioni, falsificazioni e illusioni. La pratica della nonviolenza è inefficace ed egoista. In senso rivoluzionario, non solo la nonviolenza non ha mai funzionato, ma non è mai esistita. Guidare un’auto, mangiare carne, mangiare tofu, pagare l’affitto, pagare le tasse, essere gentili con un poliziotto: tutte queste sono attività violente.[224] Il sistema globale e tutti coloro che ne fanno parte sono intrisi di violenza; è forzato, coercitivo. Per coloro che soffrono sotto la violenza del colonialismo, dell’occupazione militare o dell’oppressione razziale, la nonviolenza non è sempre un’opzione: le persone devono reagire violentemente contro l’oppressore o trasferire la violenza in violenza antisociale contro altre persone. Frantz Fanon scrive:
Qui, a livello di organizzazioni comunitarie, si possono chiaramente distinguere i ben noti modelli di comportamento di elusione. È come se immergersi in un bagno di sangue fraterno li spingesse a ignorare l’ostacolo e a rimandare a un secondo momento la scelta, comunque inevitabile, che apre la questione della resistenza armata al colonialismo. Così l’autodistruzione collettiva, in una forma molto concreta, è uno dei modi in cui la tensione muscolare del nativo si libera.[225]
La pace non è un’opzione se non dopo la distruzione della violenza organizzata centralmente che è lo stato. Anche l’affidamento esclusivo alla costruzione di alternative – per sostenerci, rendere obsoleto lo stato e guarirci da questa violenza per evitare l’“autodistruzione” – non è nemmeno un’opzione, perché lo stato può schiacciare le alternative che non sono in grado di difendersi da sole. Se ci fosse permesso di vivere il cambiamento che desideriamo vedere nel mondo, non ci sarebbe bisogno della rivoluzione. Le nostre opzioni sono state violentemente limitate a quanto segue: sostenere attivamente la violenza del sistema; sostenere tacitamente tale violenza non sfidandola; sostenere alcuni dei tentativi esistenti di distruggere con forza il sistema di violenza; perseguire modi nuovi e originali per combattere e distruggere tale sistema. Lɜ attivistɜ privilegiatɜ devono capire ciò che il resto della popolazione mondiale sa da troppo tempo: siamo nel bel mezzo di una guerra e la neutralità non è possibile.[226]
Non c’è nulla in questo mondo che meriti il nome di pace. Piuttosto, si tratta di capire di chi è la violenza che ci spaventa di più e da che parte stare.
L’alternativa: possibilità per un attivismo rivoluzionario
Ho presentato una serie di argomentazioni forti, anche satiriche, contro l’attivismo nonviolento, e non ho diluito queste argomentazioni. Il mio obiettivo è stato quello di enfatizzare le critiche troppo spesso messe a tacere al fine di destituire la morsa che il pacifismo ha sul dibattito del movimento – una morsa che esercita un tale monopolio sulla moralità putativa e sull’analisi strategica/tattica in molti ambienti da precludere anche il riconoscimento di un’alternativa praticabile. Lɜ aspiranti rivoluzionariɜ devono rendersi conto che il pacifismo è così scialbo e controproducente che un’alternativa diventa fondamentale. Solo allora potremo soppesare equamente i diversi percorsi di lotta – spero anche in modo più pluralistico e decentrato – piuttosto che tentare di imporre una linea di partito o un unico programma rivoluzionario corretto.
Il mio ragionamento non è che tuttɜ lɜ pacifistɜ siano apologistɜ e vendutɜ senza merito o un posto nel movimento rivoluzionario. Moltɜ pacifistɜ sono aspiranti rivoluzionariɜ ben intenzionatɜ che semplicemente non sono statɜ in grado di superare il loro condizionamento culturale, che lɜ istruisce istintivamente a reagire agli attacchi allo stato come al più alto crimine e al tradimento. Alcunɜ pacifistɜ hanno dimostrato nella storia un impegno così prolungato per la rivoluzione – affrontando rischi e sacrificandosi – tale da essere al di sopra delle critiche tipicamente mosse allɜ pacifistɜ, e persino da rappresentare una sfida al funzionamento dello status quo, in particolare quando la loro morale non impedisce loro di lavorare in solidarietà con lɜ rivoluzionariɜ non pacifistɜ.[227] Il punto è che il pacifismo come ideologia, con pretese che vanno al di là di una pratica personale, serve inesorabilmente gli interessi dello stato ed è irrimediabilmente intrecciato a livello psicologico con lo schema di controllo del patriarcato e della supremazia bianca.
Ora che ho dimostrato la necessità di sostituire una pratica rivoluzionaria nonviolenta vorrei approfondire con che cosa potremmo sostituirla in quanto numerose forme di lotta rivoluzionaria non pacifista contengono i difetti strutturali del caso. Nel dibattito, lɜ pacifistɜ di solito generalizzano alcuni difetti di massima di alcune rivoluzioni storiche esemplificate, evitano qualsiasi analisi dettagliata e si limitano a sostenere la loro tesi. Ma piuttosto che dire, ad esempio, “Vedete, la violenta Rivoluzione Russa ha portato ad un altro governo altrettanto violento e autoritario, quindi la violenza è contagiosa”,[228] sarebbe utile sottolineare che tutto quello che i leninisti volevano era uno stato autoritario capitalista dipinto di rosso con loro a capo, e a modo loro ebbero un certo successo.[229] Potremmo anche menzionare lɜ rivoluzionariɜ anarchichɜ contemporaneɜ dell’Ucraina meridionale che rifiutarono costantemente il controllo del potere e, per anni, liberarono vaste aree dai tedeschi, dai nazionalisti antisemiti, dai bianchi e dai Rossi – ma non imposero la loro volontà a coloro che avevano liberato, ma lɜ incoraggiarono ad auto-organizzarsi.[230] Lasciando ulteriormente da parte l’analisi mistificatoria e generalizzante del pacifismo, potrebbe essere utile sporcarsi le mani nei dettagli storici e analizzare i gradi di violenza, magari mostrando che in termini di deprivazione strutturale e repressione statale, la Cuba di Castro, il prodotto di una rivoluzione violenta, era probabilmente meno violenta della Cuba di Batista. Tuttavia, ci sono già abbastanza sostenitrici di Castro da dissuadermi dall’impiegare le mie energie in questo modo.
L’elemento comune a tutte queste rivoluzioni autoritarie è la loro organizzazione di forma gerarchica. L’autoritarismo dell’URSS o della Repubblica Popolare Cinese non era un rimando mistico alla violenza che usavano, ma una funzione diretta delle gerarchie a cui sono sempre stati legati. È vago, privo di significato e in generale non veritiero affermare che la violenza generi sempre determinati modelli psicologici e relazioni sociali. La gerarchia, tuttavia, è inseparabile dai modelli psicologici e dalle relazioni sociali di dominio. In effetti, la maggior parte della violenza della società, che è indiscutibilmente sbagliata, deriva da gerarchie coercitive. In altre parole, il concetto di gerarchia ha la maggior precisione analitica e morale rispetto al concetto di violenza. Perciò, per avere veramente successo, una lotta di liberazione deve usare tutti i mezzi necessari che siano coerenti con la costruzione di un mondo libero da gerarchie coercitive.
Questo antiautoritarismo deve riflettersi sia nell’organizzazione che nei principi etici di un movimento di liberazione. Dal punto di vista organizzativo, il potere deve essere decentralizzato: ciò significa che non ci sono partiti politici o istituzioni burocratiche. Il potere deve essere localizzato il più possibile alla base, con individui e gruppi che lavorano all’interno di una comunità. Poiché i movimenti di origine e i gruppi comunitari sono limitati dalle condizioni della vita reale e hanno contatti costanti con persone esterne al movimento, l’ideologia tende a fluire verso l’alto, concentrandosi nei “comitati nazionali” e in altri livelli organizzativi centralizzati (che riuniscono persone che la pensano allo stesso modo, immerse nell’astrazione e lontane dal contatto con la realtà quotidiana della maggior parte delle persone). Pertanto, la maggior parte dell’autonomia e del potere decisionale deve rimanere alla base. Quando i gruppi locali avranno bisogno di aggregarsi o di coordinarsi in altro modo su un’area geografica più ampia – e la difficoltà di questa lotta richiederà coordinamento, disciplina, condivisione di risorse e strategia comune – qualsiasi organizzazione si crei dovrà garantire che i gruppi locali non perdano la loro autonomia e che qualsiasi livello più alto di organizzazione venga creato (come i comitati regionali o nazionali di una federazione) sia debole, temporaneo, frequentemente sostituito, revocabile e sempre dipendente dalla ratifica dei gruppi locali. Altrimenti, coloro che occupano i livelli superiori dell’organizzazione rischiano di sviluppare una mentalità burocratica e l’organizzazione rischia di sviluppare interessi propri, che finiranno per divergere dagli interessi del movimento.
Inoltre, nessuna organizzazione dovrebbe monopolizzare il movimento. Le organizzazioni non dovrebbero essere degli imperi; dovrebbero essere strumenti temporanei che si sovrappongono, proliferano e si estinguono quando non sono più necessari. Un movimento sarà più sano e più difficile da cooptare se c’è una varietà di gruppi che occupano nicchie diverse e perseguono scopi simili,[231] e questi gruppi saranno meno inclini a lotte interne se le persone all’interno del movimento tenderanno ad appartenere a più gruppi piuttosto che dare la loro lealtà a un singolo gruppo.
Anche la filosofia della lotta per la liberazione è fondamentale. Le strutture non coercitive sono facilmente sovvertibili se la cultura e i desideri delle persone che le gestiscono le spingono verso altri fini. Per cominciare, una cultura di liberazione deve favorire il pluralismo rispetto al monopolio. In termini di lotta, ciò significa che dobbiamo abbandonare l’idea che esista un solo modo giusto, che dobbiamo far aderire tuttɜ alla stessa piattaforma o alla stessa organizzazione. Al contrario, la lotta trarrà beneficio da una pluralità di strategie che attacchino lo stato da diverse angolazioni. Questo non significa che tuttɜ debbano lavorare da solɜ o in modo trasversale. Dobbiamo coordinarci e unificarci il più possibile per aumentare la nostra forza collettiva, ma dobbiamo anche riconsiderare quanto l’uniformità sia una possibilità concreta. È impossibile mettere tuttɜ d’accordo sul fatto che una sola strategia di lotta sia la migliore, e anzi questa tesi è probabilmente sbagliata. Dopotutto, persone diverse hanno forze ed esperienze diverse e affrontano aspetti diversi dell’oppressione: è logico che ci siano diversi metodi di lotta da percorrere simultaneamente per raggiungere la liberazione. Il monoteismo autoritario insito nella civiltà occidentale ci porterebbe a considerare questi altri percorsi come deviazioni non intelligenti, come concorrenza. Potremmo persino cercare di reprimere queste altre tendenze all’interno del movimento.
L’antiautoritarismo richiede di abbandonare questa mentalità, di riconoscere l’inevitabilità delle differenze e di considerare le persone che si discostano da noi come alleate. Dopo tutto, non stiamo cercando di imporre a tuttɜ una nuova società utopica dopo la rivoluzione; l’obiettivo è distruggere le strutture di potere centralizzate in modo che ogni comunità abbia l’autonomia di organizzarsi così che tutti i suoi membri decidano le modalità migliori per soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi, aderendo o lasciando associazioni libere di mutuo aiuto con le comunità circostanti.[232] Ognunǝ di noi ha un naturale potenziale verso la libertà e l’auto-organizzazione; pertanto, se ci identifichiamo come persone anarchiche, il nostro compito non è quello di convertire tuttɜ all’anarchismo, ma di usare le nostre prospettive e le nostre esperienze collettive per difenderci dagli sforzi di cooptazione della sinistra istituzionale e per fornire modelli di relazioni sociali autonome e di auto-organizzazione in culture dove attualmente non ne esistono.
C’è anche la questione della leadership in una lotta antiautoritaria. L’idea tradizionale di leadership, come ruolo istituzionalizzato o coercitivo, come potere sulle persone, è gerarchica e inibisce la crescita delle persone. Ma è anche vero che le persone non sono uguali in termini di capacità, che questa rivoluzione richiederà un’enorme quantità di competenze e che individui consapevoli e non egoisti metteranno spontaneamente qualcunə con più competenze in una posizione di leadership non coercitiva e temporanea. L’approccio di un’etica antiautoritaria nei confronti della leadership è che il potere deve essere costantemente ridistribuito verso l’esterno. È responsabilità delle persone che si trovano in posizioni di leadership prestare i propri talenti al movimento e trasmettere la propria esperienza, insegnando ad altre persone piuttosto che mantenere la propria conoscenza come forma di potere. Inoltre, un’etica antiautoritaria favorisce la lotta senza compromessi contro l’oppressione, ma si oppone a schiacciare coloro che sono statɜ sconfittɜ, favorisce la riconciliazione rispetto alla punizione.
Con queste strutture e questa cultura, un movimento di liberazione ha maggiori possibilità di successo e di non creare un nuovo sistema autoritario. Ci sarà sempre tensione tra l’essere efficaci e l’essere liberatricɜ e nella complessità della lotta c’è molta zona grigia, ma è utile vedere la formazione di una pratica antiautoritaria come una lotta continua tra due elementi (l’efficienza e la libertà) che sono in conflitto ma che non si escludono a vicenda. La visione pacifista della lotta, basata su una dicotomia polivalente tra violenza e nonviolenza, è irrealistica e autolesionista.
In concreto è difficile generalizzare il modo in cui un movimento di liberazione che utilizza una varietà di strategie diverse debba condurre la sua lotta. I gruppi specifici devono decidere da soli in base alle condizioni che devono affrontare, non in base alle direttive di un’ideologia. Con ogni probabilità, però, un movimento di liberazione antiautoritario dovrebbe imparare ad essere in grado di resistere al controllo mentale dei media istituzionali ed a porre l’accento sulla costruzione di una cultura autonoma: centri sociali, scuole gratuite, cliniche gratuite, agricoltura comunitaria e altre strutture in grado di sostenere le comunità nella resistenza. Le nazioni occidentali hanno anche bisogno di sviluppare relazioni sociali collettive. Per coloro che sono cresciuti nel Nord globale, essere anarchichɜ non rappresenta un’eccezione all’essere impregnatɜ di forme di interazioni sociali individualistiche, basate sulla repressione e sul privilegio. Dobbiamo impiegare modelli funzionali di giustizia riparativa o trasformativa, in modo da non avere più bisogno della polizia o delle prigioni. Finché dipenderemo dallo stato, non lo sovvertiremo mai.
Lə lettricə potrà notare che alcuni dei principali requisiti preliminari di un movimento di liberazione non includono azioni “violente”. Spero che ormai si possa abbandonare del tutto la dicotomia tra violenza e nonviolenza. L’uso della violenza non è una tappa della lotta che dobbiamo raggiungere e superare per vincere. Non è utile isolare la violenza. Piuttosto, dobbiamo essere consapevoli di certi tipi di repressione che probabilmente dovremo affrontare, di certe tattiche che probabilmente dovremo usare. In ogni fase della lotta dobbiamo mantenere uno spirito militante. I nostri centri sociali dovrebbero onorare lɜ militantɜ in carcere o quellɜ uccisɜ dallo stato; le nostre scuole pubbliche dovrebbero insegnare l’autodifesa e la storia della lotta. Se aspettiamo di introdurre la militanza fino a quando lo stato non avrà aumentato la repressione al punto da rendere palesemente evidente che ci ha dichiarato guerra, sarà troppo tardi.
Promuovere la militanza deve andare di pari passo con la preparazione e la sensibilizzazione.
È pericoloso rimanere totalmente tagliatɜ fuori da una realtà mainstream, precipitandosi in tattiche che nessun’altrə può capire e tanto meno sostenere. Le persone che agiscono prematuramente e si tagliano fuori dal sostegno popolare saranno facili da eliminare per il governo.[233]
Detto questo, non possiamo lasciare che le nostre azioni siano determinate da ciò che è accettabile dall’opinione pubblica. Le opinioni dell’opinione pubblica sono condizionate dallo stato, e assecondarla significa assecondare lo stato. Dobbiamo piuttosto lavorare per intensificare la militanza, educare attraverso azioni esemplari e aumentare il livello di militanza accettabile (almeno per i segmenti della popolazione che abbiamo identificato come potenziali sostenitori). Lɜ radicalɜ provenienti da un contesto privilegiato hanno il lavoro più impegnativo da fare in questo senso, perché queste comunità hanno le reazioni più conservatrici nei confronti delle tattiche militanti. Lɜ radicalɜ privilegiatɜ sembrano essere più propensɜ a chiedersi “Cosa penserebbe la società?” come scusa per la loro passività.
Aumentare il livello di accettazione delle tattiche militanti non è un lavoro facile, dobbiamo portare gradualmente le persone ad accettare forme di lotta più militanti. Se l’unica scelta che possiamo scegliere è tra il lancio di bombe e il voto, quasi tuttɜ lɜ nostrɜ potenzialɜ alleatɜ sceglieranno il voto. Sebbene si debbano superare altri condizionamenti culturali prima che le persone possano accettare e attuare azioni più pericolose e dure, queste tattiche non possono essere poste in cima a una gerarchia. Feticizzare la violenza non migliora l’efficacia di un movimento, né ne preserva le qualità antiautoritarie.
A causa della natura dello stato, ogni lotta di liberazione probabilmente finirà per diventare una lotta armata. Molti popoli sono impegnati in una lotta armata per liberarsi proprio ora, come ad esempio in Iraq, Palestina, Ijaw in Nigeria, alcune nazioni indigene in Sud America e Papua Nuova Guinea e, in misura minore, gruppi antiautoritari in Grecia, Italia e altrove. Mentre scrivo questa frase, attivistɜ indigenɜ, anarchichɜ e sindacalistɜ armatɜ di mattoni e bastoni tengono le barricate a Oaxaca contro l’imminente assalto dei militari. Moltɜ di loro sono già statɜ uccisɜ e, mentre i militari colpiscono ancora e ancora, devono decidere se intensificare le tattiche per migliorare la loro capacità di autodifesa, a rischio di conseguenze più gravi. Non dirò che la lotta armata è una necessità ideologica, ma per molte persone in molti luoghi diventa una necessità per rovesciare lo stato o semplicemente per difendersi da esso. Sarebbe fantastico se la maggior parte delle persone non dovesse passare attraverso un processo di lotta armata per liberarsi e – data la misura in cui le economie e i governi sono integrati a livello globale al giorno d’oggi – molti governi potrebbero facilmente crollare se fossero già indeboliti dalla diffusione di ondate di rivolta globale. Ma alcune persone dovranno sperimentare la lotta armata, alcune devono farlo già adesso, e sarebbe imperdonabile se la nostra strategia rivoluzionaria si basasse sulla certezza che altre persone muoiano in conflitti sanguinosi mentre noi restiamo al sicuro.
Se vogliamo essere realistɜ dobbiamo accettare che la rivoluzione è una guerra sociale, non perché ci piaccia la guerra, ma perché riconosciamo che lo status quo sia una guerra a bassa intensità e che sfidare lo stato si traduce in un’intensificazione di questa guerra. Dobbiamo anche accettare che la rivoluzione richiede un conflitto interpersonale, perché alcune classi di persone sono impiegate per difendere le istituzioni centralizzatrici che dobbiamo distruggere. Le persone che continuano a disumanizzarsi come agenti della legge e dell’ordine devono essere sconfitte con qualsiasi mezzo necessario, affinché non possano più impedire la presa di coscienza autonoma dei bisogni delle persone. Spero che durante questo processo si possa costruire una cultura del rispetto nei confronti del nostro nemico, che aiuterà a prevenire le epurazioni o una nuova autorità quando lo stato attuale sarà stato sconfitto. Potrebbe essere considerato accettabile uccidere un nemico più potente (ad esempio, qualcunə che deve essere presə di mira clandestinamente per paura di rappresaglie da parte dello stato), sfavorevole uccidere qualcunə che è in egual misura potente (in modo tale da essere giustificatə dallə propriə pari solo in circostanze difficili e per autodifesa), e del tutto immorale e ignobile uccidere qualcunə più debole (ad esempio, qualcunə già sconfittə).
Possiamo avere successo nell’attivismo rivoluzionario concreto, puntando ad obiettivi incontestabili e a lungo termine, ma non dobbiamo dimenticare le vittorie a breve termine. Nel frattempo, le persone hanno bisogno di sopravvivere e di essere nutrite. E dobbiamo riconoscere che la lotta violenta contro un nemico estremamente potente, in cui la vittoria a lungo termine può sembrare impossibile, può portare a piccole vittorie a breve termine. Perdere le battaglie può essere meglio che non combatterle affatto; combattere dà forza alle persone e ci insegna che possiamo combattere. Riferendosi alla sconfitta nella battaglia di Blair Mountain durante la guerra delle miniere del 1921 in West Virginia, il regista John Sayles scrive:
“La vittoria psicologica di quei giorni violenti potrebbe essere stata più importante. Quando un popolo colonizzato impara a reagire insieme, la vita non potrà mai più essere così semplice per i suoi sfruttatori”.[234]
Con una resistenza sufficientemente ardita e forte possiamo andare oltre le piccole vittorie per ottenere una vittoria duratura contro lo stato, il patriarcato, il capitalismo e la supremazia bianca. La rivoluzione è imperativa e la rivoluzione richiede la lotta. Esistono molte forme efficaci di lotta e alcuni di questi metodi possono portare al mondo che sogniamo. Per trovare una delle strade giuste, dobbiamo osservare, valutare, criticare, comunicare e, soprattutto, imparare agendo e sperimentando.
[1] Alcuni periodici limitati all’ambiente anarchico, come Anarchy: A Journal of Desier Armed, non sono per nulla pacifisti. Tuttavia, la loro influenza e l’influenza dellɜ loro lettrici, può essere chiaramente considerata marginale in aree in cui le persone anarchiche hanno un grande impatto. In occasione delle mobilitazioni di massa dei movimenti contro la guerra e la globalizzazione, in cui anarchichɜ sono presenze chiave, le critiche al pacifismo non vengono nemmeno prese in considerazione; al massimo, alcunɜ partecipanti dicono che forme annacquate di azione diretta si qualificano davvero come nonviolente. Media disponibili al di fuori dei circoli anarchici sono quasi esclusivamente pacifisti, anche se moltɜ dellɜ volontariɜ che mantengono in vita questi mezzi di comunicazione sono anti-autoritariɜ che sostengono una diversità di tattiche.
[2] Poiché può essere impertinente riferirsi a qualcunə che non è impegnatə in un conflitto aperto contro lo stato come ad unə rivoluzionariə, ci tengo a dire che personalmente definisco un’attivista rivoluzionariə come qualcunə che, perlomeno, si fa strada verso il punto in cui tale conflitto si verificherà. Alcune persone hanno delle remore nei confronti del termine “attivista”, o lo associano a tipi di attivismo riformista. Per evitare di essere troppo esigenti sulle parole e sulla terminologia, chiederò a chi sta leggendo semplicemente di accogliere questo termine nel miglior modo possibile.
[3] Questa particolare lista proviene da un articolo scritto da Spruce Houser (Spruce Houser, “Domestic Anarchist Movement Increasingly Espouses Violence”, Athens News, agosto 2004, http://athensnews.com/index.php?action=viewarticle§ion=archive&story_id=17497), attivista per la pace e anarchico autoproclamato.
Ho visto queste stesse presunte vittorie dichiarate da altrɜ pacifistɜ più e più volte.
[4] Hell NYC, 2/15: The Day the World Said No to War (Oakland, CA: AK Press, 2003). Questo libro dà un’idea del modo in cui lɜ attivistɜ per la pace celebrano queste proteste.
[5] Per esempio, alla conferenza anarchica citata nell’introduzione, non appena un pacifista è stato costretto ad ammettere che la lotta per i diritti civili non si è conclusa vittoriosamente, ha cambiato direzione senza battere ciglio e ha attribuito la colpa del fallimento ai movimenti di liberazione militanti, dicendo che quando il movimento è diventato violento, ha iniziato a perdere terreno. Questa argomentazione ignora il fatto che la resistenza contro la schiavitù e l’oppressione razziale era militante ben prima della fine degli anni sessanta, e inoltre disconosce qualsiasi analisi specifica. Tali correlazioni sono di fatto inesistenti.
[6] Chandrasekhar Azad, ucciso in una sparatoria con gli inglesi, è al centro di un recente film, L’ultimo rivoluzionario, del regista indiano Priyadarshan.
[7] Reeta Sharma, “What if Bhagat Singh Had Lived?”. The Tribune of India, 21 marzo 2001; http://www.tribuneindia.com/2001/20010321/edit.htm#6. È importante notare che la popolazione di tutta l’India implorò Gandhi di chiedere la commutazione della condanna a morte di Bhagat Singh, emessa per l’assassinio di un funzionario britannico, ma Gandhi scelse strategicamente di non pronunciarsi contro l’esecuzione di stato che secondo moltɜ avrebbe potuto fermare facilmente. Così un rivoluzionario rivale fu rimosso dal panorama politico.
[8] Bose si è dimesso dopo un conflitto con altri leader politici indiani, scaturito dall’opposizione di Gandhi a Bose perché quest’ultimo non sosteneva la nonviolenza. Per saperne di più sulle lotte di liberazione indiane, leggere Sumit Sarkar, Modern India: 1885-1947 (New York: St. Martin’s Press, 1989).
[9] Il professor Gopal K, in un’e-mail all’autore, nel settembre 2004. Gopal scrive: “Ho amichɜ in India che non hanno ancora perdonato Gandhi per questo”.
[10] Sebbene il conservazionismo insito in ogni sistema politico abbia impedito a molti stati europei/americani di rendersene conto per un certo periodo, il dominio neo-coloniale è molto più efficiente nell’arricchire il colonizzatore rispetto all’amministrazione coloniale diretta e nel mantenere il potere, una volta che il colonialismo diretto realizza con successo la riorganizzazione politica ed economica all’interno delle colonie. Lɜ liberali all’interno degli stati imperialisti, ingiustamente consideratɜ come antipatriotticɜ, in realtà avevano ragione quando sostenevano l’indipendenza delle colonie. George Orwell, Ho Chi Minh e altri hanno scritto sull’inefficienza fiscale del colonialismo. Si veda Ho Chi Minh, “Il fallimento della colonizzazione francese”, in Ho Chi Minh on Revolution, ed. Bernard Fall (New York: Signet Books, 1967).
[11] Lo status neo-coloniale dell’India è ampiamente documentato come parte del corpo in espansione della letteratura anti e alter-globalista. Si vedano Arundhati Roy, Power Politics (Cambridge: South End Press, 2002) e Vandana Shiva, Vacche sacre e mucche pazze: il furto delle riserve alimentari globali (DeriveApprodi, 2001).
[12] Il gruppo Direct Action in Canada e lo svizzero Marco Camenisch sono due esempi.
[13] Si veda Robert Williams, Negroes with Guns (Chicago: Third World Press, 1962); Kathleen Cleaver e George Katsiaficas, Liberation, Imagination, and the Black Panther Party (New York: Routledge, 2001) e Charles Hamilton e Kwame Ture, Black Power: The Politics of Liberation in America (New York: Random House, 1967).
[14] “Historical Context of the Founding of the Party”, http://www.blackpanther.org/legacvnew.htm. Nel 1994, il dott. Kenneth Clark, lo psicologo la cui testimonianza è stata determinante per la vittoria della sentenza della Corte Suprema Brown v. Board of Education del 1954, ha dichiarato che la segregazione era peggiore di quanto non fosse stata 40 anni prima. Si veda anche Suzzane Goldberg, US wealth gap grows for ethnic minorities, The Guardian (Regno Unito) 19 ottobre 2004, ripreso da Asheville Global Report.
[15] Mick Dumke, “Running on Race”, ColarLines, autunno 2004, 17-19.
[16] “Il movimento per i diritti civili e il movimento di liberazione nera/anti-coloniale si sono rapidamente evoluti verso la lotta armata, con l’autodifesa che ha portato alle organizzazioni armate. La violenza antigovernativa ha avuto l’approvazione e la partecipazione di massa.” E. Tani e Kae Sera, False Nationalism, False Internationalism (Chicago: A Seeds Beneath the Snow Publication, 1985), 94. Vedi anche Mumia Abu-Jamal, Vogliamo la libertà (Mimesis, 2018), 32, 65.
[17] Flores Alexander Forbes, “Point Number 7: We Want an Immediate End to Police Brutality and the Murder of Black People; Why I Joined the Black Panther Party,” in Police Brutality: An Anthology, ed. Jill Nelson (New York: W.W. Norton and Company, 2000), 237.
[18] Abu-Jamal. Vogliamo la libertà, 31.
[19] “Se le emozioni represse di un popolo oppresso non vengono liberate in modo nonviolento, saranno liberate in modo violento. Quindi lasciate che il negro marci... Perché se si permette che le sue frustrazioni e la sua disperazione continuino ad accumularsi, milioni di negri cercheranno conforto e sicurezza nelle ideologie nazionaliste nere”. Martin Luther King Jr., citato in Tani e Sera, False Nationalism, 107. Martin Luther King Jr. ha messo in risalto la minaccia della violenza rivoluzionaria nera come probabile risultato nel caso in cui lo stato non avesse soddisfatto le sue richieste riformiste, e i suoi organizzatori spesso capitalizzarono le rivolte condotte da attivistɜ nerɜ militanti per mettere in una luce più favorevole i leader neri pacifisti. Si veda in particolare Ward Churchill, Pacifism as Pathology (Winnipeg: Arbeiter Ring, 1998), 43.
[20] Come King stesso disse, “Il suono dell’esplosione a Birmingham arrivò fino a Washington”. Tani And Sera, False Nationalism, 96-104.
[21] Ward Churchill, Pacifism as Pathology. Per un altro esempio, guardare il capitolo 6 di False Nationalism. Tani and Sera.
[22] Un pacifista alla Conferenza anarchica nordamericana, rifiutando l’idea che la resistenza vietnamita – e non il movimento per la pace – abbia sconfitto gli Stati Uniti, confuse momentaneamente la sua posizione morale/tattica con quella razziale, sottolineando che furono le truppe statunitensi ad assassinare i loro ufficiali e a portare alla fine della guerra.
[23] Tani and Sera, False Nationalism, 124-125. “Projects 100,000” è stata avviata nel 1966 su suggerimento del consigliere della Casa Bianca Daniel Patrick Moynihan, il quale, tra l’altro, ipotizzava che i disoccupati destinati al servizio militare fossero “disadattati” a causa della “vita familiare disorganizzata e matrifocale”, mentre il Vietnam rappresentava “un mondo lontano dalle donne”. (È interessante notare che la demonizzazione delle donne nere si è poi insinuata nello stesso movimento del Black Power). Il colonnello William Cole, comandante di un distretto di reclutamento dell’esercito, disse: “Il presidente Johnson voleva che quei ragazzi fossero tolti dalla strada”.
[24] Tani And Sera, False Nationalism, 127.
[25] Matthew Rinaldi, Olive-Drab Rebels: Subversion of the US Armed Forces in the Vietnam War, rev. ed. (London:Antagonism Press, 2003), 17.
[26] Ibid., 11-13.
[27] N.d.T. il ROTC (The Reserve Officers Training Cops) è un programma universitario-militare che addestra studenti a diventare ufficiali in servizio, conseguendo al contempo un diploma accademico.
[28] Tani and Sera, False Nationalism, 117-118.
[29] È formativo vedere come l’élite stessa percepisse il movimento contro la guerra. Un ricco resoconto viene dal segretario alla difesa Robert McNamara nel documentario Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara, diretto da Errol Morris, 2003. McNamara ha chiaramente espresso il suo turbamento per le proteste che spesso si tenevano fuori dal suo posto di lavoro, ma con l’arroganza tipica di un burocrate riteneva che il pubblico non ne sapesse abbastanza per dare suggerimenti politici. Credeva di volere anch’egli la pace e, in qualità di esperto governativo di primo piano, di star lavorando nell’interesse dellɜ oppositrici della guerra.
[30] “Milions Give Dramatic Rebuff to US War Plans.” News, United for Peace and Justice, http://www.unitedforpeace.org/article.php?id=107. Pubblicato originalmente dall’Agenzia di stampa francese il 16 febbraio 2003.
[31] Escluso Al Sharpton, che fu trattato (come sempre) come un reietto.
[32] Sinikka Tarvainen, “Spain’s Aznar Risks All for a War in Iraq,”. Agenzia di stampa tedesca, 11 marzo 2003.
[33] Non solo commentatricɜ, telecronistɜ etc... furono quasi tuttɜ unanimi nell’attribuire il cambio di potere direttamente agli attentati, ma lo stesso governo spagnolo riconobbe l’impatto degli attentati cercando di coprire il coinvolgimento di Al-Qaeda, incolpando invece i separatisti baschi dell’ETA. I membri del governo sapevano che, se l’opinione pubblica avesse collegato gli attentati alla partecipazione spagnola nell’occupazione dell’Iraq, avrebbero perso le elezioni, e così fu.
[34] Ward Churchill, utilizzando l’esempio dell’Olocausto per dimostrare la patologia del pacifismo di fronte all’oppressione, cita Raul Hilberg in La distruzione degli Ebrei d’Europa, (Einaudi, 2017) ed Isaiah Trunk in Judenrat: The Jewish Councils in Eastern Europe Under Nazi Occupation (New York: Macmillan, 1972). I contributi di Churchill sull’argomento – che hanno contribuito a questo testo –, si trovano in Pacifism as Pathology. Egli raccomanda anche la prefazione di Bruno Bettleheirri a Miklos Nyiszli in Auschwitz (New York: Faawcett Books, 1960).
[35] L’esempio dellɜ danesi durante l’Olocausto è stato utilizzato dall’anarchico pacifista Colman McCarthy nel suo seminario Pacifism and Anarchism alla National Conference on Organized Resistance, American University (Washing Washington, DC), 4 febbraio 2006.
[36] Yehuda Bauer, They Chose Life: Jewish Resistance in the Holocaust (New York: The American Jewish Committee, 1973) 32, 33.
[37] Ibid., 21.
[38] Ibid., 36.
[39] Ad esempio, su un forum di ex “prigionieri di coscienza” della School Of the Americas Watch (SOAW) – un gruppo che ha condotto una delle più lunghe campagne di disobbedienza civile nonviolenta contro la politica estera degli Stati Uniti – un pacifista veterano insinuò che se le forze armate stavano ponendo maggiori restrizioni alle proteste fuori da una base dell’esercito che era stata presa di mira dalle manifestazioni, era perché lɜ protestanti stavano facendo qualcosa di sbagliato e avrebbero dovuto fare un passo indietro. La stessa persona, rappresentante di un’ampia tendenza all’interno del pacifismo statunitense, si oppose anche a chiamare una protesta “marcia”, preferendo il termine “camminata” (nonostante dichiarasse di sostenere l’eredità di King e di Gandhi).
[40] Bauer, They Chose Life, 45.
[41] Ibid., 39-40.
[42] Ibid., 39 (riguardo a Kovno), 41 (riguardo alla Francia).
[43] Ibid., 47-48.
[44] Ibid., 50.
[45] Ibid., 52-53.
[46] Ibid., 53-54.
[47] Un esempio di come la sola minaccia della violenza popolare possa creare un cambiamento viene dall’American Indian Move (AIM), a Gordon, in Nebraska, nel 1972. Un uomo Oglala, Raymond Yellow Thunder, fu ucciso da bianchɜ che la polizia si rifiutò di arrestare (era un fatto relativamente comune). Lɜ parenti, stufɜ dell’apatia del governo, chiamarono l’AIM. Centinaia di indianɜ occuparono la città di Gordon per tre giorni, minacciando: “Siamo venutɜ qui a Gordon oggi per ottenere giustizia per lɜ Indianɜ d’America e per rendere noto Gordon... e se la giustizia non verrà immediatamente ottenuta, distruggeremo tutto “. [Ward Churchill e Jim Vander Wall, Agents of Repression: The FBI’s Secret Wars Against the Black Panther Party and the American Indian Movement (Cambridge: South End Press, 1990), 122.] I due assassini furono prontamente arrestati, un poliziotto fu sospeso e le autorità locali si sforzarono di porre fine alla discriminazione nei confronti degli Indiani d’America.
[48] Vedi ad esempio Malcolm X, “Twenty Million Black People in a Political, Economic, and Mental Prison,” in Malcolm X: The Last Speeches, ed. Bruce Perry (New York: Pathfinder, 1989), 23–54.
[49] In una conversazione che ho avuto con unə pacifista, Mandela è stato additato come una persona razzializzata esemplare e abbandonato subito dopo quando ho menzionato l’abbraccio di Mandela alla lotta armata. [Dettagliato nella sua autobiografia: Nelson Mandela, Lungo cammino verso la libertà (Feltrinelli, 2013)].
[50] Jack Gilroy, e-mail, 23 gennaio 2006. Questa particolare e-mail era il culmine di una conversazione piuttosto sordida sul servizio email di un gruppo pacifista bianco, durante la quale lɜ partecipanti hanno discusso di una marcia in stile diritti civili suggerita attraverso il cuore del Sud nero. Una persona ha suggerito di chiamarla “passeggiata” invece di “marcia”, perché “marcia” è un “linguaggio violento”. Gilroy ha affermato: “Ovviamente stiamo rivendicando il mantello del dottor King!”. Quest’ultimo era in risposta a una critica mossa da un attivista nero, il quale ha affermato che, organizzando una marcia di questo tipo (che sarebbe dovuta partire da Birmingham o da un’altra città di uguale simbolismo), stavano cooptando l’eredità di King e probabilmente avrebbero offeso e allontanato le persone nere (dato che l’organizzazione era prevalentemente bianca, minimizzava la razza nella sua analisi e si concentrava sull’oppressione che si verificava all’estero, trascurando, per esempio, il fatto che il movimento per i diritti civili sta ancora continuando in patria). Il veterano della pace bianco ha risposto in modo estremamente condiscendente e offensivo alle critiche, chiamando addirittura l’attivista nero “ragazzo” e sostenendo che il movimento pacifista è così bianco perché le persone razzializzate “non hanno ascoltato, non hanno insegnato quando hanno imparato, non hanno predicato dal loro pulpito... non sono state in grado di collegarsi al nostro movimento per portare giustizia a tutti i popoli dell’America Latina, che comprende milioni di persone razzializzate”. Ha concluso la stessa e-mail insistendo sul fatto che la lotta contro l’ingiustizia “non ha colore”.
[51] Rev. Dr. Martin Luther King Jr., intervista di Alex Haley, Playboy, gennaio 1965. http://www.playboy.com/arts-entertainment/features/mlk/index.html.
[52] Malcolm X, citato in Abu-Jamal, Vogliamo la libertà, 41. Per approfondire l’analisi di Malcolm X, allora cruciale, si veda George Breitman, ed., Malcolm X Speaks (New York: Grove Press, 1965).
[53] Tani and Sera, False Nationalism, 106.
[54] Abu-Jamal, Vogliamo la libertà, 262.
[55] Le accuse di coinvolgimento del governo nell’assassinio di Malcolm X sono presentate in modo convincente da George Breitman, Herman Porter e Baxter Smith in The Assassination of Malcolm X (New York: Pathfinder Press, 1976).
[56] Ward Churchill e Jim Vander Wall, The COINTELPRO Papers: Documents from the FBI’s Secret Wars Against Dissent in the United States (Cambridge: South End Press, 1990)
[57] So che personalmente, nonostante fossi interessato alla storia e avessi frequentato corsi di storia degli Stati Uniti di livello avanzato durante i miei anni in alcune delle migliori scuole pubbliche della nazione, mi diplomai sapendo ben poco di Malcolm X, se non che fosse un musulmano nero “estremista”. Tuttavia, già alle scuole elementari sapevo un po’ di più di King. Per essere onesti, Malcolm X è una figura importante, se non di più, per i diritti civili e i movimenti di liberazione delle persone nere quanto King. Negli anni successivi, la mia educazione politica nei circoli progressisti bianchi non riuscì a correggere né l’oscuramento di Malcolm X né l’agiografia fuorviante di King. Solo dopo aver letto l’importanza di Malcolm X negli scritti dellɜ attivistɜ nerɜ, iniziai a fare ricerche necessarie per capire come si fosse sviluppato il movimento di liberazione.
[58] Darren Parker, e-mail all’autore, 10 luglio 2004.
[59] Si consideri la popolarità, ad esempio, della seguente citazione: “Quello che questɜ bianchɜ non capiscono è che lɜ negrɜ che si ribellano hanno rinunciato all’America. Quando non si fa nulla per alleviare la loro situazione, questo non fa che confermare la convinzione dellɜ negrɜ che l’America sia una società irrimediabilmente decadente”. Martin Luther King Jr., “Un testamento di speranza” in James Melvin Washington, ed., A Testament of Hope: The Essential Writings of Martin Luther King, Jr. (San Francisco; Harper & Row, 1986), 324.
[60] Questo sentimento, sebbene sia stato espresso da molte persone diverse, mi viene più direttamente da Roger White, Post Colonial Anarchism (Oakland: Jailbreak Press, 2004). White si occupa principalmente della frequente tendenza dellɜ anarchichɜ bianchɜ a rifuggire i movimenti di liberazione nazionale perché non conformi a una particolare ideologia anarchica. La dinamica è simile a quella creata dal pacifismo, che ho descritto, ed entrambe sono più funzioni della bianchezza che di una particolare ideologia. Il pacifismo è stato un ostacolo che ha permesso allɜ radicali bianchɜ di controllare o sabotare i movimenti di liberazione, ma non è affatto l’unico. Il libro di White merita di essere letto, proprio perché lɜ anarchichɜ bianchɜ militanti incontrano molti degli stessi problemi dellɜ pacifistɜ bianchɜ.
[61] Tani e Sera, False Nationalism, 134-137.
[62] Ibid., 137-161.
[63] Abu-Jamal, Vogliamo la libertà, 7.
[64] Email personale all’autore, dicembre 2003.
[65] David Cortright, “The Power of Nonviolence”, The Nation, 18 febbraio 2002, http://www.thenation.com/doc/.%0A%0920020218/cortright. Questo articolo attribuisce una citazione di una sola parola a Cesar Chavez, ma lascia allɜ pacifistɜ bianchɜ il compito di spiegare il significato e l’attuazione delle strategie nonviolente.
[66] Bob Irwin e Gordon Faison, Why Nonviolence? Introduction to Theory and Strategy, Vernal Project, 1978, http://www.vernalproject.org/OPapers/WhyNV/WhyNonviolence2.html.
[67] Staughton Lvnd e Alice Lynd, Nonviolence in America: A Documentary History (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995).
[68] Parole dette a quel tempo dallɜ organizzatrici bianchɜ. Riportato su Ward Churchill, Pacifism as Pathology, 60-62.
[69] Art Gish, “Violenza/Nonviolenza” (discussione di gruppo, Conferenza anarchica nordamericana, Athens, OH, 13 agosto 2004).
[70] Tani e Sera, False Nationalism, 101-102.
[71] Belinda Robnett, How Long? How Long? African-American Women in the Struggle for Civil Rights (Oxford: Oxford University Press, 1997), 184- 186
[72] Kristian Williams, Our Enemies in Blue (Brooklyn: Soft Skull Press, 2004), 87.
[73] Ibid., 266.
[74] Keith McHenry, e-mail, servizio email internazionale di Food Not Bombs, 20 aprile 2006.
[75] Frantz Fanon, I dannati della Terra (Einaudi, 2007), 86.
[76] Ibid., 94.
[77] Darren Parker, e-mail all’autore, 10 luglio 2004.
[78] Churchill e Vander Wall, Agents of Repression, 188.
[79] Alcunɜ dellɜ attivistɜ nonviolentɜ più impegnatɜ negli Stati Uniti hanno affrontato torture e omicidi nel corso del lavoro di solidarietà in America Latina. Ma non è la stessa cosa di ciò che affrontano lɜ attivistɜ razzializzatɜ negli Stati Uniti, dato che questɜ attivistɜ bianchɜ hanno affrontato la violenza in una situazione che hanno cercato e non imposta a loro, alle loro famiglie e alle loro comunità. Dopo tutto, è molto più facile avere il complesso del martire per se stessɜ che per la propria famiglia. (il che non vuol dire che tuttɜ questɜ attivistɜ fossero motivatɜ da un tale complesso, anche se di certo ne ho conosciutɜ alcunɜ che hanno sfruttato questo rischio per affermare di aver vissuto un’oppressione pari a quella subita dalle persone razzializzate).
[80] Churchill, Pacifism as Pathology, 60-61.
[81] David Gilbert, No Surrender: Writings from an Anti-Imperialist Political Prisoner (Montreal: Abraham Guillen Press, 2004), 22–23.
[82] Alice Woldt, citata in Chris McGann, “Peace Movement Could Find Itself Fighting Over Tactics,” Seattle Post-Intelligencer, February 21, 2003, http://seatrlepi.nwsource.com/local/109590_peacemovement21.shtml.
[83] E-mail all’autore, ottobre 2004. Questo stesso attivista ha riscritto paternalisticamente la storia della liberazione nera per dichiarare che le Pantere Nere non sostenevano la violenza. Nella stessa e-mail, citava l’Arte della guerra di Sun Tzu per per sostenere la sua tesi e migliorare la sua raffinatezza tattica. Che Sun Tzu sia stato d’accordo con l’utilizzo delle sue teorie utilizzate in un’argomentazione a favore dell’efficacia del pacifismo è quantomeno discutibile.
[84] E-mail all’autore, ottobre 2004.
[85] David Dellinger, “The Black Rebellions”, in Revolutionary Nonviolence: Essays by David Dellinger (New York: Anchor, 1971), 207. Nello stesso saggio, Dellinger ammette che “ci sono occasioni in cui coloro che agiscono in modo nonviolento devono diventare alleatɜ riluttanti o sostenitrici critichɜ di coloro che ricorrono alla violenza”.
[86] Gilbert, No Surrender, 23.
[87] Abu-Jamal, Vogliamo la libertà, 76.
[88] Belinda Robnett sottolinea che, diventando più militanti e adottando l’ideologia del Black Power, gruppi precedentemente nonviolenti come l’SNCC “portarono lɜ sostenitrici finanziarie liberali [presumibilmente in maggioranza bianchɜ] a smettere di contribuire”. Questa perdita di finanziamenti mainstream portò in parte al collasso dell’organizzazione (Robnett, How Long? 184-186). Robnett, tuttavia, equipara l’abbandono della nonviolenza al maschilismo. Riflettendo il suo status accademico (come professoressa di sociologia dell’Università della California), sfuma la linea di demarcazione tra i provocatori pagati dall’FBI che sostengono il sessismo all’interno del movimento (ad esempio, Ron Karenga) e lɜ attivistɜ legittimɜ che sostengono una maggiore militanza, o gli attivisti legittimi che, di fatto, confondevano la militanza con il machismo. L’autrice cita anche il fatto che Angela Davis si lamentava di essere criticata dai militanti nazionalisti neri “perché faceva un lavoro da uomo” (Robnett, How Long? 183), ma omette di dire che la Davis era molto influente nel sostenere la lotta militante. Robnett sembra anche trascurare di menzionare quanto sia problematico quando gruppi con programmi radicali come l’uguaglianza razziale non sono autosufficienti e si affidano invece al sostegno del governo federale e di donatori bianchi.
[89] Il 9 febbraio 2006, un membro del gruppo nonviolento SOA Watch (che attira il sostegno di una serie di persone, dalle progressiste alle anarchiche) ha suggerito in una lista di e-mail che, poiché negli ultimi anni la polizia si è occupata con maggiore aggressività della manifestazione annuale davanti a Fort Benning, in Georgia, il gruppo avrebbe dovuto spostare la manifestazione in un luogo pubblico lontano dalla base militare per evitare scontri. Ha scritto: “Ovunque ci sia polarizzazione, è tempo, a mio avviso, che la campagna per la pace rivaluti le sue tattiche. Le relazioni sono al centro della costruzione della pace. Il “Noi” e il “Loro” possono portare alla guerra. Il “noi” ha maggiori possibilità di raggiungere soluzioni negoziabili (nonviolente) e può portare, in ultima istanza, a una cultura della pace.
[90] In un esempio recente, i volantini distribuiti a migliaia di persone durante le proteste contro la Convention Nazionale Repubblicana del 2004 sostenevano che chiunque sostenesse la violenza fosse probabilmente un agente di polizia.
[91] Churchill e Vander Wall, Agents of Repression, 94-99, 64-77. Nel caso di Jonathan Jackson, sembra che l’FBI e la polizia avessero istigato l’intero colpo nel tentativo di assassinare le Pantere californiane più militanti. Incoraggiarono un sequestro di ostaggi al tribunale della contea di Marin, ma solo perché si prepararono con una squadra di tiratori scelti per neutralizzare lɜ militanti. Tuttavia, “non abboccare all’esca” (questa frase è usata come se tuttɜ lɜ sostenitrici della militanza fossero provocatricɜ. Un’accusa pericolosa e potenzialmente violenta che è stata rivolta a moltɜ) non terrà nessunə al sicuro. L’informatore dell’FBI William O’Neal incoraggiò le Pantere dell’Illinois – in cui si era infiltrato – a partecipare a complotti bizzarri come l’ottenimento di gas nervino o di un aereo per bombardare il municipio. Anche quando desistettero dal farlo, l’FBI procedette ad assassinare comunque il leader delle Pantere Fred Hampton.
[92] Due ottimi libri sulla repressione COINTELPRO sono Agents of Repression di Churchill e Vander Wall e Vogliamo la libertà di Abu-Jamal. Su una repressione simile all’estero, leggere William Blum, Killing Hope: US Military and CIA interventions since World War II (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995).
[93] La repressione dell’ELF, definita Green Scare [La Paura Verde], e l’incarcerazione dellɜ attivistɜ di Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) furono ampiamente riportate dai media radicali e ambientalisti. Si veda, ad esempio, Brian Evans, “Two ELF Members Plead Guilty to 2001 Arson”, Asheville Global Report, no. 404 (12 Ottobre 2006): http://www.agrnews.org/section=archives&caUd=48&article_id=1296; e “The SHAC 7”, http://www.shac7.com/case.htm.
[94] Il 3 maggio 2006, una ricerca negli archivi di due siti web di media indipendenti di sinistra non militanti – Common Dreams e AlterNet – ha rivelato la disparità prevista. Ho cercato due frasi, “Centro Thomas Merton” e “Filiberto Ojeda Rios”. La prima ricerca riguardante il Centro Thomas Merton per la Pace e la Giustizia, uno degli obiettivi di una campagna relativamente poco invasiva con cui l’FBI ha sorvegliato i gruppi pacifisti come rivelato dalle indagini dell’ACLU all’inizio del 2006, ha restituito 23 articoli su Common Dreams e cinque su AlterNet. La ricerca su Filiberro Ojeda Rios, ex leader dei Macheteros, un gruppo del movimento indipendentista portoricano, assassinato dall’FBI il 23 settembre 2005 ha trovato un articolo su Common Dreams e zero su AlterNet. Sebbene poche persone sul continente si siano mostrate preoccupate, decine di migliaia di portoricanɜ hanno marciato a San Juan per protestare contro la sua uccisione. Questi due siti web contenevano un numero considerevolmente inferiore di articoli sulle ondate di violenti raid dell’FBI contro lɜ attivistɜ indipendentistɜ portoricanɜ che si sono verificate nel febbraio 2006 rispetto alla rivelazione, resa pubblica più o meno nello stesso periodo, che l’FBI in Texas stava spiando il gruppo prevalentemente bianco Food Not Bombs come parte delle sue attività antiterrorismo. Per la copertura mediatica sullo spionaggio dellɜ attivistɜ pacifistɜ bianchɜ, si veda “Punished for Pacifism”, Democracy Now, Pacifica Radio, 15 marzo 2006. Per la copertura dell’assassinio da parte dell’FBI e delle successive incursioni a Porto Rico, si veda “30 settembre Newsbriefs” (2005) e “28 febbraio Newsbriefs” (2006) su SignalFire, www.signalfire.org. Entrambi gli eventi sono stati coperti da Indymedia Puerto Rico (ad esempio, CMI-PR, “Fuerza Bruta Imperialista Allana Hogar de Compañera, Militantes Boricuas le Dan lo Suyo”, Indymedia Puerto Rico, 10 febbraio 2006, http://pr.indymedia.org/news/2006/02/13197.php).
[95] Abu-Jamal, Vogliamo la libertà, 262–263
[96] Churchill and Vander Wall, Agents of Repression, 364.
[97] Federal Bureau of Investigation, FBI Intelligence Bulletin No. 89 (October 15, 2003). Disponibile online all’indirizzo http://www.signalfire.org/resources/FBImemo.pdf.
[98] Ibid.
[99] Greg White, “US Military Planting Stories in Iraqi Newspapers,” Asheville Global Report, no. 360 (December 7, 2005):http://www.agrnews.org/?section=archives&cat_id10&article_id=194.
[100] Fanon, I dannati della terra, 61–62.
[101] William Cran, 88 Seconds in Greensboro, Frontline, PBS, 24 gennaio1983.
[102] “La Legione americana dichiara guerra al movimento per la pace”, Democracy Now, Pacifica Radio, 25 agosto 2005. Alla convention nazionale della Legione Americana nel 2005, l’organizzazione (che conta 3 milioni di persone) decise di usare tutti i mezzi necessari per porre fine alla “protesta pubblica” ed assicurare “l’appoggio congiunto” della popolazione statunitense alla guerra al terrorismo.
[103] Durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, la Legione Americana fu un’importante forza paramilitare che aiutò il governo a reprimere lɜ attivistɜ contrariɜ alla guerra e lɜ sindacalistɜ, in particolare lɜ Wobblies (IWW, Industrial Workers of the Labour). Nel 1919, a Centralia, Washington, castrarono e linciarono Wesley Everest dell’IWW.
[104] Glenn Thrush, “Protest a ‘Privilege,’ Mayor Bloomberg Says,” NY Newsday, 17 agosto 2004, http://www.unitedforpeace.org/article.php?id=2557. Mentre commentava le proteste contro la Convention Nazionale Repubblicana del 2004 a New York, il sindaco Bloomberg definì la libertà di parola un privilegio che può essere tolto nel caso se ne abusi. Ci sono numerosi altri episodi di funzionari così schietti e un’intera cronologia di episodi di negazione della libertà di parola e di altri diritti civili da parte del governo quando questi interferissero con il buon funzionamento dell’autorità.
[105] Ciò include anche le restrizioni legislative alla “libertà di parola”, dagli Alien and Sedition Acts del 18° secolo all’Espionage Act della Prima Guerra Mondiale; poteri istituzionali come la capacità dei governatori o del presidente di dichiarare la legge marziale, o i poteri di emergenza della FEMA e attività discrezionali come le attività di sorveglianza e neutralizzazione da parte dell’FBI ai sensi del COINTELPRO o dell’USA PATRIOT Act.
[106] Jennifer Steinhauer, “Just Keep It Peaceful, Protesters; New York Is Offering Discounts,” New York Times, 18 agosto 2004.
[107] Allan Dowd, “New Protests as Time Runs Out for WTO,” The Herald (Glasgow), December 3, 1999, 14.
[108] Cortright, “The power of Nonviolence”. Mi sono imbattuto in questo articolo in forma di fotocopia distribuita ed elogiata da una persona autodefinitasi pacifista anarchicə.
[109] Churchill and Vander Wall, Agents of Repression, 281–284.
[110] Ibid., 285.
[111] Alcunɜ potrebbero sostenere che un movimento rivoluzionario misogino o razzista non potrebbe usare il diritto all’autodeterminazione come scusa. Le ovvie contro-argomentazioni sono che a) equiparare l’autodifesa con la misoginia o il razzismo non equivale certo a una posizione morale; b) considerare la violenza come un’attività immorale è semplicistico e impreciso. Sottomettersi alla violenza dell’oppressione è ripugnante almeno quanto uccidere i propri oppressori (se la nostra moralità ci impone di considerare l’uccisione degli schiavisti come un atto ripugnante), e lɜ privilegiatɜ nonviolentɜ traggono vantaggio dalla violenza dell’oppressione, diventando quindi complici. Pertanto, la pretesa dellɜ pacifistɜ di condannare legittimamente la violenza dellɜ oppressɜ con lɜ quali altrimenti potrebbero allearsi è sciocca e ipocrita.
[112] Irwin and Faison, Why Nonviolence?, 7, 9.
[113] Cortright, The Power of Nonviolence.
[114] Per saperne di più sull’evoluzione della visione dello stato in materia di controllo sociale, si veda Williams, Our Enemies in Blue.
[115] Ci furono alcuni casi minori di resistenza contro la polizia, ma venne fatto tutto in ritirata. Lɜ anarchichɜ avevano interiorizzato l’idea che solo la polizia potesse iniziare la violenza, quindi se avessero combattuto, sarebbe stato solo in caso di fuga. Per una buona raccolta di informazioni sulle proteste anti-FTAA a Miami, in particolare per quanto riguarda gli effetti traumatizzanti su moltɜ manifestanti, si veda The Miami Mode! A Guide to the Events Surrounding the FTAA Ministerial in Miami, November 20-21, 2003 (pubblicazione e distribuzione decentrata, 2003). Per ulteriori informazioni, scrivere a theresonlynow@hotmail.com.
[116] Wolfi Landstreicher, “Autonomous Self-Organization and Anarchist Intervention,” Anarchy: A Journal of Desire Armed, no. 58 (Autunno-inverno2004): 56. Le due citazioni seguenti nel paragrafo provengono dalla stessa pagina. Landstreicher consiglia Albania: Laboratory of Subversion (London: Elephant Editions, 1999). Disponibile online a http://www.endpage.com/Archives/Mirrors/Class_Against_Class/albania.html.
[117] Fanon, I dannati della terra, 124.
[118] Per approfondimenti sul patriarcato sono consigliabili le opere di bell hooks e quelle di Kate Bornstein (Gender Outlaw) e Leslie Feinberg (Transgender Warriors). In più, da un punto di vista storico e antropologico, The Creation of Patriarchy di Gerda Lerner (New York: Oxford University Press, 1986) ha delle ottime fonti, seppur si limiti ad un punto di vista binario del genere, accettandolo come naturale e quindi ignorando il primo e più importante passo nella creazione del patriarcato, ovvero l’istituzione di due rigide categorie. Altre fonti che correggono questa omissione si possono individuare in Representations of Gender from Prehistory to Present di Moira Donald e Linda Hurcombe.
[119] L’ultima strategia è stata applicata con successo nel corso della storia da numerose società anti-autoritarie, incluso l’attuale popolo Igbo della Nigeria. Vedi “ ‘Sitting on a Man’, Colonialism and the Lost Political Institutions od Igbo Women” di Judith Van Allen — Canadian Journal of African Studies, vol.2 (1972):211-219.
[120] Per approfondimenti sulla giustizia restauratrice, una modalità di inflizione del danno attraverso un approccio guaritore e di riconciliazione (perciò un concetto di giustizia adatto per confrontarsi con i numerosi “crimini” radicati nel patriarcato), vedi Battering of Women: The Failure of Intervention and the Care of Prevention di Larry Tifft (Boulder: Westview Press, 1993) e Restorative Justice: Healing the Foundations of Our Everyday Lives di Dennis Sullivan e Larry Tifft (Monsery, NY: Willow Tree Press, 2001).
[121] bell hooks, in alcuni suoi libri, fa fronte ad analisi più complesse che trattano della violenza sulle donne, come in La volontà di cambiare. Mascolinità e amore (Il Saggiatore, 2022). Tuttavia, la violenza di cui parla hooks non è politica e non si scontra consapevolmente contro chi veicola il patriarcato, ma è piuttosto un impulsivo trasferimento d’abuso rivolto a bambinɜ ed altrɜ in posizioni inferiori nella gerarchia sociale. Questo è un esempio di vero ciclo di violenze che lɜ pacifistɜ ritengono essere l’unica forma di violenza. E mentre tutte le esperienze traumatiche di violenza si ripetono (cioè quelle oggetto di continue e successive ramificazioni nelle quali le persone provano con fatica ad individuarne e combatterne l’origine) lɜ attivistɜ affermano che tutte le gerarchie violente sono tenute insieme da schieramenti sistemici che si muovono verso una posizione inferiore, gli ideatori che devono essere neutralizzati. Ma il mondo non è un parco giochi a livelli dove la violenza si riflette omogenea, influenzando in egual modo le persone sullo stesso livello in termini di poteri e responsabilità. Per essere più specifico, se le donne organizzassero collettivamente di attaccare e opporsi agli stupratori, verrebbero prevenuti specifici casi di stupro, il trauma delle violenze passate verrebbe esorcizzato in modo costruttivo e agli uomini verrebbe negata l’opzione di stuprare senza rimanere impuniti, scoraggiando così future molestie. Oppure, come altro esempio, cittadinɜ nerɜ o latinoamericanɜ che organizzano attacchi alle autorità poliziesche non diverrebbe incentivo di una serie di violenze da parte delle forze dell’ordine. La polizia non uccide persone razzializzate per via dei traumi di violenze passate; lo fanno perché il sistema suprematista bianco lo richiede e perché vengono pagati per farlo. Un’attività di rivoluzione risulterà in un aumento di uno stato di repressione, ma questo è un ostacolo che deve essere superato per raggiungere la distruzione dello stato, il più grande veicolo di violenza. Dopo la sua distruzione e quella del capitalismo e delle strutture patriarcali, le persone saranno ancora traumatizzate e avranno ancora posizioni autoritarie e patriarcali, ma i singoli problemi che non vengono rafforzati da strutture esterne possono essere affrontati in cooperazione. Gli eserciti non devono esistere.
[122] Per esempio, in Il demone amante: sessualità della violenza (Vanda Edizioni, 2022) di Robin Morgan. L’opuscolo di The Rock Block Collective, Stick it to the Manarchy (Pubblicazione e distribuzione decentralizzate, 2001), fa delle valide osservazioni critiche verso il machismo dei circoli di anarchici bianchi, ma definisce anche la militanza stessa come maschilista, considerando donne e altri gruppi oppressi e razzializzati troppo fragili per partecipare alle rivoluzioni violente.
[123] Against the Masculinization of Militancy di Laina Tanglewood, viene citato in Against the Corpse Machine: Defining a Post-Leftist Anarchist Critique of Violence (Pubblicazione e distribuzione decentralizzate, 2022 aprile) di Ashen Ruins. Testo completo su https://theanarchistlibrary.org/library/ashen-ruins-against-the-corpse-machine-defining-a-post-leftist-anarchist-critique-of-violence.
[124] Vedi link riportato sopra.
[125] Sue Daniels, Settembre 2004. Per altro sull’autodifesta delle donne, Daniels consiglia Real Knockouts: The Physical Feminism of Women’s Self-Defense (New York: New York University Press, 1997).
[126] The Will to Win and Self-Defense è un opuscolo anonimo distribuito dall’Anachist Black Cross di Jacksonville.
[127] Il motto “il cambiamento avviene dall’interno” non va confuso con l’autocritica. Da un punto di vista funzionale, questa filosofia inabilita le persone a sfidare il sistema e a combattere oppressioni strutturali; è analogo al significato del peccato cristiano, come una barriera di ribellione e altre azioni collettive contro le oppressioni. Nei pochi casi in cui il principio del “cambiamento dall’interno” significa più di un semplice impegno alla nonviolenza, si tratta di una forma impotente di auto-miglioramento che pretende che le oppressioni sociali siano il risultato di diffusi fallimenti della personalità che possono essere superati senza la rimozione di forze esterne. L’auto-miglioramento dellɜ attivistɜ anti-oppressione, d’altra parte, è un’ammissione del fatto che le forze esterne (cioè le strutture dell’oppressione) influenzino anche coloro che lottano contro di esse. Pertanto, affrontare gli effetti è un complemento adeguato alla lotta contro le cause. Piuttosto che agire come un complemento, l’auto-miglioramento pacifista cerca di essere un sostituto.
[128] “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” o “Incarna il cambiamento...” sono tipici slogan pacifisti che si possono trovare su cartelloni e manifesti di qualsiasi grande protesta pacifica negli USA.
[129] E-mail personale all’autore, dicembre 2003.
[130] The Power of Nonviolence di Cortright.
[131] How long? di Robnett, 87, 166, 95.
[132] La storia di Rusting Bayard, che dovette abbandonare il SCLC perchè gay, si trova in Bayard Rustin: The Troubles I’ve Seen (New York: HarperCollins Publishers, 1997) di Jervis Andersen e in From Yale to Jail: The Life Story of a Moral Dissenter (New York: Pantheon Books, 1993).
[133] Tuttavia, persone la cui strategia si basa sulla creazione di partiti oppure simili organizzazioni centralizzate, che siano pacifiste o rivoluzionarie, mantengono le distanze dall’autocritica. Ma lɜ attivistɜ rivoluzionariɜ di oggi stanno manifestando un allontanamento dai partiti politici, unioni e altre organizzazioni che nutrono interessi personali.
[134] Robett, How Long? 93-96.
[135] Abu-Jamal, Vogliamo la libertà, 159.
[136] Ibid.
[137] “An Interview with Mujeres Creando” di Julieta Paredes, in Quiet Rumors: An Anarcha-Feminist Reader, ed. Dark Star Collective (Edinburgh: AK Press, 2022), 111-112.
[138] N.d.t. Gelderloos qui parla erroneamente di Sylvia solo come drag queen, ci siamo presɜ la responsabilità di aggiungere che si trattava anche di una donna trans, punto fondamentale per comprendere interamente la storia del Gay Liberation Front.
[139] Leslie Feinberg, “Leslie Feinberg Interviews Sylvia Rivera” Workers World, 2 Luglio 1998
[140] Ann Hansen, Direct Action: Memoirs of an Urban Guerrilla, (Toronto: Between The Lines, 2002), 471.
[141] Emma Goldman, “The Tragedy of Woman’s Emancipation,” in Quiet Rumours, ed. Dark Star Collective, 89.
[142] Paul Avrich, Anarchist Portraits (Princeton: Princeton University Press, 1988), 218.
[143] Yael, “Anna Mae Haunts the FBI,” Earth First! Journal, July-August 2003: 51.
[144] Ibid.
[145] “Interview with Rote Zora,” in Quiet Rumours, ed. Dark Star Collective, 102.
[146] Ibid, 105.
[147] Sul sessismo del Weather Underground: False Nationalism di Tani e Sera e Outlaws of America: The Weather Underground and the Politics of Solidarity di Dan BErger (Oakland, CA: AK Press, 2005). Sull’opposizione delle Brigate Rosse al femminismo, considerato da loro grossista e borghese piuttosto che un abbraccio verso le sue origini radicali, vedi Chris Aronson Beck et al., Strike One to Educate One Hundred: The Rise of the Red Brigades in Italy in the 1960s-1970s (Chicago: Seeds Beneath the Snow, 1986).
[148] Carol Flinders, “Nonviolence: Does Gender Matter?” Peace Power: Journal of Nonviolence and Conflict Transformation, vol. 2, no.2 (estate 2006).; http://www.calpeacepower.org/0202/gender.htm.
[149] Ibid.
[150] Per chi non fosse familiare con il termine, con “essenzialista di genere” ci si riferisce alla considerazione del genere non come un costrutto sociale o un’utile, ma come un insieme di categorie innate dall’essenza immutabile.
[151] Flinders, “Nonviolence: Does Gender Matter?”.
[152] Patrizia Longo, “Feminism and Nonviolence: A Relational Model,” The Gandhi Institute, https://gandhiinstitute.org.
[153] “Feminism and Nonviolence Discussion,” Febbraio e Marzo 1998, http://www.h-net.org/~women/threads/ disc-nonviolence.html.
[154] Ho riscontrato questa stessa formulazione da almeno tre diversɜ attivistɜ, tra cui giovani ambientalistɜ e vecchiɜ pacifistɜ. Non so se tuttɜ abbiano preso l’idea da una fonte simile o se l’abbiano elaborata in maniera indipendente, ma questa glorificazione della capitolazione deriva essenzialmente dalla loro posizione.
[155] Stephen Bender riporta questo estratto dal libro di Bernays nel suo articolo Propaganda, Public Relations, and the Not-So-New Dark Age, LiP, inverno 2006: 25.
[156] Ibid., 26.
[157] Per approfondire la teoria della propaganda dei media, si veda Noam Chomsky e Edward Herman, La fabbrica del consenso. Ovvero la politica dei mass media (Il Saggiatore, 2008) e Noam Chomsky, Illusioni necessarie. Mass media e democrazia (Elèuthera, 2010). Mentre l’insurrezione irachena cresceva nei mesi successivi alla dichiarazione del presidente Bush che si erano concluse le principali operazioni di combattimento, alcuni funzionari della CIA e dirigenti del Pentagono iniziarono a disertare, rilasciando pubblicamente dichiarazioni che possono essere suddivise in tre temi, tutti ovviamente incentrati sulle preoccupazioni per l’egemonia statunitense: 1) l’invasione è stata mal preparata; 2) sta danneggiando la nostra immagine all’estero; e 3) sta portando le nostre forze armate a un punto di rottura.
[158] Chiunque abbia familiarità con i media indipendenti dovrebbe conoscere diversi esempi di chiusura di stazioni radio indipendenti e pirata da parte della FCC (oltre alla criminalizzazione federale delle radio indipendenti negli ultimi tempi, che ha portato all’espansione di ciò che è considerato “pirata”). Per articoli che descrivono nel dettaglio i singoli casi di repressione governativa di queste stazioni radio si veda: “Pirate Radio Station Back On San Diego Airwaves”, Infoshop News, 6 gennaio 2006 e Emily Pyle, “The Death and Life of Free Radio”, The Austin Chronicle, 22 giugno 2001. C’è anche il famoso scontro tra KPFA e Pacifica Radio, in cui la società proprietaria era il repressore in veci dello stato.
[159] Indymedia è stato un obiettivo primario di questa repressione. L’archivio del sito centrale di Indymedia (www.indymedia.org) contiene probabilmente la documentazione più completa sulla repressione statale dei vari siti di Indymedia in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, Sherman Austin, webmaster anarchico del sito rivoluzionario di successo Raise the Fist, è stato imprigionato per un anno con accuse false. Al momento della stesura di questo articolo [2007], è in libertà vigilata e gli è vietato l’uso di Internet. Il governo federale ha chiuso il suo sito web.
[160] Culture Jam di Kalle Lasn (New York: Quill, 2000) è plateale nell’ottimismo sconsiderato con cui ipotizza che la diffusione di semplici idee possa cambiare la società.
[161] A differenza dei media statali socialisti dell’URSS, che godevano di scarsa credibilità tra la loro stessa popolazione cinica, i media aziendali devono essere un sistema mediatico totale che gode dell’illusione di essere al di sopra della propaganda politica. Quindi, se le persone che si recano al lavoro vedono una protesta pacifica ma non sentono nulla di quella protesta pacifica al telegiornale, non c’è nulla di strano. Le persone al di fuori del movimento hanno bisogno di poco per essere convinte che tale protesta sia irrilevante per loro; così, i direttori dei notiziari possono fingere di rispondere alle richieste del loro pubblico. Ma se le persone che si recano al lavoro vedono una rivolta o scoprono che è esplosa una bomba fuori da una banca, e non trovano riferimenti a questi eventi nei media tradizionali, saranno propensi a guardare altrove e a chiedersi cos’altro i media stiano nascondendo. Uno dei motivi per cui il sistema democratico corporativo è un modello totalitario più efficace dello stato autoritario a partito unico è che deve rispondere a questi eventi nei media tradizionali, piuttosto che ignorarli.
[162] Lɜ anarchichɜ russɜ all’epoca della rivoluzione del 1905 finanziarono le loro massicce azioni di propaganda e di volantinaggio con espropri e rapine ai danni della classe proprietaria. Paul Avrich, Gli anarchici nella rivoluzione russa (La Salamandra, 1976), 44-48, 62. Combinando l’istruzione con le tattiche militanti, le persone altrimenti impoverite furono in grado di comprare macchine da stampa e raggiungere un pubblico di massa con le idee anarchiche.
[163] John Tutino, From Insurrection to Revolution in Mexico: Social Bases of Agrarian Violence, 1750–1940 (Princeton: Princeton University Press, 1986), 6.
[164] Fanon, I dannati della Terra, 61.
[165] Più recentemente, il SOAW ha finalmente fatto qualche passo avanti lavorando con i regimi latinoamericani. Diversi governi di sinistra in Sud America, in particolare Venezuela, Uruguay e Argentina, hanno accettato di non inviare più soldati e ufficiali alla SOA. Questo è un altro esempio di come lɜ pacifistɜ debbano affidarsi ai governi, che sono istituzioni coercitive, per raggiungere i loro obiettivi. In particolare, hanno a che fare con governi che hanno messo in discussione il “Washington Consensus” e, quindi, hanno meno interesse a far addestrare le loro truppe dagli Stati Uniti. Tuttavia, questi governi sono stati tutti attivi nel calpestare i movimenti popolari con metodi che includono la soppressione dei media dissidenti e l’uccisione dellɜ manifestanti. Poiché questi governi sono nati dalla sinistra autoritaria, hanno cooptato e frammentato la ribellione. Il risultato finale è lo stesso di quando erano più strettamente allineati con Washington: il controllo. Sarebbe utile notare che in alcuni di questi casi, in particolare in Argentina, i movimenti sociali militanti hanno svolto un ruolo importante nel rovesciare le precedenti amministrazioni allineate con gli Stati Uniti e nel permettere l’elezione di governi di sinistra.
[166] Beck A., “Strike One to Educate One Hundred,” 190–193
[167] David Graeber, Frammenti di antropologia anarchica (Elèuthera, 2020). L’anarchico e, non a caso, accademico David Graeber, suggerisce che, oltre a creare alternative sotto forma di “istituzioni internazionali” e “forme locali e regionali di autogoverno”, dovremmo privare gli stati della loro sostanza eliminando “la loro capacità di ispirare terrore” (63). Per raggiungere questo obiettivo, suggerisce di “far finta che nulla sia cambiato, consentire ai rappresentanti ufficiali dello stato di mantenere la loro dignità, persino di presentarsi nei loro uffici e compilare un modulo di tanto in tanto, ma per il resto ignorarli” (64). Curiosamente, egli offre i vaghi esempi di un paio di società del Madagascar ancora dominate e sfruttate da regimi neocoloniali come prova che questa pseudostrategia possa in qualche modo funzionare.
[168] Penny McCall-Howard, “Argentina’s Factories: Now Producing Revolution,” Left Turn, no. 7 (Ottobre/Novembre 2002); e Michael Albert, “Argentine Self Management,” ZNet, 3 Novembre 2005.
[169] Non voglio dipingere la repressione come un fattore automatico. A volte le autorità non si accorgono di qualcosa come un centro comunitario anarchico e, più spesso, scelgono di contenerlo piuttosto che smantellarlo. Ma, dura o morbida che sia, tracciano una linea di demarcazione oltre la quale non ci lasceranno passare senza lottare.
[170] Rick Rowley, La quarta guerra mondiale (Big Noise, 2003). Potete anche leggere le mie critiche al film, The Fourth World War: A Review su www.signalfire.org.
[171] Ian Traynor, “US Campaign Behind the Turmoil in Kiev,” Guardian UK, November 26, 2004, http://www.guardian.co.uk/international/story/0„1360080,00.html.
[172] Williams, Our Enemies in Blue.
[173] N.d.T. Il community policing, o COP, è una strategia di polizia che si concentra sullo sviluppo di relazioni con i membri di una comunità. Semplicemente, un agente pattuglia la stessa area per un periodo prolungato e costruisce una rapporto di fiducia (magari anche di veemenza) con lɜ cittadinɜ, in modo da identificare più facilmente i problemi e risolverli in modo collaborativo. In altre parole, è una strategia per coinvolgere le persone a fare il lavoro degli sbirri, rendendo di fatto la forza repressiva più efficiente.
[174] “I conflitti interni sono un’altra grande fonte di vulnerabilità all’interno del movimento”. Randy Borum e Chuck Tilbv, Anarchist direct actions: A Challenge for Law Enforcement, Studies in Conflict and Terrorism, n. 28 (2005): 219. Le stesse forze dell’ordine sono molto attratte da queste pugnalate tra attivistɜ.
[175] Citato in Fifth Estate, no. 370 (autunno 2005): 34.
[176] George W. Bush, “Address to a Joint Session of Congress” (speech, United States Capitol, Washington, DC,September 20, 2001); http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html
[177] Al momento in cui scriviamo [ndt. 2006], oltre una dozzina di presunti membri dell’Earth Liberation Front (ELF) e dell’Animal Liberation Front (ALF) sono stati arrestati dopo che l’FBI si è infiltrata nel movimento ambientalista radicale. Sono stati minacciati di ergastolo per semplici incendi dolosi e, sotto questa tremenda pressione, molti hanno accettato di spiare per il governo. Sei attivistɜ di Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC), un gruppo che ha condotto con successo un boicottaggio aggressivo contro un’azienda che effettuava test su animali [non umani], sono statɜ incriminatɜ nel marzo 2006 secondo l’Animal Enterprise Terrorism Act e incarcetatɜ per diversi anni. Rodney Coronado, attivista dell’ELF, indigeno di lunga data ed ex prigioniero, è stato appena rimandato in prigione solo per aver tenuto un seminario che incoraggiava l’ambientalismo radicale in cui includeva informazioni su come aveva costruito l’ordigno incendiario usato nell’attacco per il quale era già stato incarcerato.
[178] Williams, Our Enemies in Blue, 201.
[179] JH, “World War 1: The Chicago Trial,” Fifth Estate, no. 370 (fall 2005): 24.
[180] JH, “Sabotage,” Fifth Estate, no. 370 (fall 2005): 22.
[181] JH, “World War 1: The Chicago Trial,” 24.
[182] Paul Avrich, Sacco and Vanzetti: The Anarchist Background (Princeton: Princeton University Press, 1991), 153, 165.
[183] Lɜ Galleanistɜ era un gruppo di anarchichɜ incentrato su un giornale pubblicato da Luigi Galleani. Sebbene fossero influenzatɜ dall’anarchismo di Galleani, non lo nominarono leader né si diedero il suo nome. L’etichetta di “Galleanista” è principalmente un’etichetta di convenienza.
[184] Paul Avrich, Sacco and Vanzetti: The Anarchist Background, 127.
[185] Ibid., 207.
[186] Ibid., 127.
[187] Ibid., 147.
[188] Ibid., 209.
[189] Ibid., 211.
[190] Ibid., 213.
[191] Lon Savage, Thunder in the Mountains: The West Virginia Mine War, 1920–21 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990).
[192] Borum and Tilby. “Anarchist Direct Actions” 220.
[193] A gennaio 2006, l’88% dellɜ sunnitɜ in Iraq e il 41% dellɜ sciitɜ ammettevano di approvare gli attacchi contro le forze guidate dagli Stati Uniti (Editor & Publisher, “Half of Iraqis Back Attacks on US”, ristampato in Asheville Global Report, no. 369 [9-15 febbraio 2006]: http://www.agmews.org/?section=archives&cat_id=13§ion_id=10&briefs=true). È possibile che, dato il clima di repressione politica in Iraq, le percentuali reali siano più alte, ma moltɜ non hanno voluto rivelare allɜ sondaggistɜ il loro sostegno all’insurrezione. Nell’agosto 2005, l’82% dellɜ irachenɜ ha dichiarato di essere “fortemente contraria” alla presenza delle truppe di occupazione, secondo un sondaggio militare britannico segreto che è stato divulgato alla stampa. La stessa percentuale ha dichiarato di volere l’allontanamento delle truppe statunitensi dal proprio Paese in un sondaggio condotto nel maggio 2004 dalla Autorità provvisoria della coalizione (Thomas E. Ricks, “L’82% dellɜ irachenɜ si oppone all’occupazione statunitense”, Washington Post (13 maggio 2004): http://www.globalpolicy.org/ngos/advocacy/protest!iraq/2004/0513poll.htm. Tuttavia, in questi giorni è difficile parlare di resistenza irachena, perché i media occidentali ci fanno credere che i bombardamenti settari sullɜ civili siano l’unica cosa in corso. Esiste la forte possibilità che questi bombardamenti siano orchestrati dagli occupanti, anche se dalla nostra attuale posizione non possiamo sapere cosa stia succedendo nella resistenza. Basti dire che la maggior parte dei gruppi di resistenza iracheni ha preso posizione contro l’uccisione di civili, ed è a questi gruppi che mi riferisco. Ho scritto di più sulla possibilità di un coinvolgimento degli Stati Uniti nelle uccisioni settarie in “An Anarchist Critique of the Iraq War”, disponibile su www.signalfire.org.
[194] Martin Oppenheimer, The Urban Guerrilla (Chicago: Quadrangle Books, 1969), 141–142.
[195] Michael Nagler, The Steps of Nonviolence (New York: The Fellowship of Reconciliation, 1999), Introduzione. Qualsiasi cosa diversa dalla nonviolenza viene dipinta come il risultato di “paura e rabbia... emozioni potenzialmente dannose”.
[196] Irwin a Faison, Why Nonviolence?
[197] Ibid.
[198] Tani e Sera, False Nationalism, 167.
[199] George Jackson, Con il sangue agli occhi. Lettere e scritti dal carcere (Agenzia X, 2008).
[200] Abu-Jamal, Vogliamo la libertà, 105.
[201] Kuwasi Balagoon, A Soldier’s Story: Writings of a Revolutionary New Afrikan Anarchist (Montreal: Solidarity, 2001), 28, 30, 72. Link al testo completo: https://theanarchistlibrary.org/library/kuwasi-balagoon-a-soldier-s-story.
[202] Fanon, I dannati della terra, 249–251.
[203] “La resistenza attiva si verifica quando lɜ attivistɜ usano la forza contro la polizia... o si impegnano proattivamente in attività illegali come vandalismo, sabotaggio o danni alla proprietà”. Questa frase appare in Borum e Tilby, “Anarchist Direct Actions”, 211. Gli autori, uno professore e l’altro ex capo della polizia, includono i sit-in e simili come resistenza passiva.
[204] Mi riferisco ai black bloc come tattica militante, non ai blocchi di moda punk che si vestono di nero ma alla fine agiscono passivamente. I veri black bloc stanno diventando meno comuni negli Stati Uniti.
[205] Spruce Houser, “Violenza/Nonviolenza”. Houser è un autoproclamato anarchico e pacifista.
[206] Houser, “Domestic Anarchist Movement Increasingly Espouses Violence,” http://athensnews.com/in-%0A%09dex.php?action=viewarticle§ion=archives&story_id=17497. Da vero pacifista, Houser ha inviato il suo articolo all’Athens News in preparazione dell’imminente Conferenza anarchica nordamericana, nel tentativo di sostenere il pacifismo, rivolgendo l’opinione pubblica locale contro lɜ “anarchichɜ violentɜ”. Egli protesta docilmente per il fatto che il suo articolo sia stato trasformato dai media aziendali in propaganda contro l’intero movimento anarchico con una nota scritta a mano, scarabocchiata sulle numerose fotocopie dell’articolo che ha distribuito, in cui si afferma che il titolo originale era “Anarchismo e violenza”, ma l’editore l’aveva cambiato
[207] Burt Green, “The Meaning of Tiananmen,” Anarchy: A Journal of Desire Armed, no. 58 (Autunno-Inverno 2004): 44.
[208] Judith Kohler, “Suore contro la guerra condannate a due anni e mezzo”, Associated Press, 25 luglio 2003. Non rimprovero a nessunǝ dell’uso di qualsiasi strategia processuale che ritenga appropriata, ma, in questo caso, l’argomentazione delle suore riflette sinceramente il fatto che non hanno causato alcuna distruzione reale e fisica all’impianto missilistico, mentre avevano certamente l’opportunità di causarla.
[209] Una terza possibile definizione potrebbe cercare di tracciare una linea, basata sul buon senso, attraverso i potenziali candidati alla violenza. Se vivessimo in un’economia politica basata sui bisogni, il buon senso riconoscerebbe il bisogno delle persone di difendersi e di vivere libere dall’oppressione; quindi, l’azione rivoluzionaria per raggiungere l’obiettivo di una società in cui tuttɜ possano soddisfare i propri bisogni non potrebbe essere considerata violenta. Poiché viviamo in una società in cui il nostro concetto di giustizia si basa sulla punizione, significa che il comportamento delle persone giuste consiste nell’evitare la trasgressione, il buon senso riconosce che pagare le tasse (ad uno stato imperialista) è nonviolento, mentre pagare un assassino su commissione è considerato violento. Sebbene entrambe le azioni abbiano risultati simili, è certamente più facile aspettarsi che le persone non commettano la seconda azione (che richiede di prendere l’iniziativa) e permettere loro di commettere la prima azione (che è solo assecondare il flusso). In una società di questo tipo (per esempio la nostra), il pacifismo è davvero un passivismo, perché non commettere violenza ha più a che fare con l’evitare la colpevolezza piuttosto che assumersi la propria responsabilità.
[210] Todd Allin Morman, “Revolutionary Violence and the Future Anarchist Order,” Social Anarchism, no. 38 (2005): 30–38.
[211] Ibid. 34.
[212] Ibid., 35.
[213] Fanon, I dannati della Terra, 306.
[214] Churchill and Vander Wall, Agents of Repression, 103–106.
[215] Questo è quanto ha consigliato l’anarchico accademico Howard Ehrlich nel suo discorso di apertura alla Conferenza anarchica nordamericana ad Athens, Ohio, 14 agosto 2004.
[216] Citato in un videoclip incluso in Sam Green e Bill Siegel, regista/produttore, The Weather Underground (The Free History Project, 2003). Per quanto riguarda la flessibilità dell’impegno di Gandhi verso la nonviolenza, le sue parole sulla resistenza palestinese sono istruttive: “Vorrei che avessero scelto la via della nonviolenza nel resistere a ciò che giustamente considerano un’inaccettabile invasione del loro Paese. Ma secondo i canoni accettati del giusto e dell’ingiusto, non si può dire nulla contro la resistenza araba di fronte a probabilità schiaccianti”. Jews for Justice in the Middle East, The Origin of the Palestine-Israel Conflict, 3m ed. (Berkeley: Jews for Justice in the Middle East, 2001). Gli autori citano Martin Buber e Paul R. Mendes-Flohr, A Land of Two Peoples (New York: Oxford University Press, 1983).
[217] Lɜ attivistɜ nonviolentɜ si affidano spesso ai media per diffondere il loro punto di vista. Ho già citato diversi esempi che riguardano le proteste. Un altro esempio: Il 31 gennaio 2006, un’attivista di un internet service del presunto gruppo radicale antiautoritario Food Not Bombs ha postato un suggerimento per un’azione durante il discorso sullo stato dell’Unione del Presidente Bush. Il suggerimento prevedeva che migliaia di persone cercassero su Google la frase “Impeach Bush” durante il suo discorso. Si supponeva che i media aziendali avrebbero colto questo fatto e iniziato a pubblicizzarlo piuttosto che la loro tipica analisi superficiale di quanto Bush si sia presentato bene nel suo discorso. Inutile dire che non è successo nulla di tutto ciò.
[218] Malcolm X disse questo sulle nozioni gandhiane di fratellanza e amore universali: “La mia fede nella fratellanza non mi impedirebbe in alcun modo di proteggermi da un popolo la cui mancanza di rispetto per la fratellanza lo fa sentire incline a mettere il mio collo su un albero alla fine di una corda”. Perry, Malcolm X: gli ultimi discorsi, 88.
[219] Ad esempio, i miei compagni di carcere erano conservatori nel condannare il “cecchino di Washington” e addirittura speravano che il colpevole ricevesse la pena di morte. Ma quando un agente dell’FBI fuori servizio si aggiunse alla lista delle vittime del cecchino tutti espressero un’immensa soddisfazione.
[220] Ashen Ruins, Against the Corpse Machine. 31. Fanon, I dannati della Terra, 54.
[221] Due ottimi esempi sono Stephen Salisbury e Mark Fineman. The Philadelphia Inquirer, vol.305 no.121, 8 novembre, 1981, A1. Nei primi sei paragrafi dell’articolo sono tutti dedicati a Joseph Bowen e la sua esperienza nel Buco, con numerose citazioni di Bowen e descrizioni personalizzate che lo ritraggono mentre parla – chi legge viene così portatǝ in prigione proprio accanto a lui. L’ottavo paragrafo inizia così: “Ma Joseph Bowen ha anche costretto i negoziatori – e quindi il mondo delle strade – a vedere qualcosa di più di un tre volte assassino con un nuovo potere. Attraverso il negoziatore Chuck Stone e i media che hanno coperto ogni sfumatura dei suoi cinque giorni di assedio, Bowen ha anche costretto il mondo esterno a confrontarsi con la realtà di un altro mondo – un mondo di istituzioni che lui e migliaia di altri detenuti in Pennsylvania percepiscono come oppressive e razziste, che derubano gli esseri umani non solo della loro dignità, ma, a volte, della loro vita”.
[222] Chuchill, Pacifism as Pathology, 70-75.
[223] Per confermare la prevalenza di questa mentalità tra i pacifisti anti-SOA e per sentire ripetere ad nauseam queste assurde affermazioni, basta partecipare alla veglia annuale davanti a Fort Benning, sede della SOA.
[224] Mangiare carne e pagare le tasse sono forse semplici da spiegare. La ricerca sulla produzione di alluminio (e la conseguente costruzione di dighe idroelettriche), le condizioni delle autofficine, l’inquinamento atmosferico causato dalla combustione interna, il livello di incidenti mortali causati dalla cultura dell’auto e il modo in cui i Paesi industrializzati si procurano il petrolio riveleranno perché guidare un’auto è un’attività violenta, tanto che non possiamo prendere sul serio un pacifista morale che guida un’auto. Mangiare tofu, nell’economia attuale, è strettamente legato all’uso di manodopera immigrata usa e getta, alle modifiche genetiche della soia e alla conseguente distruzione degli ecosistemi, delle culture alimentari e alla capacità degli Stati Uniti di minare le culture agricole di sussistenza in tutto il mondo, alimentando la globalizzazione con la minaccia e la realtà della fame. Pagando l’affitto si sostengono i proprietari di immobili che getteranno una famiglia per strada se non è in grado di pagare in tempo, che investono in uno sviluppo ecocida e in un’espansione urbana e che contribuiscono alla gentrificazione delle città, con la conseguente violenza contro i senzatetto, le persone razzializzate e le famiglie a basso reddito. Essere gentili con un poliziotto contribuisce alla cultura masochista del culto che permette agli agenti della legge e dell’ordine di picchiare e assassinare le persone con la forza. È una particolarità storica sorprendente che permette alla polizia di godere di un ampio sostegno popolare, e persino di considerarsi degli eroi, quando un tempo erano ben noti come feccia e lacchè della classe dirigente.
[225] Fanon, I dannati della terra, 54.
[226] “Siamo in guerra...” Art Burton (discorso programmatico, People United, Afton, VA, 19 giugno 2004). Burton era un membro della NAACP di Richmond. Lɜ zapatistɜ descrivono l’attuale ordine mondiale come la Quarta Guerra Mondiale, e questo sentimento è stato ripreso in tutto il mondo.
[227] Helen Woodson e il mio ex compagno di cella Jerry Zawada sono due esempi di persone che mi vengono in mente come pacifistɜ rivoluzionariɜ.
[228] Sebbene questa particolare citazione sia stata formulata da me, l’argomento che rappresenta proviene spesso dalla bocca di attivistɜ nonviolentɜ. Todd Allin Morman inizia il suo articolo “Revolutionary Violence and the Future Anarchist Order” (La violenza rivoluzionaria e il futuro ordine anarchico) sottolineando che nessuna delle rivoluzioni violente negli Stati Uniti, in Russia, in Cina o a cuba “ha portato a una società giusta, a una società libera o addirittura a un ‘paradiso dei lavoratori’” (30).
[229] Sto giudicando le motivazioni dei leninisti in base agli obiettivi e alle azioni dei loro leader – in quanto membri di un’organizzazione autoritaria, i ranghi e le file dimostrarono di dare priorità ai leader rispetto alle proprie intenzioni, buone o cattive che fossero. Gli obiettivi e le azioni della leadership leninista, fin dall’inizio, comprenderono il miglioramento e l’espansione della polizia segreta zarista, ricostituita come Cheka; la conversione forzata di milioni di contadinɜ indipendenti in lavoratricɜ salariatɜ; il blocco del baratto diretto tra produttricɜ; l’istituzione di rigide gerarchie salariali tra ufficiali e soldati zaristi; l’assunzione dell’esercito, composto in gran parte da ex ufficiali zaristi, la presa di controllo, la centralizzazione e, infine, la distruzione dei “soviet” o consigli operai indipendenti; la ricerca e l’accettazione di prestiti per lo sviluppo da parte dei capitalisti britannici e americani; la contrattazione e la collaborazione con le potenze imperialiste alla fine della Prima guerra mondiale; la repressione dell’attivismo e delle pubblicazioni di anarchichɜ e social-rivoluzionariɜ; e altro ancora. Si veda Alexander Berkman, The Bolshevik Myth (London: Freedom Press, 1989), Alexandre Skirda, Nestor Makhno, Anarchy’s Cossack: The Struggle for Free Soviets in the Ukraine 1917-1921 (Oakland: AK Press, 2004), e Voline, The Unknown Revolution (Montreal: Black Rose, 2004).
[230] Una buona documentazione su questo movimento si trova in Alexandre Skirda, Nestor Makhno, Anarchi’s Cossack.
[231] Nel loro articolo scritto per gli strateghi della polizia, “Anarchist Direct Actions”, Randy Borum e Chuck Tilbv sottolineano che in alcuni casi il decentramento ha lasciato lɜ anarchichɜ isolatɜ e più vulnerabili alla repressione, anche se nel complesso è chiaro che il decentramento rende i gruppi radicali più difficili da infiltrare e reprimere; la comunicazione, il coordinamento e la solidarietà sono le componenti critiche per la sopravvivenza delle reti decentrate. Borum e Tilbv, “Azioni dirette anarchiche”, 203-223.
[232] Senza autonomia non può esserci libertà. Per un’introduzione di base a questi e altri principi anarchici, si veda Errico Malatesta, L’anarchia (1920); oppure Peter Kropotkin, Il mutuo appoggio. Un fattore dell’evoluzione (1921). Un buon articolo che contiene riflessioni su un processo rivoluzionario anarchico simile a quello che ho formulato è “Autonomous Self-Organization and Anarchist Intervention” di Wolfi Landstreicher. Inoltre, l’anarchismo post-coloniale di Roger White fornisce una serie di importanti argomenti a favore del diritto di ogni comunità e nazione di identificarsi autonomamente e di scegliere il proprio metodo di lotta.
[233] Ad esempio, la Black Liberation Army, uno dei gruppi di guerriglia urbana di maggior successo negli Stati Uniti, fallì in gran parte per la mancanza di una struttura di supporto in superficie, secondo Jalil Muntaqim, We Are Our Own Liberators (Montreal: Abraham Guillen Press, 2002), 37-38. D’altra parte, l’esercito anarchico insurrezionale guidato da Makhno in Ucraina poté sostenere a lungo un’efficace guerriglia contro l’Armata Rossa, immensamente più grande e meglio armata, proprio perché godeva di un grande sostegno da parte dellɜ contadinɜ che nascondevano e curavano lɜ feritɜ, fornivano cibo e provviste e raccoglievano informazioni sulle posizioni nemiche. Skirda, Makhno, Anarchy’s Cosack, 248, 254-255.
[234] John Sayles, “Foreword”, in Lon Savage’s Thunder in the Mountains: The West Virginia Mine War, 1920-21 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990).