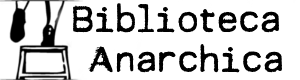Un’amico di Ludd
All’aria aperta
Note su repressione e dintorni
«Dobbiamo abbandonare ogni modello, e studiare le nostre possibilità»
E. A. Poe
Le note che seguono nascono da un’esigenza: quella di riflettere assieme sulla situazione attuale al fine di trovare il filo di una prospettiva possibile. Esse sono il frutto di diverse discussioni in cui si sono mescolati il bilancio critico di esperienze passate, l’insoddisfazione per le iniziative di lotta in corso e la speranza per le potenzialità esistenti. Non sono la linea di un gruppo in competizione con altri, né sottendono la pretesa e l’illusione di riempire i vuoti — di vita e di passioni progettuali — con l’accordo più o meno formale su alcune tesi. Se conterranno critiche spiacevoli non è per il gusto fine a se stesso di muoverle, bensì perché credo sia urgente dirsi anche le cose spiacevoli. Come tutte le parole di questo mondo, esse avranno un’eco solo in chi avverte un’esigenza simile. Insomma, una piccola base di discussione per capire cosa si può fare, e con chi.
Sappiamo per esperienza che una delle forze maggiori della repressione è quella di seminare confusione e d’instillare sfiducia negli altri non meno che in se stessi, oppure di determinare chiusure identitarie e sospetti più o meno paralizzanti. In questo senso, prima si approfondiranno certi problemi, meglio sarà. Si preparano anni difficili che scuoteranno non poche delle nostre abitudini pratiche e mentali. Se è vero che il pregiudizio più pericoloso è quello di pensare di non averne, mi piacerebbe tuttavia che queste note venissero criticate per quello che dicono, senza letture preconcette. Un simile desiderio ne spiegherà il tono e persino lo stile.
Una casa inabitabile
La condizione in cui ci troviamo mi sembra quella di chi si barrica entro quattro mura per difendere spazi in cui per primo non ha voglia di vivere. Tanto discutere di aperture, di allargamenti, di alleanze nasconde il fatto che stiamo difendendo una casa diroccata in un quartiere inabitabile. La sola via d’uscita mi sembra quella di incendiare le postazioni e di andare all’aria aperta, scrollandosi di dosso l’odore di muffa. Ma cosa vuol dire, fuor di metafora?
L’epoca in cui viviamo è così prodiga di sconvolgimenti che sotto le macerie sono finite o stanno finendo le nostre stesse capacità di interpretare e, ancor più, di prefigurare gli avvenimenti. Se ciò vale per tutti i rivoluzionari, particolarmente malconce ne sono uscite le visioni del mondo e della vita basate su modelli autoritari e quantitativi. I gestori più o meno ammiccanti delle lotte altrui gestiscono solo inutili rappresentazioni politiche di conflitti già pacificati; le lotte che squarciano la pacificazione si lasciano sempre meno gestire. L’illusione del partito — in tutte le sue varianti — è ormai il cadavere di un’illusione.
Il disporsi, l’allinearsi e lo sciogliersi delle forze in campo, nei piccoli come nei grandi conflitti sociali, si fa sempre più misterioso. Quello che è sempre stato un nostro tratto distintivo — una visione non omogenea e non cumulativa della forza, una repulsione per la dittatura del Numero — corrisponde in parte alle attuali condizioni sociali e alle imprevedibili possibilità di rottura che queste nascondono. Dalle trasformazioni stesse del dominio — attraverso la sua rete di strutture, tecnologie e saperi — ad eventi come la guerriglia in corso in Iraq, possiamo trarre alcuni insegnamenti. Appare chiaro che gli scontri si verificano sempre meno nel senso dell’affrontamento di due eserciti o fronti, e sempre più nel senso di una miriade di pratiche diffuse e incontrollabili. Un dominio fatto di mille gangli spinge i suoi nemici a farsi più imprevedibili. Un modo non centralizzato di concepire le azioni e i rapporti è non solo più libertario, dunque, ma anche più efficace contro le maglie del controllo. Se una simile consapevolezza esiste a livello teorico, non sempre riusciamo a mantenerla nelle proposte pratiche. Da un lato si afferma che il potere non è un quartier generale (bensì un rapporto sociale), dall’altro però si propongono iniziative che tale lo raffigurano. Credo che dovremmo cercare le forme di azione più adeguate alle nostre caratteristiche, alle nostre forze (quantitative e qualitative). Purtroppo continuiamo a pensare che agire in pochi debba per forza voler dire agire in modo isolato. Per questo di fronte all’arresto di compagni e, più in generale, all’inasprimento della repressione, emergono sempre le solite proposte: il presidio, il corteo, eccetera. Non si tratta, beninteso, di criticare queste forme di protesta in quanto tali, ma la mentalità che per lo più le accompagna. In certi contesti — attualmente soprattutto locali —, all’interno di una serie di iniziative anche il corteo o il presidio possono avere il loro senso. Ma quando questo intreccio tra le forme di azione manca, e, soprattutto, quando si ragiona nell’ambito stretto dei compagni, credo che ripetere certi modelli finisca col creare un senso di impotenza e col riprodurre il noto meccanismo delle scadenze più o meno militanti. Anche qui, c’è bisogno di aria fresca. Organizzandosi, anche in cento si può, volendo, intervenire in modo interessante in cortei più o meno vasti. Ma se si è in cento e basta, poniamo, perché un corteo? Cosa possono fare cento compagni in una città di cui conoscono i punti nevralgici? Cosa ci stanno insegnando tutte le lotte che, a livello mondiale, riscoprono un uso appassionato e potenzialmente sovversivo del blocco?
In molti si sono resi conto che il problema della repressione non può essere ridotto all’ambito dei rivoluzionari. La repressione — quella diretta come quella indiretta — coinvolge fasce sempre più ampie di popolazione. Essa è la risposta di un dominio che sente franare il terreno sotto i propri piedi, consapevole di quanto ampio si stia facendo lo scarto fra l’insoddisfazione generale e le capacità di recupero dei suoi servitori storici: partiti e sindacati. Senza indagare qui le ragioni di tutto ciò, basterà dire che i sovversivi parlano tanto di carcere perché è sempre più facile finirci dentro e che sentono, allo stesso tempo, la necessità di non limitarsi, di fronte ad un giro di vite complessivo, alla difesa dei propri compagni arrestati. Qui cominciano i problemi. Se non si riesce ad opporsi alla repressione indipendentemente dagli individui su cui questa si abbatte, allora ognuno difenderà i propri amici e compagni, quelli con cui condivide idee, passioni e progetti — ed è inevitabile che sia così. La solidarietà contro la repressione, quando quest’ultima colpisce rivoluzionari con cui non si ha alcuna affinità, deve essere ben distinta dall’appoggio a progetti politici che non si condividono o che sono addirittura antitetici ai propri desideri antipolitici. Ora, più l’ambito delle iniziative si restringe ai rivoluzionari, più si rischia appunto di dare una mano a resuscitare ipotesi autoritarie fortunatamente in rovina. Più esso è ampio, viceversa, più i due piani (quello della solidarietà contro e quello della solidarietà con, cioè della complicità) risultano ben distinguibili. È quindi piuttosto stupefacente che, consapevoli della portata sociale ed universale della mannaia repressiva, da più parti si proponga come “soluzione” l’unità d’azione fra… le componenti rivoluzionarie. In questo modo, non solo ci si isola dal resto degli sfruttati che avvertono come noi il peso del controllo sociale e della sbirraglia, ma ci si illude anche su di un aspetto non trascurabile: una simile “unità d’azione” ha un prezzo (forse non nell’immediato, se i rapporti di forza sono favorevoli, ma alla lunga sì). Se invece di essere cento anarchici ad un’iniziativa, siamo in centocinquanta perché si uniscono cinquanta marxisti-leninisti, e per far questo dobbiamo sottoscrivere manifesti e volantini redatti in un gergo più o meno impenetrabile, si tratta forse di un «allargamento»? Non sarebbe forse più significativo organizzare un’iniziativa anche in dieci ma affrontando problemi sentiti da molti ed esprimendo dei contenuti più vicini al nostro modo di pensare e di sentire? Quanto alla solidarietà specifica ai compagni dentro, esistono ben altre forme…
Non vorrei che questo atteggiamento venisse letto come una “chiusura ideologica” o come la ricerca di egemonia su altri gruppi. È proprio per non ragionare in termini di sigle, cappelli e formalismi che è meglio mantenere ampie e chiare le proposte, senza avere come interlocutori determinati gruppi politici, bensì chiunque si senta coinvolto: dopo di che, chi vuole partecipare da pari a pari, è il benvenuto. Se gli altri rivoluzionari applicheranno lo stesso metodo, il giovamento sarà per tutti. C’è un’aria di alleanze più o meno di servizio che trovo irrespirabile. I fronti unici, le unità d’azione fra le forze rivoluzionarie — ben al di là di un obiettivo specifico di lotta, in cui ci si confronta con chiunque sia interessato, compagno o meno che sia — fanno parte, per me, della difesa di una casa inabitabile. E questo indipendentemente da quanto tizio e caio siano brave persone, corrette o simpatiche; è un problema di prospettive. Una volta Malatesta rispondendo a Bordiga disse più o meno: «Ma se, come pretendono questi marxisti, le differenze fra loro e noi non sono così sostanziali, perché invece di farci aderire ai loro comitati non vengono nei nostri?». Fare le cose fra anarchici, dunque? Nient’affatto. Agire su basi chiare, anche in pochi, ma rivolgendosi a tutti gli sfruttati, a tutti gli insoddisfatti di questo ergastolo sociale. E inserire in quello che diciamo e facciamo — si tratti di una lotta contro gli inceneritori, contro le espulsioni o per la casa — il problema del carcere (e quindi dei nostri compagni dentro). Non giustapponendo o appiccicando al resto la “questione carceraria”, bensì smascherando i nessi reali sulla base dell’esperienza comune. Qualsiasi lotta autonoma si scontra, prima o poi, con la repressione (sia che essa la affronti apertamente, sia che ripieghi per evitarla). Anche le occupazioni di case pongono il problema della polizia, degli interessi che difende, del controllo nei quartieri, dei ghetti e delle galere. L’autorganizzazione sociale è sempre anche autodifesa contro la repressione.
Saltare al cuore dell’occasione
Abbiamo un’occasione per certi aspetti storica: quella di intervenire in conflitti sociali — presenti e a venire — senza mediazione. Se gli epigoni delle forze autoritarie che hanno soffocato tante spinte sovversive sono, come numeri e come progetti, male in arnese, perché aiutarli noi ad uscire dalle loro ambasce? Perché attardarsi fra le mummie quando il vento soffia forte? Loro fanno calcoli politici, noi no. Nell’esperienza pratica si vedrà chi è davvero per l’autorganizzazione. Basiamoci su quella.
Con il ripiegamento riformistico generale, le poche realtà su posizioni anticapitaliste e antistituzionali sono come un incendio nella notte — ed è forte, dunque, la tentazione di tenersi stretti al di qua di certe barricate. Ma non è lì la nostra forza. Fourier diceva che una passione è rivoluzionaria se determina un innalzamento immediato del piacere di vivere. A me questo sembra il criterio più affidabile. So per esperienza che diversi ragazzi si sono avvicinati ad alcune realtà anarchiche poiché hanno scoperto che nella solidarietà e con il coraggio delle proprie idee si vive meglio. Perché? Perché il peso della merce e del lavoro è meno forte quando lo si affronta insieme, perché i comportamenti fuori-legge sono contagiosi per chi ama la libertà, perché i rapporti amorosi senza briglie possono essere più sinceri ed appaganti, perché nell’unione di pensiero e azione si rinnova, come diceva Simone Weil, il patto dello spirito con l’universo. Ecco allora che l’entusiasmo — quello della leggerezza pensosa e non della frivolezza avvilente — dovrebbe informare le nostre pratiche. Perché «portare il panico alla superficie delle cose» è appassionante; perché non c’è festa senza rottura della normalità. Lasciamo certi linguaggi da tristi militanti ad altri e fuggiamo i modelli che il potere conosce e si aspetta.
Dal guado in cui ci troviamo attualmente non usciremo con qualche iniziativa, per quanto ben riuscita. Sarà il caso di dirsi che i tempi saranno piuttosto lunghi. Trovare affinità reali, sperimentare di nuovo forme articolate e fantasiose di azione collettiva, beffare il controllo poliziesco, sono possibilità da reinventare fra mille ostacoli. «Sì, intanto però i compagni sono dentro, intanto la repressione incalza» — ci si potrebbe rispondere. Ma la cosa migliore che possiamo intraprendere per i compagni prigionieri non è forse far diventare socialmente pericolose quelle esigenze di vita per cui sono stati rinchiusi? In tal senso, è inutile guardarsi in specchi politici che ci dicono che non siamo nudi. Meglio una consapevole nudità piuttosto che qualche abito tessuto d’illusioni. Meglio ricominciare da capo, lontani dall’odore di cadavere e dal ciarpame ideologico incomprensibile agli indesiderabili di questo mondo.
Ecco, per tanti aspetti c’è bisogno di uno strappo forte che porti nelle relazioni individuali come nella pubblica piazza comportamenti inauditi. Non nel senso del gusto istrionico e autopromozionale di una sorta di vena artistica — notoriamente cadaverica —, bensì in quello di una nuova esigenza di vita che afferma spudoratamente se stessa. C’è bisogno di un odio di classe che non sa che farsene delle vecchie geremiadi e attacca i mille nodi dello sfruttamento quotidiano. Di una tensione etica che non confonde mai oppressori ed oppressi e che non esaurisce il proprio fiato contro i servi del potere — perché cerca di liberarsene, anche con la violenza, ma per andare oltre. C’è bisogno di una nuova bontà, armata e risoluta, capace di sconvolgere i calcoli da bottegai dei nostri contemporanei, capace di fare del disprezzo del denaro un comportamento individuale e sociale. C’è bisogno, insomma, che l’insopportabilità di questo mondo — dei suoi lavori come delle sue case, dei suoi consumi come della sua morale — trovi la propria espressione incontenibile, costante, quotidiana. È nella nostra vita che si gioca la guerra sociale, perché è nella vita di tutti i giorni che il capitale tesse la sua rete di alienazioni, di dipendenze, di piccoli e grandi capitolazioni. È lì l’alfa e l’omega di ogni sovversione sociale.
Non dite che siamo pochi…
Dite soltanto che siamo. Così cominciava un famoso adesivo antimilitarista di tanti anni fa. Poi continuava dicendo che anche solo qualche nuvola nera può oscurare il cielo. Non si tratta soltanto di un’astuzia dell’ottimismo (una sorta di bacio perugina dell’anarchia), ma anche di un’esperienza reale.
Per parecchi anni — almeno una quindicina — nel movimento anarchico d’azione diretta (quello autonomo dalla Federazione e dal sindacalismo, per intenderci) c’è stata in generale poca attenzione verso i conflitti sociali e le forme più o meno significative di autorganizzazione degli sfruttati. Oltre a ragioni storiche (la grande pacificazione degli anni Ottanta), ciò era dovuto ad un problema di atteggiamento mentale. Molti compagni che parlavano di insurrezione — un fatto indubbiamente sociale — percepivano la società come uno spazio abitato quasi interamente da servi e da rassegnati. Con una tale visione rimanevano così sospesi fra le dichiarazioni di principio e le loro effettive esperienze: indecisi rispetto ad una rivolta apertamente solitaria, lenti ad aprire l’uscio a possibilità collettive. (Forse da ciò, chissà, nasceva un certo rancore rovesciato nelle polemiche fra compagni). A fianco di questa scarsa sensibilità verso le lotte che rompono con la massificazione — ma che dalla massificazione tuttavia escono —, si è sviluppata una certa capacità di intervento autonomo, con una significativa diffusione di pratiche di attacco alle strutture del dominio (dal nucleare al militare, passando per le banche, i dispositivi del controllo tecnologico o i laboratori di vivisezione). Ora qualcosa sta cambiando, come se una confusa esigenza individuale incontrasse nuove condizioni sociali — ed ecco compagni che improvvisamente parlano di lotta di classe, magari prendendo a prestito letture e gerghi dal marxismo. Solo che spesso, oltre la retorica dei volantini, la visione della società è rimasta la stessa: attorno a noi, insomma, solo complici del potere. Credo che in tutto ciò giochi parecchio una mancanza di esperienza di lotte sociali direttamente vissute e stimolate. Qualche tentativo locale è esistito ed esiste, senza tuttavia raggiungere quelle difficoltà istruttive tipiche dei conflitti allargati. Ancora una volta, siamo come in un guado. Alcune riflessioni pratiche sono nate sulla base dei vari blocchi realizzati da lavoratori e non solo. In tanti ci siamo buttati, domandando a quelle lotte molto di più di quello che potevano esprimere — salvo poi tornare a lamentarsi del servilismo degli sfruttati. Altre occasioni non mancheranno, né forse mancherà una maggiore attenzione da parte nostra. Ma non basta.
Penso che sia meno che mai il momento di rinunciare al gusto per l’azione diretta, anche in pochi. Solo che questa dovrebbe essere maggiormente legata ai contesti sociali, alle insoddisfazioni percepibili. Quante occasioni abbiamo perso (dopo Genova, durante i blocchi contro i treni della morte, dopo Nassiriya, durante la tragedia della Cap Anamur, eccetera)? Il tempo è l’elemento in cui vivono gli uomini, e la rivolta è fatta di occasioni. Dovremmo studiare meglio le nostre possibilità, invece di girare così spesso in tondo. C’è stata qualche nobile eccezione, ovviamente (diverse azioni dopo Genova, altre contro le biotecnologie o la macchina delle espulsioni, alcuni sabotaggi contro la guerra, eccetera), ma sporadica, circondata dal clamore provocato da un’inutile retorica, da proclami al vento e da una distinzione pratica (ed etica) tutt’altro che chiara su chi siano i nemici. Proprio in un periodo in cui, di fronte alla violenza indiscriminata che sempre più spesso si impadronisce delle istanze di resistenza e liberazione dei dannati della terra, questa chiarezza sarebbe necessaria. Soprattutto da parte di chi ripete di continuo che la miglior teoria è la pratica, ma poi lascia al caso molto di quello che fa. Forse, abbacinati dagli effetti speciali dello spettacolo, noi per primi crediamo poco alle conseguenze delle nostre azioni (lasciandoci andare al pressappochismo), oppure ne esageriamo la portata (lasciandoci prendere dall’illusione mediatica). Ci sono effetti che continuano a produrre delle cause.
Il grande gioco
Il grande gioco, mi sembra, sta nella capacità di unire una certa dose di spregiudicatezza quotidiana (disturbare ovunque è possibile la normalità sociale, dai dibattiti cittadini alle fiere del consumo e dell’inebetimento culturale, dal lavoro alla paranoia del controllo) con la prontezza ad agire quando il momento è opportuno. Per essere conduttori di gioia di vivere, e non cassandre del futuro collasso capitalista. Perché l’azione anonima e distruttrice esprima la costruzione di una vita che anonima non è. Troppo vago? Certo, e non potrebbe essere diversamente. Trattandosi del più serio dei giochi, la partita spetta a ciascuno di noi. Le difficoltà esistono eccome, vista la perdita progressiva degli spazi di autonomia, tragicamente erosi dal presente sistema sociale e dai suoi mille narcotici tecnologici. Eppure spesso i limiti sono soprattutto nella nostra risolutezza e nella nostra fantasia, appesantiti come siamo dal fardello dell’abitudine nei gesti, nelle parole, nei rapporti. Un incontro più ampio fra le varie realtà locali nascerà dai rispettivi percorsi di autonomia di pensiero e di lotta, non da una sommatoria di forze dettata dall’urgenza. Allora le discussioni non saranno un balletto immobile di frasi fatte, bensì l’occasione di imparare gli uni dagli altri, di far comunicare finalmente i modi di vivere, cioè i reciproci mondi. Allora si ritroveranno la fiducia e l’entusiasmo, e nascerà qualcosa che assomiglia a un’esperienza comune.
La rivolta è l’incontro della leggerezza e del rigore.
settembre 2004