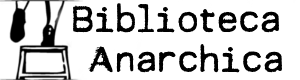Prima edizione: novembre 2001
Seconda edizione: novembre 2013
Alfredo M. Bonanno
Nichilismo e volontà di potenza
Nota introduttiva alla seconda edizione
L’usbergo della volontà ha protetto per molto tempo gli anarchici, è tempo che qualcuno rifletta sui costi di questo baluardo, costi psicologici e, in ultima analisi, costi sociali, rivoluzionari.
Volere, prima di ogni cosa, è automatismo della coscienza immediata, cioè intima connessione del processo fattivo con cui siamo legati alla vita amministrata e coatta che conduciamo nella quotidianità, misura del quantitativo, prima di tutto, quindi dell’accumulabile e del possedibile, parte del nostro cuore che si inaridisce, in questo modo, e deve essere tutelata, difesa, custodita, accudita, insomma protetta da tutti gli attacchi che dall’esterno possono metterla in pericolo.
Ma volere è anche utile, in quanto ci mette a disposizione quegli strumenti che sono indispensabili alla lotta, primo fra tutti lo strumento conoscitivo, la cultura, la capacità di capire i meccanismi naturali e sociali di un mondo di cui, bene o male, facciamo parte. E poi? Poi dovremmo avere la capacità di capire che la volontà, da sola, non basta a fornirci una distanza critica tra queste acquisizioni (sia pure indispensabili) e l’azione, cioè la ricerca della qualità, il nostro interrompere la quotidianità amministrata e tagliare per la via scoscesa e impraticabile del coinvolgimento.
L’attacco al nemico che ci soffoca e ci costruisce attorno i muri all’interno dei quali viviamo la nostra vita coatta di tutti i giorni, sia pure con i crismi della volontà capace di decidere e di conoscere, di valutare e comprendere i limiti di quello che acquisiamo e difendiamo, deve spezzare questi muri, quindi anche il meccanismo volontario che partecipa del mantenimento e del perfezionamento di essi, e questa rottura è qualcosa che oltrepassa qualsiasi capacità di volere o di conoscere.
Molti restano al di qua. Sognano tutta la vita un gesto che avrebbero potuto maturare, mettendosi in gioco, ma che non hanno fatto, e per tutta la vita hanno continuano a vivere la propria morte, non rendendosi conto di essere, sostanzialmente, cadaveri forniti di respiro e di parola, il più delle volte usata a sproposito. Pochi si sono messi in gioco, e quei pochi non hanno conquistato nulla, si sono ritrovati però con una grande esperienza qualitativa, l’esperienza dell’azione, e di questa hanno fatto tesoro, seppure non in grado di poterla comunicare. Non sono le parole che aprono le porte della qualità. Con le parole ci si imbroglia e si imbroglia. Qualche volta, raramente, esse possono essere stornate in maniera violenta e servire da rammemorazione, cioè venire costrette con la forza a dire qualcosa della qualità, ma si tratta di un tenue balbettio, spesso raccolto per piccoli sprazzi e briciole insignificanti, soggetto al pericolo di autonegarsi suggerendo fraintendimenti ai portatori della conoscenza ragionevolmente legata al fare coatto, perfettamente in linea con le costruzioni tetragone e progressive.
Il cuore no, non viene, di solito, preso in considerazione, il sentimento, il coraggio, il coraggio vero, non quello delle barricate, ma quello che sa affrontare l’ignoto e l’incomprensibile, no di questo c’è sempre scarsa disponibilità.
Il nulla, insomma, che è l’unica acquisizione possibile che non dobbiamo difendere come un triste possesso che ci impedisce di dormire la notte. La nostra esperienza nell’azione è solo qualitativa, ed è essa un nulla di cui non possiamo parlare se non balbettando.
Ecco. Questo libretto è in sostanza un tenue balbettio, e tale rimane anche nella sua seconda edizione.
Trieste, 21 novembre 2011
Alfredo M. Bonanno
Nota introduttiva alla prima edizione
“Che cosa significa nichilismo? Significa che i valori supremi si svalutano. Manca lo scopo. Manca la risposta al perché”. (F. Nietzsche, La volontà di potenza. Saggio di una trasvalutazione di tutti i valori).
“Il nichilismo come negazione di storia, realtà, accettazione della vita è una grande qualità, come negazione della realtà in assoluto significa un impiccolimento dell’Io. Il nichilismo è una realtà interna e cioè una determinazione di mettersi in movimento verso un’interpretazione estetica, in esso sfocia il risultato e la possibilità della storia”. (G. Benn, Sul tema storia).
“Invece di aspettare che gli uomini diventino maggiorenni, e non sappiamo se si decideranno mai a esserlo; invece di cercare di illuminarli su problemi insolubili e su paradossi indefinibili, che né gli scienziati né i logorroici risolveranno e definiranno; invece di fare appello alla coscienza, che non hanno; invece di fare appello alla buona volontà, che è solo fanatismo; invece di fare appello alla buona fede, che è solo fanatismo; invece di far appello alla buona fede, che è solo allucinazione approvata; invece di sperare nel miracolo, che è poi quello a cui in definitiva si riduce tutto quanto precede, bisogna agire come se tutto dovesse morire, bisogna prepararsi a sopravvivere alla catastrofe, bisogna pensare ai resti che sussisteranno nell’universo inabitabile, bisogna considerare la massa di perdizione irrimediabilmente perduta, e non ragionare più se non tenendo conto della sua transitorietà. Quello che affermo sembra disumano, ma disumano il secolo lo sarà sempre di più, e i sermoni non modificheranno questa sua peculiarità, gli uomini potranno pure assieparsi nei templi, ciò non toglie che i templi finiranno per crollare, e sulla testa dei fedeli, nell’ombra della morte comune”. (A. Caraco, Breviario del caos).
L’impero della volontà è su delega della ragione. Volere qualcosa, in un certo modo, in vista di un fondale, è semplicemente volere. La prigionia della volontà è un effetto legante, un movimento che ci accartoccia sugli schematismi introiettati e quindi ci governa lasciandoci fare quello che vogliamo, apparentemente quello che vogliamo.
La volontà ci appartiene in condominio con il mondo che ci circonda ed è costruita ed educata a partire dal riverbero delle connessioni più immediate, le quali, a loro volta, sono in rapporto con altre connessioni più lontane che concorrono alla costruzione della volontà. La cosiddetta libertà del volere è sempre relativa a qualcosa che funge da misura e da punto di riferimento. Questo qualcosa è un legame che impedisce al concetto di libertà di esprimere quello che dovrebbe esprimere, cioè scioglimento di tutti i legami. Queste considerazioni non meriterebbero di essere approfondite, tanto alla fine risultano, come le mura di Gerusalemme, di per sé quasi ovvie, se non ci fossero state sull’argomento più confusioni e idiozie che altro. La terra è spenta, questo è il senso finale di ogni partita ancora da giocare. Un discorso serio sulla volontà deve quindi, prima di tutto, dire qualcosa sul fatto della condizione coatta in cui essa si trova.
Non è infatti casuale che ogni volontà sia volontà di potenza, affermazione di se stessi di fronte all’inquietudine e all’incertezza. La potenza è ciò a cui agogniamo per paura e per disperazione, ed è anche ciò a cui siamo disposti a sacrificare tutto quello che siamo.
Eccoci pertanto alla continua ricerca di qualcosa che non abbiamo e la cui mancanza ci inquieta. Ci inquieta perché riteniamo di essere continuamente in pericolo (questo lo dice la volontà) e quindi di avere continuamente bisogno di una maggiore potenza di quella che abbiamo (difficile riconoscerla perché la volontà tende a sottovalutarla) e di essere pertanto quello che non siamo. Essendo essenzialmente desiderio di potenza, di sempre maggiore potenza, la volontà è costretta a volere sempre di più e quindi resta prigioniera di un meccanismo che stanca e snatura l’uomo, il quale è detto appunto di “buona volontà” perché a lui, e solo a lui, spetta il regno dei cieli. Il perché non è difficile.
Una buona volontà adegua la potenza alla sua capacità e chiede di diventare sempre più potente “dentro certi limiti” che non disturbano troppo i progetti del potere. Pensare che la hýbris sia l’eccesso che spezza questi limiti nel senso di una richiesta di potenza spropositata, è stato un fantastico abbaglio. L’eccesso è nella parte opposta, nel pretendere di rinunciare alla volontà di potenza e nel diventare quello che si è, potenza quest’ultima di gran lunga più pericolosa per l’ordine fondato sui protocolli e sulle corrispondenze.
Di certo, non si può diventare completamente quello che si è per il medesimo motivo per cui non si può rinunciare alla volontà di potenza. Volere significa volere essere qualcosa d’altro di quello che si è, e volerlo essere nel senso di una maggiore potenza. L’acquisizione è l’illusione che ci sprona per tutta la vita, prima fra tutte quella della cultura. Poiché costa fatica, la cultura fa sognare tutti indistintamente, anche coloro che ne sono assolutamente privi, i quali non fanno passare occasione per mettere in mostra quel poco che hanno. Infaticabile la torcia iconoclasta di Hugo.
Ogni sistema sottoculturale funziona come surrogato e garantisce soddisfazione sicura scambiandosi nell’ambito dei partecipanti come messaggio di riconoscimento impagliato. Il ruolo sociale, e la condizione coordinata di status, riflettono questa fame acquisitiva e, nello stesso tempo, l’insoddisfazione di sé e l’inquietudine di mai pervenire a un completamento del possesso. Ogni desiderio partecipa di questa condizione imposta dalla volontà e quindi urge nel proprio inestinguibile soddisfacimento, prima di tutto per quello che il desiderante riesce ad acquisire, mentre la considerazione dell’altro, ridotto a simbolo di qualcosa di completante, scade a oggetto e tassello di un puzzle.
La volontà è pertanto diretta sempre all’acquisizione, e ogni acquisizione è nutrimento e aumento di potenza o, almeno, tale sembra all’acquirente. Tutto quello che appare come dispendio, per la volontà deve avere una controparte, basta pensare al modo in cui dal bambino all’adulto ci si dispone nei confronti del gioco e dell’incantesimo. Il primo vi vede un fare piacevole, il secondo un variare di fatica, pertanto piacevole anch’esso. Ma la piacevolezza del fare ludico, in ambedue i casi, non è legata all’assenza di scopo, questo esiste ed è quantitativamente identificabile se non altro in termini di tempo, un passatempo è un gioco e ogni gioco è un passatempo.
L’istinto verso qualcosa, per esempio l’istinto sessuale, ribolle indifferentemente nella vita, ma trova il proprio indirizzo estrinsecativo solo quando entra in contatto con la volontà e quando da questa è incanalato e smussato da tutte le irregolarità che minacciano di renderlo inadatto alla condizione del mondo, cioè all’esistenza. Ciò è senza dubbio una riduzione di vitalità, ma è visto come un aumento di potenza e fondamento del quotidiano.
Facendosi portatrice della ragione, e delle regole da pollaio che questa ha costruito e continua a costruire, la volontà incanala la vita e la modifica in esistenza. Una società fortemente intollerante verso l’omosessualità farà sviluppare una volontà indirizzata a nascondere questa forma di sessualità diretta verso lo stesso proprio sesso, fin quando la tensione che ne viene fuori si rompe e la sessualità si orienta verso scelte accompagnate da forti sensi di colpa e spiacevoli sentimenti di insoddisfazione e incompletezza.
Presupporre possibile una conoscenza della volontà equivale alla pretesa di costruire una scienza della volontà o, almeno, una teoria del volontarismo. Quello che di tutto ciò è possibile è una modesta affermazione di cecità: la volontà vuole e nient’altro, non esiste una “nolontà”, e quando non si vuole è facile concludere che la negazione riguarda l’oggetto e che si sta volendo il non avere l’oggetto, non il non volere, che è mera assurdità come il niente assoluto. Coloro che hanno provato a costruire una scienza formale della volontà, come Spinoza e Kant, si sono trovati nell’impossibilità di procedere oltre le formulazioni propedeutiche. Un contributo alla conoscenza della volontà deve partire dalla coscienza immediata, cioè dal modo in cui l’uomo si determina volontariamente all’acquisizione di potenza nel mondo, premunendosi contro gli inferni della paura e l’inquietudine.
Il sapere è la totalità di questa potenza, la sua totalità possibile e mai completamente realizzabile. Il sapere è una selva impenetrabile i cui confini si spostano in avanti man mano che la conoscenza procede nel suo intento scientifico di penetrazione. L’uomo, che si era scrupolosamente pensato libero (premio finale alla buona volontà), se in grado di acquisire questo possesso, si sente così sempre di più rinviato all’avvenire della propria completezza, e riscopre in questo modo le inquietudini che aveva pensato di fugare. Il peso in termini di protesi delle scoperte scientifiche diminuisce, cresce al contrario l’ampiezza delle pretese esplicative e l’ottusità del processo volontario che chiudendosi si fa propositore di un più rigido controllo.
Noi abbiamo esperienza vaga del sapere. Anche di ciò che conosciamo bene, riusciamo a dare cognizione a noi stessi in maniera approssimativa, spesso con ridicoli appressamenti, eppure la volontà organizza modificazioni produttive in continuazione, tutte basate sulla conoscenza, spesso in maniera automatica o quasi. Il modo in cui funziona questo meraviglioso meccanismo spremitore di risultati, considerando i processi dal punto di vista che qui ci interessa, si chiama “personalità” e varia da individuo a individuo. La personalità fa risuonare dentro di sé la volontà in modo che non entri troppo in contrasto con gli istinti, le pulsioni e le intuizioni che la vita continuamente fa rampollare dentro ognuno di noi come tanti sortilegi. La volontà cerca ciecamente la potenza, ma la cerca in modo diverso in ognuno di noi.
L’agire oltrepassa improvvisamente le dimensioni del fare coatto proprio perché coglie motivazioni furibondemente sconosciute al ragionamento scientifico. Non c’è modo di fare vedere la forma che assume questo trepido “andare oltre”, in quanto non si tratta di processi dimostrabili, lo stesso meccanismo produttivo del fare coatto è descrivibile in modo insufficiente in quanto provvisto di un finalismo errato, destinato all’incompletezza che lo rende sempre bisognoso di potenza. Quando una pulsione verso la diversità, poniamo una insoddisfazione qualitativa per l’esistenza in cui viviamo che ci copre dell’insulto dell’apparenza e dell’approssimazione e quindi ci nega la verità, quando, dicevo, una pulsione del genere si fa avanti, non c’è subito un rigetto della volontà. Questa non avverte una presenza nemica, anzi collaziona una stima elogiativa che facilmente si traduce in volontà di potenza.
Ma l’elevatezza della pulsione potrebbe resistere a ogni tentativo di derubricazione, cioè potrebbe non accettare la lettura in termini di residuo, dove la qualità del vero diventa quantità verificabile. Ciò conduce a un’opposizione col giudizio espresso dall’intelletto organizzato nella ragione dalla volontà. Qui scatta l’allarme. La volontà insiste nella sua decodificazione sbriciolando la pulsione di partenza che ha orrore di essere scoperta e stenta a organizzarsi subito verso l’apertura a una coscienza diversa, a un itinerario verso la qualità. In base all’ostacolo e alla modificazione attuati dal meccanismo volontà-ragione, la coscienza immediata, rimessa al suo posto la pulsione vitale, la condanna come infondata e come sorgente d’inquietudine, mentre trova conforto e forza nell’afflusso di potenza che le viene dalla volontà. Tutti i conti tornano ed è pace a Varsavia.
Le pulsioni vitali non possono essere sottoposte a calcolo etico, almeno non nei termini formalistici di cui al tentativo di Kant. Sono di certo sentimenti forti, ma non controllabili, i cui effetti non sono prevedibili come accade con la volontà. Non hanno di mira la potenza, non allettano con qualche garanzia riguardo al futuro. Sono là perché la vita è fatta così, non hanno una qualche proprietà che le differenzia dalla vita, non sono la vita considerata sotto un certo aspetto – poniamo quello attivo – non sono atto di qualche potenza, né sono il contrario di quest’ultima ipotesi. Ogni riflessione su di loro le avvilisce sgretolandole in banali residui, quindi noi le conosciamo sotto questo aspetto riduttivo, e la volontà si illude di governarle, ma ne organizza soltanto gli impassibili fantasmi. Le pulsioni vitali non hanno un effetto piacevole su di noi che le avvertiamo, a volte con eccessiva crudezza, quindi non siamo noi che le sollecitiamo a presentarsi, né la volontà può azionarle a suo piacere o in vista dei suoi scopi di potenza. Ci fanno a volte alzare la testa, e in ciò Kant ha giustamente intravisto un grande impulso etico, ma poi si è fermato a metà strada pretendendo di averle segregate nel valore assoluto della morale.
Che la coscienza immediata, prigioniera del fare coatto, si senta racchiusa in un involucro di legami che la soffocano, è esperienza che ognuno può fare facilmente non appena vi pone mente. Ciò non vuol dire però che la pulsione vitale che gli fa toccare, senza muovere un dito, le pareti del carcere, sia lo stesso tipo di esperienza, lo stesso cielo vuoto. Nella prima è con la ragione che si capisce la situazione bruciacchiata in cui ci si trova, nella seconda è col sentimento che si coglie la medesima situazione, ovviamente da una collocazione diversa. Ora, questa differenza tra capire e cogliere rende diversa la situazione, non solo il modo di vivere all’ombra delle sue torri maledette. La situazione vissuta in maniera oppressiva viene a mettere in moto due vie differenti. Nel caso della riflessione, la volontà e la ragione giustificano la coazione predicandola come sacrificio in vista dell’acquisizione di potenza, nel caso del sentimento, la forza vitale sollecita a un’azione risolutamente diversa, non progetta, non afferma, non suggerisce impazienti calcoli o equilibri, si limita a essere quello che è, sollecitando all’azione con la sua sola presenza. La vita è in maniera incondizionata, non può condizionare immediatamente.
Se la volontà propone un’acquisizione di potenza, e la ragione capisce e dimostra l’utilità di questa proposta, la forza vitale essendo universalmente presente non può essere incrementata come una specifica potenza (per esempio, quella della volontà che intende aumentare le sue capacità di protesi), essa è e basta, ma è nel senso della fulminea pienezza non nel senso della parzialità dell’esistenza. Di fronte alla vita, l’enumerazione delle tante possibili acquisizioni di potenza è faccenda ridicola. Eppure è questa la strada che l’agghiacciante volontà prende regolarmente, essendo obbligata a farlo e non possedendo una vera alternativa. Volere fare il bene o volere fare il male è la medesima cosa dal punto di vista della volontà, ambedue i processi, quello diretto a fare il bene e quello diretto a fare il male, vengono considerati processi di acquisizione di potenza. L’ipotesi che fare il bene aumenti la somma totale di benessere dell’umanità e fare il male la diminuisca è chiaramente un sofisma non provvisto di fibbie robuste in quanto può essere sostituito dall’altro ragionamento – parimenti sofistico – che l’aumento di potenza produce un pari aumento nella possibilità collettiva di fare il bene.
È chiaro che qui l’accento deve essere posto nel verbo “fare”. Questo verbo, di regola da me proposto in coppia con l’aggettivo “coatto”, che del verbo diventa simbolo e sostanza, serve a indicare il processo produttivo della modificazione caratterizzante il mondo in cui viviamo. Essendo questo mondo legato insieme da regole e protocolli che garantiscono artificialmente equilibri e rapporti di corrispondenze, la volontà “fa” in relazione ai formalismi che riflettono questi legami, quindi fa il bene con lo stesso rispetto delle regole come fa il male. Nell’aiutare una vecchia ad attraversa una strada ci sono regole da rispettare non diverse, né antitetiche, a quelle che occorre tenere presenti nel rapinare una banca. La volontà ottimizza questo rispetto allo scopo di ricavare il massimo di perfezione nella potenza che desidera ottenere, e a ciò accorda una nota positiva. Chiedersi quale sia la potenza ottenuta nell’aiutare la vecchia significa non aver capito il movimento del concetto di potenza che si proietta dall’interesse immediato, alla coscienza di sé per poi distendersi al giudizio degli altri su di noi, per affievolirsi in mille altre considerazioni di status, sedimentazioni di comportamenti, scenari fantastici, residui culturali, ecc. Lo stesso per “fare” una banca, come si suol dire. L’interesse del guadagno improvviso e considerevole è uno dei tanti stimoli della volontà e forse nemmeno il più importante, è un messaggio che viene fuori da profondità caotiche. Una serie di modelli di comportamento si sviluppa davanti a chi affronta questo “fare” e, di regola, questi comportamenti sono tutti (o quasi) annegati nell’ambito quotidiano della produzione. L’alta considerazione che il rapinatore ha del coraggio, della propria volontà di potenza, del ruolo dominante e oppressivo del capitalismo, ecc., sono elementi non di contorno, ma primari e spesso indistinguibili uno dall’altro. Se il processo produttivo del fare si mantiene a questo livello, la volontà controlla tutto quello che si presenta davanti a lei e non c’è nessuna possibilità che si sviluppi una coscienza diversa.
Lo stimolo deve venire da più lontano e non dalla chiarezza delle regole e dei protocolli, da forze che non si conoscono e che non si vedono. Ciò dipende dal fatto che si tratta di una pulsione vitale, la quale può ribollire per anni senza rompere gli argini, e può trionfare sull’ostacolo in pochi attimi. Qui non c’è l’interesse per l’acquisizione di potenza, non c’è nemmeno un’aggiunta di senso dovuta all’orientamento percettivo. Avvertiamo qualcosa che urge dentro di noi e lasciamo che questo venga avanti nell’oscurità senza accecarlo con i risultati secondari della civiltà.
Platone aveva intuito qualcosa in merito alla elementarietà delle manifestazioni morali. L’impulso vitale non è diretto a causare piacere o dispiacere, è esso stesso piacere e può essere dispiacere, qui le sfumature sono trascurabili. Certe volte ci sentiamo in grado di mangiarci il mondo, altre volte siamo avvinti da un torpore che non è neanche stanchezza, che ci impedisce di levare un braccio fuori dalla gabbia. Sono istinti vitali che si risvegliano e che verranno presto catalogati o abbandonati. Alla lunga ci abituiamo alla loro catalogazione o alla loro dimenticanza. Non c’è nessuna logica nell’istinto vitale, nemmeno quella del “tutto e subito”, la quale pur essendo una logica diversa è sempre una logica.
L’istinto dilaga in noi fin quando non lo contrastiamo orientandolo nella percezione e annullandolo nella copula della volontà acquisitiva. Ogni movimento recuperativo lo legge come simpatia o antipatia, ma sono palliativi in attesa di un ricorso vero e proprio all’inglobamento della volontà di potenza. L’ampio raggio di apertura dell’istinto vitale resta sconosciuto alla volontà. Da ciò si può partire per negare la volontà e procedere avanti aggirandola sfruttando l’euforia o il senso di elevazione che spesso deriva sia dal senso di benessere o di stanchezza in cui ci troviamo a causa dello stimolo vitale. Tuttavia in tale modo di avvertire la presenza dell’impulso vitale non ci potrà mai essere un’evidenza rigorosa fin quando l’intelletto non avrà catalogato desolando tutto per bene.
Prima di questa catalogazione avvertiamo via via qualcosa di più preciso, eppure non ancora del tutto in balia dell’occhio rapace che le forze organizzative della potenza sanno acuire. Questo avvertire è indicazione di una presenza non chiara di cui liberamente possiamo fantasticare producendo rappresentazioni che si irradiano a volte con la loro forza vitale senza tuttavia riuscire a diventare cogenti in maniera diretta. Ci sentiamo commossi, cioè messi in moto da qualcosa che sta dentro di noi, ancora troppo tenue per essere oggetto di appetito per la volontà. Ogni individuo costruisce un suo modo, una sua personalità, per disporsi in modo convinto nei confronti di questi movimenti vitali che lo commuovono e lo colgono di sorpresa, produce così risposte non ancora definitive a quelle che saranno le sollecitazioni dei rapporti modificativi che dominano nel mondo. Non si tratta ancora di risposte vere e proprie, che si appoggiano sulla volontà, e quindi possono essere riassunte in catalogazioni precise, piuttosto si tratta di rappresentazioni vaghe che si appoggiano sulla frontiera degli istinti, che vengono fuori dal terreno magico delle pulsioni, delle intuizioni, dove la personalità immerge le sue radici inconsce, dove non ragiona, né riflette qualcosa fuori di sé, ma è essa stessa queste radici e l’humus vitale dove sembrano immergersi.
Questo allargarsi e vivificarsi della personalità richiede certo un poco di coraggio, perché non c’è nulla di preciso su cui poggiare i piedi, eppure si tratta di movimenti vitali che hanno qualcosa di persuasivo, una specie di connessione positiva che a volte si sviluppa in modo rigoglioso e a volte viene messa a tacere immolata in un sacrificio. In questo territorio pauroso e avvincente hanno origine le fantasie religiose e i discorsi intimi col dio remoto e vicino. Nessuna di queste pulsioni vitali, interpretata dalla personalità individuale, quindi fatta risuonare in una immediatezza che resta pigra anche se disponibile alla trasgressione, inavvertita ancora del dramma che si sta addensando all’orizzonte, nessuna di queste pulsioni può essere comprensibile universalmente.
La vita è ridotta a ragione secondo l’immagine vuota di uno schema comune, perfino altamente sofisticato nella scienza specifica, ma prima di questo passo riduttivo, ognuno la vive a suo modo e la coerenza morale con la quale ci opponiamo alla volontà di potenza, negandone i presupposti e i risultati, nasce qui, in questo terreno vago, dove germogliano anche i desideri per il dio remoto e la fede per l’incredibile che può sempre accadere.
Il moto dell’animo in un uomo di cuore è di già, in se stesso, ben distribuito e convincente, delinea cioè una personalità aperta al mondo e fiduciosamente ottimista. Non può però venire meno a una certa impenetrabilità, una volta che lo si esamina dal punto di vista riflessivo. Permane in esso una certa elementarietà che sconcerta tutti coloro che sono abituati agli orribili formalismi della morale filosofica. Non ci sono analisi che possono dirci qualcosa di chiaro sulla natura, l’origine e la consistenza di quei sentimenti che siamo soliti definire “ragioni del cuore” seguendo il suggerimento di Pascal. Non riuscendo a definire questi impulsi, non li possiamo né indicare agli altri, né suggerire, come non possiamo trasferirli, e ciò a causa della loro uguaglianza di fondo che trova spazio e variazione solo nella singola personalità, venendo pertanto frastornata dalla comunicazione mascherata che quest’ultima di solito adotta.
Pensando possibile partire dagli schemi tassonomici di già acconciati dalla ragione, se ne ricava solo una rete di formalismi etici che può di certo funzionare in una caserma, ma che impietrisce qualunque uomo in grado di avvertire dentro di sé stimoli vitali. Attraverso un processo di astrazioni si ricavano categorie logicamente corrispondenti, ma prive di vita. Dall’esistenza codificata, attraverso i processi modificativi della produzione, possono essere messi in piedi legami astratti costituenti una morale precettistica. Questi precetti hanno tutto l’aspetto della chiarezza, ma prevedono un’esistenza di già regolata per essere comprensibili, per cui non siamo noi ad accettarli in quanto regole munite di senso, ma li accettiamo in quanto il senso che loro hanno è lo stesso che abbiamo noi, compartecipi di un mondo reciprocamente reificato.
Non tenendo presente questo mondo del fare quotidiano, sarebbero precetti privi di significato, suoni verbali, esercizi retorici, ma niente che possa costituire una guida per vivere, una guida sensibile alla pietà. La loro pretesa generalizzante parte da casi particolari, abbandonando la specifica situazione modificativa in cui quei casi particolari acquistavano senso. Non si possono trarre insegnamenti da opinioni che vengono fabbricate dal processo sociale, in quanto il processo in questione non è effetto di quei precetti, ma caso mai è la causa che li produce. Noi possediamo il precetto di “fare il bene”, ma non possiamo dire che facciamo il bene in un mondo che è esso stesso un “bene” particolare, cioè quello che la sussistenza delle condizioni esistenti perpetua nella continua modificazione. Occorrerebbe produrre un bene più elevato del bene che si può fare nel procedimento produttivo coatto, ma una volta prodotto, questo bene più elevato, sarebbe sempre un prodotto del processo produttivo, avente significato all’interno di quest’ultimo e non in un ipotetico livello “più elevato”.
La dimensione del quotidiano, con la sua sconcia ferocia, livella qualsiasi pulsione vitale, stornandola dalla sua iniziale indifferenza verso la volontà di potenza e indirizzandola alla produzione. Apparentemente questa uniformazione sembrerebbe facilitare l’individuazione di un principio etico comune, come per esempio il “sommo bene” volto nel “vivere insieme”, cioè nella società, ma questo livellamento tende verso il basso, cioè minima ricerca di bisogni e interessi comuni per ottenere quel vivere insieme che sarebbe certo più difficile o impossibile sulla base di maggiori pretese. Questa non è una regola universale, ma una norma di buona amministrazione di qualsiasi azienda, a partire da quella familiare. Nella storia ci sono sempre condizioni diverse che vengono appiattite nell’uniformità lacrimevole dei rapporti tra dominanti e dominati. Ciò ha fatto concludere per l’eticità di un rapporto di contrasto che condurrebbe al miglioramento per la maggior parte dell’umanità. Nessuna persona sensata accetta oggi l’utilitarismo, per quanto il concetto di cui sopra, con tutta la sua prudenza, continui a circolare liberamente. Ma il rapporto di contrasto, riscontrabile sempre, è una condizione di questa società, almeno per come lo conosciamo, per cui una società diversa produrrebbe un contrasto diverso. Non ha senso partire da questa base di ragionamento per ricavarne un principio etico formalmente assoluto, perché quella apparente costanza storica cambia al variare delle regole della società.
La conclusione è che non c’è principio universale che possa fondare un’etica pratica, cioè non opacamente formalistica. Non c’è un principio nell’impulso vitale, non c’è nell’ideale che la ragione può costruire con grande arte a partire dai sentimenti. Non ci sono princìpi che possono reggere il mondo, c’è solo il tentativo di negare la volontà di potenza, di contrapporgli la vita veramente vissuta, non le regole dell’esistenza. Prendere un singolo elemento – per esempio, la volontà di potenza – e fargli svolgere il ruolo di fondamento morale dell’agire è impossibile, lo stesso per l’impulso vitale se lo si proponesse come fondamento morale del fare. I due elementi si scontrerebbero muovendosi ciascuno in un territorio circoscritto della realtà, quindi negandosi la possibilità di accedere all’ipotetica funzione di principio fondante. Il male, comunque, è meno dannoso quanto più si avvicina alla propria purezza. In fondo quello che colpisce di più è l’ambiguità delle intenzioni.
Niente può costituire seriamente un dovere, nemmeno la vita, o l’impulso che essa ci detta. Niente può impegnarci se non liberamente, cioè nella libertà. Ma l’esistenza così come la conosciamo non è libera, mentre l’ideale delle libertà è un lumicino di residuo, una larva di compassione. Certo, l’accordo che abbiamo “liberamente preso”, il cosiddetto “libero accordo”, ci impegna. Ma è stato veramente preso in modo “libero”? Non è stato preso in questo modo. Non c’è niente nella società che può essere preso in tal modo, in quanto le condizioni dell’esistenza, comunque valutate nella loro possibile clemenza parziale, sono coatte. Se io mantengo l’accordo preso, lo faccio perché voglio acquisire una merce pregiata, la correttezza, la quale ha mercato ottimo e può aprirmi tutte le porte. È ancora la volontà di potenza con il suo afflato chirurgico che regge l’accordo cosiddetto libero, non un principio etico che, come abbiamo visto, non può fondarsi sull’interesse all’acquisizione propugnato dalla volontà. In questo modo nemmeno la coerenza può aspirare al principio etico che sembra suggerire a prima vista. Si è coerenti perché si cerca il rispetto degli altri, e in fondo di se stessi, ma questa ricerca è ancora una volta un progetto della volontà di potenza, trovandomi sicuramente a mal partito in rapporti inquinati da una scarsa considerazione che gli altri si sono fatta del mio modo di mantenere gli impegni presi. Un buono o un cattivo giudizio dipende dalla conformità a certe regole, ma del giudizio stesso, se si prescinde dalle regole, non resta nulla. Dovrebbe restare ciò che è buono o cattivo, ma questo, nelle condizioni date, era esso stesso prodotto del giudizio, quindi va via con la sua scomparsa.
In questo modo non c’è differenza tra l’agire e il fare. Solo apparentemente. Facendo attenzione, c’è nell’agire un elemento in più, il coinvolgimento, e questo esclude come misura sia il mero principio del piacere (coinvolgersi può essere a volte molto spiacevole), sia il principio dell’utilità (di certo è più utile seguire le regole del gioco imposte dal mondo). Ma l’agire non è soltanto coinvolgersi, in quanto ci si può mettere a rischio anche per una supervalutazione della volontà di potenza, cercando cioè di produrre di più nel retrobottega della modificazione per mero desiderio di dominio. Non so se qui siamo o meno di fronte a un problema di terminologia, però io questo coinvolgimento, in cui ci si gioca la vita alla roulette russa, non lo definirei propriamente tale. Comunque, nell’agire c’è dell’altro, c’è la ricerca di una coscienza diversa attraverso una messa in discussione negativa della volontà di dominio.
Questa possibilità ci viene data dal nostro destino, che abbiamo costruito nella testarda ricerca di qualcosa oltre la banalità del mondo che ci ospita. Essa fiorisce improvvisamente come pulsione vitale che ci apre il cuore a sentimenti e intuizioni mai provati, di fronte ai quali esprimere un giudizio è povera cosa, un tentativo di recupero come un altro. Sappiamo che questo ribollire del sentimento dentro di noi è una festa offertaci dal destino, ma non sappiamo bene cosa fare se non lasciare che questa forza vitale ci permei, esperienza diversa che non è sempre gradevole visto che il dolore ne fa parte. Se stimiamo più alto il ragionamento ordinativo, facciamo un passo indietro e giudichiamo secondo ragione, cioè facendo un calcolo riguardo le possibilità o meno di un’acquisizione di potenza, in caso contrario, se riusciamo a lasciarci penetrare dal flusso vitale, possiamo farci portare in un territorio in cui la desolazione della realtà si presenta in modo sempre più visibile, dove non abbiamo più scuse per tirarci indietro, dove dobbiamo agire per trasformare la situazione che ci sta di fronte. Qui si colloca l’inizio dell’eticità come azione che attacca e distrugge, oltrepassandolo, il mondo del fare produttivo.
La difficoltà di cogliere questo momento, per cui si rende necessaria una lenta iniziazione alla vita, è data dal fatto che non si possono paragonare tra loro un processo intellettivo e la forza vitale di un’intuizione o di un sentimento. Non si può dire quello è migliore o quella è peggiore, né viceversa. Non sapremo mai, a priori, cioè in base al silenzioso massacro di una scala di valori formalistica, se è meglio un godimento estetico o un’azione politica, ammettendo che questi due aspetti del fare non si siano di già allontanati nell’iniziale dimensione dell’agire. Di già, parlando di estetica e di politica, si è nell’ambito dell’esistente, mentre la forza vitale è faccenda che non esiste ma vive senza preclusione alcuna. Tutti i conferimenti di valore appartengono alla società in cui viviamo. Chi si pone nell’ottica dell’azione è già fuori di questa società, quindi opera in modo trasformativo, modo che nel mondo è privo di valore perché diverso. Ogni distruzione è negativa, ogni negazione è un disvalore non un valore, ovviamente per la situazione modificativa e coatta dell’esistenza.
Chi si contrappone alla volontà di potenza è distruttore delle regole sociali che mantengono l’ordine della costrizione, egli è quindi nemico del sistema di regole che nella storia del pensiero si è via via costituito, fra l’altro, anche in morale, regole che a seconda di come vengono fra loro combinate danno vita alle varie scienze, dalla logica all’economia, ecc. Chi si dispone a spezzare i legami della sopraffazione che lo vincolano, pone la sua eticità altrove, cioè nella vita che lo stimola alla rottura dei legami in questione.
Ma la moralità non è nella vita come la pera in un canestro, essa consiste nella diversa attività che rende possibile, attività che si contrappone alla fatticità del mondo coatto che ci ospita. L’attività contraddistingue pertanto la moralità, l’agire e il contrario esatto del chiamarsi fuori e del giudicare sulla base di regole formali. Non è una semplice differenza di valutazione, ma trascina con sé fino in fondo, e non c’è potenza intellettuale che può metterlo a tacere quando si muove perturbando il mondo. È la vita che urla nel singolo gesto.
Che ne è stato così dello scopo? Il “fine ultimo” del bene, visto nel formalismo etico, legava l’originario “bene supremo” alla volontà di potenza che acquisendo pensava di impadronirsene. Se cerchiamo l’etica nell’impulso vitale, nella forza della vita, questa non ha scopo e ogni interpretazione organicistica ha capovolto la realtà cercando nell’organizzazione sociale un esempio dell’organismo, non invece nell’organismo una interpretazione basata sull’abitudine all’organizzazione sociale. Quando gli anarchici affermano la non necessità di un capo, di un governo, di una struttura piramidale, dicono in pratica la stessa cosa che sto dicendo qui, cioè si riferiscono a una futura possibilità che la forza vitale permei diversamente la società rendendo anacronistica qualsiasi autorità. Spesso però molti di loro cadono nell’errore che questo risultato, sia pure parziale e progressivo, possa essere frutto di una gigantesca volontà di potenza, cioè di un’acquisizione. Che ci sia qui un residuo politico è fuor di dubbio. Quando al contrario parlo di risultato parziale e propositivo, mi riferisco a momenti storici determinati in cui la forza vitale è vissuta alla luce di un livello collettivo, non in maniera accumulabile, ma tutta in una volta, tutta e subito, per poi scomparire e ricomparire nuovamente. L’eventuale residuo positivo, la crescita delle libertà e di una certa qualità complessiva nella società è sempre e soltanto uno degli aspetti del movimento produttivo della modificazione sociale.
Il condizionamento culturale diventa sempre più feroce assecondando la volontà, questa a sua volta si incupisce nella ricerca della potenza acquisendo cultura. Il movimento progressivo della storia è privo di qualunque logica interna, non ci sono dentro di esso meccanismi rigidi. Quello che noi vediamo come “progresso” dipende dal fatto di collocarci dal punto di vista dell’esistenza, una sommessa faccenda di riverniciatura delle catene.
Se invece ci collochiamo dal punto di vista etico, cioè della vita, non c’è “progresso” fin quando un solo uomo sarà schiavo, perché anch’io in questo caso sarò schiavo, e come schiavo non godo di nessun reale progresso. Questo mi dice la vita, ma l’esistenza mi fa il discorso del “negro da cortile”. Il pernicioso sofisma di Rousseau era proprio legato a una costruzione dell’unità etica dell’uomo man mano che si allontanava dalla vitalità originaria. I risultati di questa tesi sono sotto gli occhi di tutti.
Sottoposti al processo culturale e organizzativo, smussati e levigati dalla combinazione della volontà e della ragione, gli impulsi vitali, definitivamente snaturati nelle loro capacità negatorie e distruttive, sono diventati elemento della struttura, archeologiche sciocchezze come l’amore di patria, il razzismo, la proprietà, ecc., hanno riempito i cimiteri. Non potendo far vivere un corpo storpio come la società, la volontà di potenza, partendo dai canoni logici della ragione ordinatrice, ha storpiato la forza vitale, la tensione qualitativa dell’agire, immergendo l’esistenza nella brutale produzione del fare coatto.
Non si insegna a vivere e nemmeno si impara, forse l’equivoco si fonda sulla confusione tra vita ed esistenza. Non c’è pertanto eticità in pedagogia, ma solo chiacchiere e instradamento al rispetto delle regole. Se nella pedagogia includiamo (scorrettamente) anche le tecniche di iniziazione, corporee e intellettive, allora ci si lascia andare verso una concezione d’apertura della coscienza diversa che può, dentro certi limiti, avvertire meglio, più approfonditamente, il richiamo della vita. Ma questo genere di spiegazioni, sorprendendo la volontà alla fine contribuisce a un processo, non deve essere confuso con il processo vitale stesso che è altro, assolutamente altro.
La vita è posta in rapporto al destino e questo è ciò che costruiamo venendo meno all’impegno con la volontà di potenza.
Abbandonandoci all’iniziazione ci abbandoniamo al destino, e siccome l’unico modo di agire sul nostro destino è quello di abbandonarsi alla vita, ne deriva che così facendo lo costruiamo, di certo in maniera diversa di qualsiasi costruzione del mondo in cui viviamo.
L’educazione forma l’individuo secondo le regole pustolose della società in cui quest’ultimo vive, l’iniziazione lo conduce sui sentieri sconosciuti degli istinti vitali. Niente può essere più diametralmente opposto. Il punto in cui i due movimenti si collegano è la scelta, che se operata (fatta) conduce verso l’educazione, se lasciata continuamente come scelta in atto (agita), conduce verso l’iniziazione.
L’iniziazione non “forma” l’uomo, perché non suggerisce imperdonabili schemi formalizzati o regole, lo mette, spesso violentemente, di fronte alle sue disposizioni vitali, queste vengono così a trovare un ambito individuale più proficuo e possono estendere meglio la propria influenza. È facile capire che anche nel caso di un fallimento di queste iniziative, c’è sempre qualcosa della forza vitale che filtra nell’esistenza illuminandola, sia pure a tratti, di luce diversa. Anche nell’uomo più ottuso, nel poliziotto più bieco, c’è questa luce remota che non trova modo di venire fuori a causa della grande paura che all’origine aveva determinato la scelta professionale. Ciò non assolve nessuna delle sue responsabilità morali, ma fa capire meglio l’estensione delle forze vitali.
L’esistenza è regolata da norme che si presumono nate dalla sollecitazione del bene comune. È molto facile far vedere come la cosa sia tutt’altro che fondata. Lo sviluppo degli istinti vitali equivale alla loro deformazione in scialbi processi di accomodamento. Quegli istinti sono di già pieni nella loro completezza quando si manifestano, quindi non si possono sviluppare se non snaturandosi. Si possono cioè modificare, ed è proprio quello che accade quando la volontà li articola secondo ragione.
Non c’è scopo nella pulsione vitale, essa si manifesta e basta, darle uno scopo significa addomesticarla, cioè ridurla all’ingranaggio dell’esistenza. L’istinto non è coordinato a uno scopo, l’interpretazione evoluzionista della vita è, appunto, una interpretazione che parte dalle strutture dell’esistenza, le quali sono tutte munite di scopo. Anche l’abitudine è un movimento modificativo che cresce nel mondo del fare coatto. Alla pulsione vitale non si fa l’abitudine, basta su questo punto pensare all’amore.
Il rapporto tra istinti, intuizioni, sentimenti, pulsioni, ecc., non è coordinato nel senso di una possibile integrazione reciproca. Ogni movimento della vita è la vita nella sua interezza. Osservando le cose dal punto di vista del fare coatto, facciamo una comoda distinzione tra istinto, pulsione, sentimento, intuizione, ecc., ma si tratta solo di distinzioni tassonomiche fatte a posteriori, quando la vita è stata modificata in nomenclatura.
La ragione identifica e chiarisce i vari movimenti di scopo, di connessione, di affinità, di verificazione, di intensificazione e affievolimento, la volontà costruisce raccordi o relazioni con i precedenti protocolli in vista di raggiungere la potenza, l’acquisizione di protesi sempre più efficaci a sconfiggere la paura. Tutto questo movimento è considerato qualcosa di buono perché utile all’uomo nella sua lotta contro l’incognita del futuro, quindi si è pensato che il “bene” dovesse essere per forza in esso. Ogni aumento di paura del futuro è male, ogni diminuzione è bene. Immorale è chi fa paura (forse è meglio dire amorale), morale è chi conforta chi ha paura, chi illude dicendo che il futuro è assicurato. Il costume, le usanze, le leggi, le regole della logica, le prescrizioni etiche, i giudizi sintetici (e anche quelli analitici, a maggior ragione), sono prodotti all’interno di questo movimento diretto al bene. Guerre e massacri, ferocia e barbarie, tutto galleggia osceno in questo brodo schifoso chiamato “bene comune”.
È stato suggerito che non il “bene” viene così realizzato, ma solo un avvicinamento a esso, per cui non si tratta di una volizione diretta (come quella che si realizza nell’acquisizione di potenza), ma di una “intenzione”, la quale dà soltanto frutti parziali. Ed è stato suggerito che il compito etico, fra cui anche quello vischiosamente storico, sarebbe quello di individuare, nel costume, nella tradizione, nel diritto, nella filosofia, ecc., i movimenti intermedi che, prendendo altre strade, impediscono la modificazione dell’intenzione in bene comune effettivamente acquisito.
Tutto ciò è completamente errato. Le modificazioni delle singole volizioni tendono al controllo reciproco e alla separazione, producono distanza e miseria. Pensare che da esse, cioè dal fare della volontà che cerca di acquisire sempre maggiore potenza, si possa arrivare al bene comune è la medesima illusione della scienza economica. Partire dal principio del piacere e collocarlo negli impulsi vitali visti prima è un altro genere di errore, commesso in particolare dagli utilitaristi, i quali in aggiunta hanno considerato quantificabile la vita per come si esprime nella forza delle pulsioni. I loro concetti di misurabilità del bene comune ottenuto cercando ognuno la propria felicità, sono soltanto comici.
La volontà, e il suo meccanismo di ricerca della potenza, costituiscono un circolo chiuso. La ragione, e la sua logica di completezza, hanno lo stesso percorso e quindi sono anch’essi in un circolo chiuso che le costituisce. Non ci sono processi volitivi o intellettivi capaci di oggettivare gli istinti (riassumo con questa parola i concetti precedenti). Quando gli stinti vengono derubricati in “valori”, si ha la loro storicizzazione, essi decadono dal compito etico iniziale. Wundt aveva capito (nebulosamente) che non sono i valori a muovere la volontà, quindi non è la ricerca della soddisfazione, ma la coscienza come valore in sé, come vita. Pensiero importante anche se mal posto a causa della intermediarietà volontaria che sbocca sempre nel controllo e non può attingere l’eticità di cui Wundt vuole discutere.
La società in cui viviamo non è prodotta dagli istinti modificati, ma al di sopra degli istinti modificati, per cui questi ultimi non riescono mai a trasformarla in qualcosa di vivo. La volontà e la ragione sono i due infaticabili custodi del cimitero. Se la ragione, nominandola, crea la natura (formalisticamente parlando), quindi anche gli istinti, questi creano la ragione (sempre formalisticamente parlando), che torna ad agire su di essi chiudendo il circolo perverso.
Rompere l’accerchiamento significa agire diversamente.
In navigazione, primi di aprile 2001
Alfredo M. Bonanno
* * * * *
«Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontando». (N. Nietzsche, Così parlò Zarathustra).
«No, io non sono pessimista, donde io provengo, dove io cado, ciò è tutto superato. Io faccio girare un disco e sono girato, io sono tolomaico. Io non gemo come Geremia, non gemo come Paolo: quel che amo, non lo faccio, faccio solo quel che odio – io sono quel che sarò, io faccio quel che mi appare». (G. Benn, Il tolomaico).
«La voce profonda che percepiscono tutti coloro che non sono sordi ci mette in guardia su quanto ci attende, sappiamo che il male è senza rimedio e che credere nel miracolo è un’empietà, sappiamo che non risaliremo la china e che saremo lieti di discenderla per ragioni in apparenza plausibili, sappiamo che stiamo per scoppiare da un polo all’altro e perire nell’incendio che ci preparano le nostre idee al pari dei nostri mezzi. Presto il caos sarà il nostro denominatore comune, lo portiamo in noi e lo troveremo simultaneamente in mille luoghi, dappertutto il caos sarà il futuro dell’ordine, l’ordine già non ha più senso, non è più altro che un meccanismo vuoto e noi ci logoriamo nel perpetuarlo perché ci voti all’irreparabile. Innalziamo un tempio alla Fatalità, lo onoriamo di sacrifici e non è lontano il momento in cui offriremo noi stessi, il mondo è pieno di gente che sogna di morire, trascinando gli altri alla morte. Sembrerebbe quasi che gli uomini in soprannumero distillassero un veleno che si spande sull’universo e rende l’ecumene inabitabile. Perciò l’Inferno, lungi dall’essere il nulla, è la presenza». (A. Caraco, Breviario del caos).
1
“Il mondo vero – un’idea, che non serve più a niente, nemmeno più vincolante – un’idea divenuta inutile e superflua, quindi un’idea confutata: eliminiamola!”. (F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli ovvero come si filosofa col martello).
“Il malato ripercorre con la sua sofferenza tutte le tappe della storia umana, cose che egli non ha mai posseduto coscientemente nel suo Io: l’elemento bestiale, quello demoniaco, il metafisico, il titanico, tutto in lui si rispecchia sul piano cosmico nello scontro di forze mitiche”. (G. Benn, Intorno alla natura della poesia).
“Noi entriamo nella notte, dove tutto si disgrega, e ormai non possiamo più guardare indietro, dove le luci stanno spegnendosi del tutto, siamo soli con le nostre idee e le nostre opere, in balìa della loro comune dismisura. Eppure bisogna andare avanti, non è in nostro potere fermarci, abbiamo smarrito il cammino, e quando indugiamo è il cammino a trascinarci. In verità, siamo giustamente puniti per non aver ripensato il mondo, il mondo ci sfugge nel momento in cui lo umanizziamo, ci sfugge perché non vediamo chiaro in noi stessi, e non vogliamo veder chiaro per paura di dover profanare quello che ancora riveriamo. La profanazione ci avrebbe salvati, il coraggio intellettuale avrebbe contrastato la fatalità, divenuta la nostra quintessenza: gli Anarchici e i Nichilisti volevano fare tabula rasa e il futuro darà loro ragione, ma l’ordine li schiaccia e li schiaccerà, finché permane, quell’ordine che ci protegge e ci proteggerà dalla sovversione, non già dal caos e dalla morte, verso i quali ci ingiunge di marciare serrando i ranghi, gli uni contro gli altri, a passo di carica, nella notte che presto macchieremo di sangue”. (A. Caraco, Breviario del caos).
Che esista un pensiero reazionario la cosa è fuori dubbio. Che questo pensiero abbia una storia, cioè un suo sviluppo più o meno logico nel tempo, anche questo è un fatto che può essere provato. In altri termini, può essere scritta una storia del pensiero reazionario.
Il nichilismo si inserisce in questa storia quando volge lo sguardo nostalgico alla tradizione, dalla quale pensa di trarre tutto quello che manca nel presente. Se volge lo sguardo al futuro, e trae dai pericoli che in questa prospettiva si fanno sempre più pressanti, la conclusione che occorre procedere a smascheramenti del presente e del passato allo scopo di evitare l’inquietudine e la paura, non è più corretto parlato di pensiero reazionario. Scrive Nicolás Gómez Dávila: «Il mondo moderno è il risultato della confluenza di tre serie di cause tra loro indipendenti: l’espansione demografica, la propaganda democratica, la rivoluzione industriale». (Sucesivos escolios a un texto implicito, ns. tr., Bogotá 1992, p. 161). E altrove: «Esso sbocca nella barbarie della presente umanità che ha sostituito il mito di una passata età dell’oro con quello di una futura età della plastica». (Escolios a un texto implicito, vol. II, ns. tr., Bogotá 1977, p. 88). Resta da vedere se i smascheramenti critici sono ancora possibili, oppure se non si debba andare al più presto alla ricerca di una nuova strada. Secondo Gómez Dávila la verità è nella storia, anche se la storia non è la verità, questa va cercata con altri mezzi, diversi da quelli dell’osservazione. Il logos, nei termini in cui l’aveva visto Platone, forse non è più utilizzabile come protesi. Egli aveva scritto: «L’anima ragiona nel modo migliore quando nessuno dei sensi la turba, né la vista, né l’udito, né il dolore, né il piacere, ma tutta sola si raccoglie il più possibile in se stessa, lasciando il corpo e, senza alcuno scambio né contatto con esso nella misura in cui può, si protende verso l’essere». (Fedone, 65c). Il logos afferma sempre di meno, mentre la chiarezza che lasciava presupporre si va oscurando sempre di più. I valori che su di esso si erano fondati, ora cambiano colore, sbiadiscono e ingrigiscono pietosamente.
In fondo il nichilismo è di per sé già una interpretazione di ciò che si potrebbe indicare come la “paura del nulla” e che altri hanno chiamato l’“ esperienza del nulla”, momenti di panico che stanno alla base di ogni pensiero (inteso come percezione di un flusso di significati). Parmenide aveva detto: «È necessario che l’essere sia, quando è, e che il non-essere non sia, quando non è; tuttavia non è necessario che tutto l’essere sia, né che tutto il non-essere non sia; non è infatti la stessa cosa che tutto ciò che è sia necessariamente, quando è, e l’essere senz’altro di necessità. La stessa cosa si dica del non-essere». (Fr. 19a, 23-27). Il futuro ci appare sempre come qualcosa che si proietta verso il nulla e da cui sembra venirci addosso, delle due prospettive non si dà un unico significato, né una sola verità assoluta, sciolta cioè da ogni condizionamento, ma noi siamo chiamati a vivere quello che sta per accadere, e spesso ci sentiamo trascinati verso il fondo di noi stessi, in un rapporto tempestosamente equivoco con quello che veramente siamo, lontano da quello che vorremmo essere o che stiamo per diventare. Scrive Gianni Vattimo: «L’assunzione del nichilismo come una chance, come la possibilità di sopravvivere senza nevrosi nel mondo post-moderno della realtà diventata favola è anche, inscindibilmente, una accettazione della morte come condizione positiva della storia. Questa connessione, tra fabulazione del reale e gioco dei media e assunzione della mortalità costitutiva della nostra condizione, è l’unica possibile profondità e verità dell’esperienza in un mondo in cui tutto è “solo più” apparenza e superficie ma che, proprio per questo, sembra aprire nuovi orizzonti di umanità, tolleranza, in definitiva non-violenza, che, teoricamente e praticamente, sono ancora tutti da esplorare». (Apologia del nichilismo, in “Belfagor”, n. 2, 1981, p. 219). L’accadere di un mondo storicamente conosciuto per via indiretta, quindi inattendibile, ci dà l’impressione di assistere alle vicende del nulla. Vattimo, come al solito, si sbaglia, e lo sa perfettamente. Se la verità è una maschera del mondo, quindi prodotta nel mondo, che copre tutte le cose, non possiamo usarla, o dobbiamo accontentarci di quello che essa riesce a darci e non di più, come ha suggerito Heidegger. Più precisamente: «L’essenza della verità in quanto essenza della veritas e della rectitudo trapassa nella ratio dell’uomo. L’àletheúein greco, il disvelare lo svelato, che ancora per Aristotele domina completamente l’essenza della téchne, si trasforma nell’installarsi calcolante della ratio. È quest’ultima che in seguito, in virtù di una nuova metamorfosi essenziale della verità, determina la tecnicità della tecnica moderna, cioè della tecnica delle macchine, che ha la sua origine nell’ambito originario da cui proviene l’imperiale. L’imperiale scaturisce dall’essenza della verità intesa come correttezza nel senso dell’assicurazione direttiva e instaurativa della sicurezza del potere. Il “tenere per vero” della ratio, il reor, diventa il porre al sicuro anticipante e di vasta portata. La ratio diventa conto, calcolo. La ratio è l’installarsi in base al corretto. La ratio è una facultas animi, una facoltà dell’animo umano, il cui actus ha luogo all’interno dell’uomo. Distinta dalla ratio è la res, la cosa. È a quest’ultima che, nella rectitudo in quanto adaequatio, ci si deve adeguare. Ma tutto ciò avviene ora senza l’ambito essenziale, nel frattempo completamente sepolto e dimenticato, dell’alétheia , cioè della svelatezza delle cose e del comportamento disvelante dell’uomo. L’essenza della verità in quanto veritas e rectitudo è priva di spazio e di terreno. La veritas in quanto rectitudo è un carattere dell’atteggiamento psichico-mentale interno all’uomo. Perciò riguardo alla verità bisogna chiedere: come è mai possibile che un processo psichico-mentale interno all’uomo venga fatto coincidere con le cose all’esterno? Cominciano così i tentativi di fare chiarezza all’interno di una regione non chiarita. Se riflettiamo sul fatto che già da lungo tempo l’essenza dell’uomo viene intesa nel senso dell’animal rationale, cioè dell’essere vivente che pensa, ne risulta che la ratio non è una qualche facoltà fra le altre, ma la facoltà fondamentale dell’uomo». (Parmenide, tr. it., Milano 1999, pp. 109-110).
Che poi la storia della reazione si identifichi con la storia dell’irrazionalismo nichilista, questo è un altro problema. Non è per niente vero che sussista l’equazione di scuola marxista che “il sonno della ragione genera i mostri”. «Qual è la nascita del grande pessimismo? Che cosa ha provato Buddha, per fuggire all’alba da un banchetto di ebbri rovesciati scompostamente nel sonno? Il disgusto per una vita dell’uomo soltanto animale, chiusa nei dolori e nei piaceri dell’individuo. Questo sentimento radicale della religione Nietzsche lo porta con sé sin dagli anni della fanciullezza». (G. Colli, La ragione errabonda, Milano 1982, p. 152). I mostri peggiori sono stati prodotti dalla ragione, sono stati conseguenze del razionalismo e, per necessità di veicolazione e di propaganda, sono stati camuffati attraverso coreografie e ideologie irrazionaliste (mitiche e mitologiche).
Per quanto riguarda i Tedeschi c’è da dire qualcosa in più. Schopenhauer affermava che «Un errore peculiare dei Tedeschi è quello di cercare nelle nuvole ciò che hanno sotto il naso. Per spiegare i semplici rapporti di vita umani che ne costituiscono la materia [del diritto naturale], dunque torto e ragione, proprietà, Stato, diritto penale e così via, si vanno a prendere i concetti più ridondanti, astratti, e quindi più lati e privi di contenuto, e poi da essi si costruisce ora questa ora quella torre di Babele, alta fino alle nuvole, secondo i capricci peculiari del professore di turno». (Parerga e Paralipomena, vol. II, tr. it., Milano 1983, p. 316). Ecco, questa considerazione su una tendenza dei Tedeschi non è del tutto campata in aria. La filosofia tedesca ha una straordinaria pulsione verso l’astrattezza fuori misura – ed anche verso la profondità fuori misura –, alcune volte anche al di là delle indispensabili necessità dell’argomento.
Ciò è stato spiegato con la particolare storia di questo popolo negli ultimi duecento anni, con le vicende interne e internazionali della nazione tedesca, con l’evoluzione delle sue forze produttive, con la trasformazione della società. Ed è anche stato fatto bene. Però, non si può dire che ci si possa accontentare di studi, anche fondamentali, come quello di György Lukás (La distruzione della ragione, tr. it., Torino 1959). Per me, questo libro, a suo tempo, al momento della pubblicazione in Italia, fu un avvenimento fondamentale, e non solo per me. Ma facemmo presto a scoprirne i limiti e il meccanismo perverso. Alcuni non riuscirono a scoprire questi limiti, e caddero negli equivoci dello stalinismo ritardato (che poi furono equivoci anche peggiori di quelli del periodo aureo). Altri retrocedettero impauriti verso le più comode spiagge liberali e possibiliste. Io andai avanti. Il disgusto di queste pratiche preconcette mi si era di già insinuato attraverso la lettura della critica di Pareto a Marx, critica che, come scopersi poi in un ricordo di Antonio Labriola, era altrettanto preconcetta visto che il buon marchese non aveva letto, o aveva letto superficialmente, il primo libro de Il Capitale. Ma queste cose vanno così. Malgrado la successiva scoperta della malafede di Pareto non diminuirono in me né la simpatia per quest’ultimo né i sospetti verso Marx.
Comunque, tornando a Lukács, il suo libro non è certo una lettura da consigliare, e non è neanche una storia dell’irrazionalismo tedesco, mentre potrebbe dirsi una storia dell’ideologismo marxista applicato ad alcuni filosofi macchiatosi di peccati più o meno gravi (alcuni addirittura costruiti ad arte) contro la “ragione”. Monolitico Friedrich Engels: «Nel momento che facciamo uso di oggetti secondo le qualità che in essi percepiamo, sottoponiamo a una prova infallibile l’esattezza o l’inesattezza delle percezioni dei nostri sensi. Se queste percezioni erano false, anche il nostro giudizio circa l’uso dell’oggetto deve essere falso; di conseguenza il nostro tentativo di usarlo deve fallire. Ma se riusciamo a raggiungere il nostro scopo, se troviamo che l’oggetto corrisponde all’idea che ne abbiamo, che esso serve allo scopo a cui lo abbiamo destinato, questa è la prova positiva che entro questi limiti le nostre percezioni dell’oggetto e delle sue qualità concordano con la realtà esistente fuori di noi». (L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza, tr. it., Roma 1951, p. 25). Se non c’è dubbio che il pensiero deve essere riportato continuamente al suo fondamento concreto che si trova nella società, non c’è nemmeno dubbio che se questa operazione viene fatta solo ed esclusivamente come una giustapposizione ideologica non può dare frutti positivi. Si vedranno risultati che apparentemente sono allettanti, ma in sostanza riducono tutto alla solita chiacchierata in famiglia sui guai della società. Un esempio doloroso lo hanno dato, in questi ultimi decenni, i non pochi “manuali” di storia della filosofia improntati al metodo marxista, la cui lettura risulta agli inizi gradevole ed interessante, conducendo alla scoperta di connessioni e considerazioni che vecchi lettori di manuali come me non avevano magari fatto in passato. Poi, invece, ci si accorge che avendo letto uno di questi libri li si è letti tutti. La sostanza è sempre quella, come era sempre quella dei manuali idealisti e dei manuali spiritualisti o positivisti. Il supporto sociale deve essere quello necessario e non diventare il fondamento che trasforma in accidentale il pensiero, in puro fatto periferico. Altrimenti non si capisce più come il pensiero stesso si produce e come agisce, cioè come concorre a trasformare la società. Non è vero difatti che il pensiero sia un prodotto delle condizioni oggettive sociali ed economiche, come non è vero il contrario. In effetti, altrove, lo stesso Lukács aveva detto qualcosa di diverso: «La differenza che sussiste tra l’operaio di fronte alla singola macchina, l’imprenditore di fronte a un certo tipo di evoluzione delle macchine, il tecnico di fronte allo stato della scienza ed alla redditività della sua applicazione tecnica, è una differenza di grado, puramente quantitativa, e non direttamente una differenza qualitativa nella struttura della coscienza». (Storia e coscienza di classe, tr. it., Milano 1971, pp. 127-128). Le cose stanno in modo molto più complesso e le polarizzazioni di queste relazioni (influenze reciproche) non possono essere individuate attraverso il filtro ideologico.
2
“Io vi insegno il superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. L’uomo è una fune sospesa tra l’animale e il superuomo – una fune sopra l’abisso. Quel che è grande nell’uomo è che egli è un ponte e non una meta: quel che si può amare nell’uomo è che egli è una transizione e tramonto”. (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra).
“Interessante – ecco una parola significativa! Interessante – non ci porta in quella profondità opaca, tormentante, familiare, non di bel subito alle Madri, questo prediletto soggiorno tedesco – interessante non è in alcun modo identico a divertente – traducetelo alla lettera: inter-esse: tra l’essere, cioè tra la sua oscurità e il suo bagliore – olimpo dell’apparenza”. (G. Benn, Doppia vita).
“Lo spirito di dissoluzione pervade ogni cosa, noi soccombiamo con voluttà all’orrore e, colti da provvidenziale follia, riformiamo in continuazione i programmi di studio, sopprimendo, uno dopo l’altro, gli elementi che furono i gradini della chiaroveggenza. In cambio offriamo un caos di frantumi alla generazione nascente e, rifiutando le lezioni della Storia, ci affanniamo a innovare, per essere alla moda. Sicché rinunciamo alla dialettica del mutevole e del persistente, immoliamo il secondo al primo e poi ci stupiamo di non aver più alcun punto di riferimento e di ritrovarsi in mezzo ai barbari. Giacché sappiamo solo imbarbarire coloro che pretendiamo di istruire, e li rendiamo inermi di fronte alla vita fingendo di prepararveli. Nel pieno del cambiamento perpetuo, bisognava più che mai attaccarsi al persistente, bisognava più che mai meditare la Filologia e la Storia, bisognava più che mai fornirci di punti di riferimento e più che mai di campioni di pesi e misure. Abbiamo capitolato in anticipo di fronte a ciò che domani ci inghiottirà, colpevoli”. (A. Caraco, Breviario del caos).
Un interessante approccio al problema dell’irrazionalismo tedesco è contenuto nel libro di Rudolf Rocker, Nazionalismo e cultura, Edizioni Anarchismo, Catania 1977-1978, voll. I e II. (Cfr. la mia Introduzione alle pp. 7-19 del vol. I). Una vasta opera, armonicamente strutturata che affronta le vicende del potere e dello sfruttamento con riferimento particolare agli strumenti teorici forniti dalla filosofia per giustificare questi due malanni dell’umanità. Anarchico e uomo d’azione, rivoluzionario e organizzatore, Rocker, autodidatta, resta – e non poteva essere altrimenti – un esempio notevolissimo di quella cultura tedesca a cavallo tra i due secoli, che si accinge ad elaborare continue proposte modificative al ceppo idealistico-materialista di origine hegeliana, su cui si era innestata, con i contrassegni rivoluzionari, la riflessione marxista.
Rocker lavora per quasi quarant’anni al suo libro, certo non in modo continuativo, che troppe attività e troppe persecuzioni lo tennero lontano dal lavoro a tavolino, ma è nell’arco di tempo che va dall’ultimo decennio del secolo XIX agli anni Trenta che dobbiamo collocare l’elaborazione dell’opera.
Nazionalismo e cultura è un libro troppo importante, e non solo per gli anarchici, perché non si renda necessario collocarlo, nel momento della sua iniziale gestazione, in una situazione storica precisa, nulla presentando di quelle venature superficialmente utopistiche che disturbano, spesso, la lettura di certe esercitazioni libertarie. Questa volta, siamo di fronte ad un’opera di impegno colossale che si pose – e si pone – davanti ad una struttura oggettiva in trasformazione, donde possibili modificazioni nel modulo di lettura, a secondo dei possibili raccordi tra il testo e quelle situazioni passate, o possibili e contingenti situazioni da affrontare.
Con la fondazione dell’Impero tedesco, la Germania interrompe il suo ruolo di aspirante nazione capitalista per dare inizio a quello sviluppo che la porta in poco più dì un decennio a superare la stessa Inghilterra. Scrive Hagen Schulze: «L’impero tedesco, fondato nel 1871 sui campi di battaglia della Francia, era una confederazione di prìncipi tedeschi sostenuta dalle armi prussiane e legittimata dall’esultanza della borghesia tedesca di sentimenti nazionali, che nel 1848 aveva tentato invano di fondare lo Stato nazionale tedesco sulla sovranità popolare e i diritti umani e che adesso attraverso la politica di potenza di Bismarck vedeva realizzato il sogno di uno Stato di tutti i Tedeschi». (Storia della Germania, tr. it., Roma 2000, p. 103). Le condizioni ottimali di cui discuteva Marx per analizzare e attaccare il capitalismo, si trasferiscono dall’Inghilterra in Germania. Ma il popolo tedesco non è simile a quello inglese. Le strutture associative di quest’ultimo – anche di fronte a situazioni economiche similari – non sorgono automaticamente in Germania (ulteriore prova dell’inconsistenza della visione meccanicistica di un certo materialismo storico e riconferma indiretta della stessa tesi di Rocker, di cui parleremo qui di seguito).
Certo, la borghesia tedesca fa presto ad uscire dalla visione quasi medievale delle piccole città e spinta dall’amore del guadagno e del potere, si getta nella costruzione della visione capitalista del mercato nazionale, primo passo per l’impegno colonialistico e quello imperialistico. Continua Schulze: «Verso la fine degli anni settanta si sviluppò la lotta del governo contro la socialdemocrazia. August Bebel, presidente della frazione parlamentare della SPD, spaventò a morte il governo e i ceti proprietari allorché, il 25 maggio 1871, dichiarò che la Comune di Parigi era stata “una piccola scaramuccia di avanguardie” in confronto con la rivoluzione sociale che attendeva i suoi contemporanei». (Ib., p. 107). A spingere la borghesia tedesca è la volontà di dominio (evidentemente più chiara negli esponenti politici di quest’ultima) e la volontà di affacciarsi al mondo esterno. «Dopo decenni di libero scambio, uno dei principali dogmi della borghesia liberale, a metà degli anni settanta le industrie pesanti della Germania occidentale si levarono a chiedere protezioni doganali contro la concorrenza dei prodotti stranieri e, preoccupati della crescente sovrapproduzione mondiale di cereali, alla richiesta aderirono anche i contadini a est dell’Elba». (Ib., p. 111).
Gli stessi intellettuali borghesi tedeschi di questo periodo, contrariamente ad un Kant, per esempio, che non era mai uscito dalla propria città, si attaccano a tutti i possibili contatti internazionali, diventano virulenti, verbosi, sfacciati, attaccabrighe (Lassalle si fa uccide in duello, la maggior parte degli studenti universitari tedeschi porta in faccia i segni degli scontri con la spada e il fioretto come, ad esempio, il matematico Weierstrass), facilmente acquistabili dal potere politico ed economico che, via via, comincia a rendersi conto della loro importanza per il dominio del popolo. Lo stesso imperatore incarna lo spirito della nuova epoca: «A differenza del padre, Gugliemo II appariva volentieri in pubblico, era brillante e affascinante. Da studente, a Bonn, aveva imparato che sapere è potere; da cadetto a Potsdam, aveva sviluppato un’inclinazione agli atteggiamenti eroici e al culto della Prussia. Un uomo molto dotato, di brillante memoria e di acuto ingegno, ma educato in modo bigotto e romantico fino a rasentare l’assurdo e oltretutto psichicamente disturbato a causa di un braccio deforme e di una madre dispotica». (Ibidem). Ma la borghesia tedesca non ha cambiato di molto le sue strutture mentali. Resta, fra le diverse borghesie europee, una delle più facili da governare. È abile, intelligente, mediamente istruita, ma non è capace di critica nei confronti dell’autorità. Aspetta supinamente di essere organizzata, si batte, anzi, perché ciò avvenga, e quando teme di non trovare un qualsiasi “uomo del destino” fa di tutto per crearselo al più presto possibile. Più o meno intorno alla metà degli anni novanta, Max Weber scrive: «Dobbiamo comprendere che l’unificazione della Germania è stata una ragazzata che la nazione ha compiuto in età avanzata e dalla quale, dati i suoi alti costi, avrebbe fatto meglio ad astenersi, se essa doveva rappresentare la conclusione e non il momento iniziale di una potenza politica tedesca su scala mondiale». (Freiburger Antrittsrede [1895], in Gesammelte Politische Schriften, ns. tr., Tübingen 1963, p. 21).
Se la cultura tedesca ospita, tra la sconfitta della Francia del 1870 e il primo decennio del nuovo secolo, un amplissimo quadro del dibattito tra razionalismo e irrazionalismo, ciò non significa che, in ambedue i versanti, non si insista, con tutti i mezzi a disposizione, sul fatto che “i grandi uomini fanno la storia”. Che questa storia venga considerata come una linea progressiva (hegelianamente o marxianamente gestita) o che venga considerata come il dominio del caos e dell’assurdo (gestori di questa visione: Schopenhauer e Nietzsche), non sposta il discorso che il popolo deve subire. Il legame esterno tra Hegel e Marx è garantito dall’idea di progresso, il legame interno tra Schopenhauer (più conseguente) e Nietzsche (meno conseguente), è garantito dall’idea della negazione del progresso.
La Germania, sviluppatasi sulla linea capitalista, accoglie stranamente elementi culturali eterogenei, capaci di spiegare quella linea e fortemente in contrasto con essa. Schopenhauer, con precisione: «Il carattere fondamentale di tutte le cose è la transitorietà: nella natura vediamo tutto, dal metallo all’organismo, consumarsi e logorarsi, in parte a causa della sua stessa esistenza, in parte a causa del conflitto con le altre cose. Come potrebbe, allora, la natura sopportare la conservazione delle forme e il rinnovamento degli individui, l’infinito ripetersi del processo vitale, durante un tempo infinito e senza stancarsi, se il suo nucleo non fosse qualche cosa di al di fuori del tempo e perciò di assolutamente indistruttibile, una cosa in sé di genere affatto diverso dai suoi fenomeni, un qualcosa di metafisico eterogeneo a qualsiasi elemento fisico? – Cioè la volontà in noi e nel tutto. In ogni essere vivente si trova l’intero centro dell’universo. Perciò per lui la sua esistenza è la somma di tutto. Su ciò si fonda anche l’egoismo. Credere che la morte lo annienti è estremamente ridicolo, perché ogni esistenza deriva da esso solo». (Parerga e paralipomena, op. cit., p. 125). Il vecchio romanticismo tedesco, vedeva nell’esaltazione di una visione arretrata della realtà, una porta stretta attraverso cui arrivare a comprendere (meglio di un qualsiasi inglese a nome Burke) finanche il macroscopico fenomeno della rivoluzione francese. «La grande filosofia non isola l’uomo dal regno animale, come ha fatto il cristianesimo sino a Kant e alla Rivoluzione francese (Spinoza segue questo errore). La grande filosofia – quella greca più antica e quella indiana, immerge l’uomo nell’animalità, e comprende l’uomo – sotto l’aspetto universale della vita – attraverso la sua animalità. Per questo la rinascita della grande filosofia è legata al nome di Schopenhauer, e Nietzsche è un grande filosofo nella misura in cui si rivela l’unico schopenhaueriano autentico. L’uomo non è l’animale razionale che proprio per la sua ragione è superiore agli animali, e l’uomo più alto non è quello che annulla e sottovaluta tutto il resto per essere soltanto ragione. Piuttosto l’uomo è superiore agli altri animali per una maggiore intensità di vita, cioè di quel comune patrimonio che è sostanza di lui e degli altri animali: la ragione non è altro che l’espressione visibile di questa maggiore intensità, ma la natura della ragione non è indipendente dall’animalità, ma manifesta appunto questa. Tale è il grande pensiero di Schopenhauer, cui è stata assegnata la sigla di irrazionalismo, mentre in realtà non è altro che una teoria della ragione che contesta la supremazia della ragione». (G. Colli, La ragione errabonda, op. cit., p. 128). È così che, nel mutare dell’evento oggettivo (sviluppo del capitalismo), mutare violento e rapido quanto altri mai nella storia, una contraddizione persiste attraverso i decenni della grande costruzione borghese: la struttura politico-sociale, mutua modelli di comportamento del periodo precedente, come ad esempio l’inconsistenza del parlamentarismo e la persistenza del potere degli Junker prussiani (quindi persistenza di certi superati rapporti agrari), il tutto favorito dall’acquiescenza endemica della borghesia tedesca. «Nella Germania del XVIII secolo il borghese che non si è ancora impadronito del potere ma ad esso anela – grazie, in primo luogo, ad una crescente importanza economica – è preda di una malinconia che si allontana dal mondo poiché questo appartiene alla nobiltà». (W. Lepenies, Melancholie und Gesellschaft, ns. tr., Frankfurt a. M. 1969, p. 95). La vecchia divisione per Stati, ben altrimenti capace di scatenare contraddizioni all’interno del parallelo sistema italiano post-unitario, in Germania finisce per filtrare attraverso la nuova struttura capitalista, a conduzione politica parlamentare.
I migliori intellettuali guardano alla lotta filosofica, patrocinata dal dominante Schopenhauer, come ad una possibile chiave risolutiva dei mali che intravedono in una società che non riesce a seguire il modello standard dello sviluppo capitalistico inglese. Filosofia essenziale, per i Tedeschi, questa di Schopenhauer. Eccolo come propone il rapporto con la realtà: «Il problema della realtà del mondo esterno, come l’abbiamo finora considerato, derivava sempre da uno smarrimento della ragione, che giungeva sino a misconoscere se stessa, e sotto questo riguardo il problema andava risolto con la semplice chiarificazione del suo contenuto. Una volta esaminata tutta l’essenza del principio di ragione, la relazione fra oggetto e soggetto e la vera natura dell’intuizione sensibile, esso doveva eliminarsi da sé, proprio perché non gli rimaneva più alcun significato. Il problema ha però ancora un’altra origine, del tutto diversa da quella, meramente speculativa, sin qui indicata: un’origine propriamente empirica, anche se in questa forma essa viene presentata con intendimenti speculativi; ed esso ha in questo senso un significato molto più intelligibile del primo, e precisamente questo: noi abbiamo sogni; non è forse tutta la vita un sogno? – o più precisamente: esiste un criterio sicuro per distinguere sogno e realtà, fantasmi ed oggetti reali? – L’addurre la minor vivacità e chiarezza dell’immagine sognata rispetto a quella reale non merita alcuna considerazione; dato che nessuno ancora ha avuto presenti contemporaneamente l’uno e l’altro per confrontarli, ma si poteva confrontare soltanto il ricordo del sogno con la realtà presente. Kant risolve così il problema: “Il rapporto delle rappresentazioni fra di loro secondo la legge della causalità distingue la vita dal sogno”. Ma anche nel sogno ciascun particolare dipende parimenti in tutte le sue forme dal principio di ragione, e questo si rompe soltanto fra la vita e il sogno e fra i singoli sogni. La risposta di Kant potrebbe quindi essere formulata così: il lungo sogno (la vita) ha in sé connessioni costanti secondo il principio di ragione, ma non le ha coi sogni brevi; sebbene ciascuno di questi abbia in sé la stessa connessione: fra questi e quello è adunque rotto il ponte, e in base a ciò si distinguono tra loro. Tuttavia, iniziare una ricerca secondo questo criterio, per sapere se qualcosa sia sognato o realmente accaduto, sarebbe assai difficile e sovente impossibile; noi non abbiamo, infatti, in alcun modo la capacità di seguire grado per grado il nesso causale fra quella circostanza passata e il momento presente, e tuttavia non possiamo per questo riconoscerlo come sogno». (Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 5). Ancora oggi non siamo usciti da questo dilemma. Se il capitalismo viene inserito all’interno del progresso storico, come fatto limitato nel tempo, quindi come fenomeno economico interpretato attraverso un’analisi materialista, si apre la strada alla dialettica e non sempre ci si può salvare dal determinismo meccanicistico che un approssimativo entusiasmo per le scienze della fine dell’Ottocento, e in particolare per la meccanica, aveva diffuso. Se il capitalismo viene estrapolato dal progresso storico, con una negazione di quest’ultimo, si apre la strada all’irrazionalismo eternizzando il fenomeno capitalista, confortando la falsa coscienza della piccola borghesia, e creando un grosso alibi alla sua incapacità di superare il baratro che la divide dal proletariato.
Ma, ribaltando il problema, l’accettazione del meccanismo dialettico non solo consente una più chiara visione del processo storico (anche se spesso gli estremismi riformisti finiscono per sfumare quest’ultimo in un vago positivismo o darwinismo che dir si voglia, negatore di ogni capacità d’intervento dell’uomo, preda delle forze naturali e sociali), non solo esalta, nel processo storico, le capacità attive dell’uomo, il suo rapporto con la collettività, il suo rifiuto dell’azione risolutiva delle “grandi personalità”, ma, nuovo elemento di pericolo, solidifica proprio nel vasto concetto di collettività che trasforma la storia all’interno dello schema progressivo, l’idea del “nuovo capo”, un capo collettivo che si chiama partito, ma sempre capo e sempre desideroso di parlare per conto altrui.
In effetti non sappiamo che livello di comprensione ci fosse veramente della filosofia hegeliana. «Leggete la Fenomenologia, dove vi parrà quasi un poeta o un drammaturgo o un romanziere. – E l’onesto Bergson che essendo uomo di molto valore non temeva di dichiarare i limiti del suo sapere: – je vous avoue que je n’ai jamais lu Hegel. Il faudra bien le lire. – Ma non so se avesse poi il tempo di iniziarne la lettura». (G. Sasso, L’illusione della dialettica, Roma 1982, p. 204). Comunque ci fu la vasta accettazione (vedere lo sviluppo della socialdemocrazia tedesca da Bebel in poi) da parte del popolo, sempre desideroso di rimettere nelle mani di qualcuno i sia pur minimi bagliori della propria libertà. E l’irrazionalismo, il rifiuto dello schema, anche di quello progressivo della storia, se consente di sfuggire al pericolo della cattura meccanicistica di una certa dialettica, apre ogni tipo di strada al dilagare di filosofie contraddittorie (ma vive) da Bergson a Sorel, da Nietzsche a Simmel; con l’altro aspetto, questa volta conservativo, di riuscire a veicolare, in una grande quantità di luoghi comuni, tanto allettanti per il palato del borghese medio tedesco, alcuni concetti di fondo essenziali: il concetto del potere e quello dei pericoli connessi alla sua assenza. Ha scritto Giorgio Colli: «L’unico pensatore controcorrente è Schopenhauer. Nietzsche rimane immerso nell’irrazionalismo di tutto il secolo, non è uno degli scatenatori dell’irrazionalismo, anzi lo è meno di tutti gli altri, sino a che si rivolge ai Greci dell’epoca classica e a Schopenhauer. Ma neppure lui ha visto il problema della ragione. La sua formazione filosofica non ha rotto la barriera: egli ha toccato i Greci nell’arte, nel ritmo, nella storia, ma non riguardo al lógos. Il problema della ragione è la ricerca di leggi universali (anti-relativismo): quindi proprio gli illuministi, gli storicisti, gli hegeliani, i più fluidi, sono i più irrazionalisti. Essi guardano alla fenomenologia, non alle condizioni. E Nietzsche è il più razionalista, nel tentare le grandi gerarchie che discendono dalla “natura” umana». (La ragione errabonda, op. cit., p. 120).
È il periodo di fioritura dell’imperialismo. La Germania culturale si fa portatrice della violenza aggressiva della struttura economica di fondo. La vasta e rapida concentrazione capitalista rende possibile, cioè fondato, un discorso di conquista e di “spazio vitale”. «Così il cannocchiale della fantasia cinge le isole felici del passato, la lodata terra del futuro con rifrazioni di spazio multicolore». (Jean Paul F. Richter, Leben des Quintus Fixlein, in Werke, vol. IV, ns. tr., München 1963, p. 197). La cultura tedesca ne risulta permeata. Non potendo essere una nazione colonialista, perché arrivata tardi nei confronti delle altre grandi nazioni, la Germania, con tutta la fame e la sete di chi arriva tardi al banchetto, si getta sul progetto imperialista mettendo alla corda, in una specie di crociata nazionalista, le forze culturali interne. «Nel 1891, la costituzione di colonie tedesche in Africa e in Oceania divenne ufficialmente parte integrante della politica estera tedesca». (H. Schulze, Storia della Germania, op. cit., p. 122).
I due filoni del dibattito culturale e filosofico in senso specifico, forniscono due prodotti. Aveva notato Wilhelm Windelband: «La critica kantiana si distingue in linea di principio da tutte le forme di scepsi che la precedettero: perché essa ha superato proprio il presupposto generale che stava a fondamento di tutte. Quella che Kant ha superato è l’idea che lo scopo della scienza umana, e il suo criterio regolativo, consista nella riflessione di un mondo esistente indipendentemente da lei». (Preludi, tr. it., Milano 1947, p. 27). Da una parte, l’idealismo hegeliano rinnovatosi con il contatto con il neokantismo, fornisce una critica progressiva della democrazia borghese, nel senso di un miglioramento riformista (sarebbe interessante andare a vedere i rapporti tra i neo-kantiani e i marxisti tedeschi della Seconda Internazionale). «Per imprimere nelle teste degli uomini questa fede nella c. d. “rivoluzione filosofica” non si risparmiava mezzo alcuno: essa appariva infatti come uno degli strumenti più efficaci per combattere il materialismo. Dal canto suo il materialismo dialettico comprese che la minima deviazione dalla teoria del rispecchiamento in direzione agnostica rappresentava una concessione, attraverso l’agnosticismo, all’idealismo soggettívo: e diede battaglia aperta contro il pericolo del neokantismo. Così si spiega l’aspro attacco di Lenin alla teoria dei “geroglifici” di Plechanov, in cui questi, riprendendo la concezione kantiana di Helmholtz, secondo cui le percezioni sensibili ci danno non un rispecchiamento ma solo simboli della realtà, faceva delle percezioni stesse dei “geroglifici” della realtà obiettiva. Gli oggetti reali ci verrebbero cosi segnalati in questi segni: ma essi non permetterebbero una penetrazione della natura essenziale, obiettiva, di quelli, e quindi la costruzione nel pensiero di una immagine della realtà». (A. Schaff, La teoria della verità nel materialismo e nell’idealismo. Questioni generali, tr. it., Milano 1959, p. 38). Dall’altra parte, l’irrazionalismo del vecchio Schopenhauer, rivissuto da nuovi grossi pensatori (Dilthey e Simmel, per primi) fino a Nietzsche, fornisce una critica estremista della democrazia sotto qualsiasi forma si presenti. Così Georg Simmel, con la solita perspicacia: «Quando l’organizzazione del lavoro, o la situazione sociale generale, passa dalla forma personale a quella oggettiva – e, parallelamente, dalla forma dell’economia naturale a quella dell’economia monetaria – constatiamo in primo luogo o parzialmente un pareggiamento nella posizione del subordinato. In confronto al salario, la remunerazione dell’operaio in prodotti in natura presenta certamente, accanto ad una serie di pericoli, alcuni vantaggi. Infatti la prestazione in cambio di denaro sconta la sua maggiore determinatezza esterna, la sua precisione, per così dire, logica con la maggiore insicurezza del suo quantum di valore finale. Il pane e l’abitazione hanno per il lavoratore un valore che si potrebbe definire assoluto, un valore che come tale è uguale in tutti i tempi; le oscillazioni di valore, alle quali nulla di empirico può sottrarsi, ricadono sul datore di lavoro e sono indifferenti per il lavoratore. Lo stesso salario, invece, può significare oggi qualcosa di completamente diverso rispetto ad un anno fa, divide il rischio delle oscillazioni di valore tra chi dà il salario e chi lo riceve. Ma questa insicurezza e questa irregolarità, che spesso possono essere molto sensibili, sono tuttavia il correlato inevitabile della libertà. Il modo in cui si presenta la libertà è quello dell’irregolarità, dell’imprevedibilità, dell’asimmetria; perciò – come dopo verrà spiegato più esaurientemente – le costituzioni politiche liberali, come quella inglese, sono caratterizzate proprio dalle loro anomalie interne, dalla loro mancanza di un piano e di una struttura simmetrica, mentre il dispotismo tende alle strutture simmetriche, all’uniformità degli elementi, all’eliminazione di ogni elemento rapsodico. Le oscillazioni dei prezzi, per le quali l’operaio che riceve un salario affronta difficoltà completamente diverse da quelle di un lavoratore che viene pagato in natura, hanno quindi una connessione profonda con la forma di vita della libertà, che corrisponde al sistema del salario, come il pagamento in natura corrisponde alla forma di vita basata sulla servitù. Conformemente alla regola, valida al di là della politica: dove c’è una libertà c’è anche un prezzo da pagare – il lavoratore paga con l’insicurezza del salario il prezzo della libertà che essa produce o a cui apre la via. Qualcosa di analogo succede quando, al contrario, le prestazioni di chi è socialmente sottoposto passano dalla forma della prestazione in natura a quella della prestazione in denaro». (Filosofia del denaro, tr. it., Torino 1984, pp. 484-485).
Ancora una volta, occorre distinguere, per evitare errori derivanti da troppo facili conclusioni. La rivoluzione è frutto di una approfondita critica della democrazia, intesa nella sua giusta accezione di frutto politico della borghesia rivoluzionaria, storicamente determinato con tutte le conseguenze sociali connesse. «Diffido di tutti i sistematici e per la strada li evito. La volontà di sistema è una mancanza d’onestà». (F. Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli. Sentenze e frecce, 26). Ma quando la critica arriva filtrata attraverso il dispositivo di controllo marxista c’è da chiedersi due cose: a) si valuta il fatto storico in chiave riformista (forme socialdemocratiche molto di moda oggi); b) lo si valuta in chiave rivoluzionaria, ma autoritaria (forme presenti anche oggi in fasce limitate di estrazione leninista)? Scrivono Marx e Engels nel loro testo più pregno di conseguenze filosofiche: «Noi conosciamo soltanto una scienza, la scienza della storia. La storia può essere considerata da due lati; storia della natura e storia dell’umanità. I due lati, però, non sono da scindere; finché esistono gli uomini, storia della natura e storia degli uomini si condizionano reciprocamente». (L’ideologia tedesca, tr. it., Roma 1972, p. 40). Poco prima avevano affermato: «Persino questa scienza “pura” della natura ottiene il suo scopo, così come ottiene il suo materiale, soltanto attraverso il commercio e l’industria, attraverso l’attività degli uomini. Ed è tanto vero che questa attività, questo continuo lavorare e produrre sensibile, questa produzione, è la base dell’intero mondo sensibile, quale ora esiste, che se fosse interrotta anche solo per un anno Feuerbach non solo troverebbe un enorme cambiamento nel mondo naturale, ma gli verrebbe ben presto a mancare l’intero mondo umano, la sua stessa facoltà intuitiva, e anzi la sua stessa esistenza». (Ib., p. 26). La risposta a queste affermazioni ci apre la strada, vera e non approssimativa, a una critica del processo dialettico e ci consente di capire, fra l’altro, anche il discorso di Rocker sulla volontà di potenza.
Quando, invece, questa critica viene filtrata attraverso il rifiuto irrazionale c’è da chiedersi altre due cose: a) il fatto fisico e naturale lo si considera primario e staccato in modo assoluto dal contesto storico? b) c’è una vera e propria negazione dell’idea di progresso, quindi una negazione della democrazia in senso assoluto, senza possibilità di miglioramenti parziali, accumulabili nel tempo?
Questo duplice ordine di problemi era presente nella situazione tedesca dell’esplosione imperialista e aiutava ad alimentare quel malcontento degli strati superiori – professori universitari ed educatori al primo posto – che avrebbe sempre più isolato alcuni tentativi onesti di radice marxista, come i consiliaristi o gli spartachisti, obbligandoli a chiudersi in una visione settaria dell’organizzazione del proletariato (almeno di fronte alle reali possibilità della Germania di quel momento).
Richard Kroner in Von Kant bis Hegel (Tubinga 1923-24) caratterizza il rapporto di Hegel e Fichte come il movimento in cui l’io, nella misura in cui è contrapposto tramite la riflessione all’alterità, non si distingue da ogni alterità: così appartiene semmai, all’opposto, alle leggi, ai contenuti di pensiero, ai momenti della sua attività. La questione qui è fondata, come ha visto bene tutto l’idealismo tedesco, nella distinzione fichtiana di individuo e soggetto, oppure kantiana tra io come sostrato della psicologia empirica e “io penso” trascendentale.
Ma, mentre il soggetto finale resta sempre un “pezzo di mondo” (Husserl), l’io penso kantiano, cioè l’identità pura A=A, resta sempre separato da ogni causalità spazio-temporale (condizione questa per potersi risolvere senza residui nel suo stesso concetto). Quindi in Kant sembrerebbe che il primo necessita di un constitutum che si possa identificare nel secondo, ma Kant non fece mai questo passo. Per cui in Kant si ha da un lato la necessità che le forme categoriali dell’“io penso” abbiano un contenuto che derivi dalla natura, ma dall’altro lato si ha la costante considerazione delle stesse forme categoriali e dell’io penso come una datità reale. In questo senso quindi la Critica della ragione pura diventa una specie di fenomenologia soggettiva. Con questa posizione kantiana si dimostra l’irriducibilità del fattuale allo spirito.
Fichte invece ha spinto avanti la differenza tra soggetto trascendente e l’empirico ed ha tentato, vista l’inconciliabilità di entrambi al di là di Kant, di liberare il principio dell’io dalla fattualità e di giustificare in questo modo l’idealismo in quell’assolutezza che diventerà il medium del sistema hegeliano. Ma in questo modo Fichte ha portato alla luce la problematicità del suo stesso soggetto assoluto per cui è costretto a definirlo un’astrazione. Ma l’io puro deve per forza condizionare ciò da cui esso viene astratto e da cui esso stesso è condizionato in quanto, in caso contrario lo stesso concetto non potrebbe nemmeno essere pensato. Fichte ha congelato l’io astratto, e in questo Hegel non si è discostato da lui. Entrambi hanno ignorato che il termine io deve indicare la coscienza pura trascendentale e anche la coscienza empirica immediata.
L’io assoluto di Fichte e di Hegel, come astrazione dell’io empirico, può sopprimere radicalmente il suo contenuto solo non essendo più ciò da cui viene astratto cioè rinunciando alla fattualità insita nel suo concetto per cui esso non sarebbe più quella dimora della conoscenza; ma allora in questo caso cadrebbe tutta la premessa dei sistemi idealistici della priorità della soggettività. Per altro un io del genere sarebbe un assurdo in quanto non avrebbe nessuna relazione con la coscienza individuata e quindi con la persona operante nello spazio e nel tempo «L’uno e medesimo di questa relazione, – scrive Hegel – il riferimento a sé che si ha in essa, è, perciò, immediatamente, riferimento negativo a sé; vale a dire, è la mediazione che l’uno e medesimo è indifferente verso la differenza, e che il riferimento negativo a sé è quello che respinge sé da sé come riflessione in sé facendosi differenza, e si pone esistente come riflessione in altro; e, per converso, questa riflessione in altro riconduce al riferimento a sé e all’indifferenza; – il che dà la forza e la sua manifestazione. La relazione del tutto e delle parti è la relazione e conversione immediata, e perciò inintelligente, dell’identità con sé nella diversità. Si fa passaggio dalle parti al tutto e dal tutto alle parti, e si dimentica nell’uno il contrasto verso l’altro, giacché ciascuno per sé, una volta il tutto, un’altra le parti, è preso come esistenza indipendente. O, dovendo le parti consistere nel tutto, e questo di quelle, una volta l’uno, una volta le altre sono ciò che davvero sussiste; e ogni altro termine è l’inessenziale. La relazione meccanica, nella sua forma superficiale, consiste, in generale, nell’esser le parti prese come indipendenti tra di loro e verso il tutto. Il progresso all’infinito, che concerne la divisibilità della materia, si può servire anche di questa relazione; ed è allora l’alternarsi inconsapevole dei due lati di essa. Una cosa una volta è presa come un tutto, poi si passa alla determinazione delle parti: questa determinazione vien quindi dimenticata, e ciò che era parte vien considerato come tutto: poi si ha di nuovo la determinazione della parte, ecc., all’infinito. Ma questa infinità, presa come il negativo che essa è, è il riferimento negativo della relazione a sé, la forza, il tutto identico a sé, come essere in sé, e che supera questo suo essere in sé e si manifesta, e, per converso, è la manifestazione, che sparisce e torna nella forza». (Enciclopedia delle scienze filosofiche, vol. I, tr. it., Bari 1973, p. 128).
Il discorso che alla fine prevalse fu quello di critica radicale della democrazia, quindi un discorso ancora correttamente sviluppabile se non fosse stato lasciato, a seguito di alcuni accadimenti precisi, nelle mani di una minoranza di intellettuali che ne fecero un elemento notevolissimo per la borghesia al potere, elemento su cui, successivamente, si poté inserire il nazionalsocialismo. «Viviamo in un’epoca singolare, strana, inquietante. Quanto più in modo follemente veloce la gran quantità delle informazioni aumenta, tanto più decisamente si estende l’accecamento e la cecità per i fenomeni. Di più ancora, quanto più l’informazione è smisurata, tanto più minima è la capacità della consapevolezza che il pensiero moderno diventa sempre più cieco e un calcolare che non guarda, il quale ha solo l’unica prospettiva di poter contare sull’effettivo ed eventualmente sulla sensazionalità». (M. Heidegger, Seminari di Zollikon, tr. it., Napoli 1991, p. 138). La verità fu che quella critica radicale non trovava corrispettivo in un’organizzazione avanzata del proletariato (questa era gestita, al massimo, nella prospettiva socialdemocratica), né trovava rispondenza in una situazione psicologica del tedesco medio, tale da potere contare, specie fra i giovani, su di una pronta risposta a certe intuizioni teoriche nei confronti del marciume della democrazia borghese del momento. «Tra i moderni – ha notato Giorgio Colli – Burckhardt, che è forse l’unico storico filosofico (come Nietzsche sarebbe il solo filosofo storico), ha teorizzato l’opposizione – di carattere elementare – tra Stato e cultura (il terzo elemento, la religione, è concettualmente più debole, potendo nei suoi vari aspetti dicotomizzarsi nei primi due), che sembra affine alla nostra. Al primo dovrebbe appartenere l’individuo della potenza, alla seconda l’individuo della grandezza. Il nostro punto di vista si presenta però come più astratto: oltre che considerare gli elementi della storia, anziché la sua apparenza, io delineo gli archetipi, i modelli dell’umanità, i generi – nel senso di essenze – che condizionano la sua manifestazione storica, e da un lato anzi un caso limite. Inoltre la sfera burckhardtiana della cultura non si accorda affatto con ciò che viene qui suggerito come grandezza. La cultura prende origine, è vero, dalla grandezza, ma per costituirla occorre un’immersione nel campo della potenza, e quindi un’accettazione, entro certe condizioni, di questa. Tali condizioni consistono nella scelta di particolari forme sensibili che nel dominio della potenza traducano e impongano l’isolamento e l’interiorità della grandezza. Caratteristica di queste forme è la fissità sensibile – riflesso dell’immortalità della grandezza – gettata nella sfera della mortalità. Alludiamo all’espressione filosofica, artistica, scientifica, e per certi aspetti anche religiosa. D’altro canto, la grandezza come caso limite, nella sua purezza, porta lontano da ogni espressione – poiché questa implica lotta e imposizione – e quindi da ogni cultura». (La ragione errabonda, op. cit., pp. 146-147). Ecco perché tante letture di Nietzsche sono state sfruttate dai nazisti, quando, al contrario, avrebbero potuto costituire punto di partenza per un’onesta analisi delle condizioni del cancro capitalista, analisi da venire impiegata in un progetto organizzativo delle forze proletarie, tale da esaltare lo sbocco rivoluzionario. Bisogna comprendere come stavano in realtà le cose in Germania, in questi decenni a cavallo tra i due secoli.
Il popolo, in Germania, nelle fasce più coscienti, era legato ad una visione socialdemocratica e sindacalista e non domandava di meglio che consegnare le proprie deleghe. «Socialdemocrazia, Centro e Liberali di sinistra, erano a favore di una trasformazione dello Stato autoritario monarchico in moderno Stato democratico, da compiersi attraverso una fondamentale conservazione delle esistenti strutture economiche e sociali, e che dunque in un certo senso aspiravano a completare la rivoluzione del 1848». (H. Schulze, Storia della Germania, op. cit., p. 131). La classe politica radicale (marxisti compresi) accettava tutto ciò come passaggio verso una nuova fase di lotta, quella del capitalismo avanzato, che riteneva di potere intravedere nelle future modificazioni dell’imperialismo tedesco dell’epoca. «Alle forze della borghesia si contrapponevano i sostenitori di una rivoluzione rossa: un insieme eterogeneo di gruppi rivoluzionari di sinistra, tra i quali emergeva la Lega di Spartaco». (Ibidem). La borghesia gestiva il progetto imperialista e si preoccupava di reperire un consenso attraverso un’esaltazione dei canoni tradizionali del romanticismo tedesco, accumulando tutti i materiali culturali nazionalisti che poi sarebbero stati consegnati a piene mani al nazionalsocialismo. Così Peter Gay ha descritto l’esistenza di due Germanie: «L’una caratterizzata dalla boria militaresca, dalla sottomissione abietta all’autorità, dall’avventurismo aggressivo verso l’esterno, dall’ossessiva preoccupazione per la forma, e l’altra, la Germania della lirica, dell’umanesimo in filosofia, del pacifico cosmopolitismo». (La cultura di Weimar, tr. it., Bari 1978, p. 21). Da canto suo, la media borghesia, razionalizzava il mito nazionalista, stringendo la cinghia e sopportando sacrifici anche più grandi di quelli del proletariato (doveva pur sempre salvare la faccia e ciò per il tedesco è molto importante), e sognava l’avvento di un regno definitivo dell’ordine, considerato possibile proprio in forza di quelle teorie irrazionaliste che leggeva nei libri di Schopenhauer e nelle poesie di Stefan George, divulgati ormai a livello di massa all’interno di questa classe.
Gli intellettuali erano consci dell’importante ruolo che erano chiamati a recitare e del discorso che dovevano fare ai Tedeschi, come pure delle grosse possibilità che avevano di essere ascoltati da questo popolo taciturno e riflessivo. A proposito del libro di Ernest Kantorowicz, Kaiser Friedrich II (tradotto in Italia dalla Garzanti e continuamente riletto anche oggi), Peter Gay scrive: «Federico II era morto da tempo eppure ancor vivo, in attesa del riscatto di un popolo tedesco che ancora non s’era capacitato della sua reale grandezza semidivina. Kantorowicz fece molto di più che riportare delle leggende medievali. Il suo linguaggio, con le sue iperboli, con la sua balenante indeterminatezza, il suo plaudire estatico, suggerisce un coinvolgimento nel soggetto estremamente tendenzioso, sarei tentato di dire erotico, e rivela una fede in queste leggende come in profonde verità di importanza vitale per una Germania sofferente». (Ib., p. 81). E il loro discorso attingeva indiscriminatamente al progetto razionalista-hegeliano e a quello irrazionalista schopenhaueriano (rivissuto attraverso l’originale elaborazione di Nietzsche, per quello che quest’ultima poteva fare nel momento in cui cominciava a diffondersi dopo la morte dell’autore). Un piccolissimo gruppo di pensatori e di rivoluzionari cercava la sua strada fra tanto squallore. Rocker era uno di questi.
La realtà politica e sociale complessiva della Germania degli anni novanta è che il sistema permane antidemocratico, assolutista sotto molti aspetti (quelli che rendono possibile la persistenza di strutture del mondo passato, diviso in tanti piccoli Stati), e sotto certi altri semplicemente burocratica (quelli nuovi, che cadono sotto una critica superficiale di tipo efficentista, condotta da quei teorici democratici borghesi che consideravano esaurito il loro compito quando per portare a termine una pratica del ministero, invece di settantacinque passaggi se ne facevano soltanto trentadue). Dice Georg Simmel: «Nei tempi più antichi la personalità aveva nascosto e quasi fagocitato i rapporti materiali, nel tempo dello stato patrimoniale invece questi ultimi fagocitano la prima. L’economia monetaria differenzia i due elementi, beni materiali (o proprietà) e personalità diventano reciprocamente indipendenti. Il culmine raggiunto da questo processo formale nel denaro viene definito nel modo più esatto da un’espressione tipica dello stadio più progredito dell’economia monetaria: il denaro “lavora”, cioè compie le sue funzioni in base a forze e norme che non sono affatto identiche a quelle del suo proprietario, ma relativamente indipendenti da queste. Se libertà significa obbedire soltanto alle leggi della propria natura, l’allontanamento della proprietà dal proprietario, reso possibile dalla forma in denaro del guadagno, consente di raggiungere una libertà altrimenti inaudita: la divisione del lavoro tra la soggettività e le norme della cosa diviene completa, ognuno dei due ambiti ha i propri compiti da svolgere per sé, in base alla propria natura, libero dal condizionamento dell’altro, che gli è intimamente estraneo». (Filosofia del denaro, op. cit., p. 478). E questo grande popolo, che era stato capace di produrre le elaborazioni teoriche più originali ed alte, forse le più adatte al suo spirito, non riusciva nemmeno a leggere nella giusta misura le produzioni di quei critici borghesi della sua realtà che gli suggerivano lo scherzo satirico o il romanzo. L’agrario sussisteva (e si sviluppava) permanendo nelle sue forme sorpassate accanto al burocrate, e nessun paese (forse eccetto la Russia) aveva esempi tanto raffinati di burocrazia, quanto la Germania. Se il lavoratore manuale tedesco delegava se stesso nelle mani del rappresentante sindacale, e se ne compiaceva; il burocrate tedesco delegava se stesso nelle mani del superiore e, con questo, si riteneva realizzato: tutto il suo impegno si coagulava nell’adempiere in modo perfetto (se militare, in modo prussianamente perfetto), alle disposizioni delle circolari, agli ordini.
La tragedia della prima guerra mondiale non muta di molto il quadro sociale che abbiamo abbozzato per grandi linee. Cade la struttura guglielmina, ma la repubblica di Weimar non produce la capacità di accettare la democrazia e di stabilire un dibattito positivo all’interno di strutture democratiche, per un cambiamento rivoluzionario dell’organizzazione sociale. Persiste lo strano contrasto tra vecchio e nuovo, persistono le critiche bifronti del processo democratico, persiste la disposizione all’accettazione supina degli ordini. La lotta che i pochi militanti rivoluzionari, anarchici in primo piano, impegnarono, fu asperrima e si concluse con la morte di molti di loro e, più tardi, con l’esilio dei superstiti. Ma, la realtà che dovettero affrontare aveva sue strutture ben rigide: prima fra tutte, una formazione teoricamente debole delle classi proletarie. Ne derivò che quando la minoranza proletaria e intellettuale cosciente decise di attaccare la borghesia e consoci sul piano rivoluzionario, il resto del proletariato (la maggioranza), si trovò spinto dai suoi capi riformisti ad allearsi con la borghesia. Sarà questa strana unione, tipica di un’anormale situazione di sviluppo e arretratezza, quindi, di ambivalenza e di equivoco, che verrà sfruttata dai nazionalsocialisti per costruire la base di massa del loro partito.
3
“Come si potrebbe costringere la natura ad abbandonare i suoi segreti se non contrastandola vittoriosamente, ossia mediante ciò che è innaturale? Questa conoscenza la vedo impressa nella terribile triade dei destini di Edipo: lo stesso che scioglie l’enigma della natura – della Sfinge dalla duplice natura – deve anche violare, come assassino del padre e marito della madre, i più sacri ordinamenti naturali”. (F. Nietzsche, La nascita della tragedia).
“Potenza quasi inspiegabile della parola che scioglie e connette. Potenza sconcertante dell’ora da cui figure incalzano sotto l’impeto del nulla che esige una forma. Realtà trascendente della strofa piena di tramonto e piena di ritorno: la caducità dell’individuale e l’essere cosmologico, in essa si trasfigura la loro antitesi, essa sostiene i mari e l’altezza della notte e fa della creazione un sogno stigio”. (G. Benn, Pietra, verso, flauto).
“Noi odiamo un mondo pieno di insetti, e chi ci assicura che sono uomini mente: la massa di perdizione non è mai stata costituita da uomini, ma da reprobi, e perché mai un automa spermatico dovrebbe essere il mio prossimo? Se il mio prossimo deve essere questo, allora dico che non esiste e che è mio dovere non assomigliargli in nulla. La carità è solo un raggiro e coloro che me la vogliono insegnare sono miei avversari, la carità non salva un mondo pieno di insetti, che sanno soltanto divorarlo imbrattandolo con il loro lerciume: non si deve né prestar loro assistenza né ostacolare le malattie che li decimano, più ne muoiono e meglio sarà per noi, giacché non avremo bisogno di sterminarli. Stiamo entrando in un futuro barbaro e dobbiamo armarci della sua barbarie, per adeguarci alla sua dismisura e resistere alla sua incoerenza, non abbiamo altra scelta che mantenere o abdicare, non abbiamo altra che scelta che contenere o cedere, dobbiamo colpire oggi chi ci colpirebbe domani, questa è la regola del gioco, e coloro che ci implorano ci punirebbero subito per averla dimenticata”. (A. Caraco, Breviario del caos).
Rocker, che era stato costretto a lasciare la Germania nel 1893, a seguito delle leggi bismarckiane, vi fa ritorno dopo la fine della prima guerra mondiale. Si batte per la costruzione di un movimento libertario e lotta sia contro il militarismo che contro le tendenze autoritarie del marxismo. È il momento dell’avanzata gestione di Nazionalismo e cultura, che comincia a prendere forma per grandi linee, fino alla stesura originale in tedesco. Nel frattempo, le esperienze di lotta si accumulano. Il chiudersi del periodo guglielmino aveva segnato l’ingresso dei capitalisti nella direzione del monopolio tedesco, fino a quel momento diretto per interposta persona, tramite grossi personaggi politici. Non che questi mancheranno dopo (basti pensare a Hindenburg), ma vi avranno un ruolo di secondo piano. Il capitale invia direttamente i suoi uomini a ricoprire le cariche statali, instaurando una politica che vuole essere liberale e democratica ma, date le condizioni oggettive, finisce solo per mettere in risalto le contraddizioni. Gli agrari prussiani e la casta militare insistono per non perdere la supremazia, la nuova classe preme e mette in mostra la propria incapacità di utilizzare alcuni strumenti (come quello fascinoso del nazionalismo romantico) che agrari e militari avevano usato tanto bene. «Poiché non potrete vivere mai giorni felici nella stessa maniera così bella con la quale essi risplendono dopo, nel ricordo, o prima, nella speranza: preferite desiderare il giorno senza l’uno e l’altra; e poiché si percepiscono i lievi sferici accordi della musica solo ad entrambi i poli dell’ellittica volta del tempo, e non nel centro del presente, preferite restare nel centro e tendere gli orecchi, ma passato e futuro – che nessun uomo può vivere poiché sono soltanto due diversi modi poetici del nostro cuore, un’Iliade e un’Odissea, un Paradiso di Milton perduto e ritrovato – questi non li volete ascoltare e non li volete lasciar avvicinare, al solo scopo di annidarvi sordamente e ciecamente in un bestiale presente». (J. P. F. Richter, Titan, ns. tr., in Werke, vol. III, op. cit., p. 221).
Questi nuovi padroni parlano in termini di efficientismo, di produttivismo. “Mai sono cominciati i Buchenwald, e mai sono finiti. I campi di morte, genuina creazione umana, ignota alle stesse fiere, sono eterni”. (Annamaria Ortese). Le masse dei lavoratori, specialmente dopo gli avvenimenti russi, s’indirizzano un poco verso l’idea dell’organizzazione rivoluzionaria, uno spiraglio si apre ad alcuni processi di socializzazione; il fenomeno dei consigli operai e contadini non è solo un momento nella storia tedesca, vi rimane come un segno non facilmente cancellabile. Grandi speranze nel 1918, grandi delusioni negli anni successivi. Restano gli stimoli anticapitalisti, i quali vengono chiaramente individuati dalle forze neocapitaliste ed incanalati in direzione reazionaria. Scrive Max Weber: «L’ “istinto del profitto”, la “sete del guagagno”, di guadagno monetario, anzi del massimo guadagno monetario possibile; tutto ciò non ha niente a che vedere con il capitalismo. Tale aspirazione è presente, e lo è sempre stata, presso camerieri, medici, cocchieri, artisti, prostitute, impiegati venali, soldati, banditi, crociati, giocatori d’azzardo, mendicanti; è presente, si può dire, presso all sorts and conditions of men, in tutte le epoche e in tutti i paesi del mondo dove vi sia stata o vi via in qualche modo la possibilità obiettiva di raggiungere tale scopo. Questa ingenua definizione del capitalismo dovrebbe venir abbandonata una volta per tutte allo stadio primitivo della storia della cultura. La sconfinata sete di profitto non si identifica minimamente con il capitalismo, né tanto meno con il suo “spirito”. Il capitalismo, anzi, può essere identificato con il temperamento o perlomeno con il controllo razionale di questi impulsi irrazionali. Di fatto il capitalismo coincide – nella razionale impresa capitalistica a carattere stabile – con la ricerca del profitto; anzi, del profitto sempre rinnovato, della “redditività”. Perché così deve essere». (L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, in Sociologia delle religioni, tr. it., vol. I, Torino 1975, p. 92).
Per fare ciò si rende necessario uno strumento di propaganda che colpisca sentimenti irrazionali nelle masse e che risulti capace di mettere a tacere gli stimoli di socializzazione che si erano fatti sentire. Ha sottolineato Emanuele Severino: «Si può obiettare che il capitalismo non ha mai perseguito, nella sua storia, il puro profitto, ma è sempre stato vincolato e limitato da istanze religiose, morali, politiche. La democrazia, ad esempio, è un limite all’intento di porre il profitto come scopo primario della società (che è insieme l’intento di subordinare al profitto ogni altra istanza sociale). Che il capitalismo includa nei propri scopi la salvezza della Terra e l’innovazione tecnologica non è dunque altro che uno dei diversi modi in cui il perseguimento del profitto si trova ad essere limitato, vincolato e condizionato, sin dalla sua nascita, dal contesto in cui viene a trovarsi. E come il capitalismo ha continuato ad essere tale anche quando era vincolato e limitato dalle istanze religiose, morali e politiche, così continuerà ad essere capitalismo anche quando il perseguimento del profitto sarà limitato e condizionato dalla volontà di salvare la Terra e di attivare l’innovazione tecnologica. Il capitalismo sopravvive nelle forme sempre diverse che esso va assumendo nel suo rapporto con i fattori che lo limitano. Per rispondere a questa obiezione va innanzitutto rilevato che i limiti che ostacolano un’azione non possono essere qualcosa di interno ad essa, non appartengono alla sua essenza, perché altrimenti l’essenza sarebbe l’opposto di se medesima. I limiti le sono esterni quindi non possono appartenere allo scopo cui essa mira. È vero che sin dalla sua nascita il capitalismo è ostacolato, che il perseguimento del profitto è limitato da una molteplicità di contrastanti distanze sociali; ma è anche chiaro che tali istanze sono forze che, appunto, combattono il capitalismo e contro cui quest’ultimo combatte, e dunque non appartengono agli scopi che esso si propone di realizzare, ma a quelli che intende evitare. Tanto più vitale, il capitalismo, quanto più contrasta tali forze». (Il destino della tecnica, Milano 1998, pp. 65-66). Gli intellettuali si mettono al lavoro: loro committenti sono il grande capitale, i residui militaristi mai spenti, le forze agrarie prussiane. Stranamente, ma non troppo, ove si conosca bene l’indole del popolo tedesco, questi discorsi irrazionali, questi appelli al mito del passato, alla grande Germania, alla volontà di potenza, al rifiuto dell’analisi del presente, alla condanna (a parole) del capitalismo, vengono recepiti dalle grandi masse, anche da una certa parte del movimento operaio. Su questo problema Freud ha scritto: «Nella massa l’individuo si trova posto in condizioni che gli consentono di sbarazzarsi delle rimozioni dei propri moti pulsionali inconsci. Le caratteristiche apparentemente nuove che egli manifesta sono appunto le espressioni di tale inconscio, in cui è contenuto, a mo’ di predisposizione, tutto il male della psiche umana. Non abbiamo difficoltà a spiegarci il fatto che, in tali circostanze, la coscienza morale o il senso di responsabilità vengono meno: abbiamo da tempo sostenuto che il nocciolo della cosiddetta coscienza morale è l’“angoscia sociale”». (Psicologia delle masse e analisi dell’Io, in Opere, tr. it., vol. IX, Torino 1967-1993, p. 265).
Bisogna comprendere che proprio a essere responsabili di questa “apertura” verso l’irrazionalismo erano, in un certo senso, i rappresentanti di quella politica possibilista che aveva finito per disgustare i lavoratori. Questi erano stati attirati dal programma della Seconda Internazionale, avevano pensato possibili vittorie progressive, miglioramenti concreti; avevano sognato un crollo futuro (e indiscutibile) del capitalismo; avevano considerato il proprio sviluppo storico come facente parte di un tutto armonicamente razionale. Avevano, di conseguenza, abbandonato ogni concetto rivoluzionario, insurrezionale, anarchico, della lotta sociale. Quando la situazione (come i marinai ad Amburgo) li aveva spinti ad attaccare, i motivi erano presenti in modo chiaro, non potendo andare avanti si era, momentaneamente, cercata un’altra strada. Non potendosi fare massacrare in un’ultima battaglia inutile (sognata nel “crepuscolo degli dèi”, tanto caro alle fantasie dei borghesi tedeschi e tanto esaltato dai progenitori romantici degli intellettuali al servizio dei padroni), i marinai avevano scelto la strada della rivoluzione e costituito i loro “Consigli”, allargando, su tutto il territorio tedesco, un fenomeno a macchia d’olio.
Poi, finito il movente determinato, il fenomeno era rientrato nei ranghi. Il flusso del movimento operaio tedesco correva nelle sue linee precedenti del riformismo e del possibilismo. Poi, una ulteriore delusione. La repubblica di Weimar, senza ombra di democrazia e di repubblica, una critica del capitalismo senza rivoluzionari, una critica della democrazia fatta da borghesi interessati alla sua restaurazione, o da estremisti emarginati, per altro, di difficile lettura. Ha notato Giorgio Colli: «Oggi la grande filosofia sembrerebbe avere un terreno più favorevole che un secolo fa. Il mito del predominio della ragione, anche se in apparenza domina, in sostanza è stato debellato. Nelle scienze l’indirizzo tecnico – rivolto all’utile – ha preso sempre più il sopravvento, e in questo senso la ragione è stata riportata al servizio degli impulsi della vita, cessando di essere un valore per sé. Questo del resto è un processo che ha inizio con Descartes, e oggi la stessa matematica ha valore solo in quanto fornisce strumenti ai fini tecnici. Il mito sopravvive nella politica e nella cultura (uguaglianza degli uomini), ma sostanzialmente come fossile ideologico e surrogato della religione, mentre anche qui prevale l’asservimento della ragione agli impulsi della vita (maggior benessere per tutti). Per contro, le grandi guerre e i rivolgimenti sociali hanno rimesso in luce l’unitaria animalità dell’uomo, e quello che nelle guerre è apparso come violenza barbarica e crudeltà, dopo le guerre si manifesta come obbedienza agli impulsi della specie animale – affermazione sensibile dell’individuo e propagazione della specie – senza altri orizzonti. Tutto ciò che è prodotto dalla ragione in apparente antitesi a questi impulsi tende a essere spazzato via. I concetti morali, cioè prodotti della ragione tendenti a raffrenare gli istinti della vita, sono in rapido declino (e appunto essi fioriscono quando vale il mito del predominio della ragione). L’unico valore è il godimento sensibile e la ragione serve a renderlo possibile in modo ordinato e distribuito, evitando il caos barbarico degli istinti. (Da inserire la considerazione del vero significato della psicanalisi). In tutto questo Nietzsche è stato profetico, nella previsione di un tramonto del predominio della ragione. Ma questo non è che un aspetto, e non il più importante, della grande filosofia di Nietzsche». (La ragione errabonda, op. cit., pp. 129-130).
Quello che Rocker vive è un momento difficile della storia. «La solidarietà morale è incomprensibile ormai all’uomo moderno il quale rimane chiuso nella soggettivizzazione dei valori». (M. Scheler, Il risentimento nella edificazione delle morali, tr. it., Milano 1975, p. 29). Uno di quei momenti che spiegano come – con i fatti – si distruggono teorie perfette (a priori), come quella di un certo marxismo, rivissuto da epigoni interessati a cristallizzarlo onde renderlo innocuo, o smembrato nelle sue componenti da settari, da uomini di partito, da fanatici giacobini, diretti soltanto all’impadronimento del potere. In quel momento, e ancor più di fronte alla crisi del 1929, il movimento proletario tedesco presta orecchio alle mitologie irrazionaliste, accettando di diventare il supporto di massa della volontà di potenza di una ristretta minoranza di avventurieri. «La riprova di un godimento è il suo ricordo – solo i paradisi della fantasia diventano di buon grado fantasia e non vengono mai perduti, ma continuamente conquistati – solo l’arte della poesia riconcilia il passato con il futuro ed è la lira di Orfeo che comanda di arrestarsi alla stritolatrice possanza di queste due rocce». (Jean Paul F. Richter, Das Kampaner Tal, in Werke, vol. IV, ns. tr., München 1963, p. 202). Fallisce il mito marxista, altre analisi diventano urgenti. Quella di Rocker, nel quadro generale dell’analisi anarchica, è una delle più ampie e convincenti.
Rocker studia il concetto di potere e la realizzazione storica dello sfruttamento. Il primo ostacolo che incontra è la tesi di fondo del materialismo economico. Egli indica come nella storia ci siano innumerevoli eventi che non possono spiegarsi con ragioni soltanto economiche e che quindi è pericoloso incanalare tutti i fatti in uno schema concettuale rigido. «Vi sono – egli scrive – eventi storici che hanno avuto il più profondo valore per milioni di uomini, e che non possono spiegarsi con i loro aspetti puramente economici. Chi vorrebbe sostenere, per esempio, che le invasioni di Alessandro erano causate dalle condizioni di produzione del suo tempo? Il fatto stesso che l’enorme impero costituito da Alessandro con il sangue di centinaia di migliaia di uomini cadde in rovina subito dopo la sua morte dimostra che le conquiste economiche e politiche del conquistatore macedone non erano storicamente determinate da necessità economiche». (Nazionalismo e cultura, vol. I, op. cit., p. 26). In questo modo Rocker si colloca fuori dello schema del materialismo dialettico. Ciò comporta, per un pensatore tedesco rivoluzionario, il rifiuto di Hegel, oppure la rivalutazione di Kant (e di quell’interpretazione normativa che attraverso tante vicende alimenterà la scienza nuova moderna); oppure, una forte esaltazione dell’irrazionalismo da Schelling a Heidegger; oppure, l’impiego di una metodologia che si limiti a constatare l’evolversi di alcuni fatti riservandosi di prendere soltanto quelle conclusioni ritenute utili alla prassi d’intervento nella lotta concreta contro il potere.
Rocker sceglie quest’ultima direzione. E la sua scelta corrisponde non solo al suo impegno politico, ma anche alla sua estrazione sociale. «La pericolosa mania che vede in ogni fenomeno sociale solo l’inevitabile risultato dei metodi capitalistici di produzione ha impiantato negli uomini la convinzione che tutti gli eventi sociali sorgono da necessità economiche determinate e sono quindi inalterabili. Questa nozione fatalistica può condurre soltanto a paralizzare i poteri e le capacità di resistenza degli uomini, rendendoli così pronti ad accettare un compromesso con le condizioni qualsiasi per essi create, anche se siano orribili e inumane». (Ib., p. 33). Nella sua analisi, questo proletario, figlio di proletari e autodidatta, si pone di fronte al “mondo chiuso” della cultura ufficiale germanica dell’epoca, e la indaga con obiettività, con freddezza, proprio con quell’atteggiamento che può solo assumere chi non la riconosce come propria, ma come frutto dell’attività del nemico, del potere. Eppure, questa cultura va indagata, anche se non accettata, va studiata nelle sue capacità di trasformare la realtà a beneficio delle classi dominanti, e queste possibilità sono enormi.
Ebbene, il compito di Rocker sarebbe stato molto facile se la cultura tedesca ufficiale avesse presentato un unico filone di sviluppo: quello hegeliano, dentro cui si poteva anche inserire la rilettura scientista di Kant. Se fosse stato così, la lotta contro Marx si sarebbe risolta nel tentativo di ridimensionare una sinistra (per altro chiaramente riformista in Germania), riportarla alle sue responsabilità rivoluzionarie, denunciarne gli errori di metodo e quelli di strategia (autoconsunzione dello Stato). Invece egli va più in là, a questo proposito, ed ecco come si pone nei riguardi di Marx: «Benché avesse esclamato in gioventù che “i filosofi hanno variamente interpretato il mondo, ma ciò che occorre è di cambiarlo” non fece altro per parte sua che cercare in tutta la vita di interpretare il mondo e la storia. Egli analizzò la società capitalista, mostrando una grande potenza intellettuale e una enorme erudizione. Ma gli era negata la capacità creativa di Proudhon; egli rimase sempre un analista, un brillante e colto analista e null’altro. È per questa ragione che egli non arricchì il socialismo di una sola idea creativa, ma ingarbugliò le menti dei suoi seguaci nella fine rete d’una dialettica acuta che vede nella storia ben poco più dell’economia, chiudendo la via ad ogni più profonda visione del mondo degli eventi sociali». (Ib., p. 215). Contro Schopenhauer, cioè contro l’irrazionalismo utilizzato dalla grande borghesia per agganciare la media e la piccola, non si limita a far tacere una destra reazionaria senza contatti con la cultura viva, ma si rende conto che queste puntate estremiste senza fondamento possono trovare, per un verso o per l’altro, un certo riscontro nei bisogni delle masse. Infatti egli scrive, a proposito di Le Bon e Schopenhauer, ma anche di Gobineau, Chamberlain, Woltmann, ecc.: «Tutti usarono lo stesso metodo, attribuirono qualità speciali dell’individuo alle nazioni, classi e razze, e credettero d’aver così trasformato una figura astratta in un organismo vivente. È lo stesso metodo che impiegò l’uomo per crearsi i suoi dèi, trasferendo il suo proprio essere nella diafana forma della propria fantasia, e rendendolo padrone della sua propria vita». (Ib., vol. II, p. 166).
Invece la realtà tedesca accettava sia il razionalismo hegeliano, di cui il marxismo dei riformisti tedeschi era un grosso esempio; ma anche l’irrazionalismo borghese, con tutte le sue derivazioni nazionaliste, romantiche e mistiche in genere. Quindi, il primo passo che fa Rocker, un passo decisivo e che bisogna comprendere bene, è il rifiuto del concetto di totalità. «Conoscere un oggetto, significa, così afferma Kant, realizzare unità nella molteplicità delle percezioni. Dal materiale caotico della nostra rappresentazione del mondo, dal flusso continuo delle impressioni ne isoliamo alcune come appartenenti l’una all’altra e le raggruppiamo in unità che chiamiamo poi “oggetti”. Quando abbiamo raccolto la totalità delle impressioni, da raccogliere a unità, allora possiamo dire di conoscere un oggetto. Cosa altro può significare questa unità se non l’appartenenza funzionale e reciproca di quelle singole impressioni e percezioni? L’unità degli elementi non è qualcosa al di fuori degli elementi stessi, se non la forma del rapporto di appartenenza in essi permanente e soltanto da essi rappresentata». (G. Simmel, Filosofia del denaro, op. cit., p. 164). Tutto il lavoro di Rocker tiene presente questo tipo di rifiuto, quindi si fonda su di una metodologia essenzialmente diversa da quella marxista. Anche se c’è da discutere sulla sua critica – strettamente parlando – del materialismo economico, resta lo stesso, e forse anche di più, uno dei pochissimi pensatori anarchici che abbia saputo collocarsi al di là della metodologia marxista, in modo generale, e ciò proprio sulla base del rifiuto del concetto di totalità.
Quando Rocker scrive: «La volontà di potenza, che sempre sorge nella società da individui o da piccole minoranze, è di fatto la più possente forza conduttrice della storia. L’estensione della sua influenza è stata finora troppo poco considerata, benché abbia spesso avuta una influenza determinante nella formazione dell’intera vita economica e sociale», (Nazionalismo e cultura, vol. I, op. cit., p. 27), intende proporre un elemento d’indagine parziale attraverso cui giungere a disegnare un quadro generale dello sviluppo storico, che risulta quindi una conseguenza della lotta tra sfruttati e sfruttatori, ma senza che questo sviluppo, nella sua totalità, venga condizionato, fin dall’inizio, dall’appartenere a una dimensione metodologica globalizzata, cioè “pensata nella sua totalità”. Anche Rocker propone indagini parallele, come ad esempio quella sul potere e sulla religione, concludendo per una valutazione della religione come radice primaria dell’idea di potere; ma queste indagini non sono (come, per esempio, nel caso di Max Weber), poste lì per ricavarne una conclusione normativa, dogmatica, da farsi valere al di dentro di una ipotesi totalizzante. Queste indagini servono per illustrare il rapporto tra il principio fondamentale del potere e la Storia. Ecco perché sono d’accordo con l’inizio del lavoro di Rocker che, giustamente, attacca il materialismo economico marxista, anche se gli strumenti impiegati possono, oggi, allargarsi a nuove riflessioni e a nuovi metodi d’analisi. Sono d’accordo perché il nocciolo della critica è validissimo: il rifiuto della metodologia marxista, il rifiuto del concetto totalitario di totalità. Che poi sia possibile lo sviluppo di un altro concetto di totalità, questo è proprio uno dei compiti che mi sono prefisso nell’elaborazione delle mie ricerche.
Quindi, critica di Hegel e della filosofia tedesca della linea Kant-Fichte-Hegel. Scrive Rocker: «Hegel è diventato così il creatore moderno di quella cieca teoria del destino i cui sostenitori vedono in ogni evento storico una “necessità storica” e in ogni fine concepito dall’uomo una “missione storica”. Hegel è tuttora vivente nel senso che ancor nel nostro tempo v’è stato e v’è chi parla molto seriamente della missione storica di una razza o di una nazione o di una classe. E la maggior parte di loro nemmeno sospetta che questo concetto fatalistico, così mutilante per l’attività dell’uomo, abbia le sue radici nel metodo di pensiero di Hegel. Eppure in quel concetto egli esprime una fede cieca che non ha alcun rapporto con la realtà della vita e le cui implicazioni sono del tutto prive di qualsiasi prova. Gli stessi discorsi circa il “corso obbligatorio degli eventi storici” e le “necessità storicamente condizionate” della vita sociale – vuote formule ripetute fino alla nausea dai sostenitori del marxismo – che altro sono se non una nuova fede nel Fato sorta dallo spettrale mondo di Hegel, salvo che in questo caso le “condizioni di produzione” hanno assunto il ruolo dello “spirito assoluto”. Eppure ogni ora della vita dimostra che queste “necessità storiche” persistono soltanto finché gli uomini vogliono accettarle senza opposizione. Non vi sono infatti nella storia cause obbligatorie, ma soltanto condizioni che gli uomini sopportano, le quali scompaiono appena essi riescono ad accorgersi da che derivano e cominciano quindi a ribellarsi contro di esse». (Ib., p. 178). Dove, il concetto di missione storica, come aveva visto giustamente Bakunin, entra in contraddizione con la lotta rivoluzionaria che deve essere sostenuta anche quando, sulla base di un ragionamento a priori, risulta contraria agli “interessi storici” del popolo che la mette in atto, proprio perché essa porta quel popolo davanti alle proprie responsabilità, lo educa a governare se stesso, lo rende adatto ad affrontare il contrasto con quelle classi che intendono sfruttarlo. Tutto ciò non può reperirsi nella filosofia hegeliana e risulta, per ragioni di cose, zavorra e ritardo di ogni eventuale buonafede marxista.
4
“Chi, da spassionato ricercatore, segue la storia dell’occhio e delle sue forme nelle infime creature e mostra tutto il graduale divenire dell’occhio, deve pervenire al grande risultato che il vedere non è stato lo scopo riposto nella formazione dell’occhio, piuttosto esso si è presentato quando il caso ebbe messo assieme l’apparato visivo. Un unico esempio di questo genere, e le ‘finalità’ ci cadono dagli occhi come bende!”. (F. Nietzsche, Aurora).
“Qui da noi tutto dev’essere sempre e subito profondo e oscuro e onniavvolgente – presso le Madri, questo prediletto luogo di soggiorno germanico –; io credo invece che le mutazioni interiori che l’arte, che la poesia è in grado di operare, quelle che sono vere mutazioni e trasmutazioni, e il cui effetto viene propagato dalle generazioni, provengono dall’eccitante, dal fascinativo, molto più che dal pacato e dal placato, e con conseguenze assai più ricche”. (G. Benn, Pietra, verso, flauto).
“Se c’è un Dio, il caos e la morte figureranno nel novero dei Suoi attributi, se non c’è, non cambia nulla, poiché il caos e la morte basteranno a se stessi fino alla consumazione dei secoli. Non ha importanza quello che si incensa, si è vittime della caducità e della dissoluzione, qualsiasi cosa si adori non si eviterà nulla, i buoni e i cattivi hanno un solo destino, un unico abisso accoglie i santi e i mostri, l’idea di giusto e di ingiusto non è mai stata altro che un delirio, al quale ci appigliamo per ragioni di convenienza. In verità, l’origine delle idee religiose e morali è nell’uomo, cercarla fuori dell’uomo è un nonsenso, l’uomo è un animale metafisico, il quale vorrebbe che l’universo esistesse solo per lui, ma l’universo lo ignora, e l’uomo si consola di questa indifferenza popolando lo spazio di dèi, dèi fatti a sua immagine. Sicché riusciamo a vivere accontentandoci di princìpi vuoti, ma questi princìpi così belli e così consolanti cadono nel nulla quando ci si aprono gli occhi sulla morte e sul caos da cui viviamo avvolti, in costante pericolo. La fede non è che una vanità tra le altre e l’arte di ingannare l’uomo sulla natura del mondo”. (A. Caraco, Breviario del caos).
L’analisi dei rapporti tra potere e religione, sfere considerate in antagonismo da Rocker, gli consente di precisare un’analisi del potere fondata sull’indagine storica diretta a penetrare la realizzazione di questo potere nel corso dei secoli, realizzazione via via differenziata ma sempre costante sotto alcuni aspetti: primo fra tutti l’“attiva coscienza d’autorità”. «Il potere – afferma Rocker – è una attiva coscienza d’autorità. Ogni potere è animato dall’aspirazione verso il Potere unico, perché nella natura del suo essere si ritiene assoluto e perciò si oppone a ogni ostacolo che prospetti limiti alla sua influenza. Non può, come dio, sopportare nessun altro dio dinanzi a sé. È per questa ragione che si scatenano lotte per l’egemonia appena diversi gruppi di comando sorgono insieme in un paese o si trovano a dominare nello stesso tempo su paesi confinanti. Quando uno Stato sia giunto alla forza che gli consente di considerare l’uso decisivo della sua potenza, non sarà soddisfatto finché non giunga al dominio su tutti gli Stati vicini, assoggettandoli alla sua volontà. È disposto a compromessi quando non è forte abbastanza, ma appena si sente potente non esita a servirsi di qualsiasi mezzo per estendere il proprio dominio, poiché la volontà di potenza segue le sue proprie leggi, che lo Stato può mascherare ma non negare. L’aspirazione verso un solo dominio che raggruppi tutto, lo sforzo di unire meccanicamente e di assoggettare alla propria volontà ogni attività sociale, è fondamentale per qualunque potere. Non importa se consideriamo la persona del monarca assoluto dei tempi antichi, o l’unità nazionale di un governo eletto costituzionale e rappresentativo, oppure ancora le tendenze accentratrici di un partito che ha a suo motto la conquista del potere». (Nazionalismo e cultura, vol. I, op. cit., p. 58). È, ancora una volta, la volontà di potenza che viene utilizzata come strumento interpretativo della storia.
Certo, anche in Hegel (e quindi in Marx) c’è un ruolo per la volontà, ma nel marxismo di dottrina, come nell’hegelismo di scuola, questa volontà è mera affermazione intellettuale, una volontà che non vuole nulla, tutto restando in una universalità astratta storicamente razionalizzata attraverso il procedimento dialettico. Rocker non vuole capovolgere il piatto, come, in un certo senso, aveva fatto Nietzsche, per fornirci il dettato di una volontà, ancora una volta astratta, una volontà che vuole tutto e, per questo semplice motivo, continua a non volere nulla di concreto, ad essere condannata a questo volere-non volere. Scrive Schopenhauer: «Chi ha raggiunto, anche in abstracto, quindi con chiarezza e certezza, la conoscenza che ciascuno ha immediatamente in concreto, ossia come sentimento, che cioè l’essenza in sé del suo proprio fenomeno, il quale gli si presenta come rappresentazione sia nelle sue azioni, sia nel permanente loro substrato, il suo corpo, è la nostra volontà, che costituisce l’elemento immediato della nostra coscienza, ma come tale non è totalmente passata nella forma della rappresentazione, in cui si contrappongono soggetto e oggetto, bensì si manifesta in una maniera immediata, nella quale soggetto e oggetto non sono chiaramente distinti e tuttavia si rende conoscibile all’individuo, non nel suo complesso, ma solo nei suoi singoli atti: chi, io dico, ha raggiunto con me questa convinzione, troverà che questa è per lui come la chiave per la conoscenza dell’intima essenza dell’intera natura, dato che potrà applicarla anche a quei fenomeni che non gli sono dati, come i suoi propri, in conoscenza immediata oltre che mediata, ma solo in quest’ultima, quindi solo in modo unilaterale, come semplice rappresentazione. Non soltanto in quei fenomeni che sono del tutto simili al suo proprio, negli uomini e negli animali, egli dovrà riconoscere, come più intima essenza, quella medesima volontà; ma la riflessione prolungata lo condurrà a riconoscere anche la forza che ferve e vegeta nella pianta, e quella per cui si forma il cristallo, e quella che volge l’ago magnetico al polo Nord, e quella che si genera dal contatto di due metalli eterogenei, e quella che si rivela nelle affinità elettive della materia, come ripulsione e attrazione, separazione e combinazione, e da ultimo perfino la gravità, che in ogni materia così potentemente agisce, attrae la pietra alla terra e la terra al sole, tutte queste forze in apparenza diverse riconoscerà nell’intima essenza come un’unica forza, come quella forza a lui più intimamente e meglio nota di tutte le altre, che là, dove più chiaramente si produce, prende il nome di volontà. È solo quest’uso della riflessione che non ci fa più arrestare al fenomeno, bensì ci conduce sino alla cosa in sé. Il fenomeno si dice rappresentazione, e niente più: ogni rappresentazione, di qualsiasi genere sia, ogni oggetto, è fenomeno. Cosa in sé invece è soltanto la volontà: essa, come tale, non è punto rappresentazione, bensì qualcosa toto genere diversa da questa; ogni rappresentazione, ogni oggetto, è fenomeno, estrinsecazione visibile, oggettività. Essa è l’intimo essere, il nocciolo di ogni singolo, e così pure del Tutto: essa si manifesta in ogni cieca forza naturale: essa si manifesta nel meditato agire dell’uomo; la grande differenza tra questi due campi riguarda soltanto il grado della manifestazione, non l’essenza di ciò che si manifesta». (Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 21). Rocker individua la volontà di potenza come uno dei motori della storia, quindi come uno dei punti costanti di riferimento per comprendere fatti e azioni che, altrimenti, resterebbero comprensibili solo attraverso metodologie interpretative tipo quella marxista o quella irrazionalista.
La realtà è molto più varia, molto più completa, molto più ricca di quanto non possa mai sognare il procedimento dialettico, come pure di quanto potrebbe spiegare lo strumento “Volontà di potenza”, se Rocker avesse avuto la pretesa di utilizzarlo in senso dogmatico. Al contrario, egli ci suggerisce una lettura parallela, dove interviene “anche” l’elemento economico, giustamente collocato davanti al suo corrispondente reale, cioè all’elemento politico. Così scrive: «Qualsiasi sfruttamento dell’economia pubblica da parte di piccole minoranze conduce inevitabilmente all’oppressione politica; come, d’altra parte, ogni specie di predominio politico deve condurre alla creazione di nuovi monopoli economici e quindi ad un maggior sfruttamento dei gruppi più deboli della società. I due fenomeni vanno sempre assieme. La volontà di potenza è stata sempre volontà di sfruttamento del più debole; ed ogni forma di sfruttamento trova la sua espressione concreta in una struttura politica obbligata a servirle di strumento. Dove appare la volontà di potenza, l’amministrazione degli affari pubblici si muta in dominazione dell’uomo sull’uomo; la comunità assume le forme dello Stato». (Nazionalismo e cultura, vol. I, op. cit., p. 85).
Sorge naturale, quindi, la negazione dell’idea di progresso intesa in senso assolutizzante, punto di riferimento costante dell’analisi marxista. È stato spesso asserito che lo sviluppo della struttura sociale in Europa nella direzione dello Stato nazionale si è prodotto in senso progressivo ad opera della borghesia. È significante che proprio i protagonisti del “materialismo storico” siano stati i più accesi difensori di questo concetto, cercando di provare che gli eventi storici di quel tempo furono causati da necessità economiche che esigevano l’allargamento delle condizioni tecniche della produzione. Marx e Engels scrivono nel Manifesto del partito comunista: «La borghesia ha avuto nella storia una funzione sommamente rivoluzionaria. Dove è giunta al potere, essa ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali, idilliache. Essa ha lacerato senza pietà i variopinti legami che nella società feudale avvicinavano l’uomo ai suoi superiori naturali, e non ha lasciato tra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, lo spietato “pagamento in contanti”. Essa ha affogato nell’acqua gelida del calcolo egoistico i santi fremiti dell’esaltazione religiosa, dell’entusiasmo cavalleresco, della sentimentalità filistea. Ha fatto della dignità personale un semplice valore di scambio; e in luogo delle innumerevoli libertà faticosamente acquisite e patentate, ha posto la sola libertà di commercio senza scrupoli. In una parola, al posto dello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche, ha messo lo sfruttamento aperto, senza pudori, diretto e arido». (In Opere, vol. VI, tr. it., Roma 1973, pp. 488-489). In realtà, questa favola non deriva da alcuna seria considerazione dei fatti storici, ma piuttosto dal vano desiderio di presentare lo sviluppo sociale dell’Europa nella luce di una evoluzione progressiva.
Lo sforzo di negazione condotto da Rocker non deve essere sottovalutato, esso si pone contro tutta una tradizione che faceva e fa presa nel mondo intellettuale moderno, sia della Germania post-guglielmina come dell’Europa. Egli scrive: «È ben noto a tutti che le condizioni economiche hanno una loro influenza sul mutare dei rapporti sociali: è però molto più importante come gli uomini reagiscono con il loro pensiero a quella influenza per determinare le loro decisioni sulle iniziative da prendere per mettere in moto il mutamento delle condizioni da essi considerato necessario. Proprio i pensieri e le azioni degli uomini rifiutano di accettare l’impronta dei soli motivi economici. Chi vorrebbe sostenere, per esempio, che il puritanesimo, che ha così decisamente influenzato lo sviluppo spirituale dei popoli anglosassoni fino a oggi, era il risultato necessario dell’ordine economico capitalistico ancora infantile al tempo delle sue origini? Chi vorrebbe cercare di provare che la passata guerra mondiale doveva necessariamente derivare dalle condizioni del sistema capitalistico ed era perciò inevitabile in assoluto?». (Nazionalismo e cultura, vol. I, op. cit., p. 85). In più, in quel tempo, la situazione del dibattito culturale e le condizioni di sviluppo delle lotte operaie, rendevano il problema ancora più complesso e pieno di pericolose risonanze.
A difendere la tesi del progresso erano i riformisti marxisti, i democratici repubblicani (più o meno in minoranza), i borghesi più avanzati, i capitalisti che intendevano assumere in proprio la gestione statale. Scrive Engels: «Le leggi della dialettica vengono ricavate per astrazione tanto dalla storia della natura come da quella della società umana. Esse non sono appunto altro che le leggi più generali di entrambe queste fasi dell’evoluzione, e del pensiero stesso. Esse, invero, si riducono fondamentalmente a tre: la legge della conversione della quantità in qualità e viceversa; la legge della compenetrazione degli opposti; la legge della negazione della negazione. Tutte e tre sono state sviluppate da Hegel, nella sua maniera idealistica, come pure leggi del pensiero. Se noi capovolgiamo la cosa, tutto diviene più semplice: le leggi della dialettica, che nella filosofia idealistica appaiono estremamente misteriose, diventano subito semplici e chiare come il sole». (Dialettica della natura, Opere, vol. XXV, tr. it., Roma 1974, p. 357). A sostenere la tesi della negazione del concetto storico di progresso erano gli irrazionalisti, romantici e metafisici, gli agrari nazionalisti, i militaristi. Ecco René Guénon, uno dei più significativi tradizionalisti: «È un’uniformità che è stata possibile ottenere spogliando tutti gli esseri delle qualità loro proprie per ridurli a semplici “unità” numeriche. Ciò ha significato, specie nell’ambito umano, una riduzione di tutti gli esseri a semplici macchine, in quanto la macchina, prodotto tipico del mondo moderno, è appunto ciò che rappresenta, al più alto grado finora raggiunto, il predominio della quantità sulla qualità. Ciò ha determinato un “livellamento” verso il basso, cioè verso la quantità pura, che si situa al di sotto di ogni manifestazione corporea, non soltanto al di sotto del grado occupato dai più rudimentali esseri viventi, ma ancora al di sotto di quella che i nostri contemporanei hanno convenuto di chiamare “materia bruta”, la quale peraltro, manifestandosi ai sensi, è ancora lungi dall’essere interamente sprovvista di qualità». (Il regno della quantità e i segni dei tempi, tr. it., Milano 1982, pp. 54-55). Prendere partito con coraggio, fra tanto schieramento, avere la forza di dire che a essere nel torto, volutamente, erano tutti, marxisti riformisti in testa, non fu faccenda da poco.
Oggi, che siamo più agguerriti negli interventi teorici, che abbiamo tante esperienze, oggi che l’esperienza dello Stato sovietico totalitario sta lì, ormai conclusa, davanti a tutti, a dare pugni negli occhi delle nostre eventuali illusioni residue: quanti sono quelli fra noi che nello sviluppare le proprie analisi sono esenti dall’inquinamento di una certa mentalità marxista? Certamente non molti. Ebbene, Rocker, in una situazione storica molto più complessa dal punto di vista delle interconnessioni culturali, di quanto non sia la nostra, ha la capacità di scegliere la strada giusta fra le tante possibili alla critica anarchica del potere, e questa strada passa attraverso la critica del concetto di determinismo storico, di totalità storica, di necessità storica; tutti concetti che alimentano il mito del progresso. Ma la sua non è una semplice reazione culturale allo schema dialettico, come poteva essere, poniamo, quella di un qualsiasi professore universitario tedesco di quell’epoca. Egli scrive: «Le differenti forme della vita culturale hanno di per se stesso dato luogo a certe distinzioni e, benché sia arduo tracciare linee rette fra i diversi campi d’attiva cultura umana, non possiamo ancora fare a meno di esse, perché i nostri cervelli sono costruiti in tal maniera che si può progredire soltanto con l’aiuto delle stampelle dei concetti. Così, quel che indubbiamente dette il primo impulso alle più profonde interpretazioni culturali della storia, fu l’esposizione della storia puramente politica di particolari Stati il cui contenuto fu limitato quasi esclusivamente all’enumerazione delle dinastie, all’annotazione e descrizione delle guerre di conquista e alla spiegazione dei diversi sistemi governativi. Si comprese allora che queste unilaterali presentazioni non avevano esaurito in nessun modo la illimitata abbondanza degli eventi culturali, ma che invece mettevano in mostra i loro più sterili e indecenti aspetti. Perché proprio come le forze della natura non sono tutte al servizio degli scopi umani, così anche non tutto quel che avviene nell’ambiente sociale creato dall’uomo fa progredire il suo sviluppo. Alcuni di questi avvenimenti, al contrario, gli sono d’ostacolo». (Nazionalismo e cultura, vol. II, op. cit., p. 82). La sua è la presa di posizione di un militante anarchico e rivoluzionario che individua la base di una mistificazione culturale, con notevoli conseguenze nella prassi d’intervento nella realtà. Proprio in vista dei chiarimenti necessari a quest’ultimo punto, cioè all’azione concreta, la sua analisi è condotta e portata a termine.
La differenza tra i pensatori irrazionalisti tedeschi che – apparentemente fanno un discorso simile a quello di Rocker (negazione del progresso, critica della democrazia borghese, ecc.), deve essere chiaramente sottolineata. Così Schelling: «Ogni tensione alla fine si smorza, ogni conflitto trova la sua meta, e per quanto recalcitri e opponga resistenza, tutto deve alla fine rientrare nel posto che gli spetta. Poiché dunque il passaggio è naturale e necessario, non vi è bisogno di dimostrare che vi sarà un momento successivo, ma può tornare utile conoscere la modalità del progresso nel momento seguente. Già il momento precedente giungeva al punto di materializzare il principio esclusivo contro la potenza superiore e così di introdurre in generale una successione, solo che esso si oppose a tale materializzazione. Il momento successivo deve dunque essere quello in cui ciò che è assolutamente esclusivo cede la sua esclusività e si fa effettivamente materia di un superiore, ossia si rende da esso superabile. Potete immaginarvi così il concetto di cui qui si tratta e che, come comprendete da voi stessi, senza bisogno di miei richiami, è importante non solo per la mitologia ma in generale. Quel principio che si è fatto positivo contro la sua destinazione (allorché sia stato sottomesso) non deve rientrare immediatamente di nuovo nella relazione del non essere – il che sarebbe un processo totalmente all’indietro, senza senso – ma deve restare positivo e tuttavia, in quanto resti positivo, deve farsi potenziale, certo non in se stesso ma relativamente alla potenza superiore. (Diventare superabile – farsi materia – farsi potenza – sono concetti del tutto equivalenti. La pura materia ad esempio è da un lato più che pura potenza e tuttavia si comporta di nuovo come semplice possibilità, come il puro nocciolo di tutte le cose materiali che da essa provengono, ossia che essa non sarebbe in grado di produrre da sé, se non provocasse in e da esse una potenza superiore)». (F. W. J. Schelling, Filosofia della mitologia, tr. it., Milano 1990, pp. 47-48). Non c’è acquietamento possibile in questo pensiero, nel processo di apparente “superamento”. La storia non viaggia verso un porto sicuro, essa si muove verso una trasformazione potenziale della realtà, ma può presentare persistenze considerate del tutto scomparse, le quali invece erano sempre accanto a noi, nella loro orrenda potenzialità.
Quando Schopenhauer, poniamo, avanza le sue tesi sulla volontà, siamo davanti ad un filosofo borghese che considera la volontà una forza (obbligata), capace di spiegare tutto, di essere il contenuto delle cose, della realtà, ma, in sostanza, così facendo si limita a porre il problema, passando quindi a confondere il problema con la sua soluzione. «La volontà, così come la troviamo nel nostro intimo, non scaturisce dalla conoscenza, come pretendeva sinora la filosofia, e non è della conoscenza una semplice modificazione, una cosa secondaria, dunque, derivata, determinata dal cervello come la conoscenza; la volontà è il prius della conoscenza, il nucleo del nostro essere, è quella forza originaria che crea e conserva il corpo animale, del quale compie tutte le funzioni consapevoli e inconsapevoli: in ciò consiste il primo passo nella conoscenza essenziale della mia metafisica. Ancor oggi a molti sembra paradossale che la volontà in se stessa sia una cosa senza conoscenza; tuttavia già gli scolastici lo hanno in qualche modo riconosciuto e intuito; ad esempio, un esperto della loro filosofia, Giulio Cesare Vanini (la nota vittima del fanatismo e del furore pretesco), dice, a p. 181 del suo Amphiteatro: Voluntas potentia coeca est, ex scholasticorum opinione. È inoltre la medesima volontà, che fa sbocciare la gemma sulla pianta per estrarne poi foglie e fiori; e la forma regolare del cristallo è soltanto la traccia lasciata dal suo sforzo momentaneo; essa, in generale, è l’unico e vero automaton, nel senso genuino del termine, che sta alla base di tutte le forze della natura inorganica, che agisce in tutte le loro manifestazioni, che attribuisce forza alle loro leggi e si mostra anche nella massa più rozza come gravità: in questa concezione consiste il secondo passo in quella conoscenza essenziale, e risulta già da una riflessione ulteriore. Sarebbe però il più grave di tutti gli equivoci credere che si tratti qui solo di designare con una parola una grandezza sconosciuta; siamo invece di fronte alla più positiva delle conoscenze positive. Si tratta invero di riportare quello che è totalmente inaccessibile alla nostra conoscenza immediata, quello che pertanto ci è, essenzialmente estraneo e ignoto, quello che noi designiamo con la parola forza naturale, a quello che ci è più esattamente e più intimamente noto, anche se ci è accessibile solo immediatamente nel nostro essere proprio, dal quale deve perciò essere riportato agli altri fenomeni. È la concezione che quanto vi è di più intimo e originario in tutti i diversi mutamenti e movimenti corporei, è tuttavia identico nell’essenza, anche se a noi non è data che una sola occasione di conoscerlo più da vicino e immediatamente, cioè nei movimenti del nostro proprio corpo; in seguito di questa conoscenza dobbiamo allora chiamarlo volontà. È la concezione che quanto nella natura agisce e opera e si rivela in manifestazioni sempre più perfette, quando è giunto così in alto da essere direttamente illuminato dalla conoscenza – ossia quando è giunto all’autocoscienza – ci sta ora dinanzi come quella volontà che è per noi la cosa più esattamente conosciuta e non può pertanto essere spiegata con nessun’altra cosa, in quanto, al contrario. è proprio essa che spiega tutte le altre cose. La volontà è dunque la cosa in sé, nella misura in cui possa essere colta dalla conoscenza. Essa è pertanto ciò che deve estrinsecarsi, in un modo o nell’altro, in ogni cosa del mondo, in quanto del mondo è l’essenza e di tutti i fenomeni è la sostanza». (A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, II, 23). È questa la prova più certa della pericolosità di una simile tesi. L’essenza del mondo semplicemente non esiste, oppure, se la si vuole fare esistere – per comodità di analisi – essa non può essere la volontà, stimolo condizionato dall’acquisizione della potenza. Il fatto che Schopenhauer se ne sia andato alla ricerca della volontà anche nella natura, si deve collegare alla medesima preoccupazione che spingeva Engels verso i suoi studi sulla dialettica della natura. Un conservatore borghese può utilizzare qualsiasi formula teorica, anche quella marxista, ma resta conservatore e borghese, quando camuffa il problema confondendolo con la sua soluzione.
Rocker, al contrario, sempre sullo stesso argomento della volontà, dice che la volontà di potenza è strumento (problema), ma non scopo, che questo scopo è il potere (soluzione del problema), che la volontà, però, non è una totalità, quindi non è soggetta a leggi deterministiche, ma si realizza in concreto nella storia attraverso le accidentalità che si aprono, a ventaglio, sull’immenso scontro di sfruttatori e sfruttati. «Non neghiamo – egli scrive – che anche nella storia vi siano connessioni interne che possono definirsi di causa ed effetto, come nella natura: però negli eventi sociali le cause stanno sempre in desideri e fini umani, mentre nella natura si hanno sempre cause di necessità fisica. Queste ultime operano senza nessun nostro contributo, le prime sono invece soltanto manifestazioni della nostra volontà. Le idee religiose, i concetti etici, i costumi, le abitudini, le tradizioni, le opinioni legali, le organizzazioni politiche, gli istituti della proprietà, le forme della produzione, e così via, non sono necessità implicite della nostra esistenza fisica, ma soltanto i risultati a cui giunge il nostro desiderio di riuscire a realizzare scopi preconcepiti. Ogni idea di scopo è una questione di fede, che esclude il calcolo scientifico. Nel regno degli eventi fisici vale solo il deve-accadere, nel regno della fede vi è solo la probabilità del può-accadere, non già deve». (Nazionalismo e cultura, vol. I, op. cit., p. 23). Qui si pone la soluzione del problema: far sì che questo scontro volga a favore degli sfruttati, riducendo la volontà di potenza a mero strumento del potere ed esaltando la volontà di solidarietà, giustizia, umanità, al punto tale da costruire una barriera sufficiente per contrastare la prima: non banale rappresentazione, ma reale scontro, non riproduzione di uno schema intellettuale, ma elaborazione di analisi da impiegare nella lotta concreta. A mio giudizio, la sola scelta di uno strumento metodologico non qualifica l’analisi, la colloca soltanto all’interno di un campo che potrebbe riservare sorprese senza fine. Bisogna andare oltre, bisogna vedere se veramente chi assume una dimensione metodologica lo fa in vista di avvicinarsi veramente alla realtà e non, invece, per fuggire davanti ad essa, rifugiandosi dietro il paravento del metodo, delle parole e dei simboli.
Ma, questo modo di porsi davanti al problema, diventa una realtà operativa solo a condizione che si eviti lo scoglio pericoloso costituito dalla difficoltà di veicolare l’analisi a livello delle esigenze concrete rivoluzionarie. In vista di un’ipotesi astratta qualsiasi discorso, poniamo il discorso della violenza, può essere fatto su basi razionali e su basi irrazionali. Ma, solo accedendo al problema concreto, cioè alla domanda: per che cosa si ricorre all’impiego della violenza? si esce dal circolo retorico della sovrapposizione della soluzione al problema, si esce dal camuffamento tipicamente borghese dell’insolubilità del problema con il problema stesso. L’intenzione non attuata si può evitare solo impegnando tutta la persona dell’analizzatore nell’atto stesso dall’analisi, coinvolgendola interamente, senza settorializzare il suo lavoro (professore universitario, guerrigliero professionista, funzionario di partito, a questo livello non fanno differenza).
Rompendo il cerchio della frazione d’impegno, strappando i compagni ad una metodologia d’intervento che tende a creare ambiti specifici dove non possono essercene, il problema si pone immediatamente nella sua oggettiva possibilità di soluzione (limitata, come sappiamo, graduale, ma sempre soluzione operativa).