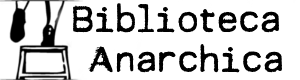Copyright: 1995 Murray Bookchin
Prima pubblicazione nel 1995 di AK Press, 370 Ryan Ave. #100, Chico, CA info@akpress.org
Traduzione di peso morto
Murray Bookchin
Anarchismo sociale o anarchismo lifestyle
Un abisso incolmabile
Anarchismo individualista e reazione
Anarchismo mistico e irrazionalista
Contro la tecnologia e la civiltà
Nota all’edizione italiana
Se il movimento anarchico non acquisterà il coraggio di considerarsi isolato, spiritualmente, non imparerà ad agire da iniziatore e da propulsore. Se non acquisterà l’intelligenza politica, che nasce da un razionale e sereno pessimismo (che è, di fatto, senso della realtà) e dall’attento e chiaro esame dei problemi, non saprà moltiplicare le sue forze, trovando consensi e cooperazione nelle masse.
Camillo Berneri
Questo testo ha avuto una storia particolarmente infelice, come lo è la storia di tutti quei lavori che cercano di affrontare un problema pressante e urgente, ma finiscono per diventare sempre più attuali con lo scorrere del tempo. A distanza di un quarto di secolo dalla pubblicazione, rimane il fatto che le questioni poste dall’autore non sono state risolte, anzi, le «deviazioni borghesi dell’anarchismo» che costituiscono l’oggetto di questo saggio hanno guadagnato sempre più terreno tra gli antiautoritari anche in Italia.
L’orizzonte politico contemporaneo è abbastanza desolante. Se c’è un elemento che più di ogni altro caratterizza la fase attuale del movimento, esso è la confusione ideologica tra i militanti. È difficile sovrastimare l’importanza di questo problema: essa conduce al disorientamento tattico e strategico, impedisce la formazione dei nuovi militanti e l’unità tra gruppi, e più in generale invalida alla base qualsiasi proposta organizzativa seria, progettuale e duratura.
Nel frattempo, stiamo assistendo al tramonto di qualsiasi prospettiva rivoluzionaria tra chi si definisce antiautoritario/a, un termine originariamente nato in seno alla Prima Internazionale per distinguere i comunisti rivoluzionari “decentralisti” da quelli centralizzatori, fautori della fase transitoria della presa del potere statale, seguaci della corrente autoritaria marxista. Viviamo in una fase storica in cui, nel migliore dei casi, la “resistenza” ha soppiantato la “rivoluzione sociale”. A quanto pare, dovremmo lasciar perdere qualsiasi ipotesi di rottura con il capitalismo e lo Stato, e pensare unicamente a resistere. Così la resistenza smette di essere una scelta tattica parziale e contestuale, che fluisce logicamente da una certa comprensione della fase, per difendersi e mantenere la posizione mentre si preparano (e non si aspettano) condizioni più favorevoli; essa sembra essere il nuovo fine. Ma la resistenza presuppone l’esistenza del nemico, non la sua distruzione. Qui non si vuole giocare con le parole, ma si parla di cose che fanno male dal tanto che sono materiali e concrete.
Ci riferiamo al fenomeno tutto italiano del “centrosocialismo”. Nel corso degli ultimi trent’anni l’immaginario politico militante è stato in buona parte colonizzato dalla categoria del “centro sociale”, spesso vere e proprie isole sottoculturali che coesistono fianco a fianco (ma comodamente separate) dalla realtà sociale che le circonda. Si tratta per lo più di una specie di integrazione funzionale con la gestione statale dei problemi sociali prodotti dal capitalismo: contenitori alternativi e sicuri di individualità “devianti” e di disagio sociale; fornitori di servizi svuotati di progettualità politica, dove il tipo di attivismo messo in pratica oscilla tra quello tipico del volontariato e quello individualista che porta alla deresponsabilizzazione sociale; che svolgono infine, da un punto di vista politico, un ruolo oggettivamente conservatore, perché prevengono strutturalmente la possibilità di una politica radicale, intercettando le spinte ribellistiche presenti nella società e canalizzandole entro acque stagnanti.
L’involuzione politica generale è così profonda che le forme, diventate veri e propri feticci, hanno rimpiazzato i contenuti: autogestione, autorganizzazione, o anche insurrezione, sono le nuove parole d’ordine degli antiautoritari, e così facendo ci siamo dimenticati come queste siano solo alcune delle forme che nel corso della storia i movimenti rivoluzionari si sono dati per esprimere ciò che invece animava qualsiasi discorso sulle tattiche e sui mezzi: il comunismo libertario, l’anarchia. D’altronde, anche questo problema è da ricondurre a quello più ampio della mancanza di consapevolezza storica e di chiarezza strategica, cui segue naturalmente quello dall’assenza di prospettive rivoluzionarie. Infatti, per i movimenti rivoluzionari del secolo scorso l’insurrezione non era che il punto zero di ogni processo rivoluzionario, cui seguiva il primo passo effettivo, l’autogestione dei mezzi di produzione da parte dei lavoratori insorti. Questo ribaltamento dei mezzi coi fini ci ha portato a un doppio vicolo cieco: un conservatorismo politico all’insegna dell’“autogestione” da un lato, che si esprime per lo più nel fenomeno dei centri sociali, e un ribellismo “insurrezionalista”, autoreferenziale e in ultima analisi sterile dall’altro.
D’altra parte, le componenti del movimento anarchico che si discostano orgogliosamente da queste manifestazioni del lifestyle non sembrano avanzare alcuna proposta alternativa e credibile. Esse si dividono tra un accademismo sterile e quel movimento d’opinione sempre criticato ma di cui si finisce a fare parte dopo anni di consolidato isolamento sociale. Nella pratica, il prodotto di questo calderone di prese di posizione e purismo dottrinale si riduce a nient’altro che un anarchismo di testimonianza. Audace nelle sue dichiarazioni e al tempo stesso inconseguente nella prassi, questo anarchismo di opinione si dimostra complice della generale deriva verso l’individualismo tra le ultime generazioni di anarchici.
Insomma, è proprio vero che “sarà la tua zona di comfort a ucciderti”, ed essa ha già fatto molte vittime, poiché tanto tra gli anarchici più o meno individualisti quanto tra i sedicenti anarchici “sociali”, l’incapacità o non-volontà di assumersi il ruolo di soggetto rivoluzionario all’interno della società rappresenta di per sé un elemento paralizzante che si auto-rinforza. Tanto più che per giustificare questa inazione si ricorre spesso e volentieri al concetto di antiautoritarismo tipico dell’anarchismo classico, il quale rigettava correttamente la nozione di stampo leninista del “rivoluzionario di professione”. Ma l’atteggiamento oggi in voga è quello di estremizzare in senso opposto la natura di questo rapporto tra gruppi politici e società, il che conduce all’inazione e alla totale deresponsabilizzazione degli anarchici nei confronti della società. Verrebbe da chiedersi che bisogna farsene allora della nozione bakuniniana di “minoranza rivoluzionaria”, che occupava un posto centrale anche nel Bakunin più maturo, o di quella makhnovista di “avanguardia anarchica”, considerando che la rivoluzione che interessò l’intera regione di Huljajpole in Ucraina nel 1918, di carattere prettamente anarchico, non venne partorita da una qualche insurrezione spontanea e creativa delle masse, ma fu il risultato di un lavoro sistematico e martellante di propaganda svolto da un ristretto nucleo di anarchici russi e ucraini tra i lavoratori delle campagne, in luoghi dove fino a pochi anni prima gli anarchici non avevano alcun tipo di presenza organizzata.
Per quanto in una fase di crisi sociale generale e di assenza di un’opposizione organizzata ed efficace, il senso di smarrimento e di impotenza possano sembrare reazioni in un certo senso “fisiologiche”, è necessario voltare pagina e scrollarsi di dosso le zavorre che ci impediscono di ritornare a discutere, di criticarci, di pensare al presente e di agire per trasformarlo. È necessario per porre le basi affinché un movimento anarchico e rivoluzionario possa sorgere negli anni a venire anche in Italia.
La pubblicazione di questo testo per il pubblico di lingua italiana vuole essere un sostegno per affrontare questo stato di paralisi confusionale. Uno dei sui meriti è quello di fissare delle coordinate per orientarsi a livello teorico; per aiutarci a capire dove vogliamo andare ma anche “da dove veniamo”, recuperando una consapevolezza storica che si sta perdendo; per risolvere le contraddizioni interne all’anarchismo contemporaneo, dando coerenza a un corpo di idee sempre più disorganico ed equivoco; per delineare, infine, gli opposti schieramenti così da individuare meglio il nemico.
Per ripartire dalla rivoluzione sociale.
– gennaio 2020
Una breve nota al lettore
Questo breve saggio è stato scritto per affrontare il fatto che l’anarchismo si trova a un punto di svolta della sua lunga e turbolenta storia.
In un periodo in cui la sfiducia popolare verso lo Stato ha raggiunto proporzioni straordinarie in molti Paesi; in cui la divisione della società tra una manciata di opulenti individui e ricche corporation contrasta fortemente con il crescente impoverimento di milioni di persone su una scala senza precedenti dal decennio della Grande depressione, in cui l’intensità dello sfruttamento ha costretto sempre più persone ad accettare una durata tipo della giornata lavorativa propria del secolo scorso, gli anarchici non hanno formato né un programma coerente né un’organizzazione rivoluzionaria per fornire una direzione al malcontento di massa che la società contemporanea sta creando.
Anzi, questo malcontento viene assorbito da parte dei reazionari e incanalato in ostilità contro le minoranze etniche, gli immigrati, i poveri e i marginali, come le madri single, i senzatetto, gli anziani, e anche gli ambientalisti, che vengono raffigurati come la principale fonte dei problemi sociali contemporanei.
Il fallimento degli anarchici – o almeno, di molti sedicenti anarchici – nel raggiungere un corpo potenzialmente enorme di sostenitori non deriva soltanto dal senso di impotenza che oggigiorno pervade milioni di persone. È dovuto in misura non trascurabile ai cambiamenti avvenuti tra molti anarchici nel corso degli ultimi due decenni. Che piaccia o no, migliaia di sedicenti anarchici hanno lentamente abbandonato il nucleo sociale delle idee anarchiche in favore dell’onnipresente personalismo New Age e yuppie che caratterizza questa era decadente e borghesizzata. In un senso molto reale del termine, essi non sono più socialisti – i difensori di una società libertaria orientata in senso comunalista – e rifuggono qualsiasi impegno serio verso un confronto organizzato, programmatico, coerente e sociale, all’ordine esistente. Sempre più numerosi, essi hanno seguito la tendenza, tipica della classe media del loro tempo, verso un personalismo decadente nel nome di un’“autonomia sovrana”, verso un misticismo nauseabondo nel nome dell’“intuizionismo”, e di una visione prelapsaria della storia nel nome del “primitivismo”. Infatti, il capitalismo stesso è stato mistificato da molti sedicenti anarchici, sostituito da un’astratta “società industriale”, e le varie oppressioni che esso infligge alla società sono state grossolanamente imputate all’impatto della “tecnologia”, non alle sottostanti relazioni sociali tra capitale e lavoro, strutturate attorno a un’economica del mercato omnipervasiva che è penetrata in ogni sfera della vita, dalla cultura all’amicizia e alla famiglia. La tendenza di molti anarchici di radicare i mali della società nella “civiltà” piuttosto che nel capitale e nella gerarchia, nella “megamacchina” invece che nella mercificazione della vita, e in confuse “simulazioni” invece che nella tirannia molto tangibile della volontà materiale e dello sfruttamento, non è dissimile dall’apologia che la borghesia fa del downsizing delle moderne corporation, visto come il prodotto degli “sviluppi tecnologici” piuttosto che dell’appetito insaziabile della borghesia per il profitto.
La mia enfasi nelle pagine che seguono riguarda la fuga costante dei sedicenti anarchici contemporanei dal dominio sociale che ha formato l’arena principale dei primi anarchici, come gli anarcosindacalisti e i comunisti libertari rivoluzionari, a favore di avventure episodiche che rifuggono qualsiasi impegno organizzativo e coerenza intellettuale; e in modo ancora più disturbante, a favore di un crudo egoismo che si nutre della più ampia decadenza culturale espressa dall’attuale società borghese.
Gli anarchici, a dir la verità, possono giustamente celebrare il fatto di avere per lungo tempo perseguito la libertà sessuale totale, l’estetizzazione della vita quotidiana, e la liberazione dell’umanità dalle oppressive costrizioni psichiche che le hanno negato la sua piena libertà sensuale tanto quanto intellettuale. Da parte mia, in quanto autore di Desire and Need, scritto circa trent’anni fa, posso solo che applaudire all’affermazione di Emma Goldman che una rivoluzione non è tale se non si può ballare; e come aggiunsero i miei progenitori wobbly all’inizio di questo secolo, una rivoluzione in cui non si possa cantare.
Ma come minimo, essi volevano una rivoluzione – una rivoluzione sociale – senza la quale questi obiettivi estetici e psicologici non avrebbero potuto essere ottenuti per l’umanità nel suo insieme. Ed essi hanno fatto di questo elementare sforzo rivoluzionario il centro di tutte le loro speranze e ideali. Purtroppo, questo sforzo rivoluzionario, e di fatto l’idealismo di sani principi e la coscienza di classe sulle quali poggia, è centrale a sempre meno sedicenti anarchici che incontro al giorno d’oggi. È propriamente lo sguardo sociale e rivoluzionario, così fondamentale alla definizione di anarchismo sociale, con tutti i suoi sostegni organizzativi e teoretici, che vorrei recuperare nell’analisi critica dell’anarchismo lifestyle che occupa le pagine a seguire. A meno di essermi sbagliato di grosso – come spero sia il caso – i fini rivoluzionari e sociali dell’anarchismo stanno soffrendo un’erosione molto profonda fino al punto in cui la parola anarchia rischia di diventare parte del vocabolario borghese del secolo che verrà; dispettosa, ribelle, noncurante, ma deliziosamente innocua.
– 12 luglio 1995
Per circa due secoli l’anarchismo – un corpo assai ecumenico di idee anti-autoritarie – si è sviluppato nella tensione tra due tendenze sostanzialmente contraddittorie: un impegno personalistico all’autonomia individuale e un impegno collettivistico per la libertà sociale. Nella storia del pensiero libertario queste due tendenze non sono mai state riconciliate. Infatti, per gran parte dell’ultimo secolo, sono semplicemente coesistite all’interno dell’anarchismo in quanto credo minimalista di opposizione allo Stato, invece che come credo massimalista che esprimesse il tipo di società nuova che si voleva creare al suo posto.
Questo non significa che varie scuole di pensiero dell’anarchismo non sostenessero forme molto specifiche di organizzazione sociale, benché spesso notevolmente in disaccordo tra loro. Fondamentalmente, tuttavia, l’anarchismo nel suo insieme avanzava ciò che Isaiah Berlin ha chiamato una «libertà negativa», cioè una formale “libertà da”, piuttosto che una sostanziale “libertà di”. Infatti, l’anarchismo ha spesso celebrato il proprio impegno verso una libertà negativa a dimostrazione del proprio pluralismo, di tolleranza ideologica, o di creatività; o anche, come ha sostenuto più di un celebrante recente del postmodernismo, della sua incoerenza.
Il fallimento dell’anarchismo nel risolvere questa tensione, di articolare la relazione tra l’individuo e il collettivo, e di enunciare le circostanze storiche che renderebbero possibile una società anarchica e senza Stato, ha prodotto nel pensiero anarchico dei problemi che rimangono tutt’oggi irrisolti. Pierre Joseph Proudhon, più di molti altri anarchici del suo tempo, ha cercato di formulare un’immagine abbastanza concreta di cosa dovesse essere una società libertaria. Fondata su contratti, essenzialmente tra piccoli produttori, cooperative e comuni, la visione di Proudhon era evocativa del mondo provinciale e artigianale nel quale era nata. Ma il suo tentativo di combinare una nozione paternalistica, spesso patriarcale di libertà, con accordi sociali contrattuali era profondamente carente. L’artigiano, la cooperativa, la comune, che si relazionano l’uno con l’altro nei termini contrattuali borghesi di equità o giustizia invece che nei termini comunisti di capacità e bisogni, rifletteva la propensione artigiana per l’autonomia personale, lasciando indefinito qualsiasi impegno morale verso una qualche collettività che andasse oltre la buona volontà dei suoi membri.
Infatti, la famosa affermazione di Proudhon che «chiunque mi metta le mani addosso per governarmi è un usurpatore e un tiranno; io lo proclamo mio nemico», è fortemente inclinata verso una libertà personalistica, negativa, che eclissa la sua opposizione a istituzioni sociali oppressive, così come la visione della società anarchica che egli prefigurava. La sua affermazione si mescola facilmente alla dichiarazione spiccatamente individualista di Williams Godwin: «Vi è un solo potere al quale posso prestare un’obbedienza convinta: la decisione della mia intelligenza, il comando della mia coscienza». Il richiamo di Godwin all’“autorità” della propria intelligenza e della propria coscienza, così come la condanna di Proudhon della “mano” che minaccia di restringere la sua libertà, hanno dato all’anarchismo una spinta enormemente individualista.
Per quanto avvincenti possano risultare tali dichiarazioni – e negli Stati Uniti si sono guadagnate una considerevole ammirazione da parte dei cosiddetti libertariani[1] (più correttamente, proprietariani) di destra, con le loro dichiarazioni in favore della “libera” impresa – esse rivelano un anarchismo in contraddizione con se stesso. D’altra parte, Michail Bakunin e Petr Kropotkin si trovavano su posizioni essenzialmente collettiviste; nel caso di Kropotkin, esplicitamente comuniste. Bakunin privilegiava enfaticamente il sociale sull’individuo. La società, egli scriveva,
è anteriore e allo stesso tempo sopravvive a ciascun individuo umano; essa è eterna come la natura; o, meglio, dato che è nata sulla terra, essa durerà tanto quanto durerà la nostra terra. Una rivolta radicale contro la società sarebbe altrettanto impossibile quanto una rivolta contro la natura, giacché la società umana non è altro che l’ultima grande manifestazione o creazione della natura su questa terra; e un individuo che volesse ribellarsi contro la società […] si getterebbe oltre il regno dell’esistenza reale.[2]
Bakunin espresse di frequente e con notevole enfasi polemica la sua opposizione alla tendenza individualista presente nel liberalismo e nell’anarchismo. Nonostante la società sia «grata agli individui», egli scrisse in un passaggio relativamente mite, la formazione dell’individuo è sociale:
anche il più miserabile individuo della nostra attuale società non potrebbe esistere e svilupparsi senza gli sforzi sociali cumulativi di innumerevoli generazioni. Così l’individuo, la sua libertà e la sua ragione, sono i prodotti della società, e non viceversa: la società non è il prodotto degli individui che la compongono; e tanto più l’individuo si sviluppa, maggiore è la sua libertà; e tanto più esso è il prodotto della società, tanto più egli riceve dalla società e maggiore è il suo debito verso di essa.[3]
Da parte sua, Kropotkin mantenne questa enfasi collettivistica con notevole consistenza. In quello che fu probabilmente il suo scritto più letto, il suo saggio sull’anarchismo apparso nell’Encyclopaedia Britannica, Kropotkin colloca in modo fermo le concezioni economiche dell’anarchismo alla «sinistra» di «tutti i socialismi», invocando la radicale abolizione della proprietà privata e dello Stato nello «spirito dell’iniziativa locale e personale, e della libera federazione dal semplice al composto, in sostituzione della presente gerarchia che va dal centro alla periferia». Infatti, gli scritti di Kropotkin sull’etica comprendono una critica sostenuta ai tentativi liberali di contrapporre l’individuo alla società, per subordinare nei fatti la società all’individuo o all’ego. Egli si collocava esattamente all’interno della tradizione socialista. Il suo comunismo anarchico, predicato sulla base di progressi nel campo della tecnologia e nell’incremento della produttività, divenne un’ideologia libertaria predominante negli anni Novanta del diciannovesimo secolo, che portò avanti con continuità nozioni collettiviste sulla distribuzione basate sull’equità. Gli anarchici, «insieme alla maggior parte dei socialisti», sottolineava Kropotkin, riconoscono il bisogno di «fasi di evoluzione accelerata che vengono chiamate rivoluzioni», che portino infine a una società fondata sulle federazioni di «ogni municipalità o comune dei gruppi locali di produttori e consumatori».[4]
Con l’emergenza dell’anarcosindacalismo e del comunismo anarchico tra fine diciannovesimo e inizio ventesimo secolo, il bisogno di risolvere la tensione tra le tendenze individualista e collettivista divenne sostanzialmente accademico.[5] L’individualismo anarchico fu di fatto reso marginale dai movimenti di massa e socialisti dei lavoratori, all’interno dei quali gli anarchici si consideravano l’ala sinistra. In un’era di turbolenti rivolgimenti sociali, segnata dall’ascesa di un movimento di massa dei lavoratori culminato nella Rivoluzione Spagnola degli anni Trenta, gli anarcosindacalisti e i comunisti anarchici, non meno dei marxisti, consideravano l’individualismo anarchico una stravaganza piccolo-borghese. Lo attaccavano spesso e in modo piuttosto diretto in quanto vizio borghese, radicato molto più nel liberalismo che nell’anarchismo.
Questa fase storica permetteva a malapena agli individualisti, nel nome della propria “unicità”, di ignorare il bisogno di forme di organizzazione energetiche e rivoluzionarie dotate di programmi coerenti e convincenti. Ben lontani dall’indulgere nella metafisica di Max Stirner dell’ego e della sua “unicità”, gli attivisti anarchici avevano bisogno di una letteratura di base che gli permettesse di orientarsi a livello teorico, discorsivo e programmatico, esigenza che venne soddisfatta, tra gli altri, da La conquista del pane di Kropotkin, da El organismo económico de la revolución di Diego Abad de Santillán, e da The political Philosophy of Bakunin di G.P. Maximoff. Che io sappia, nessuna stirneriana “unione degli egoisti” salì mai alla ribalta; sempre assumendo che tale unione avesse potuto stabilirsi e sopravvivere all’“unicità” dei suoi egocentrici partecipanti.
Anarchismo individualista e reazione
A essere precisi, l’individualismo ideologico non sparì mai del tutto in questo periodo di agitazioni sociali travolgenti. Una riserva considerevole di anarchici individualisti, soprattutto nel mondo angloamericano, si nutrì delle idee di John Locke e John Stuart Mill, nonché dello stesso Stirner. L’orizzonte anarchico era costellato di individualisti nostrani con vari gradi di attaccamento alle idee libertarie. Nella pratica, gli individualisti anarchici attraevano per lo più individui, da Benjamin Tucker negli Stati Uniti, sostenitore di una visione pittoresca della libera competizione, a Federica Montseny in Spagna, la quale ha spesso onorato le sue convinzioni stirneriane nei momenti peggiori. Nonostante il proprio riconoscersi nell’ideologia comunista anarchica, anche alcuni nietzschiani come Emma Goldman mostravano un’affinità di spirito nei confronti degli individualisti.
Difficilmente un individualista anarchico ha mai esercitato una qualche influenza sulla classe lavoratrice emergente. Essi esprimevano la propria opposizione in modi esclusivamente personali, per lo più attraverso atteggiamenti irruenti, comportamenti scandalosi e stili di vita aberranti nel ghetto culturale di fine secolo a New York, Parigi e Londra. In quanto credo, l’anarchismo individualista rimaneva uno stile di vita fortemente bohémien, vistoso più che altro nelle sue richieste per la libertà sessuale (il “libero amore”) e attratto dalle innovazioni artistiche, comportamentali e stilistiche.
Fu in tempi di pesante repressione sociale e di quiescenza sociale isolante che gli anarchici individualisti ottennero il primo piano nell’attività libertaria; e principalmente in quanto terroristi. In Francia, in Spagna, negli Stati Uniti, gli anarchici individualisti commisero atti terroristici che diedero all’anarchismo la sua reputazione di cospirazione malvagia e violenta. Coloro che diventarono terroristi, anziché socialisti libertari o comunisti, erano più spesso uomini e donne disperati che usarono armi ed esplosivi per protestare contro le ingiustizie e il filisteismo del loro tempo, putativamente nel nome della “propaganda del fatto”. Più spesso, tuttavia, l’anarchismo individualista si espresse in comportamenti di ribellione culturale. Essi salirono alla ribalta all’interno dell’anarchismo precisamente nella misura in cui gli anarchici stavano perdendo il loro legame con una sfera pubblica vitale.
L’attuale contesto sociale reazionario spiega a sufficienza l’emergenza di un fenomeno all’interno dell’anarchismo euro-americano che non può essere ignorato: la diffusione dell’anarchismo individualista. In un periodo in cui anche le forme più rispettabili di socialismo prendono frettolosamente le distanze da qualsiasi principio che potrebbe essere considerato in qualche modo radicale, la questione degli stili di vita sta nuovamente soppiantando l’azione sociale e la politica rivoluzionaria all’interno dell’anarchismo. Negli Stati Uniti tradizionalmente individualisti e liberali e in Bretagna, gli anni Novanta traboccano di sedicenti anarchici i quali – messa da parte la loro retorica eccentrica e radicale – coltivano un moderno individualismo anarchico che chiamerò anarchismo lifestyle. Le sue preoccupazioni per l’ego e la sua unicità e i suoi polimorfi concetti di resistenza stanno progressivamente erodendo il carattere socialista della tradizione libertaria. L’anarchismo, come anche il marxismo e altri socialismi, può essere influenzato profondamente dall’ambiente borghese che professa di combattere, con il risultato che la crescente “introversione” e il narcisismo della generazione yuppie hanno lasciato il segno anche su molti radicali. Un avventurismo ad hoc, spavalderie personali, un’avversione alla teoria curiosamente in linea con le distorsioni antirazionali del postmodernismo, celebrazioni di incoerenza teoretica (pluralismo), un attaccamento sostanzialmente apolitico e anti-organizzativo all’immaginazione, al desiderio, all’estasi, e un incanto verso la vita quotidiana fortemente introspettivo, riflettono il dazio che la reazione sociale ha imposto all’anarchismo euro-americano nel corso degli ultimi due decenni.[6]
Durante gli anni Settanta, scrive Katinka Matson, la compilatrice di un compendio di tecniche per lo sviluppo psicologico personale, si è verificato «un significativo cambiamento nel modo in cui percepiamo noi stessi all’interno del mondo. Gli anni Sessanta – continua – hanno visto un’ossessione per l’attivismo politico, il Vietnam, l’ecologia, l’essere, le comuni, le droghe, etc. Oggi ci stiamo rivolgendo verso l’interno: cerchiamo una definizione personale, uno sviluppo personale, il successo personale, e una personale rivelazione».[7] Il nauseabondo bestiario della Matson, redatto per la rivista «Psychology Today», tratta qualsiasi tecnica, dall’agopuntura al I Ching, dalle terapie dell’est a quella a zona. In retrospettiva, avrebbe potuto includere anche l’anarchismo lifestyle nel suo compendio dei soporiferi basati sull’interiorizzazione, molti dei quali sostengono idee di autonomia individuale piuttosto che di libertà sociale. La psicoterapia in tutte le sue mutazioni coltiva un “sé” rivolto verso l’interno, alla ricerca di autonomia entro una condizione psicologica quiescente di auto-sufficienza emotiva; non il sé socialmente impegnato indicato dalla libertà. Nell’anarchismo lifestyle così come nella psicoterapia, l’ego è contrapposto al collettivo; il sé, alla società; il personale, al comune.
L’ego – più precisamente, la sua incarnazione in svariati stili di vita – è diventato un punto fisso per molti anarchici venuti dopo gli anni Sessanta, che stanno perdendo il contatto con la necessità di un’opposizione organizzata, collettiva, programmatica all’ordine sociale esistente. “Proteste” invertebrate, millanterie prive di direzione, auto-affermazioni, e una “ricolonizzazione” assai personale della vita quotidiana affiancano il psicoterapeutico, il New Age, gli stili di vita incentrati su se stessi di baby boomers annoiati e dei membri della Generazione X. Oggi, ciò che in America e sempre più anche in Europa viene spacciato per anarchismo, è poco più di un personalismo introspettivo che denigra l’impegno sociale responsabile; un gruppo di incontro che prende il nome di “collettivo” o di “gruppo di affinità” a seconda del caso; uno stato mentale che deride con arroganza la struttura, l’organizzazione, e l’impegno pubblico; un parco giochi per pagliacciate puerili.
Consapevolmente o no, molti anarchici lifestyle esprimono l’approccio dell’“insurrezione personale” di Michel Foucault invece che quello della rivoluzione sociale, basato com’è su una critica cosmica e ambigua del potere in quanto tale, invece che su un’istanza di emancipazione[8]istituzionalizzata degli oppressi attraverso assemblee popolari, consigli, e/o confederazioni. Nella misura in cui questa tendenza esclude la possibilità reale di una rivoluzione sociale – vista come “impossibile” o “immaginaria” – essa invalida in modo sostanziale l’anarchismo socialista o comunista. Infatti, Foucault sostiene la prospettiva che «la resistenza non è mai in una posizione di esteriorità in relazione al potere […] Perciò non c’è alcun singolo [leggi: universale] luogo di grande Rifiuto, nessun’anima della rivolta, fonte di tutte le ribellioni, o pura legge del rivoluzionario». Schiacciati come siamo dalla morsa onnipresente di un potere così cosmico che, tralasciando le esagerazioni e gli equivoci di Foucault, la resistenza diventa completamente polimorfa, ci ritroviamo a vagabondare inutilmente tra il “solitario” e il “rampante”.[9] Le sue farneticanti idee conducono alla nozione che la resistenza dev’essere necessariamente una guerriglia sempre presente; e che viene inevitabilmente sconfitta.
L’anarchismo lifestyle, come quello individualista, sostiene un disprezzo per la teoria, per mezzo di filiazioni mistiche e primitiviste che sono in genere troppo vaghe, intuitive, e persino antirazionali per essere analizzate direttamente. Questi sono più propriamente sintomi che cause della deviazione generale verso una santificazione del sé come rifugio dal malessere sociale esistente. Ciononostante, gli anarchismi fortemente personalistici condividono una serie di torbide premesse teoriche che li rendono suscettibili all’analisi critica.
Il loro pedigree ideologico è essenzialmente liberale, radicato nel mito dell’individuo autonomo la cui rivendicazione all’auto-sovranità trova una conferma in “diritti naturali” assiomatici, in un “valore intrinseco”, o a un livello più sofisticato, in un ego kantiano intuito e trascendentale, generativo di tutta la realtà conoscibile. Queste posizioni tradizionali emergono nell’“Io” o “ego” di Max Stirner, che condivide con l’esistenzialismo una tendenza ad assorbire tutta la realtà dentro di esso, come se l’universo dipendesse dalle scelte dell’individuo incentrato su se stesso.[10]
In genere gli scritti più recenti sull’anarchismo lifestyle aggirano l’“Io” sovrano e totalizzante di Stirner, mantenendo tuttavia la sua enfasi egocentrica, e tendono verso l’esistenzialismo, riciclando il situazionismo, il buddismo, il taoismo, l’antirazionalismo, e il primitivismo; oppure, piuttosto ecumenicamente, ognuno di essi in varie combinazioni. I loro punti in comune, come vedremo, odorano di un ritorno prelapsario a un ego originario, spesso diffuso, e anche petulantemente infantile, che a quanto pare precede la storia, la civiltà, e una tecnologia sofisticata – possibilmente il linguaggio stesso – e hanno dato vita a più di qualche ideologia politica reazionaria nel corso dell’ultimo secolo.
Autonomia o libertà?
Per non cadere nella trappola del costruzionismo sociale che vede ogni categoria come il prodotto di un dato ordine sociale, siamo obbligati a chiedere una definizione di “libero individuo”. Come si manifesta l’individualità, e sotto quali circostanze essa può essere libera?
Quando gli anarchici lifestyle rivendicano l’autonomia piuttosto che la libertà, essi rinunciano così facendo alle ricche connotazioni sociali della libertà. Infatti, il costante martellamento degli anarchici di oggi per l’autonomia invece che per la libertà sociale non può essere liquidato come casuale, soprattutto nelle varianti anglo-americane del pensiero libertario, dove la nozione di autonomia corrisponde più strettamente a quella di libertà personale. Le sue radici risalgono alla libertas di tradizione della Roma imperiale, nella quale un ego senza vincoli è “libero” di possedere proprietà personali; e di gratificare le sue personali libidini. Oggi, l’individuo dotato di “diritti sovrani” è visto da molti anarchici lifestyle come antitetico non solo allo Stato, ma alla società in quanto tale.
In senso stretto, la parola greca autonomia significa indipendenza, a indicare un ego che si auto-gestisce, che non dipende da una qualche clientela o da altre persone per il proprio mantenimento. Che io sappia, non era molto usata dai filosofi greci; infatti non viene nemmeno menzionata nel lessico storico di F.E. Peters, Greek Philosophical Terms. Autonomia, come la parola inglese liberty, si richiama all’uomo (o alla donna) che Platone avrebbe ironicamente denominato il «padrone di sé stesso», una condizione tipica di «quando il miglior principio dell’anima umana controlla il peggiore». Anche per Platone, il tentativo di ottenere l’autonomia attraverso la padronanza di sé stessi costituiva un paradosso, «poiché il padrone è anche il servo e il servo è padrone, e in tutti questi modi di dire si parla sempre della stessa persona» (Repubblica, libro iv, 431). Paul Goodman, un anarchico essenzialmente individualista, asserì in modo emblematico che «per me, il principio base dell’anarchismo non è la libertà ma l’autonomia, l’abilità di iniziare un compito e di portarlo a termine a modo proprio»; una visione degna di un esteta ma non di un rivoluzionario.[11]
Mentre l’autonomia è associata a un individuo che si presume sovrano di sé stesso, la libertà (freedom) intreccia dialetticamente l’individuo con il collettivo. La parola freedom ha il suo analogo nel greco eleutheria e deriva dal tedesco Freiheit, termine che mantiene ancora una gemeinschäftliche, o origine comune, con la vita e le leggi tribali teutoniche. Applicato all’individuo, freedom conserva quindi un’interpretazione sociale o collettiva delle origini di quell’individuo e del suo sviluppo. In “freedom”, l’individualità non si trova in opposizione o separata dal collettivo, ma si forma in modo significativo – e in una società razionale, troverebbe la sua realizzazione – attraverso la sua stessa esistenza sociale. La parola freedom perciò non sussume la liberty individuale, ma denota la sua attualizzazione.[12]
La confusione tra autonomia e libertà è particolarmente evidente in The politics of Individualism di L. Susan Brown, un recente tentativo di elaborare e dare forma a un anarchismo sostanzialmente individualista, mantenendo tuttavia alcuni legami con il comunismo anarchico.[13] Se l’anarchismo lifestyle avesse bisogno di un pedigree accademico, lo troverebbe in questo tentativo di fondere insieme Bakunin e Kropotkin con John Stuart Mill. Purtroppo, qui giace un problema ben più che accademico. Il lavoro della Brown mostra fino a che punto i concetti di autonomia personale siano in contraddizione con quelli di libertà sociale. In sostanza, essa interpreta l’anarchismo, come Goodman prima di lei, come una filosofia che riguarda l’autonomia personale anziché la libertà sociale. Fornisce poi una nozione di individualismo esistenziale che contrasta nettamente sia con «l’individualismo strumentale» (o «l’individualismo possessivo» [borghese] di C.B. Macpherson) che con il «collettivismo»; condito da lunghe citazioni di Emma Goldman, che non era certo la migliore pensatrice nel pantheon libertario.
L’«individualismo esistenziale» della Brown condivide «l’impegno per l’autonomia individuale e l’auto-determinazione» del liberalismo, essa scrive. «Mentre la maggior parte della teoria anarchica è vista come comunista da parte sia degli anarchici che di non-anarchici», essa osserva, «ciò che distingue l’anarchismo dalle altre filosofie comuniste è la celebrazione irriducibile e instancabile da parte dell’anarchismo dell’auto-determinazione individuale e dell’autonomia. Essere anarchici – che ci si definisca poi comunisti, individualisti, mutualisti, sindacalisti, o femministi – significa affermare di impegnarsi per il primato della libertà individuale [individual freedom, N.d.T.]»; e qui usa la parola freedom nel senso di autonomia. Anche se la «critica [anarchica] alla proprietà privata e in favore di relazioni economiche libere e comunaliste» sposta l’anarchismo della Brown oltre il liberalismo, esso pone tuttavia i diritti individuali sopra – e contro – quelli della collettività.
«Ciò che distingue [l’individualismo esistenziale] dal punto di vista collettivista», continua la Brown, «è che gli individualisti» – gli anarchici non meno dei liberali – «credono nell’esistenza di un libero arbitrio autentico e motivato dall’interno, mentre la maggior parte dei collettivisti immaginano l’individuo umano come determinato esternamente da altri – l’individuo è per loro “costruito” dalla collettività». In sostanza, la Brown respinge il collettivismo – non solo il socialismo di Stato, ma il collettivismo in quanto tale; con la bufala liberale che una società collettivista richiede la subordinazione dell’individuo al gruppo. La sua straordinaria insinuazione che «la maggior parte collettivisti» hanno trattato gli individui come «semplici detriti e rottami umani spazzati via dalla corrente della storia» è un esempio calzante. Stalin la pensava certamente in questo modo, così come molti bolscevichi, con la loro ipostatizzazione delle forze sociali sopra i desideri e le intenzioni individuali. Ma i collettivisti in quanto tali? Vogliamo forse ignorare le ricche tradizioni del collettivismo che auspicavano una società razionale, democratica, e armoniosa; le visioni di William Morris, per dire, o di Gustav Landauer? Che dire di Robert Owen, i fourieristi, i socialisti democratici e libertari, i socialdemocratici dei primi tempi, o anche Karl Marx e Peter Kropotkin? Non sono sicuro del fatto che «la maggior parte dei collettivisti», anche quelli anarchici, accetterebbero il crudo determinismo che la Brown attribuisce alle interpretazioni sociali di Marx. Con la creazione di “collettivisti” immaginari, che sono meccanicisti inflessibili, la Brown contrappone a livello retorico un individuo misterioso e auto-costituitosi geneticamente, da una parte, a un collettivo onnipresente, presumibilmente oppressivo o anche totalitario, dall’altro. La Brown infatti esaspera il contrasto tra «l’individualismo esistenziale» e le convinzioni della «maggior parte dei collettivisti»; al punto che i suoi argomenti appaiono incauti come minimo, se non proprio in malafede nel peggiore dei casi.
Nonostante l’altisonante apertura di Jean-Jacques Rousseau al Contratto sociale, è ormai assodato che le persone non «nascono libere», figuriamoci autonome. Anzi, nascono decisamente non libere, estremamente dipendenti, e visibilmente eteronome. La libertà, l’indipendenza, l’autonomia che le persone hanno in un determinato periodo storico è il prodotto di tradizioni sociali di lunga data e di uno sviluppo collettivo – il che non significa negare che gli individui giochino un ruolo importante in questo sviluppo, anzi, sono obbligati a farlo se desiderano essere liberi.[14]
Gli argomenti della Brown portano a una conclusione sorprendentemente semplicistica. «Non è il gruppo che dà forma all’individuo» ci viene detto, «ma piuttosto sono gli individui a dare forma e contenuto al gruppo. Un gruppo è una collezione di individui, niente più niente meno; non ha una vita o una coscienza propria» (enfasi aggiunte). Non solo questa incredibile formulazione assomiglia molto alla nota affermazione di Margaret Thatcher che non esiste la società, ma soltanto gli individui; essa dà prova di una miopia sociale positivista, davvero ingenua, nella quale l’universale è interamente separato dal concreto. Si sarebbe pensato che Aristotele risolse questo problema quando rimproverò Platone per avere creato un regno di ineffabili “forme” che esistono separate dalle loro “copie” imperfette e tangibili.
Resta il fatto che gli individui non formano mai semplici “collezioni”; tranne forse che nel cyberspazio; al contrario, anche quando sembrano atomizzati ed ermetici, essi sono fortemente definiti dalle relazioni che stabiliscono o che sono obbligati a stabilire l’uno con l’altro, in virtù della loro stessa esistenza in quanto esseri sociali. L’idea che una collettività – e per estensione, una società – sia semplicemente una «collezione di individui, niente più niente meno» rappresenta uno “sguardo” alla natura della consociazione umana che è neanche tanto liberale quanto, specialmente oggi, potenzialmente reazionario.
Cercando insistentemente di identificare il collettivismo con un implacabile determinismo sociale, è la stessa Brown a creare un “individuo” astratto, un individuo, per giunta, nemmeno esistenziale nel senso stretto convenzionale della parola. Come minimo, l’esistenza umana presuppone le condizioni sociali e materiali necessarie per il mantenimento della vita; e le qualità affettive che la Brown indica come essenziali per la sua forma volontaristica di comunismo: la cura, il riguardo per gli altri, la condivisione. Senza la ricca articolazione di relazioni sociali nella quale le persone sono immerse dalla nascita attraverso la maturità, fino alla vecchiaia, una “collezione di individui” come quella descritta dalla Brown, a essere franchi, non è affatto una società. Sarebbe letteralmente una “collezione”, come la intendeva la Thatcher, di monadi egoistiche, egocentriche, che si “auto-avviano”. Presumibilmente compiuti in sé stessi, essi sono, per inversione dialettica, immensamente de-individualizzati perché vogliono nient’altro che la soddisfazione dei propri bisogni e piaceri; i quali oggi sono spesso costruiti socialmente in ogni caso.
Riconoscere che gli individui sono dotati di motivazioni proprie e di libero arbitrio non ci obbliga a rigettare il collettivismo, dato che essi sono anche capaci di sviluppare una consapevolezza delle condizioni sociali sotto le quali vengono esercitate queste potenzialità eminentemente umane. Il conseguimento della libertà poggia in parte su elementi biologici, come sa bene chiunque abbia cresciuto un bambino; in parte, su elementi sociali, come sa bene chiunque viva in una comunità; e al contrario di quanto sostengono i costruzionisti sociali, risiede in parte sull’interazione tra ambiente e inclinazioni personali innate, come sa bene ogni individuo pensante. L’individualità non spunta in essere ab novo. Così come l’idea di libertà, essa ha una lunga storia sociale e psicologica.
Lasciato a sé stesso, l’individuo perde quegli indispensabili attracchi sociali che costituiscono ciò che un anarchico potrebbe apprezzare nell’individualità: le capacità riflessive, che derivano in gran parte dal discorso; la dotazione emotiva che nutre la rabbia nei confronti dell’illibertà; la socialità che motiva il desiderio per il cambiamento radicale; e il senso di responsabilità che genera l’azione sociale.
Infatti, la tesi della Brown contiene implicazioni inquietanti per ciò che concerne l’azione sociale. Se l’“autonomia” dell’individuo scavalca qualsiasi tipo di impegno nei confronti della “collettività”, allora non c’è alcuna base per l’istituzionalizzazione sociale, per i processi decisionali, o anche solo per la coordinazione amministrativa. Ogni individuo, auto-confinato nella sua “autonomia”, è libero di fare ciò che vuole; presumibilmente, se si segue la vecchia formula liberale, finché non intralcia l’“autonomia” degli altri. Anche il processo decisionale democratico viene gettonato come autoritario. «Una regola democratica è sempre una regola», ci mette in guardia la Brown. «Anche se permette la partecipazione al governo di più individui rispetto alla monarchia o alla dittatura totalitaria, implica comunque la repressione della volontà di alcune persone. Ciò è chiaramente in contraddizione con l’individuo esistenziale, che deve mantenere l’integrità del proprio volere per potere essere esistenzialmente libero». Infatti, per la Brown la volontà dell’individuo autonomo è così trascendentalmente sacrosanta, che cita con approvazione l’affermazione di Peter Marshall secondo cui, stando ai principi anarchici, «la maggioranza non ha più diritto di decidere sulla minoranza, anche una minoranza di un singolo, di quanto ne abbia la minoranza nei confronti della maggioranza» (enfasi aggiunta).
La detrazione nei confronti dei metodi razionali, discorsivi, di democrazia diretta per processi decisionali collettivi, visti qui come “impositivi” e “oppressivi”, premia la minoranza di un ego sovrano del diritto di abortire la decisione di una maggioranza. Ma rimane il fatto che una società libera sarà democratica, o non sarà affatto. Nella situazione veramente esistenziale, se mi si permette, di una società anarchica – una democrazia diretta e libertaria – le decisioni verranno prese senz’altro in seguito a una discussione aperta. Dopodiché la minoranza – anche una minoranza di una persona – avrà certamente l’opportunità di presentare argomenti contrari per cercare di cambiare tale decisione. Il processo decisionale per consenso, d’altra parte, preclude il dissenso permanente; cioè l’importantissimo processo di continuo dialogo, disaccordo, sfida, e contro-sfida, senza il quale la creatività sociale così come quella individuale non sarebbe possibile.
Al massimo, basarsi sul consenso assicura che i processi decisionali importanti vengano o manipolati da una minoranza, o che collassino del tutto. E le decisioni che vengono prese rappresenteranno il minor comune denominatore dei punti di vista e il livello minimo di creatività dell’accordo. Dico ciò sulla base di una lunga e dolorosa esperienza con l’uso del consenso nella Clamshell Alliance degli anni Settanta. Proprio nel momento in cui questo movimento anti-nucleare, quasi anarchico, era all’apice della lotta, con migliaia di attivisti, venne distrutto da una minoranza attraverso la manipolazione del processo del consenso. La “tirannia da assenza di struttura” prodotta dal metodo del consenso permise a poche persone ben organizzate di controllare la maggioranza ingombrante, de-istituzionalizzata e fortemente disorganizzata del movimento.
Nemmeno fu possibile, tra le grida e i lamenti a favore del consenso, permettere al dissenso di esistere e di stimolare creativamente la discussione, promuovendo uno sviluppo creativo delle idee che avrebbero potuto portare a prospettive nuove e originali. In ogni comunità, il dissenso – e gli individui dissidenti – prevengono la comunità dalla stagnazione. Termini spregiativi come imporre e comandare si riferiscono propriamente alla messa a tacere dei dissidenti, non all’esercizio della democrazia; in modo al quanto ironico, è proprio la “volontà generale” del consenso che potrebbe benissimo, per usare la memorabile frase di Rousseau del Contratto sociale, «forzare l’uomo a essere libero».
Lungi dall’essere esistenziale in un qualsivoglia senso della parola, l’“individualismo esistenziale” della Brown tratta l’individuo astoricamente. Esso eleva l’individuo a una categoria trascendentale, in modo simile a quanto fatto negli anni Settanta da Robert K. Wolff ostentando i concetti kantiani dell’individuo nel suo discutibile Defense of anarchism. I fattori sociali che interagiscono con l’individuo per renderlo un essere davvero creativo e intenzionale, vengono qui sussunti da astrazioni morali trascendentali che, dato per scontato che queste abbiano una vita intellettuale propria, “esistono” fuori dalla storia e dalla prassi.
Oscillando tra un trascendentalismo morale e un positivismo semplicistico nel suo approccio alla relazione dell’individuo con la collettività, l’esposizione della Brown sta assieme tanto goffamente quanto il creazionismo con l’evoluzione. La ricca dialettica e l’abbondante storia che mostrano come l’individuo sia fortemente formato da, e interagisca con uno sviluppo sociale, è totalmente assente dal suo lavoro. Atomistica e strettamente analitica in molte delle sue posizioni, e tuttavia astrattamente morale e anche trascendentale nelle sue interpretazioni, la Brown fornisce un’eccellente impostazione per una nozione di autonomia che stia agli antipodi della libertà sociale. Con l’“individualismo esistenziale” da una parte, e una società che consiste di “una collezione di individui” e niente più dall’altro, l’abisso tra l’autonomia e la libertà diventa incolmabile.[15]
Anarchismo come Caos
Quali che siano le preferenze personali la Brown, il suo libro riflette e allo stesso tempo pone le premesse per lo spostamento tra gli anarchici euro-americani lontano dall’anarchismo sociale e verso un anarchismo individualista o lifestyle. Infatti, l’anarchismo lifestyle trova oggi la sua principale espressione nei graffiti, nel nichilismo postmoderno, nell’antirazionalismo, nel neo-primitivismo, nell’anti-tecnologismo, nel “terrorismo culturale” neo-situazionista, nel misticismo, e nella “pratica” di allestimento di “insurrezioni personali” foucaultiane.
Questi modi di atteggiarsi molto in voga, che seguono quasi tutti le mode yuppie contemporanee, sono individualisti nel senso importante che sono antitetici allo sviluppo di organizzazioni serie, di una politica radicale, di un movimento sociale impegnato, di una coerenza teorica e di rilevanza programmatica. Più orientata verso l’“auto-realizzazione” personale che verso il cambiamento sociale, questa tendenza presente tra gli anarchici lifestyle è particolarmente nociva per il fatto che il suo “volgersi all’interno”, come lo definisce Katinka Matson, ha la pretesa di essere una proposta politica; benché assomigli alla “politica dell’esperienza»” di R.D. Laing. La bandiera nera, che gli anarchici sociali rivoluzionari innalzarono durante le lotte insurrezionali in Spagna e Ucraina, diventa ora un pareo elegante per il diletto dei borghesi radical chic.
Uno degli esempi più sgradevoli di anarchismo lifestyle è Taz: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchism, Poetic Terrorism di Hakim Bey (nome d’arte di Peter Lamborn Wilson), un gioiello della New Autonomy Series (la scelta della parola non è affatto accidentale qui), pubblicato nel postmodernista Semiotext(e)/Autonomedia group di Brooklyn.[16] Nel mezzo di inni al caos, all’amour fou, ai bambini selvaggi, al paganesimo, al sabotaggio artistico, alle utopie pirata, alla magia nera come azione rivoluzionaria, al crimine, e alla stregoneria, per non parlare degli encomi nei confronti del “marxismo-stirnerismo”, l’appello all’autonomia si estende fino all’assurdo, tanto che sembra fare la parodia a un’ideologia narcisista che assorbe ciò che la circonda.
Taz si presenta come uno stato mentale, uno stato d’animo ardentemente antirazionale e contro la civiltà, nel quale la disorganizzazione è concepita come una forma d’arte e i graffiti soppiantano i programmi. Il Bey (il suo pseudonimo è la parola turca che sta per “capo” o “principe”) non ha peli sulla lingua riguardo al suo disprezzo per la rivoluzione sociale: «Perché preoccuparsi di scontrarsi con un “potere” che ha perso ogni significato diventando una pura Simulazione? Tali scontri produrranno solamente dei brutti e pericolosi spasmi di violenza». Potere tra virgolette? Una mera “Simulazione”? Se quello che sta accadendo in Bosnia con le armi da fuoco è una mera “simulazione”, vuol dire che viviamo in un mondo davvero sicuro e confortevole! Il lettore turbato dalle patologie in continua moltiplicazione della vita moderna potrebbe rassicurarsi al pensiero olimpico del Bey che «il realismo non solo ci richiede di smettere di aspettare “la Rivoluzione”, ma anche di smettere di volerla». Che questo passaggio voglia forse invitarci a godere della serenità del nirvana? Oppure di una nuova “simulazione” baudrillardiana? O forse un nuovo “immaginario” castoriadiano?
Avendo eliminato il classico scopo rivoluzionario di trasformare la società, il Bey sfotte paternalisticamente coloro che un tempo hanno rischiato tutto per esso: «Il democratico, il socialista, l’ideologia razionale […] sono sordi alla musica e mancano dei sensi del ritmo». Sul serio? Forse che il Bey e i suoi accoliti abbiamo essi stessi padroneggiato i versi e la musica della Marsigliese e danzato in estasi ai ritmi della Danza del marinaio russo di Gliere? C’è una pesante arroganza nel rigetto dal Bey della ricca cultura creata dai rivoluzionari nel corso degli ultimi secoli, cioè da semplici lavoratori di quell’epoca che precede il rock ‘n roll e Woodstock.
Davvero, lasciate che chiunque entri nel mondo dei sogni del Bey rinunci a tutte quelle sciocchezze riguardo l’impegno sociale. «Un sogno democratico? un sogno socialista? Impossibile, » incalza il Bey con prepotente certezza. «Nei sogni non veniamo comandati da nient’altro che dall’amore e dalla stregoneria». In questo modo i sogni di un mondo nuovo evocati da secoli di idealisti per mezzo di grandi rivoluzioni, vengono autoritariamente ridotti dal Bey alla saggezza del suo febbrile mondo dei sogni.
Per quanto riguarda invece un anarchismo che è «tutto imbevuto di Umanismo Etico, Libero Pensiero, Ateismo Muscolare, e cruda Logica Fondamentalista Cartesiana»; lasciamo perdere! Non solo il Bey, in un sol colpo, si sbarazza della tradizione illuminista nella quale l’anarchismo, il socialismo, e il movimento rivoluzionario erano un tempo radicati, egli mischia mele, come la “logica Fondamentalista Cartesiana”, con arance del tipo “Libero Pensiero” e “Umanismo muscolare” come se fossero intercambiabili o uno presupponesse necessariamente l’altro.
Nonostante lo stesso Bey non esiti un momento a rilasciare pronunciamenti olimpici e a consegnare polemiche petulanti, egli non ha alcuna pazienza per «i bisticciosi ideologi dell’anarchismo e del libertarianismo». Annunciando che «l’Anarchia non conosce dogmi», il Bey immerge tuttavia i suoi lettori in un dogma severo se ce n’è uno: «l’anarchismo implica in fondo l’anarchia; e anarchia è caos». Così disse il Signore: «Io sono ciò che sono»; e Mosè tremò prima del pronunciamento!
Infatti, in una prova di narcisismo maniacale, il Bey dispone che è il sé che tutto possiede, l’imponente “Io”, il Grande “me”, a essere sovrano: «ognuno di noi [è] il governante della propria carne, delle proprie creazioni; e di tutto ciò che possiamo afferrare e trattenere». Per il Bey, gli anarchici e i re – e i principi – diventano indistinguibili, in quanto sono tutti degli autarchi:
Le nostre azioni sono giustificate dai decreti e le nostre relazioni si formano attraverso i trattati con altri autarchi. Creiamo leggi per i nostri stessi domini; e le catene della legge vengono spezzate. Nel presente sopravviviamo forse in quanto meri pretendenti; – ma anche così possiamo comunque cogliere pochi istanti, qualche metro quadro di realtà sopra la quale imporre la nostra volontà assoluta, il nostro royaume. L’Etat, c’est moi […] Se dobbiamo essere legati a qualche etica o morale, dev’essere una che noi stessi abbiamo immaginato.
L’Etat, c’est moi? A parte i principi, mi vengono in mente almeno due persone che nel corso di questo secolo hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare queste ampie prerogative: Iosif Stalin e Adolf Hitler. La maggior parte di noi mortali, ricchi e poveri, condividiamo, come disse una volta Anatole France, il divieto di dormire sotto i ponti della Senna. Infatti, se lo scritto di Friedrich Engles Sull’autorità, con la sua difesa della gerarchia, rappresenta una forma borghese del socialismo, la Taz e le sue ramificazioni rappresentano una forma borghese dell’anarchismo. «Non c’è nessun divenire», ci dice il Bey, «nessuna rivoluzione, nessuna lotta, nessun sentiero; [se] sei già il monarca della tua stessa pelle – la tua inviolabile libertà attende di essere completata solo dall’amore di altri monarchi: una politica dei sogni, urgente quanto l’azzurro del cielo» – parole che potrebbero essere inscritte sul New York Stock Exchange come credo di egoismo e indifferenza sociale.
Certamente, questa visione non respinge le boutique della “cultura” capitalista più di quanto i capelli lunghi, la barba, e i jeans abbiano respinto il mondo imprenditoriale dell’alta moda. Sfortunatamente, fin troppe persone in questo mondo – il quale non è affatto una “simulazione” né un “sogno” – non possiedono nemmeno la propria pelle, come attestano nel modo più concreto i prigionieri ai lavori forzati e nelle carceri. Nessuno si è mai elevato dal regno terreno della miseria grazie a “una politica dei sogni” tranne che i piccoli borghesi privilegiati, che potrebbero dimostrarsi ben disposti verso i manifesti del Bey specialmente in momenti di particolare noia.
Per il Bey, infatti, anche le classiche insurrezioni rivoluzionarie non offrono niente più che un’elevazione personale, che richiama alla mente le “esperienze limite” di Foucault. «Una rivolta è come “un’esperienza massima”», ci assicura. Storicamente, «alcuni anarchici […] hanno preso parte in tutta una serie di rivolte e rivoluzioni, anche socialiste e comuniste» ma «perché trovavano nel momento stesso dell’insurrezione il tipo di libertà cui aspiravano. Perciò dove l’utopismo ha finora fallito, gli anarchici individualisti o esistenzialisti hanno avuto successo in quanto hanno ottenuto (per quanto brevemente) la realizzazione della propria volontà di potere in guerra». La rivolta dei lavoratori austriaci del febbraio del 1934 e la guerra civile spagnola del 1936, posso assicurare, furono più che “momenti di insurrezione” orgiastici, furono aspre lotte portate avanti con disperata sincerità e magnifico slancio, lasciando da parte le varie epifanie estetiche.
Eppure l’insurrezione diventa per il Bey poco più che un “trip” psichedelico, mentre il superuomo nietzschiano, che il Bey approva, è uno «spirito libero» che «disprezzerebbe perdere tempo ad agitarsi per la riforma, la protesta, per sogni visionari, o per qualsiasi tipo di “martirio rivoluzionario”». Presumibilmente, i sogni vanno bene finché evitano di essere “visionari” (leggi: socialmente impegnati); piuttosto, il Bey preferirebbe «bere vino» e avere un’«epifania privata», cose che ci suggeriscono poco più di una masturbazione mentale, senz’altro libera da costrizioni di logica cartesiana.
Non dovrebbe sorprenderci di imparare che il Bey preferisce le idee di Max Stirner, il quale «senza dedicarsi alla metafisica, conferisce tuttavia all’Unico un’assolutezza certa». A essere precisi, il Bey trova che ci sia «un ingrediente mancante in Stirner»: «un concetto funzionante di coscienza non ordinaria». A quanto pare Stirner è ancora troppo razionalista per il Bey. «L’oriente, l’occulto, le culture tribali possiedono tecniche di cui ci si può “appropriare” con vero stile anarchico […] Abbiamo bisogno di un “anarchismo mistico” di tipo pratico […] di una democratizzazione dello sciamanesimo, intossicato e sereno». Quindi il Bey richiama i suoi discepoli a diventare “stregoni” e suggerisce a essi di usare la «maledizione del Malay Djinn nero».
Cos’è, in fin dei conti, una “zona temporaneamente autonoma”? «La Taz è come una rivolta che non si scontra direttamente con lo Stato, un’operazione di guerriglia che libera un’area (di terreno, di tempo, di immaginazione) e poi si dissolve, per riformarsi altrove e in altri momenti, prima che lo Stato possa distruggerla». In una Taz possiamo «realizzare molti dei nostri veri Desideri, anche se solo per una stagione, una breve Utopia Pirata, una zona libera come distorsione del continuum spazio/tempo». «Potenziali Taz» includono «gli “incontri tribali” in stile anni sessanta, le riunioni segrete degli eco-sabotatori nella foresta, l’idilliaca Beltane dei neopagani, le conferenze anarchiche, e i circoli fatati gay», per non parlare dei «nightclub, dei banchetti», e dei «picnic libertari vecchio stile»; nientemeno! Essendo stato membro della Lega Libertaria negli anni sessanta, mi piacerebbe proprio vedere il Bey e i suoi discepoli mostrarsi a un “picnic libertario vecchio stile”!
Così transitoria, così evanescente, così ineffabile è la Taz in contrasto allo Stato e alla borghesia, le quali sono invece formidabilmente stabili, che «appena la Taz è nominata […] essa deve svanire, svanirà […] solo per rinascere nuovamente da qualche altra parte». Una Taz, infatti, non è una rivolta ma precisamente una simulazione, un’insurrezione così come viene vissuta nell’immaginazione di un cervello infantile, una ritirata sicura nell’irrealtà. Declama infatti il Bey: «Consigliamo [la Taz] perché può fornire la qualità del potenziamento senza necessariamente [!] portare alla violenza e al martirio». Più precisamente, come un “happening” di Andy Wharol, una Taz è un evento passato, un orgasmo momentaneo, un’espressione passeggera della “volontà di potere” che è di fatto totalmente priva di potere nella sua capacità di lasciare una qualche impronta nella personalità dell’individuo, nella sua soggettività, e anche nella sua auto-formazione, per non parlare della capacità di plasmare gli eventi e la realtà.
Dato il carattere evanescente di una Taz, i discepoli del Bey possono godere del fugace privilegio di vivere «un’esistenza nomadica», perché «il vagabondaggio può essere in un certo senso una virtù, un’avventura». Ahimè, il vagabondaggio può essere “un’avventura” quando si ha una casa accogliente in cui tornare, essendo il nomadismo un evidente lusso per coloro che possono permettersi di vivere senza doversi guadagnare il pane. La maggior parte dei nomadi hoboes del periodo della Grande depressione di cui abbia chiara memoria, soffrivano vite disperate fatte di fame, malattie e assenza di dignità, e solitamente morivano prematuramente; come continuano a fare, oggi, nelle strade dell’America urbana. I pochi “vagabondi” che sembravano godersi la “vita di strada” erano persone stravaganti nel migliore dei casi e tragicamente nevrotici nel peggiore. Né mi è possibile ignorare un’altra “insurrezione” proposta dal Bey: precisamente, “l’analfabetismo volontario”. Sebbene questo venga avanzato come una rivolta contro il sistema educativo, il suo effetto più desiderabile potrebbe essere di rendere le varie ingiunzioni dogmatiche del Bey inaccessibili ai suoi lettori.
Forse la migliore descrizione che possa essere data del messaggio della Taz è quella apparsa su «Whole Earth Review», il cui recensore enfatizza come il pamphlet del Bey stia «presto diventando la bibbia contro-culturale degli anni Novanta. […] Nonostante molti dei concetti usati da Bey condividano un’affinità con le dottrine dell’anarchismo», il Review tranquillizza la sua clientela yuppie che egli
si distacca puntualmente dalla tipica retorica sul rovesciamento del governo. Invece, egli preferisce la volubile natura delle “sommosse”, le quali si ritiene forniscano “momenti di intensità [che possono] dare forma e significato all’interezza della vita”. Queste tasche di libertà, o zone temporaneamente autonome, permettono all’individuo di eludere la griglia schematica del Grande Governo e di vivere occasionalmente entro reami dove lui o lei possano brevemente provare la libertà totale. (enfasi aggiunta)[17]
Esiste un’intraducibile parola yiddish per tutto ciò: nebbich! Durante gli anni Sessanta, il gruppo di affinità Up Against the Wall Motherfuckers diffuse simile confusione, disorganizzazione, e “terrorismo culturale”, solo per poi sparire dalla scena politica poco dopo. Infatti, alcuni dei suoi membri entrarono nel mondo commerciale, professionale della classe media che avevano precedentemente professato di disprezzare. Non che tale comportamento sia unicamente americano. Come disse cinicamente un “veterano” francese del maggio-giugno del ’68: «Nel ’68 ci siamo divertiti, adesso è tempo di crescere». Lo stesso ciclo isolante, con tanto di A cerchiate, venne ripetuto in una rivolta giovanile fortemente individualista a Zurigo nel 1984, solo per finire nella creazione di Needle Park, un noto ritrovo per tossici di crack e cocaina, concordato dalle autorità cittadine per permettere ai giovani tossici di distruggersi legalmente.
La borghesia non ha nulla da temere da tali declamazioni di lifestyle. Con la sua avversione per le istituzioni e le organizzazioni di massa, con il suo orientamento prevalentemente sottoculturale, la sua decadenza morale, la sua celebrazione del transitorio, e il suo rigetto dei programmi, questo tipo di anarchismo narcisista è socialmente innocuo, spesso nient’altro che una valvola di sfogo per il malcontento verso l’ordine sociale dominante. Con il Bey, l’anarchismo lifestyle prende le distanze da qualsiasi tipo di attivismo sociale significativo e di impegno costante per progetti durevoli e creativi, dissolvendosi nello sballo, nel nichilismo postmodernista, in un vertiginoso senso nietzschiano di superiorità elitista.
Il prezzo che l’anarchismo dovrà pagare, se si permette a questa robaccia di sostituire gli ideali libertari del periodo precedente, potrebbe essere enorme. L’anarchismo egocentrico del Bey, con la sua ritirata postmodernista entro un’“autonomia” individualista, verso foucaultiane “esperienze limite” ed “estasi” neo-situazioniste, minaccia di rendere la stessa parola anarchismo politicamente e socialmente innocua; un mero capriccio per il solleticamento dei piccoli borghesi di tutte le età.
Anarchismo mistico e irrazionalista
La Taz del Bey si trova in compagnia nel suo appello alla stregoneria e al misticismo. Data la loro mentalità prelapsaria, molti anarchici lifestyle adottano prontamente l’antirazionalismo nelle sue forme più ataviche. Prendiamo per esempio The appeal of anarchy, che occupa interamente il retro di un recente numero di «Fifth Estate» (estate 1989): «L’anarchia – vi si legge – riconosce l’imminenza della liberazione totale [niente meno!] e come segno della vostra libertà, siate nudi durante i vostri riti». Prendete parte a «balli, canti, risate, feste, giochi», ci viene raccomandato; e potremmo forse, a meno di essere considerati moralisti bacchettoni, avere da ridire contro questi piaceri rabelaisiani?
Ma sfortunatamente, qui c’è un intoppo. L’abbazia di Thélème di Rabelais, che il «Fifth Estate» sembra emulare, era stracolma di servi, cuochi, garzoni e artisti, senza il cui duro lavoro gli aristocratici autoindulgenti di questa utopia, tipica della classe abbiente, avrebbero fatto la fame e si sarebbero rannicchiati nudi tra i freddi corridoi dell’abbazia. A essere precisi, l’Appeal of anarchy del «Fifth Estate» potrebbe avere in mente una versione materialmente più semplice dell’abbazia di Thélème, e i suoi “banchetti” potrebbero consistere di tofu e riso anziché di pernici ripiene e gustosi tartufi. Ma il problema rimane; senza grossi progressi tecnologici per liberare le persone dalla fatica, e anche per portare sulla tavola del tofu o del riso, come potrebbe una società basata su questa versione dell’anarchia farci sperare di poter «abolire tutte le autorità», di «mettere le cose in comune», di banchettare, correre nudi, danzare e cantare?
Questa domanda è particolarmente rilevante per quanto riguarda il gruppo di «Fifth Estate». Ciò che cattura l’attenzione nel periodico è il culto primitivistico, prerazionale, antitecnologico e anti-civilizzatore, che giace al centro dei suoi articoli. Perciò l’Appeal del «Fifth Estate» invita gli anarchici a «lanciare il cerchio magico, a entrare nella trance dell’estasi, a rivelare attraverso la stregoneria ciò che scaccia tutto il potere»; esattamente le tecniche magiche che gli sciamani nelle società tribali (celebrati da qualcuno almeno dei suoi scrittori), per non parlare dei preti nelle società più sviluppate, hanno usato per secoli per innalzare il proprio status a quello di gerarchi e contro i quali la ragione ha dovuto combattere a lungo per liberare gli esseri umani dalle mistificazioni che essi stessi avevano creato. «Scacciare tutto il potere»? Di nuovo, qui c’è di mezzo la mano di Foucault, che come sempre nega la necessità di stabilire istituzioni emancipate e autogestite contro il potere assolutamente reale delle istituzioni capitaliste e gerarchiche; cioè, per l’attualizzazione di una società in cui il desiderio e l’estasi possano trovare una realizzazione genuina in un comunismo veramente libertario.
Il seducente inno estatico all’“anarchia” proposto da «Fifth Estate», così privo di contenuto sociale – svolazzi retorici a parte – potrebbe facilmente apparire su un poster nei muri di una boutique chic, o sul retro di una cartolina di auguri. Alcuni amici che hanno visitato di recente New York City mi hanno detto, infatti, di un ristorante con tavoli coperti di tovaglie di lino, menù assai costosi e una clientela di fighetti, che si trova su St. Mark’s Place nel Lower East Side – terreno di battaglia durante gli anni Sessanta – chiamato Anarchy. Questa mangiatoia della borghesia cittadina si prende gioco di una stampa del famoso dipinto italiano Il quarto stato, il quale mostra, in una scena insurrezionale di fine secolo, dei lavoratori che marciano in modo combattivo verso un padrone, o forse una stazione di polizia, non raffigurata nel dipinto. L’anarchismo lifestyle, sembrerebbe, può facilmente diventare una prelibatezza a disposizione del consumatore. Mi viene detto che il ristorante possiede anche delle guardie private, proprio per tenere fuori la canaglia locale che viene raffigurata nel dipinto murale.
Questo anarchismo lifestyle, confortevole, privatistico, edonistico, persino piacevole, può facilmente fornire quel tipo di verbosità già pronta a vivacizzare gli stili di vita borghesi dei rabelaisiani più esitanti. Come “l’arte situazionista” che il MIT ha esposto diversi anni fa per il diletto della borghesia più all’avanguardia, esso offre niente più che un’immagine dell’anarchia terribilmente “perversa” – oserei dire, un simulacro – come quelle che fioriscono in tutta la Pacific Rim of America puntando verso est. L’Industria dell’Estasi, da parte sua, se la sta passando fin troppo bene nel capitalismo contemporaneo, e potrebbe facilmente assorbire le tecniche degli anarchici lifestyle per promuovere un’immagine più accattivante da mettere sul mercato. La controcultura che un tempo lasciò a bocca aperta la piccola borghesia con i suoi capelli lunghi, le sue barbe, i suoi vestiti, la libertà sessuale, e la sua arte, è stata scavalcata da tempo da parte degli imprenditori borghesi le cui boutique, café, e persino i campi nudisti stanno facendo grandi affari, come testimoniano le tante pubblicità provocanti che parlano di nuove “estasi” nel «Village Voice» e in simili periodici.
I sentimenti sfacciatamente antirazionalisti del «Fifth Estate» contengono in effetti implicazioni molto problematiche. La sua celebrazione viscerale dell’immaginazione, dell’estasi, della “primalità”, contesta evidentemente non solo l’efficienza razionale ma la ragione in quanto tale. La copertina del numero di autunno/inverno del 1993 reca il Capriccio n. 43 di Francisco Goya, notoriamente incompreso, «El sueno de la razon produce monstruos» («Il sonno della ragione produce mostri»). Il personaggio che dorme raffigurato da Goya viene mostrato riverso sul proprio tavolo con un computer Apple davanti. L’inscrizione di Goya viene tradotta dal «Fifth Estate» in inglese con «Il sogno della ragione produce mostri», implicando con ciò che i mostri siano un prodotto della ragione stessa. In realtà, Goya intendeva dichiaratamente, come indica la sua stessa nota, che in quell’incisione i mostri sono prodotti del sonno, non del sogno, della ragione. Come egli scrisse in un suo stesso commento: «L’immaginazione, senza la ragione, genera mostri impensabili. Unita alla ragione, essa è la madre di tutte le arti, e la fonte di tutte le sue meraviglie».[18] Deprecando la ragione, questo periodico anarchico “tira e molla” entra in collusione con alcuni degli aspetti più tetri della reazione neo-heideggeriana contemporanea.
Contro la tecnologia e la civiltà
Ancora più preoccupanti sono gli scritti di George Bradford (noto come David Watson), uno dei principali teorici del «Fifth Estate», sugli orrori della tecnologia; a quanto pare, della tecnologia in quanto tale. La tecnologia, sembrerebbe, determina le relazioni sociali e non il contrario, una nozione che si avvicina più a un certo marxismo grossolano, che, per dire, all’ecologia sociale. «La tecnologia non è un progetto isolato, e nemmeno un accumulo di conoscenza tecnica», ci dice Bradford in Stopping the Industrial Hydra,
determinata da una sfera delle “relazioni sociali” in qualche modo separata e più fondamentale. Le tecniche di massa sono diventate, nelle parole di Langdon Winner, “strutture le cui condizioni per operare richiedono la ristrutturazione del loro ambiente”, quindi delle stesse relazioni sociali che le hanno portare a esistere. Le tecniche di massa – il prodotto di forme precedenti e di gerarchie arcaiche – hanno ormai superato le stesse condizioni che le hanno generate, assumendo vita autonoma […] Esse forniscono, o sono diventate, un tipo di ambiente totale e di sistema sociale, sia nel suo aspetto generale che individuale, soggettivo […] In tale piramide meccanizzata […] le relazioni sociali e strumentali sono una cosa unica.[19]
Questo superficiale corpo di nozioni aggira comodamente le relazioni capitaliste che determinano in modo palese come la tecnologia verrà usata e si concentrano su ciò che si presume sia la tecnologia. Relegando le relazioni sociali a qualcosa di secondario – invece che sottolineare l’importantissimo processo produttivo nel quale la tecnologia viene utilizzata – Bradford conferisce alle macchine e alle “tecniche di massa” un’autonomia mistica che, come anche l’ipostatizzazione stalinista della tecnologia, ha servito fini estremamente reazionari. L’idea che la tecnologia abbia vita propria è profondamente radicata nel romanticismo conservatore tedesco dell’ultimo secolo e negli scritti di Martin Heidegger e Friedrich Georg Jünger, che hanno alimentato l’ideologia nazionalsocialista, per quanto i nazisti abbiano agito contro la loro stessa ideologia antitecnologica.
Visto nei termini dell’ideologia contemporanea a noi più vicina, questo bagaglio ideologico è esemplificato dall’affermazione, oggi molto in voga, che i macchinari automatizzati di recente sviluppo costano alle persone il proprio lavoro o intensificano il loro sfruttamento; entrambe le cose sono fatti indiscutibili, ma sono radicati proprio nelle relazioni sociali dello sfruttamento capitalista, non negli sviluppi tecnologici in sé e per sé. Per dirla in modo schietto: il “downsizing” oggi non è fatto dalle macchine, ma da borghesi avari che usano le macchine per rimpiazzare la forza lavoro o per sfruttarla più intensamente.[20] Infatti, le stesse macchine che la borghesia impiega per ridurre “i costi del lavoro” potrebbero, in una società razionale, liberare gli esseri umani da fatiche insensate, dandoci più tempo per attività creative e personalmente gratificanti.
Non sembra che Bradford abbia familiarità con gli scritti di Heidegger o Jünger; piuttosto, egli sembra trarre ispirazione da Langdon Winner e Jacquest Ellul, quest’ultimo citato con approvazione da Bradford: «È la coerenza tecnologica a costituire la coerenza sociale oggi […] La tecnologia in sé non è solo un mezzo, ma un universo di mezzi; nel senso autentico di Universum: al tempo stesso esclusivo e totale».
In The Technological Society, il suo libro più noto, Ellul avanza la fosca tesi che il mondo e i nostri modi di pensare a esso siano modellati dagli strumenti e dalle macchine (la technique). Privo di qualsiasi spiegazione sociale su come questa “società tecnologica” sia venuta in essere, il libro di Ellul conclude senza offrire alcuna speranza, tanto meno un qualsiasi approccio per redimere l’umanità dal suo totale assorbimento da parte della technique. Infatti, dal suo punto di vista, persino un umanismo che cerchi controllare la tecnologia perché questa soddisfi i bisogni umani viene ridotto a una «pia speranza senza possibilità alcuna di influenzare l’evoluzione tecnologica».[21] E a buon diritto, se una visione così determinista del mondo viene portata alle sue logiche conclusioni.
Fortunatamente, tuttavia, Bradford ci fornisce una soluzione: «di iniziare immediatamente a smantellare la macchina nella sua totalità». Ed egli non tollera compromessi con la civilizzazione, ma ripete sostanzialmente tutti i cliché quasi-mistici, contro la civiltà, antitecnologici, che appaiono in certi culti ambientalisti New Age. La civiltà moderna, ci viene detto, è una «matrice di forze», che comprende «relazioni commerciali, comunicazioni di massa, urbanizzazione e tecniche di massa, insieme a […] Stati nucleari-cybernetici, interconnessi e in competizione tra loro», il tutto convergendo entro un’unica «megamacchina globale». «Le relazioni commerciali», egli nota nel suo saggio Civilization in Bulk, sono semplicemente una parte di questa “matrice di forze”, nella quale la civiltà è una «macchina», «un campo di lavoro sin dalle sue origini», una «rigida piramide di gerarchie incrostate», «una griglia che espande il territorio dell’inorganico», e «una progressione lineare che va dal furto del fuoco di Prometeo al Fondo Monetario Internazionale»[22]. Di conseguenza, Bradford rimprovera l’inutile libro di Monica Sjöo e Barbara Mor, The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth – non per il suo teismo atavico e regressivo, ma perché le autrici mettono la parola civiltà tra virgolette – una pratica che «riflette la tendenza di questo libro affascinante [!] a postulare un’alternativa o una prospettiva contraria sulla civiltà, piuttosto che metterla in questione nella sua interezza». A quanto pare, è Prometeo a doversi ricredere, non queste due Madri della Terra, il cui trattato sulle divinità ctonie, nonostante i suoi compromessi con la civiltà, risulta “affascinante”.
In realtà, nessuna menzione della megamacchina potrebbe essere completa senza citare il lamento di Lewis Mumford sui suoi effetti sociali. Infatti, vale la pena notare che tali commenti hanno del tutto frainteso le intenzioni di Mumford. Mumford non era antitecnologico, come Bradford e altri vorrebbero farci credere; e nemmeno era un mistico che avrebbe trovato di suo gusto il primitivismo anti-civilizzatore di Bradford. A questo riguardo, posso parlare per conoscenza diretta e personale dei punti di vista di Mumford, da quando ci è capitato di conversare a lungo in quanto partecipanti di una conferenza alla University of Pennsylvania intorno al 1972.
Ma basta semplicemente guardare ai suoi scritti, come a esempio Technics and Civilization, citato dallo stesso Bradford, per vedere che Mumford si sforza di descrivere in modo favorevole «gli strumenti meccanici» in quanto «veicoli potenziali per scopi umani razionali».[23] Ricordando ripetutamente ai suoi lettori che le macchine sono creazioni degli esseri umani, Mumford sottolinea che la macchina è «la proiezione di uno specifico lato della personalità umana». Infatti una delle sue funzioni più importanti è stata quella di dissipare l’impatto della superstizione sulla mente umana. Perciò:
Nel passato, gli aspetti irrazionali e demoniaci della vita aveva invaso sfere alle quali non appartenevano. Fu un passo in avanti scoprire che i batteri, non i biscotti, erano responsabili per la cagliatura del latte, e che un motore ad aria fredda era più efficace di un bastone da strega per muoversi rapidamente su lunghe distanza […] La scienza e la tecnica hanno rinforzato il nostro morale: attraverso la loro austerità e abnegazione esse […] esprimono il rigetto delle paure infantili, delle supposizioni infantili, e di altrettanto infantili asserzioni.
Questo soggetto centrale negli scritti di Mumford è stato sfacciatamente ignorato dai primitivismi; in particolare, la sua convinzione che la macchina ha reso un «contributo incalcolabile» per stimolare «le tecniche del pensiero e dell’azione cooperativa». Né Mumford ha mai esitato nel lodare «l’eccellenza estetica della forma della macchina […] sopra tutto, forse, la personalità più oggettiva che sia mai venuta in essere attraverso un rapporto più sensibile e comprensivo con questi nuovi strumenti sociali e attraverso la loro deliberata assimilazione culturale». Infatti, «la tecnica del creare un mondo neutrale di fatti, distinto dai dati grezzi dell’esperienza immediata, è stato un grande contributo generale da parte della scienza analitica moderna».
Lungi dal condividere il primitivismo esplicito di Bradford, Mumford critica duramente coloro che rigettano la macchina in modo assoluto, e considerava il «ritorno al primitivo assoluto» come un «adattamento nevrotico» alla megamacchina stessa, una catastrofe vera e propria. «Più disastrosa di ogni mera distruzione fisica delle macchine da parte del barbaro, è la sua minaccia di spegnere o di deviare il movente umano del potere», egli ha osservato nel modo più lucido possibile, «scoraggiando i processi cooperativi del pensiero e la ricerca disinteressata, che sono invece responsabili delle nostre più grandi conquiste tecniche». Raccomandando poi: «Dobbiamo abbandonare i nostri futili e deplorevoli espedienti per resistere alla macchina attraverso assurde ricadute verso lo stato selvaggio».
Anche i suoi successivi scritti non mostrano alcuna prova di cedimento in questa sua convinzione. Ironicamente, egli ha indicato sdegnosamente le visioni e le performance del «Territorio senza legge» del Living Theater sulle gang si motociclisti, come «barbarismo», e disapprovato Woodstock in quanto «mobilitazione di masse della gioventù» dalla quale «l’attuale cultura conformista, iper-regolamentata, spersonalizzata non ha nulla da temere».[24]
Mumford, da parte sua, non favoriva né la megamacchina né il primitivismo (l’“organico”), ma piuttosto la sofisticazione di una tecnologia che seguisse linee democratiche e in scala umana. «La nostra capacità di andare oltre la macchina [verso una nuova sintesi] risiede sul nostro potere di assimilare la macchina», ha osservato in Technics and Civilizazion. «Finché non avremo assorbito le lezioni dell’oggettività, dell’impersonalità, della neutralità, le lezioni del regno meccanico, non potremo avanzare nel nostro sviluppo verso un essere umano più riccamente organico, un essere umano più profondo». (enfasi aggiunte).
Denunciare la tecnologia e la civiltà come intrinsecamente oppressive dell’umanità, serve in realtà a occultare le particolari relazioni sociali che privilegiano gli sfruttatori sugli sfruttati e i gerarchi sui loro subordinati. Il capitalismo, più di ogni altra società oppressiva del passato, nasconde il suo sfruttamento dell’umanità sotto la maschera dei “feticci”, adottando la terminologia usata da Marx nel Capitale, e soprattutto, del “feticismo delle merci”, che è stato variamente – e superficialmente – ricamato dai situazionisti in “spettacoli” e da Baudrillard in “simulacri”. Proprio mentre l’acquisizione di surplus da parte della borghesia viene mascherato dallo scambio contrattuale tra salario e forza lavoro, i quali sono equivalenti solo in apparenza, ugualmente, la feticizzazione delle merci e dei loro movimenti nascondono la sovranità delle relazioni economiche e sociali del capitalismo.
Qui c’è un punto importante, cruciale anzi, che bisogna notare. Tale travisamento serve a nascondere al pubblico il ruolo causale della competizione capitalista nella produzione delle crisi dei nostri tempi. A queste mistificazioni, gli anti-tecnologisti e gli anti-civilizzatori aggiungono il mito della tecnologia e della civiltà in quanto intrinsecamente oppressive, contribuendo così a oscurare le relazioni sociali uniche al capitalismo – in particolare l’uso delle cose (merci, valori di scambio, oggetti – usate i termini che preferite) per mediare le relazioni sociali e produrre il paesaggio tecno-urbano contemporaneo. Proprio come la sostituzione dell’espressione “società industriale” al posto del capitalismo oscura il ruolo specifico e primario del capitale e delle relazioni commerciali nel formare la società moderna, così la sostituzione di una cultura tecno-urbana per le relazioni sociali, nella quale Bradford si dilunga più del dovuto, nasconde il ruolo primario del mercato e della competizione nel formare la cultura moderna.
L’anarchismo lifestyle, proprio perché si occupa di uno “stile” più che di una società, sorvola sull’accumulazione capitalista, che ha le sue radici nel mercato competitivo, come fonte della devastazione ecologica, e contempla come folgorato la supposta rottura dell’unità “sacra” ed “estatica” tra l’umanità e la “Natura”, e il “disincanto del mondo” provocato dalla scienza, dal materialismo, e dal “logocentrismo”.
In questo modo, invece di divulgare le fonti delle patologie personali e sociali contemporanee, l’anti-tecnologismo ci permette di rimpiazzare pretestuosamente il capitalismo con la tecnologia, cosa che in sostanza agevola l’accumulazione capitalista e lo sfruttamento del lavoro come principale causa di crescita e di distruzione ecologica. La civiltà, incorporata dalla città in quanto centro culturale, viene così spogliata delle sue dimensioni razionali, come se la città fosse un cancro implacabile invece che la sfera potenziale per un rapporto umano universalizzante, in netto contrasto alle limitazioni campaniliste della vita tribale e di villaggio. Le basilari relazioni sociali dello sfruttamento e del dominio capitalista sono tenute nascoste da generalizzazioni metafisiche sull’ego e su la technique, andando a offuscare la comprensione del pubblico su quelle che sono le cause fondamentali delle crisi sociali ed ecologiche; le relazioni commerciali che generano i corporate broker del potere, dell’industria e della ricchezza.
Il che non vuol dire negare il fatto che molte tecnologie siano intrinsecamente dispotiche ed ecologicamente pericolose, o asserire che la civiltà è stata una benedizione assoluta. I reattori nucleari, dighe enormi, complessi industriali altamente centralizzati, il sistema fabbrica e l’industria delle armi – come la burocrazia, il degrado urbano e i media contemporanei – sono stati nefasti quasi fin dalla nascita. Ma i secoli diciottesimo e diciannovesimo non hanno avuto bisogno di macchine a vapore, della manifattura di massa, o, per quello che conta, di città giganti e burocrazie capillari, per deforestare enormi aree del Nord America e per annientare virtualmente le sue popolazioni aborigene, o per erodere il terreno di intere regioni. Anzi, ben prima che le ferrovie raggiungessero qualsiasi territorio, gran parte di questa devastazione era già stata compiuta usando semplici asce, archibugi, carri a cavallo e aratri a versoio.
Furono queste semplici tecnologie che l’impresa borghese – la dimensione più barbarica della civiltà dell’ultimo secolo – usò per incidere gran parte della Ohio River Valley a fini speculativi. Nel Sud, i proprietari di piantagioni avevano bisogno di “mani” di schiavi, più che altro, perché ancora non esistevano i macchinari per piantare e raccogliere il cotone; infatti, il sistema agricolo americano di proprietari terrieri e fittavoli è scomparso nel corso delle ultime due generazioni principalmente a seguito dell’introduzione di nuovi macchinari per rimpiazzare il lavoro dei braccianti neri “liberati”. Nel diciannovesimo secolo i contadini provenienti dall’Europa semifeudale, seguendo i corsi dei fiumi e dei canali, si riversarono nei territori di un’America selvaggia e, con metodi eminentemente anti-ecologici, iniziarono a produrre i cereali che proiettarono successivamente il capitalismo americano verso l’egemonia economica nel mondo.
Detto chiaramente: fu il capitalismo – la relazione mercificata estesa alle sue massime proporzioni storiche – che produsse l’esplosiva crisi ambientale del nostro tempo, cominciando con le prime merci di produzione artigianale che furono trasportate in tutto il mondo da imbarcazioni a vela, alimentate dal vento e non da motori. Se escludiamo i villaggi e le cittadine tessili della Bretagna, dove la manifattura di massa ha avuto la sua svolta storica, le macchine che oggi incontrano il più grande obbrobrio sono state create solo molto tempo dopo che il capitalismo ebbe guadagnato ascendenza in molte parti d’Europa e del Nord America.
Malgrado l’attuale oscillazione del pendolo da una glorificazione della civiltà europea alla sua totale denigrazione, faremmo bene a ricordare l’importanza dell’ascesa del secolarismo moderno, della conoscenza scientifica, dell’universalismo, della ragione, e delle tecnologie che offrono potenzialmente la speranza di una gestione emancipatoria e razionale degli affari sociali, per la piena realizzazione del desiderio e dell’estasi, senza i tanti servi e artigiani che compiacevano gli appetiti dei loro “superiori” aristocratici nell’abbazia di Thélème rabelaisiana. Ironicamente, gli anarchici anti-civilizzatori che oggi denunciano la civiltà sono tra quelli che godono dei suoi frutti culturali, e fanno espansive dichiarazioni di libertà fortemente individualiste senza alcuna consapevolezza degli accorti sviluppi nella storia europea che li hanno resi possibili. Kropotkin, da parte sua, valorizzava insistentemente «i progressi della tecnica moderna, la quale semplifica meravigliosamente la produzione di tutte le necessità della vita»[25]. Per coloro che mancano di un senso del contesto storico, un arrogante senno di poi risulta piuttosto conveniente.
Mistificare il primitivo
Il corollario del pensiero anti-tecnologista e anti-civilizzatore è il primitivismo, una glorificazione edenica della preistoria e il desiderio di ritornare in qualche modo alla sua presunta innocenza.[26]Gli anarchici lifestyle come Bradford traggono ispirazione dalle popolazioni aborigene e dai miti di una preistoria edenica. Le popolazioni primordiali, egli afferma, «rifiutavano la tecnologia»; esse «minimizzavano il peso relativo delle tecniche strumentali o pratiche ed estendevano l’importanza delle […] tecniche estatiche». Questo perché le popolazioni aborigene, con le loro credenze animiste, erano intrise da un “amore” per la vita animale e la natura selvaggia; per esse, «gli animali, le piante, e gli oggetti naturali» erano «persone, persino parenti».
Di conseguenza, Bradford si oppone alla visione “ufficiale” che considera gli stili di vita delle culture preistoriche di raccoglitori «terribili, brutali e nomadi, una lotta sanguinosa per l’esistenza». Al contrario, egli fa l’apoteosi «del mondo primordiale», quello che Marshall Sahlins ha chiamato «l’originaria società dell’abbondanza»,
[società dell’abbondanza] perché i suoi bisogni sono pochi, tutti i suoi desideri vengono facilmente soddisfatti. La sua cassetta degli attrezzi è elegante e leggera, il suo sguardo è linguisticamente complesso e concettualmente profondo, e tuttavia semplice e accessibile a tutti. La sua cultura è espansiva ed estatica. Non esiste la proprietà, è comunale, egualitaria, cooperativa […] è anarchica […] libera dal lavoro […] è una società danzante, una società che canta, una società celebrativa, una società che sogna.
Secondo Bradford, gli abitanti del “mondo primordiale” vivevano in armonia con il mondo naturale e godevano di tutti i benefici dell’abbondanza, incluso molto tempo libero. La società primordiale, egli sottolinea, era «libera dal lavoro» visto che la caccia e la raccolta richiedevano molti meno sforzi di quelli che vengono richiesti oggi alle persone dalla giornata lavorativa di otto ore. Egli ammette però con una certa compassione che la società originaria poteva «soffrire occasionalmente la fame». Tuttavia, dovreste sapere che questa “fame” era in realtà simbolica e auto-inflitta, perché le popolazioni primordiali «a volte [sceglievano] di soffrire la fame come pratica per rafforzare l’interdipendenza, per gioco, o per avere visioni».
Ci vorrebbe un saggio intero per riuscire a decifrare, figuriamoci smentire, queste stupidaggini assurde, in cui una manciata di verità vengono mischiate o ricoperte da pura fantasia. Bradford basa la sua versione, ci viene detto, su «un maggiore accesso alle visioni delle popolazioni primordiali e dei loro discendenti nativi» dovuto a «un’antropologia […] più critica». Di fatto, molta di questa “antropologia critica” sembra derivare dalle idee esposte al simposio «Uomo, il cacciatore», tenutosi nell’aprile del 1966 all’University of Chicago.[27] Anche se la maggior parte dei contributi al simposio furono di immenso valore, un certo numero di essi si conformava all’ingenua mistificazione di “primitività” che stava filtrando dalla controcultura degli anni Sessanta; e che persiste ancora oggi. La cultura hippie, che ha influenzato non pochi antropologi di quel periodo, sosteneva che i cacciatori-raccoglitori di oggi sono stati completamente ignorati delle forze sociali ed economiche che operano nel resto del mondo, e perciò vivono ancora in uno stato originario in quanto residui isolati degli stili di vita del Neolitico e del Paleolitico. Inoltre, in quanto cacciatori-raccoglitori, le loro vite erano notevolmente salutari e pacifiche, vivendo, tanto nel passato quanto oggi, dell’abbondante generosità della natura.
Pertanto Richard B. Lee, coeditore della collezione dei contributi alla conferenza, stima che l’apporto calorico delle popolazioni “primitive” era piuttosto alto e il loro approvvigionamento abbondante, rappresentando una sorta di “abbondanza” vergine nella quale le persone erano costrette a procacciarsi il cibo solo per poche ore al giorno. «La vita allo stato di natura non è necessariamente cattiva, brutale, e corta», scrive Lee. L’habitat dei !Kung bushmen del deserto del Kalahari, per esempio, «abbonda di cibo già presente in natura». I bushmen dell’area di Dobe che, scrive Lee, erano ancora sul punto di entrare nel Neolitico,
oggi vivono abbastanza bene cibandosi di piante selvagge e carne, nonostante il fatto che siano confinati nella parte meno produttiva dell’area nella quale vennero formalmente trovati i bushmen. È probabile che nel passato una sussistenza ancora più sostanziale fosse caratteristica di questi cacciatori-raccoglitori, quando avevano la possibilità di scegliere tra diversi habitat africani.[28]
Non proprio! Come vedremo tra poco.
È fin troppo comune per coloro che vanno in estasi di fronte alla “vita primitiva” il vizio di ammassare insieme diversi millenni di preistoria, come se specie ominidi e umane significativamente diverse tra loro vivessero tutte all’interno di uno stesso tipo di organizzazione sociale. La parola preistoria è molto ambigua. Nella misura in cui il genere umano includeva diverse specie, è difficile paragonare lo “sguardo” dei raccoglitori aurignaziani e maddaleniani (Homo sapiens sapiens) di circa 30.000 anni fa, con quello dell’Homo sapiens neanderthalensis o di Homo erectus i cui strumenti, capacità artistiche e di linguaggio erano straordinariamente diverse.
Un altro problema è dato dalla misura in cui cacciatori-raccoglitori preistorici vissuti in tempi diversi vivessero in società non gerarchiche. Se le sepolture scoperte a Sungir (nell’attuale est Europa) risalenti a circa 25.000 anni fa permettono di trarre qualche speculazione (e non è che attorno a noi ci siano popolazioni paleolitiche che ci possono raccontare delle loro vite), la collezione straordinariamente ricca di gioielli, lance, punte d’avorio, e vestiti perlati nelle tombe di due adolescenti suggeriscono l’esistenza di linee famigliari di alto status prima ancora che gli esseri umani si sistemassero per la coltivazione. Molte culture nel paleolitico erano probabilmente relativamente egualitarie, ma la gerarchia sembra essere esistita anche nel tardo paleolitico, con forti variazioni di grado, tipo, e scopo della dominazione, al punto che non può essere sussunta da retorici inni all’egualitarismo paleolitico.
Un’ulteriore questione che si pone è quella della variazione – nei primi casi, dell’assenza – di capacità comunicative in epoche differenti. Nella misura in cui un linguaggio scritto non appare fino a tempi storici inoltrati, anche i linguaggi del primo Homo sapiens sapiens possono difficilmente essere considerati «concettualmente profondi». I pittogrammi, i glifi, e più di ogni altra cosa, i materiali che le popolazioni “primordiali” memorizzavano e sui quali facevano affidamento per la conoscenza del passato, possiedono degli ovvi limiti culturali. Senza una letteratura scritta che tenga traccia della conoscenza cumulativa di diverse generazioni, la memoria storica, per non parlare di pensieri «concettualmente profondi», è difficile da mantenere; anzi, viene persa nel corso del tempo o terribilmente distorta. Men che meno la storia trasmessa oralmente è soggetta a una critica esigente, ma anzi diventa facilmente uno strumento per le élite di “veggenti” e sciamani i quali, lungi dall’essere dei “protopoeti”, come Bradford li chiama, sembra abbiano usato la loro “conoscenza” per servire i propri interessi sociali.[29]
Il che ci porta, inevitabilmente, a John Zerzan, il primitivista anti-civilizzatore per eccellenza. Per Zerzan, una delle mani ferme di Anarchy: A Journal of Desire Armed, l’assenza del parlato, del linguaggio, e della scrittura, sono una manna dal cielo. Altro abitante della distorsione temporale di «Uomo, il cacciatore», Zerzan sostiene nel suo libro Future Primitive che «la vita prima dell’addomesticamento e dell’agricoltura era di fatto ampiamente fondata sul piacere, [30]sull’intimità con la natura, su una saggezza sensuale, sull’uguaglianza dei sessi, e sulla salute»; con la differenza che la visione di Zerzan della “primalità” si avvicina molto più all’animalità dei quadrupedi. In effetti, nella paleoantropologia zerziana, le distinzioni anatomiche tra Homo sapiens, da una parte, e Homo habilis, Homo erectus, e il “calunniato” Neanderthal, dall’altra, sono dubbie; tutte le prime specie di Homo, dal suo punto di vista, era in possesso delle facoltà mentali e fisiche dell’Homo sapiens e vissero nella benedizione primordiale per più di due milioni di anni.
Se questi ominidi erano tanto intelligenti quanto gli esseri umani moderni, potremmo essere ingenuamente tentati a chiederci, perché non furono essi a innovare il cambiamento tecnologico? «Mi sembra assolutamente plausibile», ipotizza brillantemente Zerzan, «che l’intelligenza, informata dal successo e dalla soddisfazione dell’esistenza dei cacciatori-raccoglitori, sia la ragione della spiccata assenza di “progresso”. La divisione del lavoro, la domesticazione, la cultura simbolica; queste cose furono palesemente [!] rifiutate fino a tempi molto recenti». Le specie di Homo «scelsero per molto tempo la natura rispetto alla cultura», e per cultura qui Zerzan intende «la manipolazione di forme simboliche di base» (enfasi aggiunta); un fardello alienante. Infatti, egli continua, «il tempo reificato, il linguaggio (quello scritto ovviamente, e probabilmente, per buona parte o per tutto questo periodo, anche quello parlato), i numeri, e l’arte non avevano alcuno spazio, nonostante un’intelligenza pienamente capace di esprimerli».
In breve, gli ominidi erano in grado di esprimere simboli, di parlare e scrivere ma rifiutavano deliberatamente tutte queste cose, dato che potevano comprendere gli altri e il loro ambiente istintivamente, senza ricorrere a esse. Zerzan si trova perciò d’accordo con un antropologo che medita su come «la connessione dei San/Bushman con la natura» raggiungesse «un livello di esperienza che “potrebbe quasi essere definita mistica. Per esempio, sembravano sapere cosa significasse realmente essere un elefante, un leone, un’antilope”», persino un albero baobab.
La “decisione” consapevole di rifiutare il linguaggio, gli attrezzi sofisticati, la temporalità, e una divisione del lavoro (probabilmente avranno provato, per poi grugnire «Bah!») venne fatta, ci viene detto, dall’Homo habilis, il quale, dovrei far notare, aveva un cervello grande all’incirca la metà di quello degli umani moderni e mancava probabilmente della capacità anatomica per il parlato sillabico. Eppure ci viene comunicato dall’autorità sovrana di Zerzan che l’habilis (e possibilmente anche l’Australopithecus afarensis, vissuto qualcosa come «due milioni di anni fa») possedevano «un’intelligenza pienamente capace» – niente meno! – per queste funzioni, ma si rifiutavano di usarle. Nella paleoantropologia zerziana, i primi ominidi o gli umani sarebbero in grado di adottare o rigettare, con sublime saggezza, tratti culturali essenziali come la parola, allo stesso modo in cui i monaci fanno voto di silenzio.
Ma una volta che il voto di silenzio fu rotto, tutto andò storto! Per ragioni note solo a Dio e a Zerzan,
l’emergere della cultura simbolica, con la sua volontà intrinseca di manipolare e controllare, presto aprì la porta all’addomesticamento della natura. Dopo due milioni di anni di vita umana entro i confini della natura, in equilibrio con le altre specie selvagge, l’agricoltura ha cambiato il nostro stile di vita, il nostro modo di adattarci, in un modo senza precedenti. Mai prima un cambiamento così radicale avvenne in modo così rapido e totale entro una specie […] l’auto-addomesticamento attraverso il linguaggio, il rituale, e l’arte, ispirò l’addomesticamento delle piante e degli animali che seguì. (enfasi aggiunta)
C’è un certo splendore in questo sproloquio che lascia davvero di stucco. Epoche, ominidi e/o specie umane, situazioni ecologiche e tecnologiche significativamente diverse tra loro, vengono trascinate tutte insieme verso una vita condivisa «entro i confini della natura». La semplificazione che Zerzan fa della dialettica estremamente complessa tra umani e natura non umana, rivela una mentalità così tanto riduzionista e semplicistica, che non ci lascia alternativa se non di ammirarla a bocca aperta.
In realtà, c’è molto da imparare dalle culture pre-letterate – le società organiche, come le chiamo ne L’ecologia de la libertà – in particolare riguardo alla mutabilità di ciò che viene comunemente chiamata “natura umana”. Il loro spirito di cooperazione interna al gruppo e, nel migliore dei casi, lo sguardo egualitario sono non solo ammirabili – e socialmente necessari visto il mondo precario nel quale vivevano – ma forniscono prove convincenti della malleabilità del comportamento umano contrariamente al mito che la competizione e l’avidità siano attributi umani innati. Infatti, le loro pratiche dell’usufrutto e dell’ineguaglianza degli eguali sono di grande rilevanza per una società ecologia.
Ma dire che le popolazioni preistoriche o “primordiali” venerassero la natura non umana è nel migliore dei casi fuorviante, nel peggiore completamente in malafede. In assenza di ambienti “non naturali” come villaggi, cittadine e città, la stessa nozione di “Natura”, distinta da quella di habitat, doveva ancora essere concettualizzata; un’esperienza veramente alienante, secondo Zerzan. Nemmeno è probabile che i nostri remoti antenati vedessero il mondo naturale in modo meno strumentale di quanto facessero le persone nelle culture storiche. Tenuto conto dei propri interessi materiali – la propria sopravvivenza e il proprio benessere – le popolazioni preistoriche sembrano aver cacciato tutta la selvaggina che era possibile cacciare, e se attraverso l’immaginazione popolavano il mondo animale di attributi antropomorfi, come sicuramente fecero, era per comunicare con esso al fine di manipolarlo, non semplicemente per venerarlo.
È perciò tenendo a mente obiettivi propriamente strumentali, che essi evocavano animali “parlanti”, “tribù” animali (spesso modellate sulle proprie strutture sociali), e “spiriti” animali in grado di rispondergli. Comprensibilmente, data la loro limitata conoscenza, credevano in una realtà dei sogni, dove gli umani potessero volare e gli animali parlare; in un mondo dei sogni inesplicabile, spesso spaventoso, che essi scambiavano per realtà. Per controllare gli animali che cacciavano, per sfruttare un habitat al fine di sopravvivere, per affrontare gli imprevisti causati dal tempo e simili, le popolazioni preistoriche dovevano personificare questi fenomeni e “parlargli”, direttamente, ritualisticamente, o metaforicamente.
Infatti, le popolazioni preistoriche sembrano essere intervenute sui loro ambienti tanto risolutivamente quanto era in loro potere. Non appena Homo erectus o successive specie umane impararono a usare il fuoco, per esempio, sembra l’abbiano adoperato per bruciare foreste, probabilmente per spingere la selvaggina giù dai dirupi o verso recinti naturali dove potevano facilmente massacrarli. La “riverenza per la vita” delle popolazioni preistoriche rifletteva quindi una preoccupazione certamente pragmatica per accrescere e controllare le riserve di cibo, non un qualche amore per gli animali, le foreste, le montagne (che invece con buona probabilità temevano, in quanto dimore di divinità tanto demoniache quanto benigne).[31]
Nemmeno “l’amore per la natura” che Bradford attribuisce alla “società primordiale” descrive accuratamente le popolazioni di raccoglitori di oggi, le quali spesso sono costrette ad affrontare duri problemi relativi al lavoro e alla cacciagione; i pigmei della foresta Ituri, per esempio, tormentavano la selvaggina in trappola in modo alquanto sadico, e gli eschimo erano soliti maltrattare i loro huskies.[32] Per quanto riguarda i nativi americani prima del contatto con gli europei, essi avevano già alterato vaste aree del continente con l’uso del fuoco per ripulire le terre per l’orticultura e per una migliore visibilità durante la caccia, al punto che il “paradiso” incontrato dagli europei era già stato «chiaramente umanizzato».[33]
Inevitabilmente, sembra che molte tribù indiane avessero esaurito la selvaggina locale e fossero state costrette a emigrare verso nuovi territori in cerca dei mezzi materiali per sopravvivere. E sarebbe davvero sorprendente scoprire che essi non abbiano intrapreso guerre per scacciare gli occupanti originari. Probabilmente, i loro remoti antenati spinsero alcuni dei grandi mammiferi nordamericani dell’ultima età del ghiaccio (in particolare mammuth, mastodonti, bisonti a corno lungo, cavalli, cammelli) verso l’estinzione. In alcuni siti sono ancora discernibili ossa di bisonte densamente accumulate, che suggeriscono massacri e macellazioni in stile “linea di assemblaggio” in diversi arroyo americani.[34]
Tra le popolazioni che praticavano l’agricoltura neanche l’uso della terra era necessariamente benigno dal punto di vista ecologico. Negli altipiani del Messico centrale, attorno al lago Pátzcuaro, prima della conquista spagnola, «l’uso preistorico della terra non era conservazionista nella pratica», scrive Karl W. Butzer, ma causò alti livelli di erosione del suolo. Infatti, le pratiche agricole aborigene «potrebbero essere state tanto dannose quanto ogni altro tipo di uso preindustriale della terra nel vecchio mondo».[35] Altri studi hanno mostrato che il disboscamento delle foreste e il fallimento nel praticare un’agricoltura sostenibile hanno pregiudicato la società maya e contribuito al suo collasso.[36]
Non avremo mai modo di sapere se gli stili di vita delle culture di raccoglitori odierne rispecchiano accuratamente quelle del nostro passato ancestrale.[37] Non solo le moderne culture aborigene si sono sviluppate nel corso di migliaia di anni, ma esse sono state alterate in modo significativo dalla diffusione di innumerevoli tratti provenienti da altre culture, prima di essere studiate dai ricercatori occidentali. Infatti, come ha osservato Clifford Geertz alquanto acidamente, c’è ben poco, se non niente, di “puro” riguardo le culture aborigene che i moderni primitivisti associano all’umanità degli inizi. «La realizzazione, riluttante e tardiva, che [l’intatta primalità degli aborigeni esistenti] non è tale, né per i pigmei, e nemmeno per gli eschimo», osserva Geertz, «e che queste popolazioni sono di fatto il risultato di processi di cambiamento sociale su larga scala che li hanno resi e continuano a renderli ciò che sono; è arrivata come un duro colpo che ha indotto una crisi virtuale nel campo [dell’etnografia]»[38]. Un sacco di popolazioni “primordiali”, come le stesse foreste nelle quali abitavano, al momento del contatto con gli europei non erano più “vergini” di quanto lo fossero gli indiani Lakota al tempo della guerra civile americana, malgrado Ballando coi lupi sostenga il contrario. Molti dei ben noti sistemi di credenza “primordiali” degli aborigeni ancora esistenti sono facilmente riconducibili a influenze cristiane. Alce Nero, a esempio, era un cattolico zelante[39], mentre la danza degli spiriti di tardo diciannovesimo secolo dei Paiute e dei Lakota è stata profondamente influenzata dal millenarismo evangelico cristiano.
Nelle ricerche antropologiche serie, la nozione di un cacciatore originario, “estatico”, non è sopravvissuta ai trent’anni che sono passati dal simposio Uomo, il cacciatore. La maggior parte delle «società dell’abbondanza di cacciatori» citate dai devoti del mito dell’“abbondanza primitiva” si sono letteralmente devoluti – molto probabilmente contro i propri desideri – a sistemi sociali orticoli. Le popolazioni San del Kalahari sono note per essere state ortolane prima di essere spinte verso il deserto. Diverse centinaia di anni fa, secondo Edwin Wilmsen, le popolazioni che parlavano il san praticavano l’allevamento e l’agricoltura, per non parlare degli scambi che avevano con i chiefdom agricoli vicini, all’interno di una rete che si estendeva fino all’Oceano indiano. Gli scavi hanno mostrato che verso l’anno Mille, Dobe era popolata da persone che producevano ceramiche, lavoravano il ferro e praticavano la pastorizia, esportando la produzione verso l’Europa intorno agli anni Quaranta dell’Ottocento insieme a grosse quantità di avorio; buona parte del quale ricavato dagli elefanti che gli stessi San cacciavano, i quali avranno certamente condotto questo massacro dei loro “fratelli” pachidermi con la grande sensibilità che Zerzan gli attribuisce. Gli stili di vita marginali da raccoglitori dei San che hanno così tanto estasiato gli osservatori negli anni Sessanta di questo secolo, erano in realtà il risultato di cambiamenti economici che risalgono alla fine del diciannovesimo secolo, mentre «la lontananza immaginata dagli osservatori esterni […] non era indigena ma creata dal collasso del capitale mercantile»[40]. Così, «l’attuale status delle popolazioni che parlano il san nella periferia rurale delle economie africane», nota Wilmsen,
può essere spiegata solo in termini di politiche sociali ed economiche dell’era coloniale e delle sue conseguenze. La loro apparizione in quanto raccoglitori è una funzione della loro relegazione a classe inferiore nello svolgersi dei processi storici che iniziano prima dell’attuale millennio e culminano nei primi decenni di questo secolo.[41]
Anche gli Yuquì dell’Amazzonia avrebbero potuto benissimo incarnare la società originaria di raccoglitori decantata negli anni Sessanta. Isolati dal contatto con gli europei fino agli anni Cinquanta, la cassetta degli attrezzi di queste popolazioni consistevano di poco più che qualche zanna di cinghiale, arco e frecce: «Oltre che essere incapaci di produrre il fuoco», scrive Allyn M. Stearman, che li ha studiati, «essi non avevano imbarcazioni, animali domestici (nemmeno il cane), pietre, specialisti del rituale, e possedevano soltanto una cosmologia rudimentale. Vivevano come nomadi, vagando per le foreste dei bassipiani della Bolivia in cerca di selvaggina e altri tipi di cibo che ottenevano grazie alle loro capacità di raccoglitori»[42]. Non crescevano alcun tipo di coltura ed erano estranei all’uso del gancio e della canna per la pesca.
Ben lontani dall’essere egualitari, gli Yuquì sostenevano l’istituto della schiavitù ereditaria, dividendo la loro società in un’elite privilegiata e in un gruppo di schiavi lavoratori disprezzati. Questa caratteristica viene ora considerata un residuo di stili di vita orticoli precedenti. Sembra che gli Yuquì discendano da una precedente società schiavista precolombiana, e che «con il tempo, essi abbiano subito un processo di deculturazione, perdendo parte della loro eredità culturale, mentre diventava necessario continuare a muoversi vivendo della terra. Ma anche se molti elementi della loro cultura possono essere andati perduti, altri rimasero. La schiavitù, evidentemente, fu una di queste»[43].
Non solo il mito del raccoglitore “primordiale” è stato fatto a pezzi, ma gli stessi dati di Richard Lee sull’apporto calorico dei raccoglitori delle “società dell’abbondanza” è stato seriamente messo in questione da Wilmsen e i suoi colleghi.[44] Le popolazioni !Kung avevano un’aspettativa di vita media di circa trent’anni. La mortalità infantile era alta, e secondo Wilmsen (non se ne abbia Bradford!), erano soggetti a malattie e soffrivano la fame durante le stagioni di magra. (Lo stesso Lee ha riconsiderato le sue posizioni su questo argomento dopo gli anni Sessanta.)
Analogamente, quasi sicuramente le vite dei nostri antenati era tutto tranne che incantevoli. Anzi, la vita per loro era piuttosto dura, generalmente corta, e materialmente molto esigente. Esami anatomici della loro longevità mostrano che circa la metà di essi moriva nell’infanzia o prima di compiere vent’anni, e pochi sopravvivevano ai cinquant’anni.[45] È probabile che più che essere cacciatori-raccoglitori, essi rovistavano tra le carcasse, oltre a essere allo stesso tempo prede di leopardi e iene.[46]
Verso i membri della propria banda, tribù, o clan, le popolazioni preistoriche e più tardi quelle di raccoglitori, erano solitamente cooperative e pacifiche; ma verso i membri di altre bande, tribù, o clan, erano spesso bellicose, a volte persino genocide nei loro tentativi di espropriarli e per appropriarsi della loro terra. Il più beato tra gli esseri umani ancestrali (dando ascolto ai primitivisti), l’Homo erectus, si è lasciato dietro un desolante quadro di carneficina interumana, secondo i dati raccolti da Paul Janssens.[47] È stato ipotizzato che molti individui in China e a Java siano stati uccisi da eruzione vulcaniche, ma le spiegazioni più recenti perdono di credibilità alla luce dei resti di quaranta individui le cui teste, menomate fatalmente, sono state decapitate; «difficilmente opera di un vulcano», osserva seccamente Corinne Shear Wood.[48] Passando ai raccoglitori moderni, i conflitti tra le tribù di nativi americani sono troppo numerosi anche solo per essere citate estesamente; come testimoniano gli Anasazi e i loro vicini nel Sudovest, le tribù che andarono poi a costituire la Confederazione irochese (la confederazione stessa era una questione di sopravvivenza se non volevano finire per sterminarsi reciprocamente), e il conflitto incessante tra Mohawk e Uroni, che portò al quasi sterminio e alla dipartita delle poche comunità di Uroni sopravvissute.
Se i «desideri» delle popolazioni preistoriche venivano «facilmente soddisfatti», come sostiene Bradford, era proprio perché le loro condizioni di vita materiali – e quindi i propri desideri – erano di fatto semplici. E questo è ciò che ci si aspetterebbe da ogni forma di vita che perlopiù si adatta invece di innovare, che si conforma a un habitat preesistente invece che alterarlo per renderlo conforme al proprio volere. A essere precisi, le prime popolazioni avevano una comprensione meravigliosa dell’habitat nel quale vivevano; erano, dopotutto, esseri molto intelligenti e immaginativi. Ma la loro cultura «estatica» era inevitabilmente infestata non solo dalla gioia e dal «canto […] dalle celebrazioni […] dai sogni», ma anche dalla superstizione, e perciò facilmente manipolabile dalle paure.
E nemmeno i nostri remoti antenati, così come gli aborigeni ancora esistenti, avrebbero potuto sopravvivere se avessero praticato le “incantevoli” idee da Disneyland sostenute dai primitivisti contemporanei. Di certo, gli europei non offrirono agli aborigeni una grandiosa amministrazione sociale. Al contrario: gli imperialisti sottoposero i nativi a uno sfruttamento spietato, al genocidio totale, a malattie verso le quali non avevano alcuna immunità, e al più spudorato saccheggio. Nessun incantesimo animista avrebbe potuto prevenire questo massacro, come nella tragedia di Wounded Knee nel 1890, dove il mito di maglie fantasma impermeabili ai proiettili venne tragicamente smentito.
Ciò che è di cruciale importanza è che la regressione al primitivismo tra gli anarchici lifestyle nega le qualità più salienti dell’umanità in quanto specie e gli aspetti potenzialmente emancipatori della civiltà euro-americana. Gli esseri umani sono enormemente diversi dagli altri animali per il fatto che vanno ben oltre il semplice adattamento al mondo che li circonda; essi innovano e creano un nuovo mondo, non solo per scoprire le proprie capacità in quanto esseri umani, ma per rendere il mondo che li circonda più adeguato al proprio sviluppo, sia come individui che come specie.
Per quanto questa capacità venga distorta dall’attuale società irrazionale, la capacità di cambiare il mondo è una dotazione naturale, il prodotto dell’evoluzione biologica umana; e non semplicemente il prodotto della tecnologia, della razionalità, e della civiltà. Il fatto che persone che si definiscono anarchiche sostengano un primitivismo che si avvicina all’animalistico, con il suo messaggio appena dissimulato di adattabilità e passività, infanga secoli di pensieri, ideali, e pratiche rivoluzionarie, infama gli sforzi memorabili compiuti dall’umanità per liberarsi dal campanilismo, dal misticismo, dalla superstizione, e per cambiare il mondo.
Per gli anarchici lifestyle, in particolare i primitivisti e quelli anti-civilizzatori, la storia stessa diventa un monolite degradante che ingoia tutte le distinzioni, le mediazioni, le fasi di sviluppo, e le specificità sociali. Il capitalismo e le sue contraddizioni sono ridotti a epifenomeni di una civiltà che tutto divora, e dei suoi “imperativi” tecnologici, che mancano di qualsiasi sfumatura e differenziazione. La storia, nella misura in cui la consideriamo come lo svolgersi della componente razionale dell’umanità – lo sviluppo della sua potenzialità per la libertà, l’autoconsapevolezza, la cooperazione – è un complesso resoconto della coltivazione di sensibilità umane, istituzioni, intellettualità, e conoscenza, o ciò che una volta veniva chiamata “l’educazione dell’umanità”. Guardare alla storia come una “caduta” costante da una “autenticità” animalistica, come fanno Zerzan, Bradford, e in varia misura anche i loro colleghi, con uno stile molto simile a quello di Martin Heidegger, significa ignorare l’espansione degli ideali di libertà, individualità, e autoconsapevolezza che hanno segnato le epoche dello sviluppo umano; per non parlare del fine più ampio che le lotte rivoluzionarie hanno rappresentato nel cercare di raggiungere questi obiettivi.
L’anarchismo lifestyle anti-civilizzatore è semplicemente un aspetto della regressione sociale che caratterizza gli ultimi decenni del ventesimo secolo. Proprio mentre il capitalismo minaccia di disfarsi della storia naturale riportandola indietro a un’era geologica e zoologica più semplice e meno differenziata, l’anarchismo lifestyle anti-civilizzatore è complice del capitalismo nel portare lo spirito umano e la sua storia indietro verso un mondo meno sviluppato, meno determinato, prelapsario; la società presuntamente “innocente” che precede la tecnologia e la civiltà, esistita prima della «caduta dell’umanità dalla grazia». Come i mangiatori di loto nell’Odissea di Omero, gli esseri umani sono “autentici” quando vivono in un eterno presente, senza passato o futuro; imperturbati dalla memoria o dall’ideazione, liberi dalla tradizione, e indisturbati dall’avvenire.
Ironicamente, il mondo idealizzato dai primitivisti precluderebbe in realtà l’individualismo radicale celebrato dagli eredi individualisti di Stirner. Nonostante le comunità “primordiali” contemporanee abbiano prodotto individualità ben scolpite, la forza dell’abitudine e l’alto grado di solidarietà di gruppo imposto da condizioni esigenti lasciano davvero poca libertà d’azione a comportamenti eccessivamente individualisti, del tipo di quelli pretesi dagli anarchici stirneriani che celebrano la supremazia dell’ego. Oggi, dilettarsi nel primitivismo rappresenta il privilegio di cittadini benestanti che si possono permettere di giocare con le fantasie negate non solo agli affamati e ai poveri e ai “nomadi” che per necessità popolano le strade delle città, ma anche ai dipendenti sovraccarichi di lavoro. Difficilmente una moderna lavoratrice con figli potrebbe fare a meno di una lavatrice che la sollevi, per quanto minimamente, dalle fatiche domestiche; prima di andare a lavorare per guadagnare quella che spesso rappresenta la maggior parte del reddito domestico. Ironicamente, anche il collettivo che produce «Fifth Estate» ha dovuto constatare che non poteva farlo senza un computer ed è stato «costretto» a comprarne uno; emettendo una falsa dichiarazione di non responsabilità, «Lo odiamo!»[49] Criticare una tecnologia avanzata mentre la si usa per produrre letteratura contro la tecnologia è non solo ipocrita, ma ha una dimensione moraleggiante: tale “odio” per i computer assomiglia molto al rutto del privilegiato, il quale essendosi ingozzato di prelibatezze durante la settimana, decanta le virtù della povertà durante la preghiera domenicale.
Valutare l’anarchismo lifestyle
Ciò che emerge con più forza nell’anarchismo lifestyle contemporaneo è il suo appetito per l’immediatezza invece che per la riflessione, per un’ingenua relazione uno a uno tra mente e realtà. Non solo questa immediatezza immunizza il pensiero libertario dall’esigenza di riflessioni articolate e ragionate; essa impedisce l’analisi razionale e, per questo, la razionalità stessa. Consegnare l’umanità all’atemporale, all’aspaziale, all’astorico – una nozione “primordiale” di temporalità basata sugli “eterni” cicli della “Natura” – spoglia conseguentemente la mente della sua unicità creativa e della sua libertà di intervenire nel mondo naturale.
Dal punto di vista dell’anarchismo lifestyle primitivista, gli esseri umani sono al meglio di sé quando si adattano alla natura non umana invece che intervenire in essa, oppure quando, sgravati della ragione, della tecnologia, della civiltà, e anche della parola, vivono in pacata “armonia” con la realtà esistente, magari dotati di “diritti naturali”, entro una condizione “estatica” viscerale e sostanzialmente priva di senso. Taz, Fifth Estate, Anarchy: A Journal of Desire Armed, e “zines” lumpen come Demolition Derby del stirneriano Michael William; si concentrano tutte su una “primalità” non mediata, astorica, e contro la civiltà, dalla quale siamo “caduti”, uno stato di perfezione e “autenticità” nel quale eravamo guidati, a seconda del caso, dai “legami della natura”, dalla “legge naturale”, o dai nostri ego voraci. La storia e la civiltà consistono di niente più che una discesa verso l’inautenticità dalla “società industriale”.
Come ho già suggerito, questo mito di una “caduta dall’autenticità” ha le sue radici nel romanticismo reazionario, e più recentemente nella filosofia di Martin Heidegger, il cui “spiritualismo” völkisch, latente in Essere e tempo, emerse successivamente nei sui scritti esplicitamente fascisti. Questa visione si nutre ora del misticismo quietista che abbonda negli scritti antidemocratici di Rudolf Bahro, con il suo malcelato appello alla “salvazione” da parte di un “Adolf Verde”, e nella ricerca apolitica di un spiritualismo ecologico e dell’“autorealizzazione” proposta dagli ecologisti profondi.
Alla fine, l’ego individuale diventa il tempio supremo della realtà, che esclude la storia e il divenire, la democrazia e la responsabilità. Infatti, il contatto vissuto con la società in quanto tale viene reso labile da un narcisismo così onnicomprensivo da restringere la consociazione a un ego infantile, che è poco più di un ammasso di richieste e dichiarazioni strillate per il proprio compiacimento. La civiltà non fa altro che ostruire l’autorealizzazione estatica dei desideri di questo ego, reificato in quanto massima realizzazione dell’emancipazione, come se l’estasi e il desiderio non fossero prodotti della cultura e dello sviluppo storico, ma semplici impulsi innati che appaiono ab novo in un mondo de-socializzato.
Come l’ego piccolo-borghese stirneriano, l’anarchismo lifestyle primitivista non lascia spazio alle istituzioni sociali, alle organizzazioni politiche, e ai programmi radicali, men che meno a una sfera pubblica, che tutti gli scrittori che abbiamo esaminato identificano automaticamente con il governare. Lo sporadico, l’assenza di sistematicità, l’incoerenza, la discontinuità, e l’intuitivo soppiantano il consistente, l’intenzionale, l’organizzato, e il razionale, e ogni forma di attività dedicata e duratura che vada oltre la pubblicazione di una “zine” o un pamphlet; o il dar fuoco a un cassonetto della spazzatura. L’immaginazione è contrapposta alla ragione e il desiderio alla coerenza teorica, come se le due cose fossero in radicale contraddizione l’una con l’altra. L’ammonizione di Goya che l’immaginazione senza la ragione produce mostri viene alterata per lasciare l’impressione che l’immaginazione fiorisca attraverso l’esperienza diretta di “un’unicità” indistinta. Così la natura sociale viene essenzialmente dissolta nella natura biologica; l’umanità innovativa, in un’animalità adattiva; la temporalità, in un’eternalità che precede la civiltà; la storia, in una ciclicità arcaica.
Una realtà borghese la cui brutalità economica cresce ogni giorno diventando sempre più rozza e cruda, viene scaltramente mutata dall’anarchismo lifestyle in una costellazione di auto-indulgenza, rudimentalità, indisciplina, e incoerenza. Negli anni Sessanta i situazionisti, nel nome di una “teoria dello spettacolo”, produssero in realtà uno spettacolo reificato della teoria, ma per lo meno offrirono correttivi organizzativi, come i consigli dei lavoratori, che diedero al loro estetismo una qualche ancora. L’anarchismo lifestyle, attaccando l’organizzazione, l’impegno programmatico, e una seria analisi sociale, scimmiotta gli aspetti peggiori dell’estetismo situazionista senza aderire al progetto di costruire un movimento. In quanto detrito degli anni Sessanta, esso vaga senza meta entro i confini dell’ego (rinominati da Zerzan i «confini della natura») e fa dell’incoerenza bohémien una virtù.
Ciò che più preoccupa è che i capricci estetici e auto-indulgenti dell’anarchismo lifestyle corrodono significativamente l’anima socialista di un’ideologia di sinistra e libertaria, che poteva una volta affermare la sua rilevanza sociale e il suo peso proprio a seguito del suo impegno intransigente per l’emancipazione; non fuori dalla storia, nel regno del soggettivo, ma dentro la storia, nel regno dell’oggettivo. Il grande richiamo della Prima Internazionale – mantenuta dall’anarcosindacalismo e dal comunismo anarchico dopo che Marx e i suoi difensori la abbandonarono – era la rivendicazione: «Nessun diritto senza obblighi, nessun obbligo senza diritti». Per intere generazioni questo slogan adornò le testate di ciò che noi ora dobbiamo retrospettivamente chiamare i periodici anarchici sociali. Oggi, esso si trova radicalmente in contraddizione con la richiesta sostanzialmente egocentrica del “desiderio armato”, con la contemplazione taoista e i nirvana buddisti. Dove l’anarchismo sociale esortava le persone a sollevarsi in rivoluzione e a perseguire la ricostruzione della società, i piccoli borghesi adirati che popolano il mondo sottoculturale dell’anarchismo lifestyle invocano ribellioni episodiche e la soddisfazione delle proprie “macchine desideranti”, per usare la fraseologia di Deleuze e Guattari.
La fuga costante dall’impegno storico dell’anarchismo classico per la lotta sociale (senza la quale l’auto-realizzazione e la soddisfazione del desiderio in tutte le sue dimensioni, non solo quella istintiva, non potrebbero essere raggiunti) si accompagna inevitabilmente a una disastrosa mistificazione dell’esperienza e della realtà. L’ego, identificato quasi feticisticamente come il luogo dell’emancipazione, si rivela essere identico all’“individuo sovrano” dell’individualismo laissez-faire. Staccato dal suo ancoraggio sociale, non consegue l’autonomia ma l’“individualità” eteronoma dell’impresa piccolo borghese.
Infatti, lungi dall’essere libero, l’ego nella sua “individualità sovrana” è legato mani e piedi alle leggi apparentemente anonime del mercato – le leggi della competizione e dello sfruttamento – che rendono il mito della libertà individuale un altro feticcio, così da mantenere nascoste le leggi implacabili dell’accumulazione capitalista. L’anarchismo lifestyle, infatti, si rivela essere un ulteriore inganno borghese mistificatorio. I suoi accoliti non sono più “autonomi” dei movimenti del mercato azionario, delle fluttuazioni dei prezzi e degli aspetti più ordinari del commercio borghese. Lasciando da parte tutti i richiami all’autonomia, tale “ribelle” borghese, con o senza un mattone in mano, è interamente prigioniero delle forze di mercato sotterranee che occupano tutti i terreni presuntamente “liberi” della vita sociale moderna, dalle cooperative del cibo alle comuni rurali.
Il capitalismo ci vortica intorno; non solo materialmente, ma anche culturalmente. Come rispose in maniera indimenticabile Zerzan a un intervistatore che gli chiedeva perplesso perché ci fosse una tv in casa di un tale nemico della tecnologia: «Come tutte le altre persone, anch’io devo essere narcotizzato»[50].
Che lo stesso anarchismo lifestyle sia un’illusione “narcotizzante” può essere meglio notato nell’Unico e le sue proprietà di Max Stirner, dove il richiamo dell’ego all’“unicità” nel tempio del sacrosanto “Sé” supera di gran lunga i sentimenti liberali di John Stuart Mill. Infatti, con Stirner l’egoismo diventa una questione di epistemologia. Tagliando attraverso il labirinto di contraddizioni e affermazioni miseramente incomplete che riempiono L’unico e le sue proprietà, si scopre che l’ego “unico” di Stirner è un mito perché ha le sue radici nel suo finto “altro”; la società stessa. Infatti: «La verità non può farsi avanti come fai tu», Stirner dice all’egoista, «non può muoversi, cambiare, svilupparsi; la verità attende e recluta ogni cosa da te, ed essa stessa esiste solo attraverso di te; perché esiste solo nella tua testa»[51]. L’egoista stirneriano, infatti, si congeda dalla realtà oggettiva, dalla fattualità del sociale, e perciò dal cambiamento sociale sostanziale e da ogni criterio etico e ideale che vada oltre la soddisfazione personale tra i demoni nascosti del mercato borghese. Questa assenza di mediazione sovverte la stessa esistenza della concretezza, per non parlare dell’autorità dello stesso ego stirneriano; una pretesa così totalizzante che esclude le radici sociali del sé e la sua formazione nella storia.
Nietzsche, in modo indipendente da Stirner, portò questa visione della verità verso le sue conclusioni logiche cancellando la fattualità e la realtà della verità in quanto tali: «Quindi, cosa è la verità?», egli chiese. «Un esercito mobile di metafore, metonimie, e antropomorfismi; in breve, una somma di relazioni umane, che sono state rafforzate, recepite, e imbellite poeticamente e retoricamente»[52]. Con più franchezza di Stirner, Nietzsche sostenne che i fatti sono semplicemente interpretazioni; infatti, egli chiese, «è necessario posizionare un interprete dietro le interpretazioni?» A quanto pare no, perché «anche questa è invenzione, ipotesi»[53]. Seguendo l’inesorabile logica di Nietzsche, rimaniamo con un sé che non solo crea essenzialmente la sua stessa realtà, ma che deve anche cercare di giustificare la sua stessa esistenza come qualcosa di più che una semplice interpretazione. Tale egoismo annichilisce perciò lo stesso ego, il quale svanisce tra la nebbia delle stesse premesse inespresse di Stirner.
Ugualmente spogliato della storia, della società e della fattualità, oltre che delle sue stesse “metafore”, l’anarchismo lifestyle vive in un dominio asociale nel quale l’ego, con i suoi desideri criptici, deve evaporare trasformandosi in un insieme di astrazioni logiche. Ma ridurre l’ego all’immediatezza intuitiva – ancorandolo a una mera animalità, nei “confini della natura”, o nella “legge naturale” – vorrebbe dire ignorare il fatto che l’ego è il prodotto di una storia sempre-formativa, cioè, una storia che, se vuole comporsi di qualcosa di più di semplici episodi, deve avvalersi della ragione come guida per orientarsi tra criteri di progresso e regresso, necessità e libertà, buono e cattivo, e – esattamente! – civiltà e barbarie. Infatti, un anarchismo che cerca di evitare le secche di un solipsismo assoluto da un lato, e la perdita del sé come mera “interpretazione” dall’altro deve diventare esplicitamente socialista o collettivista. Cioè, deve essere un anarchismo sociale che persegue la libertà attraverso la struttura e la responsabilità reciproca, non attraverso un ego vaporoso, nomade, che rifugge le condizioni necessarie per la vita sociale.
Per dirla in modo chiaro: tra il retaggio socialista dell’anarcosindacalismo e del comunismo anarchico (che non hanno mai negato l’importanza dell’auto-realizzazione e della soddisfazione dei desideri), e il retaggio essenzialmente liberale, individualista dell’anarchismo lifestyle (che sostiene l’inefficacia sociale, se non apertamente la negazione della società), esiste una frattura che non può essere colmata a meno di voler ignorare gli obiettivi, i metodi, e le filosofie sottintese profondamente diverse che li rendono distinguibili. Lo stesso progetto di Stirner emerse infatti in un dibattito con il socialismo di Wilhelm Weitling e Moses Hess, dove egli invocò l’egoismo proprio per contrapporlo al socialismo. «Il messaggio [di Stirner] era l’insurrezione personale invece che la rivoluzione generale», osserva con ammirazione James J. Martin[54]; una contrapposizione che continua a vivere oggi nell’anarchismo lifestyle e nelle sue filiazioni yuppie, distinte dall’anarchismo sociale che ha invece le sue radici nello storicismo, nella matrice sociale dell’individualità, e nel suo impegno per una società razionale.
La stessa incongruenza di questi messaggi essenzialmente contrastanti, che coesistono in ogni pagina delle “zines” lifestyle, riflette la voce febbrile di un piccolo borghese agitato. Se l’anarchismo perde la sua anima socialista e il suo scopo collettivista, se si addormenta nell’estetismo, nell’estasi, nel desiderio, e, incongruentemente, nel quietismo taoista e nell’umiltà buddista come sostituto a un programma libertario, alla politica, all’organizzazione, finirà per rappresentare non più una rigenerazione sociale e una visione rivoluzionaria, ma la decadenza sociale e una ribellione egoista e petulante. Peggio, esso nutrirà l’onda di misticismo che sta già travolgendo i membri agiati della generazione che si trova ora tra l’adolescenza e i trent’anni. L’esaltazione che l’anarchismo lifestyle fa dell’estasi, certamente lodabile se inserita in una matrice sociale radicale ma qui sfacciatamente mescolata con la “stregoneria”, sta producendo come nei sogni un’assimilazione agli spiriti, ai fantasmi, e ad archetipi jungiani, invece che una consapevolezza razionale e dialettica del mondo.
In modo alquanto caratteristico, la copertina di un recente numero di Alternative Press Review (Autunno 1994), un periodico selvatico anarchico americano ampiamente letto, è adornata di una divinità a tre teste buddista in un sereno riposo nirvanico, contro quello che sembra uno sfondo cosmico composto di galassie vorticose e armamentario New Age; un’immagine che potrebbe benissimo accompagnarsi al poster Anarchy di «Fifth Estate» in una boutique New Age. Nell’interno della copertina, un’illustrazione grida: «La Vita Può Essere Magica Quando Iniziamo A Liberarci» (la A in Magica è cerchiata); alla quale si è costretti a rispondere: Come? Con cosa? La rivista contiene un saggio di ecologia profonda di Glenn Parton (tratto dal periodico di David Foreman «Wild Earth») titolato: «Il sé selvaggio: perché sono primitivista», che esalta le «popolazioni primitive» il cui «stile di vita è adatto al mondo naturale esistente», lamenta la rivoluzione neolitica, e identifica il nostro «compito primario» in quanto esseri umani nel «“decostruire” la nostra civilizzazione, e restaurare lo stato selvaggio». Le illustrazioni della rivista celebrano la volgarità; vengono messi in evidenza teschi umani e immagini di rovine. Il suo contributo più lungo, Decadenza, ristampato da Black Eye, fonde il romantico con il lumpen, concludendo con esultanza: «È l’ora per una vera vacanza romana, quindi porta i barbari!»
Ahimè, i barbari sono già qui; e la “vacanza romana” nelle città americane contemporanee prospera nel crack, nel teppismo, nell’insensibilità, nella stupidità, nel primitivismo, nel pensiero anti-civilizzatore, nell’antirazionalismo, e in una consistente dose di “anarchia” concepita come caos. L’anarchismo lifestyle deve essere visto non solo nell’attuale contesto sociale dei ghetti neri demoralizzati e dei sobborghi bianchi reazionari, ma anche delle riserve indiane, quegli apparenti centri di “primalità”, nei quali le gang di giovani indiani ora si sparano a vicenda, lo spaccio impera, e «le gang di writers danno il benvenuto ai visitatori persino dal monumento sacro di Window Rock», come riporta Seth Mydans nel «The New York Times» (3 marzo 1995).
Pertanto, alla degenerazione della Nuova Sinistra degli anni Sessanta verso il postmodernismo, e della sua controcultura verso un spiritualismo New Age, è seguita una decadenza culturale generalizzata. Per gli anarchici lifestyle più titubanti, le grafiche da halloween e gli articoli incendiari portano speranza e una comprensione di una realtà che sembra sempre più distante. Strappati dalle esche del “terrorismo culturale” e dagli ashram buddisti, gli anarchici lifestyle si trovano di fatto sotto un fuoco incrociato, tra i barbari al vertice della società di Wall Street e della City, e quelli in fondo, negli squallidi ghetti urbani euro-americani. Purtroppo, il conflitto nel quale si trovano invischiati, al di là di tutte le loro esaltazioni di stili di vita lumpen (ai quali i barbari dei vertici aziendali non sono estranei al giorno d’oggi), ha meno a che fare con il bisogno di creare una società libera, quanto invece con una guerra brutale su chi debba condividere i resti del bottino proveniente dalla vendita di sostanze, corpi umani, e mutui esorbitanti; senza dimenticarci dei titoli spazzatura e delle valute internazionali.
Un ritorno alla mera animalità – o dovremmo forse chiamarla “de-civilizzazione”? – non è un ritorno alla libertà ma all’istinto, al dominio dell’“autenticità” guidata più dai geni che dai cervelli. Niente di più lontano dagli ideali di libertà enunciati in forme sempre più espansive dalle grandi rivoluzioni del passato. E niente potrebbe rivelarsi più accanito di ciò nella sua cieca obbedienza a imperativi biochimici come il DNA o più in contrasto con la creatività, l’etica, e la reciprocità resa possibile dalla cultura e dalle lotte per una civiltà razionale. Non c’è alcuna libertà nello “stato selvaggio”, se per pura selvaticità intendiamo i dettami dei modelli comportamentali innati che formano la mera animalità. Maledire la civiltà senza riconoscere le sue enorme potenzialità per una libertà consapevole – una libertà conferita dalla ragione tanto quanto dall’emozione, dall’intuizione tanto quanto dal desiderio, dalla prosa come dalla poesia – vuol dire rifugiarsi verso l’oscuro mondo dell’abbruttimento, quando il pensiero era annebbiato e l’uso dell’intelletto solamente una promessa evolutiva.
Verso un comunalismo democratico
Il mio ritratto dell’anarchismo lifestyle è tutt’altro che completo; l’impostazione personalistica di questo fango ideologico gli permette di essere modellato in più forme, premesso che parole come immaginazione, sacro, intuitivo, estati, e originario ne abbelliscano la superficie.
L’anarchismo sociale, dal mio punto di vista, è qualcosa di fondamentalmente diverso, erede della tradizione illuminista, con dovuto riguardo ai limiti e all’incompletezza di quella tradizione. A seconda di come definisce la ragione, l’anarchismo sociale celebra la mente umana pensante senza negare in nessun modo la passione, l’estasi, l’immaginazione, il gioco, e l’arte. Ma piuttosto che reificare queste cose trasformandole in categorie nebulose, esso cerca di incorporarle nella vita di ogni giorno. Ricerca la razionalità mentre si oppone alla razionalizzazione dell’esperienza; la tecnologia, pur opponendosi alla “megamacchina”; l’istituzionalizzazione sociale, opponendosi al dominio di classe e alla gerarchia; una politica autentica basata sulla coordinazione confederale di municipalità o comuni da parte delle persone attraverso una democrazia diretta faccia a faccia, mentre si oppone al parlamentarismo e allo Stato.
Questa “Comune delle comuni”, per usare uno slogan tradizionale delle prime rivoluzioni, può essere propriamente designato come comunalismo. Lasciando da parte chi si oppone alla democrazia in quanto forma di “governo”, esso descrive la dimensione democratica dell’anarchismo come amministrazione maggioritaria della sfera pubblica. Di conseguenza, il comunalismo persegue la libertà piuttosto che l’autonomia nel senso in cui le ho contrapposte. Rompe bruscamente con l’ego psico-personale stirneriano, liberale, e bohémien come sovrano di se stesso, sostenendo che l’individualità non emerge ab novo, vestita dalla nascita di “diritti naturali”, ma vede l’individualità in gran parte come il lavoro in continuo cambiamento dello sviluppo storico e sociale, un processo di autoformazione che non può essere né pietrificato dal biologismo né arrestato da dogmi circoscritti nel tempo.
L’“individuo” sovrano, autosufficiente, è sempre stato una base precaria sul quale ancorare una visione libertaria di sinistra. Come ha osservato Max Horkheimer una volta, «l’individualità è pregiudicata quando ogni uomo decide di badare a se stesso […] L’individuo assolutamente isolato è sempre stato un’illusione. Le qualità personali più stimate, come l’indipendenza, la volontà di essere liberi, l’empatia, e il senso di giustizia, sono virtù tanto sociali quanto individuali. L’individuo pienamente sviluppato è il compimento di una società pienamente sviluppata»[55].
Se non vogliamo che una visione libertaria di sinistra della società futura scompaia in un demi-monde bohémien e lumpen, essa deve offrire una soluzione ai problemi sociali, non svolazzare arrogantemente da uno slogan al successivo, schermandosi dalla razionalità attraverso una pessima poesia e grafiche volgari. La democrazia non è antitetica all’anarchismo; né il governo della maggioranza e le decisioni non consensuali sono incommensurabili rispetto a una società libertaria.
Che nessuna società possa esistere senza strutture istituzionali è evidentemente chiaro a chiunque non sia stato stupefatto da Stirner e dagli altri come lui. Negando le istituzioni e la democrazia, l’anarchismo lifestyle si isola dalla realtà sociale, così da poter essere ancora più furioso, ma di una rabbia futile, continuando a essere perciò solo una bravata sottoculturale per ragazzi creduloni e consumatori annoiati di indumenti neri e poster estatici. Sostenere che la democrazia e l’anarchismo sono incompatibili perché ogni impedimento ai desideri di anche solo «una minoranza di uno» costituisce una violazione dell’autonomia personale, vuol dire propugnare non una società libera, ma la “collezione di individui” della Brown; in breve, un gregge. A quel punto l’“immaginazione” non potrebbe più andare al “potere”. Il potere, che esiste sempre, apparterrà o alla collettività entro una democrazia istituzionalizzata e diretta, o agli ego di pochi oligarchi che finirebbero per produrre una “tirannia dell’assenza di struttura”.
Non a torto, Kropotkin, nel suo articolo sulla Encyclopaedia Britannica, considerava l’ego stirneriano come elitista e lo disapprovava in quanto gerarchico. Citava con approvazione la critica di V. Basch all’anarchismo individualista di Stirner in quanto forma di elitismo, siccome sostiene che “lo scopo di tutta la migliore civiltà non è quello di permettere a tutti i membri della comunità di svilupparsi un modo normale, ma di permettere a certi individui meglio dotati di “svilupparsi pienamente”, anche a costo della felicità e della stessa esistenza della massa del genere umano.” Nell’anarchismo, questo produce di fatto una regressione verso l’individualismo più comune, invocato da tutte le aspiranti minoranze superiori alle quali l’uomo deve infatti storicamente l’esistenza dello Stato e tutto il resto, che questi individui professano di combattere. Il loro individualismo si spinge così lontano da finire in una negazione del loro stesso punto di partenza; per non parlare dell’impossibilità dell’individuo di conseguire un pieno sviluppo nelle condizioni di oppressione delle masse da parte delle “magnifiche aristocrazie”.[56]
Nel suo amoralismo, questo elitismo conduce facilmente all’illibertà delle “masse” ponendole in fin dei conti in affidamento agli “unici”, una logica che potrebbe produrre un principio della leadership tipico dell’ideologia fascista.[57]
Negli Stati Uniti e in buona parte dell’Europa, proprio in un periodo in cui il disincanto di massa nei confronti dello Stato ha raggiunto proporzioni senza precedenti, l’anarchismo è in ritirata. L’insoddisfazione nei confronti del governo in quanto tale continua a crescere da entrambi i lati dell’Atlantico; e di rado negli ultimi tempi c’è stato un sentimento popolare così avvincente nei confronti di un nuovo tipo di politica, persino di una nuova amministrazione sociale che possa dare alle persone un senso di direzione che garantisca sicurezza e significato etico. Se è possibile attribuire a una singola fonte il fallimento dell’anarchismo nell’affrontare questa situazione, la ristrettezza dell’anarchismo lifestyle e dei suoi sostegni individualisti deve essere individuato come causa dell’incapacità di un potenziale movimento libertario di sinistra di entrare in una sfera pubblica in continua contrazione.
A suo merito, l’anarcosindacalismo al suo apice tentò di impegnarsi in una pratica vivente e di creare un movimento organizzato – così alieno all’anarchismo lifestyle – all’interno della classe lavoratrice. I suoi problemi maggiori non risiedevano nel suo desidero per la struttura e l’impegno, per i programmi e la mobilitazione sociale, ma nel declino della classe lavoratrice in quanto soggetto rivoluzionario, in particolare dopo la Rivoluzione Spagnola. Tuttavia dire che l’anarchismo mancava di una politica, concepita nel suo significato originario greco come l’autogestione della comunità – la “Comunità delle comuni” storica – vuol dire ripudiare una pratica storica e trasformativa che cerca di radicalizzare la democrazia inerente a ogni repubblica e di creare un potere municipalista confederale da contrapporre allo Stato.[58]
La più creativa tra le qualità dell’anarchismo tradizionale è il suo attaccamento a quattro principi base: una confederazione di municipalità decentralizzate; un’irremovibile opposizione allo statalismo; una fiducia per la democrazia diretta; e la visione di una società comunista libertaria. Il problema più importante che il libertarismo di sinistra incontra oggi – il socialismo libertario non meno dell’anarchismo – è il seguente: Che ne farà di questi quattro potenti principi? Come daremo essi una forma sociale e un contenuto? In quali modi e con quali mezzi li renderemo rilevanti ai nostri tempi e li metteremo al servizio di un movimento popolare organizzato per l’emancipazione e la libertà?
L’anarchismo non deve essere dissipato in comportamenti auto-indulgenti come quelli dei primitivisti adamiti del sedicesimo secolo, che «vagavano nudi per i boschi, cantando e danzando», come ha osservato sprezzantemente Kenneth Rexroth, spendendo «il loro tempo in una continua orgia sessuale» finché non vennero braccati da Jan Zizka e sterminati; con sollievo dei contadini disgustati, le cui terre essi avevano saccheggiato.[59] Esso non deve ritirarsi nel demi-monde primitivista dei John Zerzan e dei George Bradford. Sarei l’ultima persona al mondo a sostenere che gli anarchici non debbano vivere il loro anarchismo il più possibile su base quotidiana; personalmente tanto quanto socialmente, esteticamente quanto pragmaticamente. Ma essi non dovrebbero vivere un anarchismo che sminuisce, addirittura cancella le qualità più importanti che hanno distinto l’anarchismo, in quanto movimento, pratica, e programma, dal socialismo di Stato. L’anarchismo oggi deve mantenere risolutamente il suo carattere di movimento sociale – un movimento sociale programmatico e attivista – un movimento che unisca la sua visione sotto attacco di una società comunista libertaria con la sua critica intransigente al capitalismo, non oscurato da nomi come “società industriale”.
In breve, l’anarchismo sociale deve risolutamente affermare le sue differenze nei confronti dell’anarchismo lifestyle. Se un movimento anarchico sociale non può tradurre i suoi quattro principi – confederalismo municipale, opposizione allo statalismo, democrazia diretta, e infine comunismo libertario – in una pratica vissuta in una nuova sfera pubblica; se questi principi languiscono come le memorie delle sue lotte passate in pronunciamenti e incontri cerimoniali; peggio ancora, se essi vengono sovvertiti dalla “libertaria” Industria dell’Estasi e dai teismi quietistici asiatici, allora la sua anima socialista rivoluzionaria dovrà essere restaurata con un nuovo nome.
Chiaramente, non è più possibile, dal mio punto di vista, che uno si definisca anarchico senza aggiungere un aggettivo qualificante che lo distingua dagli anarchici lifestyle. Come minimo, l’anarchismo sociale è radicalmente in disaccordo con un anarchismo incentrato sul lifestyle, sugli inni all’estasi neo-situazionisti, e sulla sovranità di un ego piccolo borghese sempre più avvizzito. Le due cose divergono completamente nei principi che li definiscono: socialismo o individualismo. Tra un corpo di idee e pratiche rivoluzionarie, da un lato, e un anelito errante in cerca dell’estasi privata e dell’autorealizzazione dall’altro, non può esserci alcuna comunanza. La semplice opposizione allo Stato potrebbe benissimo unire lumpen fascisti a lumpen stirneriani, un fenomeno non senza i suoi precedenti storici.
– 1 giugno 1995
[1] «Libertarians» nel testo. Il termine inglese libertarian conserva un’ambiguità che non esiste nei Paesi europei di forte tradizione comunista. In questi ultimi, la parola libertario è nata come sinonimo di antiautoritario, identificando così gli anarchici in senso lato, e tutt’ora mantiene grosso modo tale significato. In Italia, gli “anarco-capitalisti” o “proprietariani” cui si fa riferimento nel testo, ovvero i fautori di una società interamente organizzata per mezzo della proprietà privata, del lavoro salariato, e del libero mercato come unico mezzo di allocazione delle risorse in assenza di qualsiasi autorità statale o pubblica, vengono indicati col termine “libertariani”, per mantenere la distinzione semantica e le rispettive radici storiche. [N.d.T]
[2] The Political Philosophy of Bakunin, editore G. P. Maximoff, Free Press, Glencoe, Ill. 1953, p. 144.
[3] Political Philosophy of Bakunin, cit., p. 158.
[4] Peter Kropotkin, Anarchism, articolo dell’«Encyclopaedia Britannica», in Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets, ed. Roger N. Baldwin, Dover Publications, New York 1970, pp. 285-87.
[5] L’anarcosindacalismo può essere fatto risalire, in effetti, alle nozioni di una “Grande Vacanza” o sciopero generale proposta dai cartisti inglesi. Tra gli anarchici spagnoli, era già una pratica accettata durante gli anni ’80 dell’800, un decennio circa prima che venne enunciato come dottrina in Francia.
[6] Pur con tutti i suoi limiti, la controcultura anarchica durante la prima parte dei frenetici anni ’60 era spesso intensamente politica e lanciava espressione come desiderio ed estati in termini eminentemente sociali, spesso deridendo le tendenze personalistiche della successiva generazione Woodstock. La trasformazione della “cultura giovanile”, come era chiamata originariamente, dalla nascita dei movimenti per la pace e per i diritti civili, a Woodstock e Altamont, con la loro enfasi su una forma di “piacere” puramente auto-indulgente, è riflessa nella devoluzione di Dylan da “Blowing in the wind” a “Sad-eyed lady of the lowlands”.
[7] K. Matson, Preface, in The Psychology Today Omnibook of Personal Development, William Morrow & Co., New York 1977.
[8] Empowerment nel testo. Il termine non ha un esatto corrispettivo nella lingua italiana. Il Cambridge Dictionary definisce empowerment come «il processo di ottenere la libertà e il potere di fare quello che si vuole e di controllare quello che ci succede». Due aspetti di questa definizione vanno messi in evidenza: empowerment ha una connotazione “positiva”, indica il processo di ottenere qualcosa; centrale è la nozione di potere, come capacità di fare e/o di costringere. Si vede come sia carente la nostra sostituzione con emancipazione, che ha invece una connotazione “negativa” (ci si emancipa da qualcosa o qualcuno), senza nemmeno sapere se questa emancipazione, questo affrancarsi da, sia il risultato di un nostro accrescimento di potere o semplicemente “accada” per merito di un qualche fattore esterno. Questa distinzione va tenuta in mente ogniqualvolta nel testo si ripresenterà il termine “emancipazione”. Specialmente, è da considerare alla luce dell’importanza che la nozione di contropotere ha nel pensiero di Bookchin, ovvero il dualismo di poteri rappresentato dalla società gerarchica (lo Stato e il capitalismo in primis) da un lato, e delle nostre istituzioni emancipate (meglio ancora, “empowered”) dall’altro, le quali si pongono in un’ottica di contropotere nei confronti di quella.
[9] Michel Foucault, The History of Sexuality, vol. 1, tradotto da Robert Hurley, Vintage Books, New York 1990, pp. 95-96. Sia beato il giorno in cui sarà possibile ottenere formulazioni inequivocabili da parte di Foucault, le cui opinioni vengono spesso interpretate in modi contraddittori.
[10] Il pedigree filosofico di questo ego e delle sue fortune può essere rintracciato da Fichte indietro fino a Kant. La visione di Stirner dell’ego fu meramente una ruvida mutazione dell’ego kantiano e in particolare di quello fichtiano, segnata dalla prepotenza più che dall’intuito.
[11] P. Goodman, Politics Within Limits, in Crazy Hope and Finite Experience: Final Essays of Paul Goodman, ed. Taylor Stoehr, Jossey-Bass, San Francisco 1994, p. 56.
[12] Purtroppo, nelle lingue romanze freedom viene in genere tradotta con una parola che deriva dal latino libertas – in francese liberté, libertà in italiano, libertad in spagnolo. L’inglese, che combina insieme tedesco e latino, permette di fare una distinzione tra freedom e liberty, che non risulta possibile nelle altre lingue. L’unica cosa che posso suggerire a riguardo, è che gli scrittori di altre lingue usino entrambe le parole inglesi in modo da mantenere la distinzione.
[13] L. Susan Brown, The Politics of Individualism, Black Rose Books, Montreal 1993). Il nebuloso impegno della Brown per il comunismo anarchico sembra derivare da una preferenza viscerale più che dalla sua stessa analisi.
[14] In una squisita presa in giro del mito che le persone nascono libere, Bakunin dichiarò astutamente: “Quanto sono ridicole le idee degli individualisti della scuola di Jean Jacques Rousseau e dei mutualisti proudhoniani che concepiscono la società come il risultato del libero contratto tra individui assolutamente indipendenti l’uno dall’altro e che entrano in relazioni reciproche solo a causa delle convenzioni stabilite tra gli uomini. Come se questi uomini fossero piovuti dal cielo, portando con sé la parola, la volontà, il pensiero originale, e come se fossero alieni a ogni cosa della terra, cioè, ogni cosa che abbia un’origine sociale”. Maximoff, Political Philosophy of Bakunin, p. 167
[15] Infine, la Brown fraintende in modo significativo Bakunin, Kropotkin, e i miei stessi scritti – un fraintendimento che richiederebbe una discussione dettagliata per essere corretto a pieno. Per quanto mi riguarda, non credo in un «essere umano “naturale”», come asserisce la Brown, più di quanto condivida il suo attaccamento arcaico alla «legge naturale» (p. 159). Quello di “legge naturale” può essere stato un concetto utile durante l’era delle rivoluzioni democratiche di due secoli fa, ma è un mito filosofico le cui premesse morali non hanno più sostanza nella realtà di quanto ne abbia l’intuizione dell’ecologia profonda di un “valore intrinseco”. La “seconda natura” dell’umanità (evoluzione sociale) ha trasformato così ampiamente la “prima natura” (evoluzione biologica) che il mondo naturale dev’essere nominato con più accortezza di quanto faccia la Brown. La sua affermazione, secondo la quale io credo che «la libertà sia inerente alla natura», fraintende grossolanamente la mia distinzione tra una potenzialità e la sua realizzazione (p.160). Per chiarire la mia distinzione tra il potenziale per la libertà che esiste nell’evoluzione naturale e la sua realizzazione ancora incompleta nell’evoluzione sociale, il lettore dovrebbe consultare il mio scritto più aggiornato The Philosophy of Social Ecology: Essays in Dialectical Naturalism, seconda edizione (Montreal: Black Rose Books, 1995).
[16] L. Susan Brown, The Politics of Individualism, Black Rose Books, Montreal 1993). Il nebuloso impegno della Brown per il comunismo anarchico sembra derivare da una preferenza viscerale più che dalla sua stessa analisi.
[17] Taz, in «The Whole Earth Review» (primavera 1994), p. 61.
[18] Citato da Jose Lopez-Rey, Goya’s Capriccios: Beauty, Reason and Caricature, vol. 1, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1953, pp. 80-81.
[19] G. Bradford, Stopping the Industrial Hydra: Revolution Against the Megamachine, in «The Fifth Estate», vol. 24, n. 3 (inverno 1990), p. 10.
[20] Sostituire il capitalismo con la macchina, spostando così l’attenzione del lettore dalle fondamentali relazioni sociali che determinano l’uso della tecnologia alla tecnologia stessa, ricorre in quasi tutta la letteratura anti-tecnologica dei secoli passati e presenti. Jünger parla a nome di quasi tutti gli scrittori di questo genere quando osserva che “il progresso tecnico ha costantemente accresciuto il volume totale di lavoro, e questo è il motivo per cui la disoccupazione aumenta così tanto ogni volta che crisi e disordini disturbano l’organizzazione del lavoro svolto dalle macchine.” Vedi Friedrich Georg Jünger, The Failure of Technology (Chicago: Henry Regnery Company, 1956), p. 7.
[21] Jacques Ellul, The Technological Society, Vintage Books, New York 1964, p. 430.
[22] G. Bradford, Civilization in Bulk, in «Fifth Estate» (primavera 1991), p. 12.
[23] L. Mumford, Technics and Civilization, Harcourt Brace & World, New York and Burlingame 1963, p. 301. Tutti i numeri relativi alle pagine qui citati si riferiscono a questa edizione.
[24] Lewis Mumford, The Pentagon of Power, vol. 2 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), descrizioni alle illustrazioni 13 e 26. Questo lavoro in due volume è stato costantemente frainteso come un attacco alla tecnologia, alla razionalità e alla scienza. In realtà, come indicato nel prologo, il lavoro contrappone più propriamente la magamacchina in quanto modalità di organizzare il lavoro umano – e quindi, anche le relazioni sociali – ai progressi della scienza e della tecnologia, che Mumford in genere celebra, ponendoli nel contesto sociale reale che Bradford sminuisce.
[25] P. Kropotkin, Anarchism, in «Revolutionary Pamphlets», cit., p. 285.
[26] Chiunque ci consigli di ridurre la nostra tecnologia in modo significativo, o persino drastico, ci sta anche consigliando, logicamente, di tornare all’“età della pietra” – almeno al neolitico o paleolitico (primo, medio, o tardo). In risposta all’argomento secondo il quale non potremmo tornare indietro al “mondo primordiale”, Bradford non attacca l’argomento ma chi lo ha fatto: “Gli ingegneri aziendali e i sindacalisti e i critici di sinistra del capitalismo” respingono “ogni altra prospettiva sulla dominazione tecnologica […] come “regressiva” e come desiderio “tecnofobico” di ritornare all’età della pietra”, egli lamenta (CIB, nota 3). Tralascerò di prendere in considerazione la frottola secondo cui favorire lo sviluppo tecnologico in sé significa favorire l’estendersi della “dominazione”, presumibilmente di persone e della natura non umana. Gli “ingegneri aziendali” e “i sindacalisti e critici di sinistra del capitalismo” non sono in nessun modo intercambiabili nel loro sguardo verso la tecnologia e i suoi usi. In vista del fatto che “i sindacalisti e i critici di sinistra del capitalismo” sono lodevolmente dediti a una seria opposizione di classe al capitalismo, il loro fallimento, oggi, nell’ingaggiare un ampio movimento dei lavoratori, è più una tragedia da compiangere che un’occasione per fare festa.
[27] I contributi alla conferenza sono stati pubblicati in R.B. Lee, I. DeVore, ed., Man the Hunter, Aldine Publishing Co., Chicago 1968.
[28] What Hunters Do for a Living, or, How to Make Out in Scarce Resources, in ibidem, p. 43.
[29] Vedi in particolare Paul Radin, The World of Primitive Man, Grove Press, New York 1953, pp. 139-150.
[30] John Zerzan, Future Primitive and Other Essays, Autonomedia, Brooklyn N.Y. 1994, p. 16. Il lettore che ha fede nella ricerca di Zerzan potrebbe provare a dare un’occhiata a fonti importanti come Cohen (1974) e Clark (1979) (citati rispettivamente alle pagine 24 e 29) nella sua bibliografia – sia essi che altri autori sono interamente assenti.
[31] La letteratura su questi aspetti della vita preistorica è molto ampia. Gazelle Killing in Stone Age Syria, di A. Legge e P.A. Rowly in «Scientific American», vol. 257, agosto 1987, pp. 88-95, mostra come gli animali migranti potessero venir massacrati con efficacia devastante attraverso l’uso di recinti. Lo studio classico degli aspetti pragmatici dell’animismo è Myth, Science and Religion, Doubleday, Garden City, N.Y 1954, di B. Malinowski. Un’antropomorfizzazione manipolativa risulta evidente in molte testimonianze di trasmigrazioni dal regno umano a quello non umano rivendicate dagli sciamani, come nei miti dei Makuna riportati da Kaj ‘rhem, Dance of the Water People, «Natural History», gennaio 1992.
[32] Sui pigmei, vedi Colin M. Turnbull, The Forest People: A Study of the Pygmies of the Congo, Clarion/Simon and Schuster, New York 1961, pp. 101-102. Sugli eschimo, vedi Gontran de Montaigne Poncins, Kabloona: A White Man in the Arctic Among the Eskimos, Reynal & Hitchcock, New York 1941, pp. 208-9, così come in molti altri lavori sulla cultura tradizionale eschimo.
[33] Il fatto che molte praterie in tutto il mondo siano state prodotte dal fuoco, probabilmente risalendo indietro fino all’Homo erectus, è un’ipotesi diffusa in tutta la letteratura antropologica. Uno studio eccellente è Fire in America, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1982), di J. Pyne. Vedi anche W.M. Denevan, in «Annals of the American Association of Geographers», settembre 1992, citato in W.K. Stevens, An Eden in Ancient America? Not Really, «The New York Times», 30 marzo, 1993, p. C1.
[34] Sulla questione duramente discussa dei “massacri” vedi Pleistocene Extinctions: The Search for a Cause, ed. P.S. Martin e H.E. Wright Jr. Gli argomenti che girano intorno alla questione, se siano stati fattori climatici e/o massacri umani a portare all’estinzione massiccia dei mammiferi di circa trentacinque generi durante il Pleistocene, è troppo complessa per essere trattata qui. Vedi P.S. Martin, Prehistoric Overkill, in Pleistocene Extinctions: The Search for a Cause, ed. P.S. Martin e H.E. Wright Jr., Yale University Press, New Haven 1967). Ho esplorato alcuni degli argomenti nella mia introduzione del 1991 all’edizione rivista di The Ecology of Freedom, Black Rose Books, Montreal. Le prove sono ancora tutte da discutere. I mastodonti, che venivano un tempo visti come animali ristretti dal punto di vista ambientale, ora si ritiene siano stati più flessibili dal punto di vista ecologico e avrebbero potuto essere uccisi dai cacciatori paleoindiani, probabilmente con meno rimorsi di quanto gli ambientalisti romantici vorrebbero farci credere. Non sto sostenendo che fu soltanto la caccia a spingere questi grandi mammiferi verso lo sterminio – un numero considerevole di uccisioni avrebbe potuto essere sufficiente. Una raccolta degli assalti arroyo ai bisonti si trova in B. Fagan, Bison Hunters of the Northern Plains, in «Archaeology», maggio-giugno 1994, p. 38.
[35] K.W. Butzer, No Eden in the New World, «Nature», vol. 82, marzo, 1993, pp. 15-17.
[36] T.P. Cuthbert, The Collapse of Classic Maya Civilization, in The Collapse of Ancient States and Civilizations, ed. Norman Yoffee and George L. Cowgill, University of Arizona Press, Tucson, Ariz., 1988; e J.A. Tainter, The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press, Cambridge 1988, esp. capitolo 5.
[37] È strano sentirsi dire di nuovo – questa volta da L. Susan Brown – che le mie «prove a sostegno delle società “organiche” senza gerarchie sono aperte alla discussione» (enfasi aggiunte, p. 160). Se Marjorie Cohen, citata dalla Brown, trova «non convincente» affermare che «la simmetria sessuale e la piena eguaglianza» possono essere consistentemente dimostrate sulla base di «prove antropologiche» o che «la divisione del lavoro in base al sesso» non è necessariamente «compatibile con l’eguaglianza sessuale» – tutto ciò che posso dire è: va bene! Esse non stanno cercando di fornirci prove “convincenti” di un bel niente. Lo stesso si può dire delle relazioni di genere che ho suggerito ne L’ecologia della libertà. Tutte le «prove antropologiche» contemporanee che riguardano la «simmetria sessuale» sono infatti discutibili perché gli aborigeni moderni sono stati condizionati nel bene e nel male dalle culture europee molto prima di essere raggiunti dai moderni antropologi.
Ciò che ho provato a presentare in quel libro è una dialettica dell’uguaglianza e della disuguaglianza di genere, non un resoconto definitivo della preistoria – la conoscenza della quale è necessariamente andata persa per sempre alla Brown, Cohen, e me stesso. Uso i dati moderni speculativamente: per mostrare che le mie conclusioni sono ragionevoli, cosa che la Brown respinge alla leggera con due frasi e senza addurre a supporto dati di ogni sorta.
Per quanto riguarda il richiamo della Brown alla mia mancanza di «prove» sul come la gerarchia è emersa, materiali recenti sulla Mesoamerica, in seguito alla decifrazione di pittogrammi maia, avvalorano la mia ricostruzione dell’emergenza della gerarchia. Infine, la gerontocrazia, di cui enfatizzo la priorità in quanto probabile prima forma di gerarchia, è uno degli sviluppi gerarchici più diffusi tra quelli descritti nella letteratura antropologica.
[38] C. Geertz, Life on the Edge, «The New York Review of Books», 7 aprile, 1994, p. 3.
[39] Come osserva William Powers, il libro Black Elk Speaks è stato pubblicato nel 1932. Non c’è traccia della vita cristiana di Alce Nera. Per un’accurata smentita dell’attuale fascinazione per la storia di Alce Nero vedi W. Powers, When Black Elk Speaks, Everybody Listens, «Social Text», vol. 8, n. 2, 1991, pp. 43-56.
[40] Edwin N. Wilmsen, Land Filled With Flies, University of Chicago Press, Chicago 1989, p. 127.
[41] Wilmsen, Land Filled with Flies, cit., p. 3.
[42] A. Maclean Stearman, Yuqu’: Forest Nomads in a Changing World, Holt, Rinehart and Winston, Fort Worth and Chicago 1989, p. 23.
[43] Ibidem, pp. 80-81
[44] E.N. Wilmsen, Land Filled with Flies, cit., pp. 235-39 e 303-15.
[45] Per queste spaventose statistiche, vedi C. Shear Wood, Human Sickness and health: A Biocultural View (Palo Alto, California: Mayfield Publishing Co., 1979), pp. 17-23. I Neanderthal – i quali lungi dall’essere «maligni», come piacerebbe a Zerzan, stanno ricevendo una meravigliosa pubblicità oggigiorno – vengono trattati molto generosamente da C. Stringer e C. Gamble in In Search of the Neanderthals , Thames and Hudson, New York 1993. Tuttavia questi autori concludono: «L’alta incidenza di malattie degenerative articolari nei neanderthal non sorprende considerato che sappiamo delle dure vite che essi conducevano e del logorio che queste producevano sul loro corpo. Ma la prevalenza di seri infortuni è più sorprendente, e indica esattamente quanto pericolosa fosse la vita, anche per coloro che non riuscivano a raggiungere l’“età adulta” nelle società di neanderthal» (pp. 94-95).
Alcuni individui preistorici vissero senza dubbi fino ai settant’anni, come i raccoglitori che occupavano le paludi della Florida circa ottanta mila anni fa, ma queste sono eccezioni molto rare. Ma solo un primitivista sfegatato potrebbe cogliere tali eccezioni e farne la regola. Oh, certo – le condizioni sono terribili per la maggior parte delle persone in una civiltà. Ma chi cerca di sostenere che la civiltà sia da ammirare per la gioia incondizionata, i festeggiamenti, e l’amore?
[46] Vedi, ad esempio, R.J. Blumenschine e J.A. Cavallo, Scavenging and Human Evolution, in «Scientific American», ottobre 1992, pp. 90-96.
[47] Paul A. Janssens, Paleopathology: Diseases and Injuries of Prehistoric Man, John Baker, London 1970.
[48] C. Wood, Human Sickness, cit., p. 20.
[49] E.B. Maple, The Fifth Estate Enters the 20th Century. We Get a Computer and Hate It!, in «The Fifth Estate», vol. 28, n. 2, estate 1993, pp. 6-7.
[50] Citato in «The New York Times», 7 maggio, 1995. Persone meno ipocrite di Zerzan hanno provato a sfuggire dalla presa della televisione e a trarre piacere dalla musica decente, dalla radio, dai libri, e simili. Semplicemente, non comprano queste cose!
[51] Max Stirner, The Ego and His Own, ed. James J. Martin, traduzione di Steven T. Byington, Libertarian Book Club, New York, 1963), parte 2, capitolo. 4, sez. C, «My Self-Engagement», p. 352, enfasi aggiunta.
[52] Friedrich Nietzsche, «On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense», 1873, frammento, in The Portable Nietzsche, edito e tradotto da Walter Kaufmann, Viking Portable Library, New York 1959, pp. 46-47.
[53] Friedrich Nietzsche, frammento 481 (1883-1888), The Will to Power, trad. Walter Kaufmann e R. J. Hollingdale, Random House, New York 1967, p. 267.
[54] James J. Martin, introduzione dell’editore a Stirner, Ego and His Own, cit., p. xviii.
[55] M. Horkheimer, The Eclipse of Reason, Oxford University Press, New York 1947, p. 135.
[56] Kropotkin, «Anarchism», Revolutionary Pamphlets, cit., pp. 287, 293.
[57] Kropotkin, «Anarchism», Revolutionary Pamphlets, cit., pp. 292-93.
[58] Nella sua ripugnante “recensione” del mio libro The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship (da quel momento rinominato Urbanization Without Cities), John Zerzan ripete la solita frottola secondo la quale Atene è «da lungo tempo il modello di Bookchin per la rivitalizzazione della politica urbana». In realtà, mi sforzo molto di indicare i fallimenti della polis ateniese (schiavitù, patriarcato, antagonismo di classe, guerra). Il mio slogan «democratizzare la repubblica, radicalizzare la democrazia» che giace latente nella repubblica – con l’obiettivo esplicito di creare un potere duale – è troncata cinicamente in modo che si legga: «Dobbiamo, [Bookchin] consiglia, espandere ed accrescere lentamente le “istituzioni esistenti” e “cercare di democratizzare la repubblica”». Questa manipolazione fallace delle idee merita l’apprezzamento di Lev Chernyi (anche detto Jaon McQuinn), di Anarchy: A Journal of Desire Armed e di Alternative Press Review, nella sua prefazione esortativa a Future Primitive di Zerzan (vedi pp. 11, 164, 165).
[59] Kenneth Rexroth, Communalism, Seabury Press, New York 1974, p. 89.