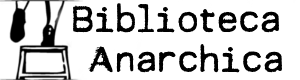Machete (rivista)
Krisis
quando la montagna partorisce un topolino
Gli scritti del gruppo Krisis, costituito attorno al sociologo Robert Kurz, editore in Germania dell’omonima rivista, erano poco noti in Italia. Questa lacuna è ormai colmata dalla pubblicazione del Manifesto contro il lavoro (DeriveApprodi, 2003).
La critica della morale del lavoro, nel pensiero di sinistra, dà un tono ed una freschezza a un testo in cui Krisis tenta di caratterizzare l’attuale situazione del capitalismo. Per loro si tratta innanzitutto di smontare le ricette riformiste che pretendono di correggere i misfatti del capitalismo da casinò: le nostalgie keynesiane, le rivendicazioni d’un salario sociale, o ancora la tassa Tobin-Attac. Per Kurz ed i suoi amici, la speculazione è la conseguenza della crisi degli investimenti e non il contrario: «lo stesso criterio della redditività, con tutti i suoi presupposti nella società del lavoro, deve essere considerato obsoleto» (p. 44-45). Krisis si differenzia così dai progetti delle varie correnti socialiste che hanno creduto di fare delle rivendicazioni quantitative, delle lotte economiche e sindacali, la leva dell’emancipazione sociale. Questo processo d’integrazione è oggi seguito dall’esplosione del mondo operaio; terreno sul quale «la sinistra classica è arrivata al capolinea» (p. 51). Per questo motivo, nei suoi progetti di rifondazione, «invece di una rottura categoriale, si fa strada una nostalgia socialdemocratica e keynesiana» (p. 52). Krisis sottolinea la natura statale dei progetti di salario sociale e di reddito garantito, confermando in questo altre critiche.
Fin qui, niente di nuovo sotto il sole! Per quanto riguarda la critica del riformismo moderno, Krisis ripete — con un pronunciato gusto per la sufficienza — quanto è stato già scritto. Esempio tipico assai diffuso, a leggerli sembra che la critica al capitalismo contemporaneo sia iniziata il giorno in cui loro si sono messi a riflettere. Ma tranne alcuni riferimenti al «situazionismo» e alle correnti della sinistra italiana, alcune formule che richiamano Il diritto alla pigrizia di Paul Lafargue (mai citato), si spazza via tutto senza distinzioni e si getta il peggio come il meglio nella pattumiera della storia, alla rinfusa. Pertanto non ci stupirà di vedere il movimento operaio ridotto al sindacalismo, semplice elemento «acceleratore della società del lavoro». Fatto significativo, si cercherà invano in questo Manifesto la minima allusione alle rotture rivoluzionarie del XX secolo od un solo riferimento alle correnti rivoluzionarie del marxismo e dell’anarchismo.
Un’idea centrale costituisce l’ossatura delle analisi di Krisis: il capitalismo è un sistema il cui scopo è «la società del lavoro», «La storia della modernità è storia dell’imposizione del lavoro» (p. 26), «il lavoro è un fine in sé, proprio perché realizza la valorizzazione del capitale: l’infinita moltiplicazione del denaro grazie al denaro stesso. Il lavoro è la forma di attività di questa assurda tautologia» (p. 18). Mai questo vettore-lavoro viene definito come rapporto sociale, storico, né viene caratterizzato in maniera specifica come lavoro alienato, salariato[1]. Ora, è lo spossessamento del lavoratore della propria attività che gli toglie il controllo della propria vita. È l’attività umana divenuta merce a fondare le separazioni. In Krisis la nozione di profitto è assente, il concetto di sfruttamento conta poco nella «macchina autoreferenziale del capitalismo» (p. 8).
La valorizzazione borghese del lavoro è posta al centro del funzionamento del sistema il cui scopo sarebbe di far lavorare gli individui! Questo discorso — che rovescia la morale religiosa che vede nel lavoro la vocazione naturale dell’uomo — abbonda di formule moralizzatrici: «principio cinico», «sistema delirante», «legge del sacrificio umano», «crociata in nome dell’idolo lavoro», o ancora «meglio avere un lavoro “qualsiasi” piuttosto che non averne nessuno è ormai diventata una professione di fede imposta a tutti» (p. 6). Ora, se il proletario si intestardisce a cercare lavoro non è perché non può fare altrimenti, essendo la vendita della sua forza lavorativa il suo solo mezzo di sopravvivenza?
Cosa caratterizza la crisi della «società del lavoro» secondo Krisis? Ecco degli elementi di risposta: «Con la terza rivoluzione industriale della microelettronica, il lavoro si scontra con il suo limite storico assoluto» (p. 35). Più precisamente, «per la prima volta il lavoro che viene cancellato con la razionalizzazione è maggiore di quello che può essere riassorbito grazie all’espansione dei mercati» (p. 36). Ne consegue che, in una società che «mai era stata una società del lavoro (...) il lavoro è stato reso superfluo. Proprio nel momento della sua morte, il lavoro getta la maschera e si rivela come una potenza totalitaria» (p. 6)[2]. Krisis sembra dimenticare che questa necessità di innalzare costantemente la produttività del lavoro, di sostituire il lavoro vivo con le macchine, è intrinseca al processo di produzione del capitale. In periodo di crisi, tutta la forza lavoro non trova acquirenti sul mercato e l’apparente superfluità del lavoro ne è solo la conseguenza. Trarne una interpretazione di tipo «catastrofista» rappresenta una mistificazione, significa riprendere l’approccio millenarista, presentare le contraddizioni attuali del capitalismo come insuperabili. Lungo tutta la sua storia, il capitalismo ha potuto ristabilire, a prezzo della barbarie, nuove condizioni di produzione di profitto, creare nuovi mercati, facendosi perpetuare. Il capitalismo va male, ma non affonderà da solo, ci vorrà l’intervento di forze sociali decise a inscrivere nei fatti un progetto emancipatore. Questo è il solo limite «assoluto» del sistema.
Krisis associa la «rottura con la categoria del “lavoro”» ad un progetto di «ri-solidarizzazione». Questo deve concretizzarsi in «nuove forme di organizzazione sociale (libere associazioni, Consigli) (che) controllino le condizioni di riproduzione a livello sociale complessivo» (p. 57). Dopo aver assimilato proletariato-soggetto storico, sciopero e integrazione sindacale al movimento operaio riformista, Krisis ha l’ambizione di porre le basi di una «nuova teoria della trasformazione sociale». Da questa emerge il proposito di un’autorganizzazione attorno ad una «lotta per un fondo di tempo sociale autonomo». Su questo tema, la lettura del Manifesto merita di essere completata dalla lettura di altri testi del gruppo[3]. Ed è a questo punto che una fitta nebbia cala sulla città!
Il settore detto della «economia sociale» (ONG e associazioni) è definito come «forma embrionale di una riproduzione emancipatrice e non-mercantile», che si tratta di «radicalizzare e unificare nella prospettiva di un superamento del sistema produttore di merci». Un altro asse della lotta vi viene associato: «la paralisi del sistema nervoso della riproduzione capitalista», ad opera degli scioperi dei camionisti e gli scontri degli ecologisti contro il trasporto di materie radioattive. Infine, squat nidi autonomi, occupazioni di terre nei paesi poveri, sono suscettibili di organizzare una «riproduzione autonoma» e contenere in germe l’esigenza di una produzione non-capitalista. Le nicchie alternative in seno alla società, le zone autonome temporanee, rifiutate in teoria nel Manifesto, vengono ripescate nella pratica. Qualsiasi insubordinazione è sovversiva? Come potranno questi «embrioni» superare il sistema? Ci può essere un superamento senza rottura? Ecco alcune domande che Krisis non pone. Qui come altrove, l’abbandono delle categorie di classe avviene a beneficio di una sorta di «fronte alternativo» prossimo all’attivismo cittadinista.
Corporativismo oblige, Krisis non dimentica che «c’è bisogno di un nuovo spazio di libertà mentale, affinché l’impensabile possa diventare pensabile... Soltanto una critica del lavoro espressamente formulata e un dibattito teoretico adeguato possono creare quella nuova contro-opinione pubblica che rappresenta il presupposto irrinunciabile per la costituzione di un concreto movimento sociale contro il lavoro» (p. 54-55). Eccoci ritornati al vecchio schema sul ruolo degli intellettuali nella elaborazione della coscienza. Se «pensare l’impensabile» significa questo, le risposte di Krisis sono tutte deludenti e pretenziose quanto i progetti dei neoriformisti criticati. Le invettive di «riformatori fai-da-te» e «teorici analfabeti» che gli autori di Krisis indirizzano ai difensori del salario sociale rischiano di rivoltarsi contro di loro. L’avvertimento elogiativo degli editori francesi — che classificano il Manifesto in terza posizione nella hit-parade della radicalità, dopo Il manifesto del partito comunista e Della miseria nell’ambiente studentesco — non ha eco.
La montagna ha partorito un topolino.
[1] Qui come altrove, la confusione mantenuta fra le nozioni di «lavoro», di «attività umana» e di «lavoro salariato», produttore di merci per altri (il capitalista), conforta coloro per cui l’attività umana non potrà che riprodurre il lavoro alienato odierno.
[2] Il Manifesto riprende qui, a modo suo, l’idea della «fine del lavoro», diffusa da anni in alcuni ambiti detti «radicali» e dove alcuni spingono le conclusioni fino ad affermare la scomparsa delle classi sociali e quindi della lotta di classe.
[3] “Antiokonomie und antipolitik”, Robert Kurz, rivista Krisis, n. 19, 1997. Le citazioni senza riferimento sono tratte da questo testo.