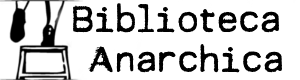Machete (rivista)
Alla ricerca di risorse oscure
«La democrazia divide gli uomini in lavoratori e fannulloni.
Non è attrezzata per quelli che non hanno tempo per lavorare»
Karl Kraus
Sappiamo tutti che la disoccupazione non sarà mai soppressa. Gli affari vanno male? Si licenzia. Gli affari vanno bene? Si investe nell’automazione e si licenzia. Una volta ci volevano i lavoratori perché ci fosse lavoro, oggi ci vuole il lavoro affinché ci siano lavoratori. Ma nessuno sa cosa farci, le macchine lavorano più in fretta e costano meno. L’automazione è sempre stato il sogno dell’umanità, se già duemilatrecento anni fa Aristotele affermava: «Se ogni utensile potesse eseguire senza comando, da solo, le sue operazioni, se per esempio le spole dei tessitori tessessero da sole, il capofficina non avrebbe più bisogno di aiuti, né il padrone di schiavi».
Oggi questo sogno si è realizzato ma è diventato un incubo per tutti, perché i rapporti sociali non sono progrediti come la tecnica, ma semmai sono regrediti grazie alla tecnica. E questo processo è irreversibile: mai più i lavoratori verranno a sostituire i robot. Inoltre, laddove il lavoro «umano» è ancora indispensabile, lo si delocalizza verso paesi con salari più bassi, oppure si importano immigrati sottopagati per farlo, in una spirale discendente che solo la restaurazione della schiavitù potrebbe fermare.
Tutti lo sanno, ma nessuno può dirlo. Ufficialmente, è sempre «la lotta contro la disoccupazione» a tenere banco. Si traffica in statistiche, si «tengono occupati» i disoccupati nel senso militare della parola, si moltiplicano noiosi controlli. E siccome, malgrado tutto, simile misure non possono bastare, si aggiunge una losca morale affermando che i disoccupati sarebbero responsabili della propria sorte, esigendo da loro una ricerca attiva d’impiego. Il tutto per costringere la realtà a rientrare nel modello della propaganda.
«Disoccupazione» è una brutta parola, una idea negativa, il rovescio di una medaglia al lavoro. Un disoccupato è solo un lavoratore senza lavoro. Il che non dice nulla della persona come poeta, come girandolone, come cercatore, come essere che respira. In pubblico, si ha diritto soltanto a parlare di mancanza di lavoro. Solo in privato, al riparo da giornalisti, sociologi e altri spandimerda ci si può permettere di dire quel che si ha nel cuore: «Sono stato appena licenziato, grande! Finalmente potrò fare festa tutte le sere, mangiare qualcos’altro dei cibi precotti, coccolare senza limiti».
Occorre abolire questa separazione fra virtù private e pubblici vizi? Ci viene detto che non è il momento, che ciò sembrerebbe una provocazione, che farebbe il gioco dei borghesi. Decine di anni fa, i lavoratori potevano mettere il loro lavoro – e il lavoro – in discussione, Oggi devono ritenersi felici per la sola ragione che non sono “vittime” della disoccupazione, e i disoccupati devono ritenersi infelici per la sola ragione che non hanno lavoro. Meglio ridere di un ricatto del genere.
Quando l’etica del lavoro è perduta, la paura della disoccupazione resta la più solida frusta per accrescere il servilismo. Un certo Schmilinsky, consigliere d’impresa per l’eliminazione dei fannulloni, lo dice nel modo più chiaro possibile: «In una scuderia, voi decidete sia quale cavallo deve avere una ricompensa sia quale non riceve nulla. Le imprese che vogliono sopravvivere oggi devono essere talvolta implacabili. Troppa bontà può spezzare loro le reni. Io consiglio ai miei clienti di agire con pugno di ferro in guanto di velluto. Oggigiorno, i lavoratori si guardano attorno e vedono dappertutto posti di lavoro soppressi. Nessuno ha davvero voglia di farsi notare per un comportamento disdicevole. Le imprese tendono ad utilizzare sempre più questo sentimento di insicurezza, al fine di ridurre molto le ore di lavoro perso».
Il lavoro è solo una questione di sopravvivenza. Il calzolaio o l’ebanista erano fieri della loro arte. E gli operai dei cantieri navali trattenevano una lacrima quando vedevano partire lontano le navi che avevano costruito. Ma questo sentimento di valere qualcosa, di essere utile, a se stessi come agli altri, è scomparso nel 95/o deij ob. Il settore dei «servizi» impiega solo domestici e appendici informatiche che non hanno ragione alcuna di essere fieri. Dal vigilante al tecnico di sistemi d’allarme, un branco di cani da guardia sono pagati solo per sorvegliare che venga retribuito ciò che senza di loro potrebbe essere gratuito. E in effetti anche un medico non è che un rappresentante di commercio delle multinazionali farmaceutiche. Chi può ancora dirsi utile agli altri? La domanda non è più «A cosa serve?», bensi «Quanto fa guadagnare?». Il solo obiettivo di ogni lavoro particolare è aumentare i profitti dell’impresa, così come il solo rapporto del lavoratore col suo lavoro è il salario che percepirà.
La disoccupazione esiste proprio perché è il denaro, e non la cosiddetta utilità sociale, ad essere lo scopo ultimo del lavoro. Il pieno impiego è la crisi economica, la disoccupazione è la salute del mercato. Cosa accade quando un’impresa annuncia una carrettata di licenziamenti? Gli azionisti saltano di gioia, gli speculatori applaudono per la sua strategia di risanamento, le azioni si impennano, ed il prossimo bilancio testimonierà i benefici così generati. Tanto che si può ben dire che i disoccupati creano più profitto dei loro ex-colleghi. Quindi sarebbe talmente logico ricompensarli per il loro contributo alla crescita, che c’è chi reclama una retribuzione per il non-lavoro.
Consideriamo cio che sosteneva il suprematista Kazimir Malevich, quando scriveva nel 1921; «Il denaro non è altro che un pezzetto di pigrizia. Quanto più se ne avrà a disposizione, tanto più si conoscerà la felicità della pigrizia.. [...] Usufruiscono della pigrizia soltanto coloro che si sono procurati un capitale. Così la classe dei capitalisti si è affrancata dal lavoro, dal quale tutta l’umanità deve affrancarsi». Se il disoccupato è infelice non è perché è senza lavoro, ma perché è senza denaro. Quindi non diciamo più «richiedente impiego» ma «richiedente denaro», basta «ricerca attiva d’un impiego» ma «ricerca attiva di denaro». Le cose saranno più chiare. Fuori dal privilegio di essere sfruttati sul posto di lavoro, bisogna colmare questa mancanza andando alla ricerca di risorse oscure. Ciò significa che non facciamo propaganda per qualcosa che è già là, che bisogna solo afferrare per poterlo gustare. I momenti rubati all’obbligo salariale sono solo fugaci evocazioni di un aldilà del mercato.
Se il disoccupato è infelice, è anche perché il lavoro è il solo valore sociale che conosca. Non ha più nulla da fare, si annoia, non conosce più nessuno, perché il lavoro è spesso l’unico legame sociale disponibile. La cosa, del resto, vale anche per i pensionati. È ovvio che la causa di una simile miseria esistenziale è da ricercare nel lavoro, non nella disoccupazione in sé.
Tutti i disoccupati dispongono in ogni caso di una cosa inestimabile: il tempo. Ecco cosa potrebbe costituire una possibilità storica, la possibilità di condurre una vita piena di significato e di gioia, di ragione e di passione. È possibile definire il nostro scopo una riconquista del tempo. Chi non lavora è quindi tutto tranne che inattivo, mentre la sedicente «popolazione attiva» può solo obbedire passivamente al destino e agli ordini dei suoi superiori nella gerarchia sociale. Ed è proprio perché i disoccupati volontari sono pieni di cose da fare, scoprire, inventare, sognare, che non hanno il tempo di lavorare. Come diceva un fuorilegge reso celebre dalle sue avventure: «Non volevo che la mia vita fosse regolata in partenza o decisa da altri. Se alle sei del mattino avevo voglia di fare all’amore, volevo prendermi il tempo di farlo senza guardare l’orologio. Volevo vivere senza orari, ritenendo che la prima schiavitù dell’uomo è comparsa nel momento in cui si è messo a calcolare il tempo. Mi risuonavano in testa tutte le frasi abituali della vita corrente... Non ho il tempo di...! Arrivare in tempo...! Guadagnare tempo...! Perdere il proprio tempo...! Io volevo “avere il tempo di vivere” e l’unico modo per riuscirci era non esserne schiavo. Ero conscio dell’irrazionalità della mia teoria, inapplicabile nella società, Ma che cos’era, poi, questa società, con i suoi bei principi e le sue leggi?».
C’è chi ribatterà che il disoccupato è senza lavoro solo nel senso attuale della parola «lavoro», cioè «lavoro salariato». Bisogna qui precisare che è ripugnante cercare un lavoro salariato quanto lo è cercare un lavoro da schiavo. Affinché lo si sappia, esistono solo due tipi di lavoro: il salariato e la schiavitù. Certo, esistono anche studenti, artisti e altri fanfaroni che non possono scrivere il più piccolo pezzo di carta o lappare la minima scodella senza pretendere di dedicarsi con ciò ad un importante «lavoro». Anche parecchi «sovversivi» non possono organizzare «seminari» anticapitalisti senza portare «dibattiti produttivi» dentro a «gruppi di lavoro». Miserabili parole, miserabili pensieri.
Non è da oggi che la parola «lavoro» è una parola segnata dall’infelicità. Arbeit è probabilmente formata su un verbo germanico scomparso il cui significato era «essere orfano, essere un bambino utilizzato per un rude compito corporale», verbo derivato dall’indoeuropeo Orbhos, «orfano». Fino all’alto tedesco moderno, arbeit significa «pena, tormento, attività indegna» (in questo senso, disoccupato felice è perciò un pleonasmo). Anche il latino labor significa pena, fatica. Nelle lingue romane, la cosa è ancora più chiara poiché travail, trabaj o, travaglio, deriva dal latino tripalium, strumento di tortura a tre punte che era utilizzato contro gli schiavi. Se la Bibbia, con la sua formula «Chi non lavora non ha il diritto di mangiare», getta le basi del ricatto economico di cui siamo tutti vittime, Lutero ha promosso da parte sua il lavoro come valore spirituale, predestinazione dell’uomo nel mondo. Citazione: «L’uomo è nato per lavorare come l’uccello per volare». Ci potremmo sentir rispondere che questa disputa di parole è senza importanza. Ma il fatto di confondere «bevanda» con «Coca-Cola», «cultura» con «Umberto Eco», «attività» con «lavoro» non può restare senza gravi conseguenze.
Non appena è questione di lavoro o di disoccupazione, si fanno avanti le categorie morali. E la tendenza va accentuandosi, basta aprire un giornale per rendersene conto: «Una concezione del mondo è prevalsa su un’altra, dichiara un esperto di Washington. Invece di considerare la povertà come prodotta da cause economiche, la nuova scuola di pensiero che domina attualmente vede nella povertà il risultato di un comportamento morale cattivo». Come ai tempi in cui i curati vedevano in pericolo il loro monopolio sulle anime, la morale è qui un tentativo di colmare la crescente incrinatura fra la realtà e la sua immagine ideologica. Chi dice al disoccupato «tu hai peccato» si aspetta da questi che faccia penitenza o che si giustifichi della sua virtù. Nei due casi, avrà riconosciuto l’esistenza del peccato. I piagnucolosi tentativi di certi disoccupati di provocare la compassione di questo mondo possono, nel migliore dei casi, generare pietà. Solo il riso sublime può disarcionare la morale sul serio.
È chiaro che Paul Lafargue, l’autore del Diritto alla pigrizia, rimane un ispiratore:
«Gli economisti continuano a ripetere agli operai: “Lavorate per accrescere la fortuna sociale!” Eppure un economista, Destutt de Tracy, risponde loro: “Le nazioni povere, ecco dove il popolo sta bene; le nazioni ricche, ecco dove normalmente il popolo è povero”. Ma gli economisti, intontiti e rimbecilliti dai propri schiamazzi, continuano a far eco: “Lavorate, lavorate in continuazione per il vostro benessere” [...] Lavorate, lavorate, acciocché, diventando sempre più poveri, abbiate più motivi per lavorare e per essere miserabili». Eppure, noi non facciamo nostra la rivendicazione d’un diritto all’ozio. L’ozio è solo il contrario dell’assiduità. Laddove il lavoro non è riconosciuto, nemmeno l’ozio può esserlo. Niente vizi senza virtù (e viceversa). Dall’epoca di Lafargue, è diventato chiaro che il sedicente «tempo libero» accordato ai lavoratori è spesso e volentieri ancora più noioso del lavoro stesso. Chi vorrebbe vivere di televisione, giochi interpassivi e Club Merd? La questione quindi non è semplicemente, come poteva credere ancora Lafargue, ridurre il tempo di lavoro per aumentare «il tempo libero». Ciò detto, siamo solidali con quei lavoratori spagnoli a cui si voleva proibire la siesta con il pretesto di doversi adattare al mercato europeo, i quali hanno risposto che al contrario era l’Unione europea a dover adottare «l’euro-siesta».
Sia chiaro: non amiamo i partigiani della divisione del tempo di lavoro, per i quali tutto andrebbe per il meglio se ciascuno lavorasse anche solo cinque, tre o due ore al giorno. Che cos’è questo spezzettamento? Guardo forse quanto tempo ci metto per preparare un pasto per i miei amici? Calcolo il tempo che trascorro a scrivere questa stronzata di testo? Si conta il tempo, quando si ama?
Ma non per questo il non-lavoro rappresenta una nuova utopia, se l’utopista deve predisporre al millimetro i piani d’una costruzione ritenuta ideale, e poi aspettare che il mondo vada a confluire in questo modello. Chi non lavora, caso mai mette assieme e sperimenta a partire dai luoghi e dagli oggetti che sono a portata di mano. Non costruisce un sistema, ma cerca tutte le occasioni e possibilità per migliorare la propria vita.
Scrive un onorevole corrispondente:
«Si tratta di guadagnare un riconoscimento sociale con il conseguente finanziamento senza condizioni, oppure si tratta di sovvertire il sistema per mezzo di azioni illegali come non pagare l’elettricità? Il legame fra queste due strategie non sembra invero logico. Difficilmente posso essere accettato socialmente e allo stesso tempo spronare l’illegalità».
Dubitiamo che esistano davvero dei fanatici dell’illegalità. Nei vari tentativi di fare il (proprio) Bene, c’è anche chi sceglie di ricorrere a vie legali, sfruttando il sistema di finanziamenti pubblici. Del resto, i crimini di una volta sono i diritti di oggi (basta pensare al diritto allo sciopero) e possono sempre ridiventare crimini. Ma soprattutto: non si tratta di cercare o rifiutare a priori un riconoscimento sociale. Il punto è che, anziché rivolgersi allo Stato o ai suoi organismi ufficiali, ci si rivolge al Signor Tutti Quanti.
Esistono in questo momento diversi movimenti e iniziative contro le misure di austerità, contro la disoccupazione, contro il neoliberismo, ecc. Ma la questione è: per cosa ci si deve pronunciare? In ogni caso, non per lo Stato-provvidenza e il tempo pieno di una volta (che per altro hanno altrettante possibilità di essere reintrodotti della locomotiva a vapore). Tuttavia potrebbe accadere anche di peggio. Per assurdo potrebbe essere concessa ai disoccupati la possibilità di coltivare i loro legumi e di improvvisare i loro rapporti sociali sui terreni incolti e infestati della post-modernità, sorvegliati a distanza dalla polizia elettronica e consegnati a qualche mafia, mentre la minoranza agiata può avanzare senza ostacoli. Bisogna cercare un passaggio per uscire da questa alternativa di terrore. È una questione di principio.
Un’altra parola compromessa dalla propaganda è la parola «esclusione». I senza-lavoro vengono esclusi dalla società, mentre le anime belle ne reclamano la reintegrazione. Esclusi da cosa esattamente? Un umanitario dell’Unesco ha dato una risposta inequivoca ad un «summit sociale» tenutasi a Copenaghen: «Il primo passo dell’integrazione sociale consiste nel farsi sfruttare». Grazie per l’invito! Tre secoli fa gli zotici alzavano gli occhi pieni di invidia verso il castello del signore; a ragione si sentivano esclusi dalle sue ricchezze, dai suoi nobili agi, dai suoi artisti di corte e cortigiane. Ma oggi, chi mai vorrebbe vivere come un quadro superiore stressato, con la voglia di imbottirsi il cranio di sequele di cifre senz’anima, di baciare le sue segretarie biondastre, di bere il suo vino sofisticato, di crepare col suo infarto? Ci escludiamo più che volentieri dall’astrazione dominante.
Nei paesi poveri, milioni di persone vivono ai margini dei circuiti dell’economia di mercato. Ogni giorno i giornali riportano la miseria del cosiddetto «terzo mondo», una serie deprimente di guerre, carestie, dittature ed epidemie. Tuttavia non bisogna perdere di vista il fatto che, assieme a questa miseria (essenzialmente importata), esiste un’altra realtà; un’intensa vita sociale sostenuta da tradizioni e costumi precapitalisti, al cui confronto le società opulente hanno l’aria moribonda. In questi paesi il lavoro dell’uomo bianco viene disprezzato «perché non finisce mai», a differenza, ad esempio, di quegli artigiani somali che sperperano i proventi della loro attività in un colpo solo, nella grande festa annuale. È una formula nota: l’attitudine delle persone alla festa inversamente proporzionale al Prodotto Interno Bruto pro capite.
«I poveri sono molto più ricchi di quanto si dica, e di quanto essi stessi non credano. L’incredibile gioia di vivere che colpisce molti osservatori delle periferie africane inganna meno delle deprimenti valutazioni oggettive degli apparati statali, che colgono solo la parte occidentalizzata della ricchezza e della povertà», sostiene un dotto sociologo. Certo, in casi simili c’è il rischio per un europeo di cadere in un facile esotismo. Ma basta ascoltare quel che dicono sull’argomento gli immigrati stessi, loro che conoscono per esperienza i due mondi, per convincersi del vantaggio che possiede il Sud del mondo in fatto di rapporti sociali.
Abbiamo molto da imparare e da disimparare dall’Africa e da altre culture non occidentali. Ovviamente non si tratta di scimmiottare quelle pratiche ancestrali, come gli hippy di un tempo, ma caso mai, senza alcuna pretesa di copiare l’originale, di trovarvi una fresca fonte di ispirazione (un po’ come Picasso e i dadaisti si erano ispirati ai loro tempi all’Arte negra). Pur cessando di considerare la ricchezza come sinonimo di montagne di banconote, televisioni al plasma, macchine di grossa cilindrata e cose simili, resta il fatto che bisogna partire da zero. Si apre davanti a noi un vasto campo sperimentale, quello per l’appunto della ricerca di risorse oscure.