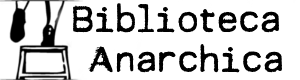Lope Vargas
Per il verso della vita
«Quanti esseri hanno attraversato la vita senza mai svegliarsi? E quanti altri si sono accorti che stavano vivendo solo per il monotono tic-tac degli orologi?»
Agli occhi più attenti non è certo sfuggito che in passato la poesia denotava una tendenza alla critica del mondo che è dato, alla trasformazione di questo mondo col fuoco della sua rivolta e delle sue esigenze. Al di là delle parole, e più precisamente contro, la poesia tendeva a trasgredire il piano in qualche modo contemplativo dove era stata confinata, per affermarsi sotto una forma attiva, concreta, materiale. Dunque a incarnarsi in questo mondo, gettandosi nella mischia per tentare di occupare un posto di primo piano nella lotta per la sua trasformazione. Si è voluto così guardare sotto una nuova luce gli autori di opere fino a quel momento considerate meramente letterarie, cominciare a udire la loro voce come se fosse quella di autentici uomini d’azione che invitavano alla battaglia. Rimbaud il comunardo, o Majakovskij il bolscevico, sono solo due degli innumerevoli esempi che in questo senso si potrebbero fare. Appare quindi tanto più strano che nessuno, o quasi, abbia pensato di intraprendere il cammino inverso, quello cioè che guarda ad individui passati alla storia per le loro azioni come ad autentici poeti.
Da questo punto di vista, si è appena agli albori della conoscenza dell’opera di Emile Henry, uno dei più grandi poeti francesi dell’Ottocento. Forse bisognerebbe ritrovare i colori usati da Lewis nel Monaco, per poter ricreare l’atmosfera appropriata che ha salutato l’apparizione di questo ragazzo ventunenne. Di fronte ai poeti d’allora, ma anche a molti poeti contemporanei, i suoi interventi a Parigi in rue des Bons-Enfants nel 1892 (cinque agenti morti nell’esplosione avvenuta in una stazione di polizia) e al Cafè Terminus nel 1894 (una ventina di feriti nel locale ritrovo della borghesia) brillano di un fulgore incomparabile; sono l’espressione di una rivelazione totale che sembra eccedere le possibilità umane. Infatti i grandi poeti non si caratterizzano forse per la loro tenace ricerca di superare i limiti a cui poteva aspirare la loro vita? Emile Henry è andato talmente lontano su questa via, da restare solo. Tutto ciò che, negli anni che seguiranno, si penserà e si intraprenderà di più audace contro il grigiore di un ordine sociale putrefatto ha trovato in lui un magico precursore. L’azione subisce con Emile Henry una svolta fondamentale, denota un ricominciamento, abbandonando le spiagge secche del beau geste.
«Inoltre ho ben il diritto di uscire dal teatro quando la commedia mi diventa odiosa ed anche sbattere la porta uscendo, col rischio di turbare la tranquillità di coloro che ne sono soddisfatti».
Sebbene abbia espresso meglio di chiunque altro le ragioni che possono spingere chi ha deciso di farla finita ad usare le cattive maniere, niente è più estraneo in lui della disperazione. Al contrario, con Henry l’atto individuale cessa di essere un martirio, ossia una manifestazione religiosa. Prima di lui, e purtroppo anche dopo, la ghigliottina non costituiva soltanto la punizione che l’ordine costituito minaccia contro il Ribelle, ma un destino considerato ineluttabile e che veniva deliberatamente scelto.
Ravachol si vanta delle proprie gesta in un locale pubblico, facendosi arrestare. Vaillant non cerca minimamente di evitare la cattura dopo aver lanciato la sua bomba alla Camera dei deputati. Anche Caserio e Bresci rinunciano alla propria libertà pur di vedere realizzata la loro opera. Dall’altro lato dell’oceano, Aleksandr Berkman e Leon Czolgosz non si comportano diversamente. Ma nel momento in cui Emile Henry apre il fuoco sugli zelanti poliziotti che lo stanno rincorrendo, cercando in tutti i modi di sottrarsi all’arresto, egli rompe con l’ideologia mortifera del sacrificio, con la logica matematica della compensazione. Al presidente della Corte che lo rimprovera di aver tutto progettato per mettersi al sicuro, Henry risponde: «È naturalissimo; come avrei potuto coltivar la speranza di ricominciare e di fare magari più vaste applicazioni, se alla prima mi fossi lasciato cogliere?». Del resto fu sempre lui a lasciar scritto che: «Tra gli economi di se stessi ed i prodighi di se stessi, credo che i prodighi siano i migliori calcolatori».
Così comportandosi, Henry fornisce per la prima volta all’azione individuale il suo orizzonte più appropriato. Una scommessa di vita, non una promessa di morte. Ma non è soltanto nelle modalità, è anche nella stessa scelta dell’obiettivo contro cui scagliare le proprie invettive che Henry opera un salto vertiginoso rispetto ai suoi contemporanei. Egli non abbatte figure simbolo dell’oppressione, non incendia parafulmini messi a protezione di un’intera classe di sfruttatori: è l’intera borghesia, con i suoi cani da guardia, che trema al rimbombo della folgore di chi è convinto che «di borghesi innocenti non ve ne sono, comunque vi piaccia qualificarli».
In Henry l’ispirazione poetica scaturisce dalla rottura tra il buon senso e l’immaginazione, rottura che – quando si verifica – il più delle volte pende in favore di quest’ultima. La rivolta, qualsiasi rivolta, non potrebbe essere considerata ancora Poesia se dovesse risparmiare indefinitamente una forma di autorità a scapito delle altre. È dunque tra le macerie di rue des Bons-Enfants e tra i tavoli rovesciati del caffè Terminus che essa si esalta, si sublima, si completa. Il contrasto flagrante che, dal punto di vista morale, sembrano offrire queste due opere con la tensione ideale che le anima è in realtà il frutto amaro dell’ideologia dominante. Se i re e i presidenti della repubblica hanno le mani sporche di sangue, i cavalieri d’industria e i gendarmi non sono da meno. Se i primi rappresentano da lontano quell’oppressione che quotidianamente prosciuga la nostra esistenza delle sue gioie più intense, i secondi ne sono la concretizzazione a noi più vicina. Insomma, se si scandaglia l’animo umano per ritrovare ciò che può costituire il fondamento di un simile furore, si scoprirà come questo riposi soprattutto sull’impossibilità di inventare le condizioni della propria avventura esistenziale, costretta a dover sottostare a banali cliché.
Con Henry ad essere rimessi in discussione sono i limiti entro i quali le idee possono entrare in rapporto con le idee, e gli atti con gli atti. Egli rifiuta la supremazia della propaganda retorica a scapito dell’azione, giacché vuole che la libertà – se essa non è un vuoto segreto fatto ad un idolo astratto – si confonda necessariamente con la messa in atto dell’idea. «Dacché un’idea è matura ed ha trovato una formula, bisogna senza più tardare cercarne la realizzazione». Un principio di mutazione perpetua si impadronisce così degli oggetti come delle idee, tendendo a raggiungere una liberazione totale che implica quella dell’uomo. Con occhio assolutamente selvaggio, Henry si tiene ai margini del perfezionamento scientifico del mondo, passando oltre la dimensione consapevolmente utilitaria di questo perfezionamento, per collocarlo assieme a tutto il resto sotto la luce nera dell’apocalisse. Apocalisse definitiva, la sua opera, nella quale si perdono e si esaltano le grandi pulsioni istintive a contatto di una gabbia d’amianto che rinchiude un cuore rovente.
«La società moderna è come una vecchia nave che affonderà nella tempesta, per non aver voluto liberarsi del suo carico accumulato durante il viaggio nel corso dei secoli; vi sono delle cose preziose, ma che pesano troppo».
Se egli accettava di agire sul mondo così come gli era stato dato, si guardava bene dal modificarne vagamente le forme in misura di un desiderio incerto, sapeva che così facendo avrebbe compromesso per sempre l’azione che sognava di esercitare. Bisognava che le sue azioni si inserissero in questa realtà fatta di bottegai, di pensionati, di funzionari, di camerieri, di appetiti meschini, di stupidi orgogli e oscure invidie. Ed egli voleva operare sul mondo e non sui fantasmi con cui è tanto comodo sostituirlo. Così, il suo passo decisivo non fu quello di inventare un universo parallelo ma di stabilire, in favore di una conoscenza esatta, il peso autentico e l’orrore fertile di quello in cui ci troviamo tutti immersi fino al collo. Il mondo è fatto così come lo conosciamo: e sia. Ma allora che cosa ce ne facciamo? A questo interrogativo, egli cercò di non mentire mai a se stesso: «tra la beatitudine dell’incoscienza e l’infelicità di sapere, io ho scelto».
Ed è proprio questa consapevolezza, questo rifiuto di arrendersi davanti alla vanità del tutto, ad aver guidato la sua mano: «Quando un uomo, nell’attuale società, diventa un ribelle cosciente delle proprie azioni, è perchè ha fatto nel suo cervello un lavoro di analisi doloroso le cui conclusioni sono imperative e non possono essere eluse se non per vigliaccheria. Lui solo tiene la bilancia, lui solo è giudice della ragione o del torto di odiare e di essere selvaggio, “perfino feroce”».
Queste parole precedono quelle che un altro grande poeta francese, Antonin Artaud, ebbe modo di scrivere qualche decennio dopo: «Non vi è crudeltà senza coscienza, senza una specie di coscienza applicata».
Emile Henry sconvolge. Sconvolge perché distrugge alle fondamenta tutto un sistema di riferimenti, perché corrode la cultura umanistica occidentale, perché colpisce senza pietà il pensiero e la società borghese. Pensiero che si è difeso dichiarando folli i suoi atti, insensate le sue parole. Ma le accuse che sono state mosse nei confronti della sua opera, al fine di sminuirla, mostrano bene come la critica non abbia mai potuto avvicinarsi ad essa senza rimanere scottata. In prima fila, come sempre del resto, si trovavano i giornalisti armati della loro ridicola psichiatria da Corte d’Assise. Si trattava di dimostrare il più in fretta possibile che Emile Henry denotava malattia e demenza. Come riuscirvi? Ricorrendo alle aberrazioni prese a prestito da Freud e consimili: il punto di partenza dell’impresa di Henry sarebbe stato una delusione amorosa, una carenza affettiva. In questo modo, ecco come la sinistra ombra dell’idiozia ha cercato di banalizzare il tentativo di rivincita del desiderio messo in atto da Henry.
Quanto alla sua dichiarazione resa in tribunale, le motivazioni che egli dà alle sue azioni hanno un tale accento passionale da non risultare affatto ciniche. Non solo Henry non è cinico, ma non è neppure un fanatico come molti hanno cercato di dipingerlo, anche fra i suoi stessi compagni. Il suo furore non è quello del puritano idealista che distrugge perché suggestionato da una visione messianica, ma è rivolto tutto contro coloro che lo opprimono. Emile Henry non si giustifica in considerazione di ciò che sarà il futuro – l’arcadia anarchica –, ma in considerazione di ciò che è il presente – un’esistenza miserevole. La pace, la giustizia, l’uguaglianza e l’amore universale saranno forse del mondo di domani, ma la realtà di oggi è la lotta fra la società dell’autorità e gli individui che vogliono la libertà perché sono responsabili di se stessi. Non a caso Henry ha fatto propria la frase messa in bocca da Zola a Souvarine, personaggio del suo romanzo più famoso: «Tutti i ragionamenti sull’avvenire sono delittuosi, perchè impediscono la distruzione pura e semplice ed ostacolano il cammino della rivoluzione». Contro ogni tentazione di riconciliazione, contro ogni speranza di poter assistere a dei placidi tramonti, Henry ammette di «avere portato nella lotta un odio profondo, ogni giorno ravvivato dallo spettacolo nauseante di questa società in cui tutto è ostacolo all’espansione delle passioni umane, alle tendenze generose del cuore, al libero slancio del pensiero».
Dopo il pensiero, toccava all’intera società borghese di doversi difendere. Di doversi vendicare, potremmo dire. Emile Henry, sebbene avesse cercato di evitare un simile tragico epilogo, lo seppe affrontare con dignità: «In questa guerra senza pietà che abbiamo dichiarato alla borghesia, noi non domandiamo pietà: noi diamo la morte, noi sapremo subirla».
Alle prime luci del 21 maggio 1894 Emile Henry venne decapitato. Come ebbe a scrivere Maurice Barrès, testimone all’esecuzione: «Sessanta chili, tutto un sistema sociale cadeva, spezzandogli il mento, sul collo di questo adolescente».
Forse si dovrebbe collocare meglio Emile Henry nell’ambito della poesia francese. Forse si dovrebbe parlare di Lautréamont o di Rimbaud, di cui egli sembra incarnare a posteriori la violenza e la rivolta. Ma come abbiamo visto non ci si può fermare a considerazioni di ordine estetico quando si tratta dell’opera di Henry, dal cui atto salutare deborda l’elemento stesso che gli ha dato origine e che è una consapevolezza senza misura.
Oggi tutto fa supporre che l’oblio sia calato su Emile Henry. L’ombra lo avvolge, un’ombra fredda che lo consegna agli archivi dei giornalisti, dei magistrati e dei gendarmi. Ma per gli spiriti accorti, la notte che lo copre non è in grado di sottrarre la sua lezione. La rivendicazione ribelle di un uomo che non ha esitato a portare delle questioni teoriche sul terreno fertile della vita, e a viverle infine nella sua carne e nel suo sangue, fino in fondo, gli conferisce una grandezza feroce. La sua morte non lascia un vuoto: essa sfonda la muraglia di compromessi e di sottomissione sotto la quale l’uomo soffoca. Attraverso questa apertura, è l’esistenza stessa dell’individuo che inizia a scorrere e a gorgogliare, senza più freni né museruole.
[Diavolo in corpo, n. 2, 5/2000 – Finimondo, 30/6/2011]