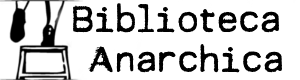Anonimo
Forbici per tutte
Testi sulla violenza machista nei movimenti sociali
Perché abbiamo sempre l’impressione di partire da zero...
Il femminismo non è un “tema da donne”
Rompendo immaginari: aggressori politicamente corretti
Il mito del macho e la coesione del gruppo
Io,donna forte: sola tra tante
Perché parliamo di sessismo negli spazi liberati?
Geometria, geografia e ideologia delle relazioni di fiducia
Appunti sulla violenza di genere
Geometria della fiducia e diritto
Ideologia e violenza nelle relazioni di fiducia
Nuova geografia per vecchie relazioni di fiducia
Sul genere e sui tipi “X”
(ovvero di come stiamo nella merda fino al collo)
Lettera per un dibattito sulle aggressioni sessuali
Un’aggressione è quando mi sento aggredit*
E nel collettivo? Come funziona?
Gli spazi liberati non sono liberi dalle aggressioni.
L’autodifesa delle e per le donne è una risposta alla violenza di genere
Nessuna aggressione senza risposta!
Sull’azione diretta femminista
Questo scritto non è parte di una campagna pedagogica: è un AVVERTIMENTO
Prologo alla seconda edizione
Sono passati quasi due anni dalla prima compilazione del testo “Forbici per tutte” che hai tra le tue mani. In questi tempi si è iniziato a discutere della violenza machista che viviamo negli spazi più prossimi a noi. Si sono creati nuovi gruppi femministi, gruppi di donne che hanno denunciato aggressioni e si son dovute confrontare con processi duri, si sono create nuove solidarietà, si sono rivisti materiali, protocolli di attuazione e riflessioni personali, si sono avviati discorsi in centri sociali, feste di quartiere, dentro ai collettivi, si sono date risposte diverse ad aggressioni concrete. Vogliamo riconoscere il valore di questo grande lavoro e dare tutto il nostro appoggio alle donne che hanno denunciato aggressioni.
Questo ravvivare il dibattito intorno al femminismo, all’auto-organizzazione di donne, alla violenza machista e alle strategie di attuazione, ha reso visibili questioni precedentemente dimenticate o conservate in un cassetto, perché non sarà facile evitare di affrontarle o guardare da un’altra parte. Alcun* hanno affrontato questo tema per la prima volta, altr* hanno continuato crescendo in direzioni diverse; si sono aperti percorsi, si sono riconsiderati punti di vista e differenze, ci sono state rotture, momenti difficili però anche di affinità e rispetto. E così, due anni dopo non partiamo da zero.
I conflitti generati hanno dato la possibilità di avanzare con un dibattito che vuole contribuire a “Forbici per tutte”.
Abbiamo deciso di rieditare questo materiale perché per affrontare aggressioni in chiave politica, per lottare contro la violenza machista e fare dell’antisessismo una realtà, non c’è niente di meglio di avere una cassetta degli attrezzi a portata di mano. Inoltre, molti collettivi e persone lo hanno utilizzato e continuano a chiederlo, per questo pensiamo che Forbici continui ad essere di estrema attualità.
Per tale motivo, questa edizione vuole essere più ampia, migliorando la diffusione discreta che abbiamo fatto in precedenza. Abbiamo mantenuto tutti i testi, le varie voci delle diverse prospettive, momenti e luoghi diversi che però condividono un comune filo conduttore: lo sguardo sulla violenza contro le donne come un problema quotidiano, strutturale, dalle molte cause e trasversale. Questa visione condivisa si oppone all’immagine mediatica che evidenzia le conseguenze più brutali della violenza, riducendola ad una questione di uomini “malati” e machisti e a delle povere donne vittime che devono essere protette. In ultimo, la maggior parte dei testi riportano il femminismo e l’azione femminista come risposta chiave.
Per quanto riguarda il titolo, abbiamo introdotto un cambiamento nel sottotitolo “testi sulla violenza di genere nei movimenti sociali”. Da un lato, abbiamo sostituito violenza di genere con violenza machista, a causa delle depoliticizzazione e dell’uso istituzionale che si fa del primo, e perché non indica la direzione della violenza, da dove proviene e chi la riceve.
Dall’altro, abbiamo mantenuto il termine movimenti sociali a sottolineare che quando parliamo di violenza machista, il limite dentro-fuori è fittizio e le dinamiche all’interno dei movimenti non sono diverse da quelle all’esterno, né nella società in generale. In fin dei conti, la violenza è la stessa. Ciononostante ci riferiamo ai movimenti sociali, dove noi stesse ci situiamo, perché inglobano realtà differenti con alcuni codici condivisi che ci permettono di comprenderci e, soprattutto, perché partono da una volontà trasformatrice che è quella a cui noi ci appelliamo.
Questa è una chiamata all’auto-organizzazione delle donne, alla solidarietà, all’azione, a gruppi misti che vogliono crescere nel rispetto, e affinché che si continui a creare iniziative e a lottare contro la violenza machista.
Le Forbici tornano nuovamente ad uscire per essere un nuovo invito, una riflessione, un argomento, un’arma, un mal di testa, una chiave inglese, un oggetto quotidiano, e soprattutto per farla finita con l’indifferenza.
Perché abbiamo sempre l’impressione di partire da zero...
“Forbici per tutte” nasce con l’intento di raccogliere la memoria collettiva che differenti gruppi femministi, collettivi misti e individu*, hanno elaborato negli ultimi anni a partire da testi che parlano di aggressioni concrete, di proposte di dibattito e che si riferiscono direttamente ai nostri spazi politici. Non siamo le prime... né saremo le ultime...
Questa raccolta di testi nasce perché siamo stufe della sensazione di partire sempre da zero, come se non fosse mai stato iniziato un lavoro in questo senso. E la verità è che, anche se così non è stato, anche se questa riflessione è stata già portata avanti da molte e da alcuni, sono stati pochi i passi avanti verso una sua realizzazione pratica, verso la politicizzazione delle aggressioni e la presa di posizione collettiva, così come nell’elaborazione di azioni pratiche di risposta. Tuttavia, molte di noi, in quanto donne, non solo sono andate avanti in questo cammino ma sono anche stanche di ripetere sempre le stesse cose.
Vogliamo denunciare che la gestione delle aggressioni sessiste è già da molto tempo tra i panni sporchi dei movimenti sociali, lontano dall’agenda e dalle priorità politiche. Che nel momento in cui emerge la denuncia da parte di donne che fanno parte dei collettivi, i meccanismi di resistenza, di minimizzazione o di “guardare al dito e non dove esso indica”, fanno sì che si perda la possibilità e la voglia di portare avanti un lavoro politico sulle aggressioni machiste.
“Forbici per tutte” è uno strumento collettivo, uno spunto per la riflessione, il dibattito e l’azione contro le aggressioni. Per convincere le donne a denunciare, agire, rispondere e invitare le persone ad autogestire la decostruzione dell’immaginario sessista che ci riguarda, ci tocca e ci attraversa. Che però nessuno si aspetti di venire illuminato perché il ruolo di educatrici non lo vogliamo. Già ci basta spiegare, segnalare, scrivere, giustificare, proporre... la violenza machista ci lascia poca voglia di essere comprese, ma con il desiderio che esistano solidarietà, azioni e reazioni, senza che ci si aspetti sempre che siamo noi a renderla visibile.
Questo dossier è un invito all’azione e per questo lo abbiamo strutturato in tre momenti differenti: i primi testi indicano il contesto al quale ci riferiamo, ovvero la violenza nei movimenti sociali; il secondo gruppo è composto dai testi che sono stati scritti come risposta ad aggressioni concrete; infine, l’ultimo gruppo è costituito da proposte di azione diretta femminista.
DAJE E FORBICI PER TUTTE
Il femminismo non è un “tema da donne”
Nessuna opzione è neutra, innocua; il silenzio è complice dei privilegi di poche. Non è sufficiente una certa “accettazione” rispetto a pratiche altre non eterosessuali: dobbiamo, invece, decostruire tutta la cultura e la simbologia patriarcale (ed eterosessista) imperante.
Una delle premesse basilari della lotta femminista, come accade nelle altre lotte che si organizzano a partire dalle necessità di un gruppo oppresso per una sua caratteristica peculiare (il colore della pelle, il sesso, l’etnia, l’età, la scelta sessuale, la classe sociale, la situazione rispetto ai documenti che regolano la condizione di immigrato, il lavoro, la libertà fisica) consiste nel fatto che la concretizzazione dei suoi interessi, la determinazione delle sue strategie politiche, sono decise da persone soggette a queste relazioni di oppressione-dominazione-sfruttamento e, nel caso del femminismo, dalle donne.
Si tratta della cristallizzazione dei ruoli nella relazione di dominazione classica che si stabilisce tra “padrone e schiavo”, nella quale la mascolinità (incarnata da uomini in carne ed ossa nel corso di tutta la storia e che, però, trattandosi principalmente di un modello, di un archetipo virile di dominazione, può essere adottato da qualsiasi persona che scelga un qualche tratto di questo modello) è la costruzione dominante e la femminilità è l’altro, cioè ciò che viene negato ed escluso da tutta un’economia non solo materiale ma anche (e soprattutto) culturale e simbolica (Lévi- Strauss definisce il momento inaugurale della cultura con l’apparizione e sviluppo del linguaggio simbolico basato sullo scambio di donne come oggetti tra gli uomini delle differenti tribù/famiglie, formalizzando in tal modo la reificazione delle donne nella nascita della cultura occidentale. Le strutture elementari della parentela, Lévi-Strauss, 1949).
Ancora oggi, questa spiegazione basilare della necessità dell’auto-organizzazione da parte delle persone oppresse in questa relazione dialettica di potere, sembra difficile da comprendere per molti uomini e molte donne compagne in altre lotte. Questa incomprensione e, ancor peggio, questa mancanza totale di rispetto è quello che dobbiamo sopportare come donne che scommettono sulla creazione di spazi-gruppi-momenti di donne non misti. Chi non rispetterebbe l’esigenza delle persone nere di auto-organizzarsi per contrastare il razzismo dopo quello che è successo a New Orleans?
E questo atteggiamento non solo è sconvolgente ma anche molto molesto. Invece di creare delle reti nelle quali la comunicazione possa fluire in maniera trasparente e senza ostacoli e creare, così, flussi orizzontali di conoscenza, ci dedichiamo a fare politica da quattro soldi, dove vince chi grida più forte o dove l’unico posto in cui scorre il dialogo è nei bar e solo per criticare le persone alle spalle senza sforzarci minimamente di generare dibattiti fruttuosi e arricchenti per tutte, a partire proprio dalle differenze e divergenze.
Dall’altro lato, un’altra ovvietà alla quale facilmente può arrivare una persona limpida e sveglia (e questo è direttamente proporzionale all’interesse che ciascuna ci mette), è che il sistema incaricato di produrre e mantenere la gerarchia diseguale tra i generi (relazione di dominazione che viene spiegata abbondantemente e documentata in molti testi disponibili a chiunque se ne interessi), ovvero il PATRIARCATO, è un problema che ci riguarda tutte (tutte siamo state socializzate come uomini o come donne) e che, quindi, saremo capaci di trasformare (o distruggere) questo sistema solo quando ognuna prenderà coscienza dei meccanismi che hanno contribuito a strutturare la nostra femminilità/mascolinità che, a loro volta, perpetuano la dominazione patriarcale.
Quindi, l’analisi della specificità del ruolo maschile deve essere portata avanti e decostruita dai suoi protagonisti che “incoscientemente” lo riproducono giorno dopo giorno, ovvero gli uomini che dovrebbero smetterla di banalizzare l’importanza di questo compito con la frasetta del “io già ci ho lavorato”. Le possibili alleanze che nasceranno da questo impegno e lavoro collettivo, sia una ad una che tutte insieme, ci permetteranno di creare reti di comunicazione e di appoggio per lottare contro il patriarcato di merda.
Nel caso delle donne, la femminilità, così come la conosciamo oggi, rappresenta lo strumento tramite il quale arriviamo a desiderare la dominazione maschile, che non è assolutamente funzionale ai nostri interessi (in quanto soggetti autonomi); costituisce l’addestramento ad erotizzare questo gioco perverso di dominazione maschile, di accesso sessuale (economico, sociale) degli uomini alle donne. La femminilità e la mascolinità sono costruiti per essere ruoli complementari e necessari, e il mito dell’amore romantico e vero si appropria degli unici codici erotici e sessuali accettati e li regola. L’eterosessualità normativa è il prodotto perfetto dell’obbligo di essere “veramente” un uomo o una donna.
E non stiamo parlando di pratiche sessuali concrete ma dell’eterosessualità come istituzione politica e sociale che struttura la società (coppie monogame, famiglia, proprietà privata... struttura che si sta ampliando recentemente alle unioni di persone dello stesso sesso, fatto che risponde più alla flessibilità del sistema nell’assimilare le nuove necessità – o possibili sovversioni – che a cambiamenti profondi). Svelare i meccanismi che operano individualmente e socialmente al fine di costringere il nostro potenziale erotico all’interno dell’opzione eteronormativa, è compito di tutte, e lo ripeto, al di là delle nostre scelte sessuali concrete. E in questo senso il lavoro continua ad essere infinito perché, fino a quando la (etero)sessualità continuerà ad essere considerata acriticamente come “normalità”, continuerà ad esistere il “fuori” per le diseredate dai privilegi lesbo-omo-transfobici e saremo condannate ad essere l’”anormale”, lo strano, l’altro... le strutture profonde del patriarcato non cambieranno ma si modificheranno per essere più efficaci, dato che non si tratta di generare tolleranza per il diverso, bensì di sconvolgere i luoghi “sicuri” e “normali”, far esplodere queste costruzioni sociali che ci dividono in normali e anormali, uomo-donna, femminile-maschile, eterosessuali-lesbiche-omosessuali...
Nessuna scelta è stata neutra, innocua; il silenzio è sempre complice dei privilegi di poche. Non è sufficiente una “accettazione” crescente delle altre pratiche non eterosessuali: dobbiamo, invece, decostruire tutta la cultura e la simbologia patriarcale (e eterosessista) imperante.
Ovviamente, questo sistema di oppressione specifico nei confronti delle donne in quanto gruppo oppresso, non definisce la nostra posizione di soggetti in lotta a partire dal vittimismo e dall’autocommiserazione (anche se non ci mancano le motivazioni per piangerci addosso), ma dall’esercizio di coscienza sulla nostra realtà psico-sociale in quanto “donne”, ci buttiamo in un’attività creativa, tramite la quale articolare le strategie di lotta a partire dalle nostre soggettività sulle quali, oltre alla divisione femminile-maschile, operano anche altri assi di oppressione quali sono la classe sociale, la scelta sessuale, il colore della pelle, i popoli a cui apparteniamo... definendo questo sistema come “etero-patriarcato-capitalismo”.
Quello che più mi preoccupa (e che è anche la ragione principale di questo scritto) è l’assenza “misteriosa” della responsabilità individuale (e ovviamente collettiva) nel confrontarci con il sano esercizio di far emergere questi processi che influenzano la costruzione delle nostre soggettività, poiché, così come mettiamo in discussione i processi di socializzazione che sin da piccole ci istruiscono all’egoismo individualista, al consumismo compulsivo, alla competitività e alla lotta per il potere, allo stesso modo veniamo educat* alla femminilità e alla mascolinità, ma queste costruzioni, cariche di interessi ideologici che lasciamo passare per “naturali” o “normali”, non le mettiamo mai in discussione (così come succede per la “naturalità” dell’eterosessualità). C’è da dire, inoltre, che questo processo di autocritica consapevole parte dall’allegria di sentirci più padrone di noi stesse, dal rispetto verso noi stesse e verso le tensioni di tutte, dall’ascolto e dal supporto reciproco e non dal sacrificio e che, per quanto ne dicano, non si tratta di negare il desiderio, l’erotismo, la sessualità.
Non era la volontà di non separare il personale e il politico quello che caratterizzava i movimenti autonomi? Non rappresentano i centri sociali e gli altri spazi collettivi una scommessa per la sperimentazione nelle nostre vite di nuove forme di socializzazione, nuovi modi di affrontare il consumo, il lavoro salariato e schiavizzante, l’industria della cultura totalitaria e omologante, la creazione di pensiero critico e di nuovi modi di vivere, di nuove strategie di lotta e denuncia...? Non critichiamo sempre la politica del “tempo libero” a latere del lavoro e della cura familiare, politica che non tiene in conto i processi concreti e materiali che operano nelle nostre esistenze?
È proprio nel piacere di rivoluzionare i micro-elementi che ordinano la vita che le femministe (già dagli anni ‘70) basano la sfida del “personale è politico”: recuperare la materialità della politica per pensarla come un continuo di elementi che giocano un ruolo centrale nelle nostre vite. Da questo nasceva l’impegno a focalizzarsi su temi che generalmente venivano tralasciati e che hanno a che fare con l’educazione, con la sessualità, con la conformazione dei corpi, sia con il sistema sesso/genere/desiderio che con l’immaginario sociale, con la cura, la sostenibilità della vita, con lo svago stesso. Il carattere sovversivo del piacere di politicizzare il quotidiano delle nostre vite, soprattutto nella lotta femminista e nell’attività di alcuni gruppi di donne, di raccontare e svelare l’universo del “personale”, è stato spesso sminuito da alcune letture che lo relegavano alla mistica della femminilità. Che c’è di male in questo? L’obiettivo è, ed è stato, tra l’altro, quello di evidenziare in maniera collettiva le strutture sociali e psicologiche che ci hanno formato nella nostra femminilità, svelare i desideri e i timori che a partire da questa si generano. L’altezzoso atteggiamento di noncuranza per questi temi, ha sminuito il potenziale sovversivo insito nel mettere in discussione i meccanismi di produzione del desiderio e delle sue possibili trasformazioni collettive.
Queste incomprensioni, incomunicabilità o “sfondoni” hanno portato a depotenziare il contagio che il femminismo stava producendo sul modo di intendere la politica negli altri spazi, l’impegno di trasformare la politica che non tenesse in conto la natura trasversale di temi come la sessualità, l’educazione, i comportamenti quotidiani, i ruoli sociali, il linguaggio o le relazioni affettive, relegando le proposte femministe nel terribile contenitore delle “questioni delle donne” o “il tema della donna”. Sintomo chiaro dell’aver smesso di prendere sul serio l’impegno femminista (ammesso che in qualche momento fosse stato realmente considerato). Chi ha detto che il femminismo è superato, che la sua lotta è antiquata?
In questi tempi di crisi delle strategie tradizionali dei movimenti sociali di fronte alle incessanti trasformazioni delle nostre società postindustriali e globalizzate, e di fronte alla difficoltà che presuppone la rottura con una certa “moralità antagonista” che sembra collocarci sempre fuori e contro tutto ( il famoso ghetto alternativo, autoreferenziale e autocompiacente, con le sue norme su cosa va bene e cosa no) e la creazione di progetti e modi di vivere e di lottare che vadano oltre le dinamiche dell’azione-reazione e dell’attacco-risposta, non dobbiamo accantonare l’impegno sovversivo di trasformare le nostre vite a partire dall’allegria, il piacere e il desiderio collettivo. Ed è in questo senso, secondo me, che il lavoro femminista continua ad essere uno strumento valido e non disprezzabile per capirci un po’ di più e comprendere questo mondo-prigione altamente tecnicizzato e dinamico nel quale (sopra)viviamo.
Siamo oneste, se non vogliamo prendere parte a progetti collettivi che mettano in discussione questo sistema in ognuna delle sue realizzazioni pratiche, perlomeno smettiamo di scagliarci l’una contro l’altra e impariamo a rispettarci veramente una volta per tutte, perché certi atteggiamenti di disprezzo (e non solo di incomprensione) sono reazionari in quanto cercano di boicottare qualsiasi tentativo di risposta o di trasformazione che metta in discussione questo sistema, nelle sue varie manifestazioni. Nessuna lotta è più importante dell’altra, finiamola con il mito della gerarchia delle lotte che continua a perpetuare una divisione tra pubblico e privato, dando spesso priorità a ciò che è urgente rispetto a ciò che è importante.
IL FEMMINISMO VIVE!!
LA LOTTA CONTINUA!!
Susana, mantisafu@yahoo.es/ Alasbarricadas.org
Rompendo immaginari: aggressori politicamente corretti
Barbara Biglia e Conchi San Martín
L’immaginario creato intorno ai maltrattatori rappresenta un mito che li descrive come esseri irascibili, rozzi, con problemi di droga o alcool, scarsamente istruiti, ignoranti, violenti, disadattati, sconvolti, falliti e/o che hanno subito a loro volta maltrattamenti da piccoli: soggetti che vanno oltre la normalità benpensante. Se le cose stanno così, le donne che hanno deciso di iniziare una relazione con uomini così dovrebbero sapere o perlomeno intuire cosa dovranno sopportare e, quindi, potrebbero considerarsi parzialmente responsabili del maltrattamento subito (San Martín in questo opuscolo).
Il lavoro di associazioni femministe di mutuo aiuto e di gruppi femministi di varie parti del pianeta (Soriano; Tamaia, in questo opuscolo) sono riuscite, in generale, a scardinare questa visione. Grazie a questo, oggi, perpetuare questa visione dell’aggressore nelle analisi teoriche o politiche non è ben visto e viene, anzi, considerato come sinonimo di ignoranza e arretratezza culturale. Tuttavia, questo immaginario continua ad esistere sotto forma di realtà che si insidia nel quotidiano. Questo comporta, per esempio, che quando scopriamo che qualcun* che conosciamo e rispettiamo ha maltrattato la sua partner, quasi istantaneamente sentiamo l’esigenza di giustificare, spiegare..., tranquillizzare noi stess* pensando che forse la perdita di controllo è dovuta a un raptus o che la persona aggredita ha, in qualche modo, scatenato tale reazione o non ha saputo prevederla...
La presentazione che i media danno dei casi di violenza (Nadali y Gordo López in questo opuscolo) si accompagna, quasi sempre, al supporto fornito dalle testimonianze dei vicini che esprimono lo stesso punto di vista: nessuno poteva sospettare dell’aggressore perché si trattava di una persona piacevole, lavoratrice, simpatica, educata, rispettabile, e tutta una serie di epiteti per definire il soggetto come una persona “perfettamente normale” che si è, inspiegabilmente, ammalata. L’incredulità e la sorpresa di questi testimoni mostrano come, anche se vari studi hanno dimostrato con chiarezza che non ci sono caratteristiche comuni a tutti gli aggressori, quotidianamente ci imponiamo di credere a questa realtà e perpetuiamo l’immaginario del mostro e della donna indifesa.
Contemporaneamente, negli ambiti politicizzati, siano essi partiti o gruppi di sinistra o movimenti sociali, circola un altro immaginario che viene raramente analizzato: quello di credere che, in fondo, gli aggressori siano reazionari e le loro compagne donne deboli e senza supporto sociale. Questo comporta che, nei contesti di attivismo e/o di estrema sinistra, nei quali la parità di genere è teoricamente desiderata e messa in pratica (sulla persistenza di discriminazioni in questi contesti cfr. Biglia, 2003; Alfama, Miró, 2005) ci sentiamo in qualche modo immuni e protette. Sfortunatamente, sulla base della nostra esperienza personale, di anni di dibattito in collettivi di femministe autonome di differenti parti del mondo, di discussioni e confronti informali con amiche/compagne, ci rendiamo conto che questo mito è completamente falso. Falsità confermata anche dalle informazioni raccolte nella tesi di Barbara: il 17,9% delle attiviste dei movimenti sociali, che hanno risposto ad un questionario online, affermano che negli spazi di movimento si verificano episodi di abuso (in forma non isolata e non solo in situazioni in cui si è ubriachi o fatti); il 26,4% afferma che situazioni di questo tipo sono casi isolati o riscontrabili nel contesto sociale più ampio (Biglia, 2005). Un’altra conferma alla falsità di questo mito, la troviamo nelle testimonianze di attiviste cilene che denunciano come alcuni compagni della guerrilla contro Pinochet scaricano oggi la loro aggressività martirizzando le loro compagne: “Credo che gli uomini, al tempo della dittatura, erano molto combattivi. Inoltre, durante la dittatura il problema era Pinochet e il suo apparato repressivo. In più, durante la dittatura in Cile era come se non ci fossero altri problemi, l’unico era Pinochet che causava la povertà, la disoccupazione e cose così, capisci? Poi arriva la democrazia e ti rendi conto che un dirigente eccellente a casa sua è una merda, mena alla moglie, abusa sessualmente dei figli” (GRICH)[1]. Gli esempi potrebbero essere molti e tutti tristemente identici tra loro: crediamo che i motivi che spingono alcuni attivisti a essere violenti con le loro compagne sono gli stessi che caratterizzano anche altri contesti; quindi non ci interessa in modo particolare quello che succede nella testa di questi “supermilitanti” aggressori né come facciano a vivere nella contraddizione che si crea tra un comportamento pubblico perfettamente “politically correct” e una realtà di violenza privata impressionante. Quello che vorremmo iniziare a capire sono le caratteristiche peculiari di implementazione e giustificazione di queste situazioni, perché crediamo che la possibilità che atti del genere continuino ad accadere, impunemente e con frequenza sia responsabilità di tutte noi. Come sottolinea in un suo comunicato l’Assemblea delle Compagne Femministe di Roma (2000)- in risposta ad un abuso sessuale che, secondo noi, potrebbe facilmente essere ampliato a qualsiasi situazione di violenza di genere/abuso-: “Non solo è complice chi difende esplicitamente il violentatore ma anche chi, uomo o donna, fomentando dubbi, diffondendo voci, delegittimando la parola delle donne, crea un clima nel quale gli aggressori continuano a mantenere la libertà di muoversi tranquilli per la città. Complice è anche chi, in nome della “ragion di Stato” e delle priorità politiche, lascia intatte e inalterate le condizioni, i luoghi, le dinamiche nelle quali si è verificata l’aggressione. Complice è anche chi trasforma la violenza nata tra le mura domestiche in una “mancanza di tatto” di un uomo verso una donna, particolarmente sensibile, in una regola della sfera privata nella quale qualsiasi limite risulta sospeso”.
In questo contesto la seconda affermazione risulta essere particolarmente rilevante in quanto mostra come sia ancora difficile che la lotta, teorica e pratica, contro le discriminazioni e la violenza di genere si affermi come priorità dell’agenda politica di movimento. Tali questioni, etichettate come afferenti alla sfera privata delle relazioni, acquisiscono un valore secondario rispetto alla politica degli spazi pubblici.
Un tema, come altri, che deve essere trattato “dalle femministe”, come dice Micaela (Spagna)[1]: “Quando c’è un collettivo di donne [...] tutto ciò che ha a che vedere con il sessismo viene lasciato in mano a questo collettivo [...] e le altre persone non si sentono in dovere di preoccuparsi di niente perché lo faranno le donne. Quindi, tutte quelle persone a cui non interessa il femminismo e il sessismo [...] ci sguazzano perché nel loro movimento c’è un immaginario, «perché il mio movimento è femminista perché ci sono le compagne che lo dimostrano quando è necessario», e per il resto non cambia niente”.
Quindi, ci interessa iniziare a pensare a queste domande, senza la pretesa di trovare risposte definitive: perché è così complicato renderci conto delle aggressioni che accadono intorno a noi? Quali sono le dinamiche e i processi che permettono di mantenere impunemente una doppia faccia di affabulatori e aggressori? Perché le femministe non sono capaci di lasciare questi uomini e far conoscere alle altre la realtà della loro vita privata? Perché se iniziano a parlare sono poche le persone disposte ad ascoltare e a credere alle loro parole? Scriviamo questo testo consapevoli delle critiche e delle polemiche che scatenerà, ma con la speranza che queste semplici riflessioni servano da stimolo per il dibattito e come supporto a compagne che stanno attraversando la stessa esperienza. Dedichiamo queste pagine a tutte quelle che sono riuscite a tirarsi fuori da situazioni di violenza di genere, a tutte quelle che hanno aiutato e, ovviamente, a quelle che ancora non hanno trovato la forza e il supporto per farlo.
Il mito del macho e la coesione del gruppo
[Come può un movimento] mobilitarsi come forza politica trasformatrice se non comincia ad interrogarsi sui valori e le norme internamente assunte che legittimano la dominazione e la disuguaglianza neutralizzando “differenze” particolari? (A. Brah, 2004).
In primo luogo, ci interessa sottolineare come, sfortunatamente, in molti ambiti dell’attivismo, la rappresentazione del “buon militante” assuma ancora un immaginario quasi caricaturale ispirato ad alcune figure-prototipo (Subbuswamy e Patel, 2001). Da un lato, facciamo nostra una rappresentazione molto simile a quella che ne danno i mezzi di comunicazione: “giovane uomo bianco con un cappuccio nero e con la propensione alla violenza” (Alldred, 2000). Le sue caratteristiche sarebbero la forza, il coraggio, la decisione, la capacità di osare e, soprattutto, come dice Silvia (Italia)[1], la capacità di nascondere tutte le sue possibili contraddizioni. Dall’altro lato, troviamo il tipo intellettuale, ovvero qualcuno con un buon bagaglio di conoscenze teoriche (o perlomeno con la capacità di simularle), una forte capacità di convincere, doti organizzative e di comando e tendenza alla leadership. Anche se questo “modello” presenta sfumature più sofisticate, perpetua comunque doti della mascolinità classica (Jorquera in questo testo); potremmo dire che mentre i primi si avvicinano più all’idea normativizzata di mascolinità delle classi sociali basse, questi ultimi sono più simili agli antichi aristocratici, più raffinati ma non meno pericolosi nei loro comportamenti machisti.
Secondo noi, l’assunzione di entrambi i ruoli, incastonati nella mascolinità normativizzata, può portare a situazioni di violenza, nella loro declinazione più fisica o più intellettualizzata. Nella declinazione fisica, con percosse o tentativi di stupro (o molestia) – occasionali o continui. Nella declinazione “invisibile”, tramite la creazione di relazioni di dipendenza, sminuendo le compagne e “facendo loro credere” che senza gli uomini non sono nessuno (per una testimonianza in questo senso: Nopper, 2005).
Ma c’è di più: le situazioni di violenza difficilmente vengono riconosciute quando il loro “protagonista” non corrisponde all’immaginario dell’aggressore. Come racconta ad esempio, la compagna dell’Association contre les violences faites aux femmes au travail (www.avf.org) con il caso di un professore universitario pro-femminismo che continua ad insegnare senza problemi nonostante le varie denunce di molestia da parte di alunne e collaboratrici. Inoltre, i gruppi di attivisti sono e/o si sentono frequentemente minacciati dall’esterno e, come strategia di difesa, tendono a cercare una coesione interna che passa, troppo spesso, attraverso un’omogeneità identitaria e una riduzione delle possibilità di mettere in dubbio qualsiasi dinamica interna di discriminazione (Apfelbaum, 1989; Biglia, 2003). In circostanze come queste, possono esserci resistenze a riconoscere l’esistenza di violenza da parte di un militante perché esporrebbe il gruppo alle critiche di altri spazi esterni. Probabilmente a questo tipo di logica risponde, almeno in parte, il vergognoso epilogo della vicenda riguardante l’omicio di Hélène Legotien da parte di Althusser (v. Rendueles in questo testo). Infine, l’aggressore può trovare riparo e giustificarsi nel pretesto del pericolo (reale o immaginario) che comporta il suo attivismo, nella repressione che sta subendo o che ha subito (come nel caso degli attivisti cileni che abbiamo citato precedentemente) o che potrebbe subire, nello stress derivante dalla sua posizione di supereroe ecc...
Elementi utilizzati per giustificare le aggressioni, per rivendicare/esigere una cura onnicomprensiva (visto che mettono così tanto nella lotta hanno bisogno anche del “riposo del guerriero”) o per accusare (espressamente o in forma latente) di connivenza con il sistema repressivo quelle donne che non vogliono prestare questi servizi, che parlano dei maltrattamenti al di fuori del privato o tentano di denunciare la situazione.
Diciamo che il maltrattatore trova dei pretesti per giustificarsi, però cosa succede intorno a lui? Come vengono recepite queste dinamiche? Questa testimonianza, frutto di confronti privati tra una compagna e un’amica (2005), a partire dalla sua esperienza di donna maltrattata e di attivista nello stesso gruppo del suo partner, dimostra la difficoltà di riconoscere tali dinamiche. Ha avuto una relazione molto lunga di violenza con un militante eroico, seduttore, carismatico. Di conseguenza ogni critica interna si convertiva in un attacco alla causa, ma come mettere in discussione chi costantemente dimostrava di giocarsi la pelle nella lotta? Come mettere in discussione chi sembrava avere l’esperienza e la lucidità necessarie per guidare il gruppo? E così la situazione si capovolgeva: era chi criticava lui ad essere colpevole ed era assurdo che arrivasse a sentirsi così. Si dissolveva, con un colpo di spugna, la messa in discussione dell’altro, sempre più fragile meno valoroso, meno eroico, meno compromesso, più egoista... questa persona si dedicava ad attaccare con quella tattica che permette di colpire le donne senza che, da fuori, si capisca. Chi avrebbe creduto (io in primis) che una persona del genere fosse un aggressore?
Quindi, criticare un “buon compagno” spesso porta ad essere accusate di fare il gioco del sistema e di non capire che ci sono questioni più importanti da affrontare; e le donne che si sono azzardate a farlo vengono messe a tacere, prese in giro, ignorate, escluse, se non minacciate e accusate di essere complici dell’avversario politico.
Pochi anni fa si è presentato un caso di questo tipo in Catalogna. Quando una compagna parlò del suo vissuto di violenza da parte di un suo ex compagno, attivista riconosciuto, la risposta generalizzata fu di forte scetticismo. Nel movimento si crearono due schieramenti contrapposti (coloro che le credevano e la appoggiavano e quelli che credevano e appoggiavano lui). Ancora peggio: alcune persone si posizionarono solo sulla base di quello che avevano sentito dire o per affinità politica con l’attivista in questione. Parlando con alcune delle donne che appoggiarono la compagna, ci hanno raccontato della situazione di tristezza, di solitudine e di rabbia nel vedere come persone con le quali avevano condiviso anni di militanza antifascista, anticapitalista, autogestione ecc., potessero mostrarsi talmente chiuse e inflessibili quando i discriminatori erano i loro stessi amici. È ovvio che, soprattutto quando conosciamo le persone implicate in una situazione di questo tipo, manteniamo una certa precauzione prima di farci un’idea precisa sui fatti. Ma ci sembra che a volte le precauzioni verso il “supposto aggressore” siano smisurate se confrontate ad altre situazioni. Ad esempio, nel caso di qualcuno che denunci pubblicamente di essere stato aggredito da altri per divergenze politiche, nessuno metterà in dubbio che sia successo veramente e la persona non dovrà spiegare mille volte tutti i particolari dell’avvenimento in successione precisa e corretta, né dovrà giustificare perché il pugno preso deve considerarsi un atto violento. Invece, nel caso in cui un’attivista sia maltrattata da un militante si sviluppa un fenomeno quanto meno curioso: la donna che si azzardi a “denunciare pubblicamente”, prima di poter “dimostrare la colpevolezza” dell’altra persona, deve difendersi dalle accuse di essere una bugiarda, rancorosa e isterica (e a volte neanche funziona, come raccontato da Rendueles in questo testo). Spesso, abbiamo sentito commenti del tipo “se fosse vero e lei non avesse niente da nascondere, verrebbe qui in assemblea a spiegarci esattamente quello che è successo; anzi potrebbero venire tutti e due, così, confrontandoli, sapremmo chi ha ragione”, che mostrano una palese insensibilità verso le dinamiche dolorose della violenza e le difficoltà nel superarla. A nessuno verrebbe in mente, per esempio, di obbligare un compagno torturato e/o violentato da un organismo di repressione a raccontare per filo e per segno i fatti davanti a tutto il gruppo a cui viene chiesta una mobilitazione di denuncia e solidarietà. Questa doppia morale fa supporre tre cose: la prima, che è facile riconoscere gli errori dei “nemici” ma che la protezione del “noi” risulta ancora più forte; secondo, che le parole delle compagne hanno ancora meno credibilità rispetto a quelle dei compagni; e terzo, che la violenza viene ancora percepita come un’esperienza personale afferente allo spazio privato e non come parte di un processo politico. Quando, poi, la violenza è di tipo psicologico, la situazione si complica ancora di più per l’impossibilità di “provare” quello che è successo: non ci sono segni fisici e si tratta di situazione di abuso sottile, privo delle sfumature più cruente e devastanti. Come suggerisce una compagna della Eskalera Karakola: “un altro passaggio da rendere reale è l’attenzione alla donna che ha subito l’aggressione [...]. In primo luogo, per comprendere come si sperimenta l’aggressione [...] e non avere paura dello scambio e dei fantasmi che la violenza provoca. Quando si verificano aggressioni, è importante creare gruppi di sostegno, di intermediazione e di appoggio perché una volta che la violenza è stata perpetrata, chi l’ha vissuta continua a frequentare gli spazi e ha molto da digerire.”
Non si tratta di invisibilizzare ma di sapere, capire come si sente la persona aggredita, come definisce la violenza e come reagisce all’aggressione subita e a quelle che verranno. Seguire i tempi e le esigenze di chi vive la violenza. In questo senso, un tentativo di affrontare questa problematica, riconoscendo che abbiamo ancora molto da imparare (che è un buon principio da cui partire), è quello di seguire le raccomandazioni della rete People Global Action Europe (PGA, 2005) quando ci si trova davanti a situazioni di violenza nei collettivi.
Io,donna forte: sola tra tante
Un altro immaginario da decostruire per superare le aggressioni nei gruppi di compagni è quello secondo il quale una donna, per essere femminista e per non essere sessista, deve aver superato tutte le limitazioni di una cultura eteropatriarcale: una donna liberata deve assomigliare allo stereotipo dell’uomo bianco moderno – indipendente, forte, attiva, sicura di sé e, nel caso delle militanti, priva di contraddizioni (per una testimonianza, Anonima 2004). Questo immaginario fa sì che le attiviste maltrattate abbiano grandi difficoltà a riconoscere la propria dipendenza dall’uomo e la poca forza che hanno per uscire da una situazione di abuso. Questa situazione viene sottolineata, ad esempio, dalla testimonianza di questa attivista nordamericana: “il disagio nel comunicare alle persone che hai subito un abuso o, come nel mio caso, che hai vissuto una relazione violenta, aumenta per le risposte che ricevi dalle persone. Più che empatizzare, molte persone si sono dimostrate deluse. Molte volte mi hanno detto che erano sorprese del fatto che mi fossi infilata in questa merda perché non ero una donna debole ma una donna forte e politicizzata” (Nopper, 2005).
In qualche modo continuiamo a sentirci colpevoli o inferiori per il fatto di sopportare una situazione di questo tipo e ci vergogniamo di ammetterlo, oltre al fatto di avere paura. Secondo noi, questo meccanismo è dovuto a una pessima concezione, che vorremmo qui sottolineare, di cosa sia il femminismo. Essere femministe o essere compagne non implica, fortunatamente, non avere bisogno del sostegno delle nostre amiche o dei nostri amici, né vuol dire essere completamente autonome né dover risolvere individualmente ogni problema personale. Tuttavia, tutte purtroppo riproduciamo forme di dipendenza eteropatriarcali e, a volte, ci comportiamo in modo sessista. Riconoscere limiti e contraddizioni, condividere il nostro malessere in uno scambio con gli/le altr*, chiedere aiuto, consigli, supporto, sono pratiche femministe che ci possono aiutare a crescere sia a livello individuale che collettivo. Rompere con l’immagine della donna forte e dura a qualsiasi costo, viverci le nostre sfumature, performandoci in maniera differente in base alle occasioni e ai momenti, sono pratiche di sovversione e disarticolazione dell’eteropatriarcato che vuole modellarci come soggettività individualizzate.
Ovviamente, abbattere le barriere della solitudine (che possono esistere anche quando abbiamo molte amiche) e del privato non è un compito facile e, ovviamente, non è di competenza solo di coloro che vivono una situazione di violenza: dovrebbe, invece, essere un lavoro politico e collettivo che ci coinvolge tutte affinché smettiamo di essere, come dicevano le compagne di Roma (vedi cit. sopra), complici del nostro silenzio e della nostra cecità.
Le barriere – come abbiamo già evidenziato – sono molteplici e assumono maggiore forza se continuiamo a considerare la violenza come espressione di rapporti privati. In questo modo, di fronte alle sue manifestazioni, ci troviamo spesso in una situazione di forte indecisione e incertezza rispetto alle possibili azioni da realizzare e tendiamo ad assegnare alla donna la responsabilità rispetto alla risposta da dare a questa situazione, come dimostra l’estratto dell’intervista fatta a Paloma (Cile)[1]:
P [...] Sono rimasta scioccata dal comportamento di un compagno che si riempie la bocca con le storie sull’uguaglianza sociale e il rispetto reciproco. Ieri sera siamo andati a mangiare una pizza e sua moglie [...] ha ordinato la pizza che [...] però non era quella che voleva lui [...] e le ha detto «come ti è venuto in mente di ordinare sta roba» e non ha mangiato e ci ha rovinato la serata perché voleva una pizza e l’ha trattata come un despota...
B Nessuno ha detto niente?
P No, o meglio alcuni di noi si sono spazientiti [...] ma nessuno gli ha detto «basta, falla finita». È che anche lei avrebbe dovuto mettergli un freno e invece è rimasta zitta e si è messa quasi a piangere. Come se fosse rassegnata”.
Nonostante alcune campagne interessanti portate avanti o perlomeno avviate da collettivi femministi in risposta a situazioni concrete, la violenza, e nello specifico quella che si sviluppa negli spazi di movimento, non è stata ancora oggetto di un dibattito politico e approfondito specifico nei movimenti sociali. Questo comporta situazioni di estrema fragilità e incertezza nell’incapacità di riconoscere la violenza e reagire. Come abbiamo potuto constatare attraverso conversazioni private, in varie occasioni nelle quali collettivi femministi autonomi hanno iniziato campagne di risposta di fronte ad aggressioni perpetrate da parte di compagni, ci si è dovute confrontare con molte contraddizioni, dubbi e, ovviamente, critiche molteplici e dolorose. La mancanza di un dibattito su questo tema, le poche iniziative realizzate, il forte ostruzionismo a cui sono state sottoposte, e il fatto di dover inventare modi di agire che siano incisivi ma che non generino rotture nel movimento, non hanno permesso di sviluppare linee di intervento. Questo, oltre a richiedere molte energie, rende a volte le campagne poco efficaci. Per esempio, in Catalogna, qualche anno fa, una donna ha raccontato la relazione violenta che stava vivendo e non c’è stata la capacità di tutelarla adeguatamente e di proteggerla da quella situazione. Alla fine questa attivista non ebbe altra via di uscita che quella di denunciare l’aggressore al sistema giudiziario, venendo poi accusata di essere una “traditrice”. Ci chiediamo: come possiamo giudicare le azioni delle persone quando chiedono un aiuto esterno se non siamo capaci di assumerci collettivamente la responsabilità di trovare una soluzione a tale problematica?
Alcune riflessioni conclusive
Qual è il fine di questo testo? Semplicemente quello di fornire uno strumento per guardare verso noi stesse e verso le nostre compagne, perché sia messa fine a dinamiche violente e perché insieme si riesca a mettere all’angolo coloro che si sentono in diritto di perpetrare tali comportamenti. Speriamo che faccia nascere una polemica, che si consideri la violenza come una questione politica rispetto alla quale dobbiamo posizionarci e di fronte alla quale dobbiamo agire. Vorremmo che le compagne che vivono un’esperienza del genere non si sentano sole, né poco femministe per quello che sta succedendo loro, ma che scoprano che è qualcosa che succede più spesso di quanto si creda e che la soluzione deve essere collettiva. Per questo motivo è importante trovare le forze per parlarne: condividere le esperienze di violenza con un’amica è il primo passo per uscirne. Dall’altro lato, speriamo che, quando un’amica lanci dei segnali su quello che le sta accadendo, le persone che le stanno a fianco si sforzino di percepirli e, a partire da questo, tentino di offrirle il supporto necessario, senza opporre rifiuti, o giudizi e attacchi, ma ascolto e accoglienza. Anche se ci sembra esagerata l’affermazione secondo la quale “ogni uomo è un potenziale aggressore”, è importante rivendicare che l’immaginario del aggressore con il quale abbiamo iniziato questo testo ci allontana dalla possibilità di riconoscere l’abuso in tutte le sue forme ed espressioni. Speriamo, inoltre, che si capisca che anche “compagni riconosciuti” possono essere aggressori, fisici e psicologici, e che chi compie una violenza non è e non può essere un compagno. Essere capaci di vedere al di là dell’immagine, di ciò che appare e disarticolare gli immaginari di genere e di “identità militante”, è, secondo noi, una pratica necessaria contro la violenza di genere.
Testo pubblicado in “Estado de wonderbra -Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género”, Virus Ed.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
LFAMA, E. y MIRÓ, N. (coords.) (2005): Dones en moviment. Un anàlisis de gènere de la lluita en defensa de l’Ebre. Valls: Cossetània.
ALLDRED, P. (2002), «Thinking globally, acting locally: women activists’ accounts». Feminist review, 70, pp. 149-163.
ANÓNIMA (2004): «Amor y Respeto, ¿si no qué?». Mujeres Preokupando, 4, pp. 46-48.
APFELBAUM, E. (1989): «Relaciones de dominación y movimientos de liberación. Un análisis del poder entre los grupos». En J. F. Morales y C. Huici (eds.): Lecturas de Psicología Social. Madrid: UNED, pp. 261-297.
ASSEMBLEA DELLE COMPAGNE FEMMINISTE DI ROMA (2000): La cultura dello stupro é viva e lotta insieme a noi. En www.tmcrew.org
BIGLIA, B. (2003): «Modificando dinámicas generizadas. Estrategias propuestas por activistas de Movimientos Sociales mixtos». Athenea Digital, 4. antalya.uab.es. (2005): Narrativas de mujeres sobre las relaciones de género en los movimientos sociales. Tesis doctoral.
BRAH, A. (2004-1992): «Diferencia, diversidad, diferenciación». En b. hooks, A. Brah y otras (2004): Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras. Madrid: Traficantes de sueños, pp. 107-136.
COMPAGNI DEL CENTRO SOCIALE «MACCHIA ROSSA» MAGLIANA (2001): Sulla violenza sessuale. Documento del CSOA Macchia Rossa di Roma, www.tmcrew.org
ESKALERA KARAKOLA (Desde la) (sin fecha): Espacios Okupados, espacios con cuidado, HYPERLINK www.sindominio.net
NOPPER, T. K. (2005): Activist Scenes are no Safe space for Women: on abuser of activist women by activistmen. En www.melbourne.indymedia.org
PGA (2005), In case of physical or psychological violence. En http://www.- all4all.org/2004/12/1362.shtml
SUBBUSWAMY, K. y PATEL, R. (2001), «Cultures of domination: Race and gender in radical movements». En
K. Abramsky (ed.), Restructuring and Resistences. Diverse voices of struggle in Western Europe, publicacióndel autor, pp. 541-3.
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA(2001): «Indicadores de riesgo. Ayuda para la mujer maltratada». Despertad!, 8 de noviembre de 2001. Anche in www.watchtower.org
Perché parliamo di sessismo negli spazi liberati?
Perché viviamo in una società capitalista e patriarcale basata sull’impero del maschio sulla donna e siamo stat* educat* in questi valori. E per costruire un’alternativa a questo sistema, il primo passo è cambiare noi stess*: la nostra concezione della vita, le relazioni, il sistema...la difficoltà non è teorizzare il cambio ma metterlo in pratica, questo è ciò che costa di più.
Perché malgrado tutti e tutte combattiamo il capitale, il fascismo e il sessismo, ancora ci sono alcuni che contano più di altre. Può essere per abitudine, per l’età o per il tono di voce, in alcuni luoghi, assemblee, iniziative...si ascolta e si dà più credibilità alla loro voce.
Perché non vogliamo solo liberare gli spazi ma anche le menti e i comportamenti. E alle feste dei centri sociali ci sono ancora persone che si sentono libere di sbavare su quelle (non quelli) al bancone per puro divertimento o ancora peggio, perché credono che è così che si può legare con loro. Perché non siamo le fidanzate di né le compagne di , senza una propria identità e personalità. Però nel nostro ambiente alternativo si riferisce ancora a tizio come “quello disobbediente che sta in tale collettivo” mentre ci si dimentica che tizia oltre ad essere la sua compagna, è disobbediente tanto quanto lui...però fa meno rumore.
Perché c’è ancora gente che crede che esser forte significhi solo darci dentro e si vergogna di mostrare debolezza in pubblico o disprezza quell* che lo fanno. E c’è già abbastanza repressione nel reprimere le nostre lacrime o la tristezza perché c’è chi non lo considera rivoluzionario. Perché noi che in teoria proviamo a rompere con i clichè e i ruoli stabiliti nella famiglia, nella coppia, nelle relazioni...riproduciamo comunque a volte le stesse divisioni dei ruoli, l’incomunicabilità e l’incomprensione tra uomini e donne.
Perché tutt* si riempiono la bocca di sesso sicuro però è ancora tristemente certo che in molti casi (coppie stabili, aperte, sporadiche, triplette, incontri casuali e altre) questa responsabilità di base è lontana dall’essere condivisa da tutte e tutti e l’idea all’inizio è sempre che si pensa che possiamo rimanere incinte.
Perché mentre la società fuori avanza verso una maggiore repressione della sessualità dei bambini e ci fanno credere che le donne sono state liberate perché possono essere militari e aggressore invece di aggredite; mentre continua la disuguaglianza tra i sessi, l’omofobia e la perpetuazione di ruoli sessisti, mentre continuiamo a soffrire del sessimo anche negli spazi “liberati”, c’è ancora chi non vede l’antisessismo come una lotta collettiva, necessaria e urgente. O non capisce perché alcune donne scelgono di allontanarsi da tutto ciò per aprire spazi di discussione, azioni e festa...solo per loro stesse. Forse perché ne hanno più urgenza?
Questo testo vuole raccogliere le impressioni, i dibattiti, le discussioni che molte di noi fanno quotidianamente sul sessismo tra compagn* e crediamo che rifletta molto bene la nostra realtà. Non si tratta di fare critica distruttiva, ma di rompere con quello che ci viene imposto con un po’ di sincera autocritica e ridendo di noi stess*.
Saluti e antisessimo.
Testo scritto da LES TENSES, collettivo feminista del c.s.o L’Hamsa pubblicato a Infousurpa 1998
Geometria, geografia e ideologia delle relazioni di fiducia
Appunti sulla violenza di genere
Antón Corpas
Geometria della fiducia e diritto
Se prendiamo il detto “le pareti parlano”, la saggezza popolare tentando di dire una verità, inganna. Le pareti ascoltano, le pareti vedono e sanno, però generalmente, le pareti tacciono molto di quello che potrebbero dire. Le pareti hanno voce, vista e udito e sono anche sensibili al tatto, ma molto spesso preferiscono chiudere gli occhi, mordersi la lingua e farsi da parte.
C’è uno spazio di diritto che si definisce, si costruisce, distrugge o trasforma nelle relazioni di fiducia: familiari e comunitarie (di vicinato, di amicizia, di lavoro...). Da questo nasce un’educazione sociale e di genere, un’educazione politica e sentimentale, perché non solo bisogna imparare qual è il proprio ruolo e la propria funzione, ciò su cui si può decidere e ciò che inibisce, bisogna anche imparare come sentire, per essere e sopravvivere. Quindi, un uomo che non forzerebbe mai “la donna di un altro”, non si fa scrupoli a farlo con “la propria donna”; una donna che si difende con le unghie e con i denti da un “estraneo”, sopporta stoicamente lo stupro da parte del “proprio marito”; lo stesso ragazzo che minaccia un altro per aver molestato “mia sorella”, riconosce a se stesso la potestà di opprimere “quel corpo”; o una madre può tacere la rabbia per un’aggressione se il responsabile è “tuo fratello”. Perché ciò sia possibile, bisogna imparare a vivere uno stesso fatto in modi differenti.
Questa è la geometria della Fiducia e il Diritto che, quando si passa dalla famiglia alla familiarità, diventa una geometria variabile. Quindi la verità può diventare paranoia, la rabbia o la paura suscettibilità, e la vicinanza invece di avvicinare allontana. Non è raro che quando una donna denuncia la molestia o l’aggressione da parte di un vicino o di un buon amico, finisca alla gogna o marchiata come problematica. Allo stesso modo, i fatti che, se letti in un giornale o visti dietro lo schermo della TV, appaiono ingiustificabili e repellenti, diventano relativi o “differenti” se accadono dietro la porta o dall’altro lato della parete. Non è una questione di status o di ignoranza, o perlomeno non necessariamente. Basta ricordare come Sigmund Freud diagnosticava a Dora – figlia di un mecenate dell’editoria della psicoanalisi – un “desiderio edipico e un polimorfismo della condotta sessuale”, quando la giovane soffriva per le molestie sessuali continue di un amico di famiglia. Il primo patriarca della psicoanalisi dava in tal modo un giudizio conveniente per la pace familiare del suo amico nonché collaboratore finanziario.
Come indicano i dati del Centro de Apoyo a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), è impossibile parlare di violenza sessuale senza riferirsi alle relazioni di fiducia. Secondo questo centro, che tratta un numero minimo del totale delle aggressioni, dei 271 casi seguiti nel 2005 più di un terzo (36,5%) corrispondono a “conoscenti della vittima o persone che hanno qualche tipo di relazione con lei”, divisi dal centro in “conoscenti recenti” e “parenti”.
Per aggredire, così come per difendersi da una aggressione, bisogna sentirsi in diritto di farlo, e per questo si richiede una convinzione personale e una certa protezione sociale. Il prototipo dello stupratore che ancora domina nell’immaginario collettivo, il sociopatico del vicolo buio, si muove nella clandestinità cosciente del reato che sta commettendo. Invece, l’aggressione – di qualsiasi tipo sia – di un marito, fratello o amico, si consuma nel segreto e sotto la protezione della dimensione privata ma con il lasciapassare della parentela e della familiarità, con la fiducia nella coesione, con la sicurezza della comprensione, la mediazione e il silenzio della comunità. Questo non implica l’approvazione collettiva di certi atti, ma la facilità con cui vengono ignorati o, se visibili e inevitabili, la priorità che viene data alla protezione e riproduzione della normalità: il padre deve continuare a fare il padre e lo stesso vale per il fratello e il fidanzato.
È all’interno di questa consapevolezza del normale e dell’anormale – di quello che può succedere sotto l’etichetta della normalità, anche quando colpisce precetti e tabù come l’incesto e la pedofilia – che un marito e un fratello, un nonno, un cugino o un vicino impongono un atto sessuale, con coperture teatrali come il gioco, l’affetto, la passione o la seduzione. Un contesto che permette di fare qualcosa contro, nonostante o senza pensare alla volontà altrui, con un’assoluta tranquillità morale ed emotiva, ed avere, inoltre, il privilegio di fare male “senza volere”, “senza l’intenzione”, “senza saperlo”. Gli uomini che trovano riparo morale e giuridico nel matrimonio o copertura sociale e morale nella famiglia o nella comunità per imporre una volontà sessuale, costantemente o sporadicamente, non agiscono mai, né ieri né oggi, sotto l’impulso di una disfunzione etica o psicologica, non lo fanno per una mancanza educativa o pedagogica, né per cattive intenzioni, ma, come già evidenziato prima, “per diritto”. Proprio come una donna che non si difende: non è una questione di debolezza fisica o mentale o di una qualche forma di shock psicologico, bensì di assenza di diritto.
Ideologia e violenza nelle relazioni di fiducia
Quando parliamo di relazioni di potere, parliamo di relazioni di diritto. Il potere è molto di più ed è generalmente diverso dall’immagine dello spintone, dello schiaffo, del sangue e degli ematomi. Forzare un corpo che oppone resistenza, gridare ad una faccia che risponde, affermarsi con un colpo contro un rifiuto, questo non è esattamente potere. Sebbene sia la forza ciò che generalmente permette di imporre e normalizzare una situazione, il potere in senso pieno sta proprio dove la forza non è necessaria, dove le cose possono “succedere” senza nessun conflitto visibile o prevedibile.
Quel 36,5% di cui parlavamo – e che, secondo me, rimane una stima al ribasso – non è un’accumulazione di “errori”, di “anomalie” individuali, non è una percentuale di immoralità né di anormalità, bensì una prova del buon funzionamento delle relazioni di fiducia come sordina e muro di gomma delle situazioni di violenza. Nel parlare delle relazioni di violenza, ci riferiamo anche e soprattutto alla non-violenza delle forme di molestia e aggressione sessuale che non necessariamente si verificano in uno scenario di percosse o forza fisica. Quando si verifica una violenza sessuale in modo normalizzato, “privato” e invisibile, è proprio il momento caratterizzato da equivoci, linguaggio sofisticato e interpretazioni varie. È interessante notare che se la violenza di genere nelle classi alte ha avuto sempre una componente psicologica e il rispetto della rigida “etichetta” dell’alta società, oggi, l’importanza dei modi e dell’apparenza si trasmette anche alle classi medie che imparano che nella non-violenza delle buone forme risiede il segreto della decenza e della distinzione. O, detto in altre parole, la relazione tra violenza, sottigliezza e buone maniere, che era patrimonio delle classi alte, si sta democraticizzando.
Dall’altro lato, nel dibattito accademico e, direi, anche nelle controversie relative alla violenza coniugale, continuano ad esistere delle divergenze – che ricordano l’instancabile e sterile discussione relativa all’umanità del feto e alla legittimità dell’aborto – sulla necessità della forza e della penetrazione per definire un’aggressione. In qualche modo, questa posizione che tenta di analizzare il fatto in maniera isolata, e che richiede per definire una violenza non solo un conflitto di diritti ma anche una sconfitta fisica, impone che ci sia una persona forte e una debole. Se ricordiamo il caso di Nvenka Fernandez, ex-consigliera che nel 2001 denunciò il sindaco di Ponferrada per aggressione sessuale, risulta paradigmatica la posizione del giudice che mise in discussione la versione della donna perché, cito a memoria, “la disinvoltura con cui lei racconta mi indica che è una donna forte e mi costa immaginarla come vittima”. Sullo stesso caso, il giornalista molto moderato e progressista Raúl del Pozo, ha rilanciato così: “Mi sembra che in questa oscura storia può essere successo di tutto, però l’aggressione sessuale non è una diagnosi adeguata, né tanto meno l’abuso di potere. Lei gode del potere della bellezza che è più forte del potere di un sindaco” (“Acoso”, El Mundo 3/04/2001). Anche se significa entrare nel terreno dell’ovvietà, mi sembra, per conoscenza diretta, che uomini fragili psicologicamente e fisicamente mantengono una solida posizione patriarcale e di dominio, e allo stesso modo, credo che donne forti e intelligenti, in alcuni momenti, hanno sorvolato o taciuto aggressioni o relazioni sessuali non desiderate.
Questa nozione molto ideologica di persona forte e persona debole, proveniente dal modello di saggezza neoliberale, si combina con il mito della violenza esplicita e visibile come rappresentazione fondamentale del dominio e con il fondamento di quel discorso che intende relazionare la competitività con la parità di genere. Sono concetti fortemente radicati nell’immaginario e nelle convenzioni morali che camuffano facilmente la realtà sociale delle relazioni di potere e la visione stessa del vissuto vicino e quotidiano.
Nuova geografia per vecchie relazioni di fiducia
In continuità con quanto dicevamo e con le vecchie strutture familiari e comunitarie, quello che stiamo spiegando è fluido e assume nuove forme nel momento in cui i tempi di vita si collocano sempre più al di fuori della dimensione privata, nel lavoro, nello svago, nello spazio pubblico e nel cyberspazio.
Siamo passat* da una vita essenzialmente consumata nella “casa” in senso lato, a una promiscuità mercantile nella quale si moltiplicano le forme e i luoghi di familiarità mentre parallelamente si riducono la profondità e l’impegno. Emerge, quindi, una nuova dimensione, una zona grigia nella quale convivono la quotidianità, la vicinanza e la scarsa conoscenza reciproca: relazioni di fiducia e superficialità. Questo succede nel mezzo di una voragine competitiva e senza che si sia creata una trasformazione sostanziale delle relazioni sociali e di genere. Possiamo dire che abbiamo fatto un salto ma non abbiamo prodotto né una rottura, né una rivoluzione, né una trasformazione: sono solo cambiati gli spazi, i tempi, le tecniche e le tecnologie. In questo modo, nonostante la individualizzazione generalizzata dello stile di vita e la distruzione di numerosi aspetti dei legami comunitari, continuiamo a trovarci di fronte a relazioni di potere sociale, senza che le modificazioni dello status giuridico delle donne in generale, e l’accesso ad altri lavori o ad altre opzioni di alcune donne, abbiano cambiato le linee di continuità del dominio maschile.
Nonostante in tutti i discorsi ed in ogni tipo di retorica (pubblica, privata, istituzionale o giudiziaria) si sia affermato un determinato significato del politicamente corretto, nella realtà non c’è un dato reale e sufficiente a cui aggrapparsi per parlare della diminuzione della violenza di genere. E coloro che attribuiscono l’incremento del numero dei femminicidi per mano di partner o ex-partner o altri dati del genere, agli “ultimi e violenti” colpi di coda del vecchio machismo, si sbagliano. La storia e le relazioni di potere non sono così “progressisti” come noi.
Abbiamo spiccato un salto e siamo cadut* se possibile ancora più nud*, ma divis* dalle stesse relazioni di potere. Questo, che in linee generali è la vita sociale tramutata in guerra civile, nel campo del genere invece di indicare una diminuzione della violenza e delle aggressioni sessuali, rende più che prevedibile il suo incremento.
Testo pubblicato nel blog “mambo.pimienta.org”, 2006.
“La lotta contro il sistema che ci circonda non è più importante della lotta contro quella parte del sistema che abbiamo interiorizzato”
Kim Ve Wong
Sul genere e sui tipi “X”
(ovvero di come stiamo nella merda fino al collo)
Ciao, scrivo queste parole non per buttare tutto in caciara, ma con la sola finalità di sfogarmi e, nel migliore dei casi, se continuerai a leggere, di condividere con te la mia inquietudine e curiosità. Senza giri di parole, quello di cui vorrei parlare non è di come ci tocca il patriarcato in quanto uomini, non voglio analizzare o diffondere idee sulle quali c’è già un sacco di materiale scritto che, se ti interessa, puoi consultare. Sappiamo che funzioniamo per stereotipi che ci associano e identificano con gruppi che compongono la società (uomo, bianco, squatter, etero...) e che noi, in un ambiente così ampio com’è quello della “movida” antagonista di Barcellona, riproduciamo tantissimi di questi stereotipi stracolmi di merda con cui ci hanno allattato sin da piccoli.
La mia frustrazione, incazzatura o inquietudine, come la vuoi chiamare, nasce dal fatto di interfacciarmi con varie situazioni intorno a me che, secondo quanto ci diciamo, dovrebbero essere superate o perlomeno su cui dovremmo lavorare e che, molte volte, riproduciamo tramite i comportamenti più grevi del paraculismo classico. So di compagne e donne aggredite dal loro partner, fisicamente e psicologicamente; so di amic*, soprattutto maschi, che nascondono la proprio omosessualità; mi rendo conto che quando c’è un dibattito su sessismo o patriarcato è sempre un’iniziativa delle donne e la posizione degli uomini è abbastanza patetica; mi scontro con dinamiche che riproducono le disparità tra uomini e donne, omosessuali e etero (rimorchio, ruoli in assemblea, rifiuto dell’etichetta di frocio...), con gerarchie informali che fanno sì che abbiamo una doppia morale di fronte a situazioni differenti (credibilità in base alla persona, viscidità, molestia, aggressioni...); mi rendo conto che non abbiamo meccanismi per affrontare tutto questo e che non abbiamo neppure lo spazio e l’interesse a crearli, discuterne e trovare vie d’uscita.
Mi vengono un sacco di dubbi: quali sono i meccanismi che sviluppiamo che ci fanno pensare di avere il diritto di dire ad un’altra persona (in questo caso all* nostr* partner) quello che deve fare? Perché, in molti casi, ricorriamo alla forza o al ricatto emotivo per ottenere quello che vogliamo? Perché siamo capaci di identificare con certezza alcuni tipi di aggressioni e altre no? Perché non interveniamo con la stessa determinazione di fronte ad un’aggressione di genere o di coppia nel nostro ambiente più prossimo? Quando una persona si mette insieme ad un’altra, smette di essere una persona? Consideriamo le relazioni di coppia qualcosa di privato o come una realtà politica? Al di là del fatto che ognun* vive la sua sessualità come vuole, perché tantissimi ragazzi non fanno coming-out? Creiamo le condizioni necessarie intorno a noi affinché si sviluppi la nostra sessualità in piena naturalezza? Se vedi un amico avvinghiato ad un altro durante una festa, i suoi abbracci continueranno ad avere lo stesso significato per te?
Ok, non vogliamo riprodurre gli schemi relazionali che utilizzano i nostri padri o chi ci sta intorno, siamo i più fighi e non crediamo nella coppia chiusa o negli schemi della famiglia nucleare. Ci limitiamo a fingere una semplice contrapposizione a questi schemi, negando a noi stessi sentimenti che classifichiamo come di merda (gelosia, impegno, dipendenza...), oppure sappiamo identificarli, metterli in discussione e smazzarceli? Fino a che punto ci condizionano i “contro-stereotipi” che abbiamo sviluppato? Perché sottovalutiamo qualità che tradizionalmente vengono attribuite al genere femminile: dolcezza, cura degli altri, fragilità...? Come viene giudicato il fatto di avere necessità che consideriamo convenzionali? Senza entrare troppo nel tema, quando consideri che una relazione sessuale è soddisfacente? Quando godi? Quando gode l’altra persona? Scopare significa penetrare? No significa no o se insisto un po’...? Mi importa quello che sento o mi importa solo venire? Ci metti fantasia a letto (o ovunque scopi), giochi, sperimenti...? Se il/la tu* partner, sporadica o fissa, ti chiede: “che senti?” sei capace di rispondere o ti si innesca la miccia, inizia a sudare freddo e ti si blocca la mente? Ci mancano le parole per esprimere quello che sentiamo o semplicemente non ce lo chiediamo neanche e quindi non lo sappiamo?
Vabbè potrei continuare a porre domande, e sono sicuro che tutt* ne abbiamo tantissime altre, ma non credo comunque che la cosa più importante sia trovare le risposte. Per me, e so che sto flashando, l’obiettivo ideale sarebbe quello di essere capaci di porci insieme le domande, di creare spazi dove dibattere e sperimentare. Che facessimo un lavoro personale e collettivo, senza distinzione di genere. Che sfruttassimo al massimo la nostra capacità emotiva e sessuale. Che imparassimo a dare una risposta alle aggressioni di genere in modo chiaro e contundente. Niente in pratica.
Se ti interessa il tema ci sono una serie di libri che ti potrebbero stimolare:
“?Que hace el poder en tu cama?”.Josep Vicent Marqués. Ed. Icaria
“Nuevas masculinidades”. Vari@s autoras/es. Ed. Icaria
“XY, la identidad masculina”. Elisabeth Badinter
“Los chicos no lloran”. Sue Askew y Carol Ross
“La dominación masculina”. Pierre Bourdieu
“Gender trouble”. Judith Butler
“Queer theories”. Anamarie Jagoda.
“Tengamos el sexo en paz”, “La pareja abierta”. Franca, Jacopo y Dario Fo.
Ci sono anche una serie di autori che hanno pubblicato libri e articoli interessanti: Robert Sly, Sam Keen, Luis Bonino, Beatriz Preciado...
E c’è gente che da tempo raccoglie informazioni e archivi sul tema: basta muoversi un po’ e sicuro si trovano.
Se hai contributi, domande, suggerimenti, critiche o insulti che vuoi trasmettermi su questo scritto, scrivi una mail a de_genere@yahoo.es
Questo testo è stato diffuso nel 2004 sui mezzi di controinformazione come Indymedia e nella fanzine “Bailamos?”.
Chi ha paura dei processi collettivi?
Appunti critici sulla gestione della violenza di genere nei movimenti sociali
Il discorso sulla violenza contro le donne forma parte del discorso politico generale, implicitamente e anche esplicitamente. La violenza machista viene rifiutata da tutta la società e tutti sembrano riconoscere che è un problema politico prioritario. Ovviamente, anche i movimenti sociali accolgono queste problematiche e mostrano apertamente il proprio discorso antisessista. Fino a qui tutto bene.
Vi chiederete perché abbiamo scritto questo testo... noi ci chiediamo perché ci sono tante aggressioni nei movimenti sociali e perché c’è tanta incapacità di gestirle collettivamente. Ci preoccupa il livello di tolleranza che c’è negli spazi politici di fronte alle aggressioni e la naturalizzazione/normalizzazione di alcune forme di violenza. Ci inquieta l’incoerenza tra il discorso e la pratica e la mancanza assoluta di sensibilità; questo dimostra che è un tema assolutamente secondario, se e quando arriva ad essere considerato come tema. Ci fa infuriare che dentro i movimenti sociali ci comportiamo come se davvero le questioni che pone il femminismo fossero state assunte da tutt* e quindi già superate, ripetitive, superflue. E questo nonostante il fatto che rivendicazioni di base già vecchie di mezzo secolo continuano a rimanere nel dimenticatoio, quando le donne di tutto il mondo soffrono per vari tipi di discriminazione che opprimono la loro libertà di espressione, di pensiero, sessuale e di movimento. Ma non solo. C’è una regressione nelle pratiche collettive e nel discorso politico rispetto ad un passato non tanto lontano a Barcellona: sono pochi i collettivi femministi rimasti a dimostrazione del fatto che, ancora una volta, erano solo le donne ad occuparsi di violenza. Questa regressione nelle pratiche collettive non è un problema solo per quanto riguarda i 4 viscidi di turno: parliamo di un problema strutturale e di una questione di responsabilità collettiva.
Sicuramente, è difficile identificare le molteplici facce della violenza contro le donne, così come individuare i casi che possono essere compresi in questa categoria. È proprio questa difficoltà che permette di dire “la violenza non va bene, ma questo non è violenza”.
La violenza strutturale contro le donne non è un concetto astratto che sta nei libri, né una cosa che si trova solo nelle vite degli altri, lontana dal nostro microcosmo dei movimenti sociali. La violenza strutturale non consiste nei quattro tipi di abusi concreti di cui parlano tutti, né la somma infinita di aggressioni che ciascun* può constatare di aver subito. Non sono neanche quelle azioni perpetrate da un mostro che vessa e pugnala. L’iceberg non è fatto solo dalla punta. Stiamo parlando di dinamiche generalizzate di dominazione che attraversano l’esperienza di essere donne in tutte le sfere della quotidianità: le relazioni personali, la percezione e l’uso dello spazio pubblico, il lavoro, l’autorità riconosciuta, la percezione dei propri diritti o l’assenza degli stessi, la relazione con il proprio corpo e la sessualità, ecc.
La violenza strutturale è un meccanismo di controllo sulle donne, non solo come forma estrema, minaccia onnipresente di castigo che deve essere provocata o scatenata, ma come forma di relazione normalizzata e naturalizzata e che, quindi, può essere esercitata senza bisogno di giustificazioni.
Ma non stiamo facendo una dissertazione teorica, parliamo di casi concreti. Nell’ultimo anno ci sono state numerose aggressioni fisiche e sessuali contro donne nei movimenti sociali e una recentemente ha coinvolto una donna del nostro collettivo: uno stupro in casa nel contesto politico di Barcellona da parte di un inquilino della stessa casa, uno dei tanti. Questo tipo se ne andava in giro tranquillo per settimane, estraneo a qualsiasi tipo di risposta che si stesse organizzando per volontà di lei, perché – poverino – non era neanche consapevole di aver fatto qualcosa di male ... ma si sbagliava. Lei ha voluto rendere pubblico il fatto e metterlo all’ordine del giorno in un collettivo, con lui presente, chiedendo il suo allontanamento immediato. Non solo perché quanto avvenuto rappresenta un’aggressione nei suoi confronti, ma anche perché è una questione politica e collettiva prioritaria. Questo collettivo ha deciso che il tipo doveva allontanarsi dalla casa occupata per una scelta collettiva e politica.
Una cosa ci sembra positiva: era molto, molto tempo che non vedevamo reagire così una donna, né un collettivo, tenendo conto delle difficoltà che si presentano nell’affrontare in gruppo queste situazioni. Ci sentiamo molto soddisfatte del fatto che questa aggressione non sia stata taciuta come tante altre e abbia ottenuto una risposta. In tal senso, questo caso è un’eccezione. Tuttavia, a partire da questo, sono successe molte cose, cambiamenti di discorso, di posizionamento e di decisione. Col passare del tempo, ciò che all’inizio è stato considerato come politico è finito per essere relegato all’ambito dei conflitti personali. Sette mesi dopo, è stata presa la decisione di far rientrare il tipo negli spazi pubblici della casa. Oltre a questa decisione discutibile, quello che ci sembra grave è il processo per il quale si arriva ad un risultato del genere, simile a tanti altri casi.
Il fatto che i gruppi (anche se solo una minoranza di essi) tentino di trovare una risposta ai casi di violenza che si producono al loro interno, presuppone una passo avanti nella riflessione, la gestione collettiva e lo sradicamento della violenza. Notiamo però che, in linee generali, a causa della mancanza di profondità e sensibilità alle quali facevamo riferimento, le risposte che i collettivi misti tendono a dare sono basilari e spesso soffrono di alcune problematiche che minano il processo stesso. Parleremo qui di tre problematiche che ci sembrano particolarmente gravi:
-
il primo, più ricorrente e influenzato dal modo mainstream di trattare il tema, consiste nel dare ai casi di violenza contro le donne la connotazione di problema privato e personale, da risolvere a due. Quando ciò che viene denunciato come aggressione viene affrontato come una questione personale nella quale intervengono emozioni, o viene letto come una vicenda torbida in cui non c’è una verità ma due percezioni distinte di una stessa situazione confusa ecc., allora perdiamo la possibilità di fare politica, che, in fin dei conti, è quello di cui parliamo quando ci riferiamo alla violenza machista. Ci sono poi modi di spostare il tema su di un piano personale anche nell’ambito di una gestione collettiva. Per esempio, quando un’attività collettiva viene presentata come qualcosa che si fa per la “vittima” e non come un compito che il collettivo necessita per sé; quando l’intervento del gruppo viene definito come una forma di mediazione fra le “parti coinvolte”; o quando il problema viene definito come una questione interna al collettivo da risolvere a porte chiuse, ovvero la versione collettiva della logica per cui i panni sporchi si lavano in casa. In altre parole, collettivizzare non è una condizione sufficiente per fare politica. Quando prendiamo decisioni o posizionamenti politici, c’è sempre la possibilità di ricevere critiche o suscitare discussioni. Di fatto, sono molte le questioni che rimangono aperte nei movimenti sociali a Barcellona. Ma di fronte alle situazioni di gestione collettiva della violenza contro le donne, si alzano muri contro le opinioni, le critiche e le sollecitazioni esterne; si cerca di mantenere il problema al di fuori del dibattito collettivo. Che succede? Perché c’è così tanta paura del dibattito? Non sarà una fobia insana verso le femministe? O sarà che non lo stiamo neanche classificando come tema politico?
-
Il secondo problema della gestione da parte di collettivi non femministi dei casi di violenza contro le donne consiste nel lavorare a partire dallo schema ingannevole vittima-aggressore, proprio della cronaca dei fatti. In base a tale schema, c’è un aggressore, che è l’uomo cattivo, il mostro, l’eccezione; e una vittima, che ha bisogno di aiuto. Quando la persona che ricopre il primo ruolo, è un amico o un compagno, abbiamo molte difficoltà ad “attribuirgli questa etichetta”, paura di “demonizzarlo”, anche perché questo schema si pone come un giudizio integrale su quella persona. Ma chiamiamo le cose con il loro nome: aggressione è il termine che descrive il fatto, aggressore colui che la commette. Fare questo non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile né un’opzione riduzionista che neghi altre sfumature che una persona può avere. Per questo, è molto peggio utilizzare eufemismi e relativismi. Per paura di chiamare le cose con il loro nome, cerchiamo “altre spiegazioni” e addirittura giustificazioni, tipo “stava ubriaco/fatto”, “lei provocava, o se l’è cercata”, e mettiamo anche in discussione il livello di responsabilità dell’aggressore per le sue azioni, ecc. Come conseguenza del non funzionamento dello schema, tendiamo a perderci in giudizi dettagliati sui fatti, come se lì risiedesse la soluzione. Si sposta la discussione su fattori esterni o dettagli morbosi dei fatti invece di affrontarla a partire dalla comprensione della componente strutturale della violenza contro le donne e dalla necessità di conservare una tensione e attenzione costante per non riprodurla. Altrimenti, perché quando il caso concreto ci tocca da vicino, i principi che in altre circostanze sono indiscutibili svaniscono?
Il secondo ruolo in questo schema è quello della donna aggredita, situata in una condizione di incapacità: tutte quello che dice o fa la “vittima” verrà letto come una reazione emotiva, come nervosismo, impulsività e vulnerabilità. I comportamenti paternalisti e protettivi verso colei che ricopre il ruolo di vittima ostacolano la sua partecipazione al processo collettivo su un piano di uguaglianza. Quindi, riconoscere la natura strutturale della violenza machista significa creare le condizioni necessarie per evitarla, e in ultima istanza responsabilizzarci quando succede intorno a noi. Però spesso non si capisce perché assumersi questa responsabilità voglia dire spianare la strada alla possibilità di riconoscersi nei panni dell’aggressore: questo timore genera strategie deplorevoli di corporativismo maschile per le quali i compagni mantengono il silenzio per paura che le loro teste cadano insieme a quella di colui che viene segnalato apertamente in quel momento.
Infine, nella gestione collettiva pratica delle aggressioni contro le donne ci troviamo di fronte ad una gerarchizzazione di interessi tacita e, quindi, una subordinazione di tutto ciò che ci riguarda, come donne. Quando la priorità viene riconosciuta al consenso, in un gruppo nel quale la metà della persone non ha sviluppato preliminarmente una riflessione propria e il cui discorso passa per semplificazioni precotte tipiche di un telegiornale qualsiasi, e, inoltre, queste opinioni vengono messe sullo stesso livello di discorsi fondati e sensibilità sviluppate a partire da un lavoro precedente, allora ci lasciamo trascinare dalla tirannia del mediocre che riuscirà a sminuire le argomentazioni e affossare il discorso ad un livello minimo. Concatenare parole magniloquenti non significa articolare un pensiero elaborato. Il consenso qui esposto svolge due funzioni: mantenere una certa coesione nel gruppo e dare una parvenza di legittimità alle decisioni. Di fronte al rischio di un conflitto si acutizzano i ruoli di genere prestabiliti, che per donne significa assolvere alla funzione di mediazione, pacificazione, comprensione. Paradossalmente ci rendiamo conto che altre donne si comportano dando priorità all’unità del collettivo e al consenso mediocre; come se l’aggressione a una di noi non fosse in realtà un problema di tutte. Questo a sua volta rende evidente quanto profondamente siano radicate le forme eteronormative nel nostro agire: la definizione di ciò che è pubblico e politico segue i canoni dell’universale maschile, e le donne assumono discorsi costruiti in questa chiave e presentati secondo questa logica, smettendo in tal modo di politicizzare questioni che ci riguardano per non annoiare o non essere al centro dell’attenzione, perpetuando così la smania di approvazione tramite lo sguardo maschile e le forme di relazione tra i sessi. Di nuovo ci hanno fregate e ci dedichiamo a cooperare perché niente cambi. Come dicono le femministe da decenni, è necessario rendere politiche le questioni che ci riguardano in quanto donne, e non solo a parole o come postilla. Se scommettiamo sui collettivi misti, poniamo al centro queste questioni dando loro l’importanza che meritano. In continuità con quanto detto prima, i collettivi che si accollano di gestire una situazione di violenza di genere devono rendere pubblico il loro posizionamento e permettere il dibattito affinché serva come precedente e produca un’accumulazione di esperienze (per non partire sempre da zero). In caso contrario, continueremo a privatizzare, rimanere sul teorico e praticare una pseudo-politica dell’autoconsumo.
Alla fine, che faremo rispetto a tutti questi temi? Il peggio del sessismo si riproduce nei movimenti sociali, ma non ci stiamo assumendo la responsabilità collettiva di gestire adeguatamente la violenza di genere. È evidente, quindi, la necessità di collettivi femministi e di raccogliere il lavoro e i contributi che questi gruppi stanno portando avanti.
LasAfines
Contributi e commenti al: lasafines@hotmail.com
Testo pubblicato nel blog mambo.pimienta.org, 2007
Spazi occupati, spazi di cura
A proposito di un’aggressione sessuale nel centro sociale occupato El Laboratorio (Madrid)
Tutte viviamo con rabbia e dolore la violenza che gli uomini impongono alle donne come conseguenza di questa divisione che fonda e gerarchizza il mondo dei due sessi. Le aggressioni contro le donne connotano il sistema di dominio ben oltre la dimensione delle relazioni personali e delle restrizioni che ogni società e ogni gruppo pone nelle mani dei machi. Che si tratti di aggressioni fisiche o psicologiche, in forma di schiaffi, stupri o molestie, o che sfoci in un femminicidio, nell’umiliazione o nell’autodifesa, la violenza consolida il potere e lo localizza nei nuclei più sensibili dell’esperienza: l’integrità del corpo, la libertà sessuale e l’autonomia di movimento e pensiero. Sono rare le donne che non ne abbiano sofferto o sulla propria pelle o per essere intervenute contro un’aggressione diretta ad un’altra donna.
Il sentimento di vulnerabilità e di dominio è un’esperienza che appartiene al quotidiano di ogni donna, innanzitutto, come percezione dei limiti e della protezione del proprio corpo e della sua capacità espressiva. Anche se è relazionata all’età, allo spazio, all’identità, alla situazione e anche al senso di sicurezza che ciascuna esprime o smette di esprimere, in realtà, la possibilità di essere sottoposta alla violenza machista trascende le circostanze concrete e si estende all’esistenza in quanto donna in generale. È così radicata nel nostro essere che anche se potessimo inserirci in altre coordinate continueremmo ad alimentarci di questi timori che risiedono in noi. Nessuna ha smesso di fare propria questa condizione di pericolo e abbiamo imparato a conviverci, a sopportare nel modo meno traumatico possibile le sue leggi e a godere delle misere vittorie personali e collettive che ci possiamo permettere senza esporci a situazioni di alto rischio.
Non possiamo smettere di considerarla come un’imposizione generalizzata e per lottare contro di essa dobbiamo stroncarla nel concreto e parlare delle sue facce negli spazi che frequentiamo e nei momenti a cui partecipiamo. L’intervento della donna, femminista o meno, in un Centro Sociale Occupato cerca, tra le altre cose, di creare uno spazio sicuro, uno spazio di cura del proprio corpo che annulli la violenza e l’interiorizzazione del pericolo sessuale. E lo cerca non attraverso regole, restrizioni o dispositivi di controllo ma come sentimento, sensibilità, attitudine di tutte le persone che lo abitano. Per questo, la cosa più terribile delle violenze che si verificano in questi posti, oltre al vissuto di chi la subisce, è la sensazione di tutte non rispetto al fatto che queste cose succedano – questo già lo sappiamo – ma che non si sia generato un comportamento, un modo di pensare e di agire che le renda rare. Che non siamo state capaci di mettere avanti questa disposizione, la tensione collettiva e quotidiana che fa sì, da un lato, che gli aggressori percepiscano immediatamente che in quel luogo non c’è agibilità per loro e che rischiano di uscirne male; dall’altro, che le donne arrivino a percepire l’esatto contrario, ovvero che in quel luogo possono sentirsi sicure e sostenute in ogni momento.
Non serve a niente ripetere che gli spazi non sono realmente liberati o che nelle occupazioni vengono riprodotti gli stessi modelli ecc ecc. Continuare a parlare in questi termini produce un paradosso sterile che si alimenta dell’illusione della liberazione che si scontra con la triste e arcinota realtà, con la denuncia che arriva sempre quando è passato il momento dell’autodifesa e con il ripartire sempre da capo. Oltre a ribadire la morale per cui niente è quello che sembra e ad aggrapparci alla marginalità dei nostri problemi all’interno del collettivo, questo spostamento del linguaggio non serve a niente. Depotenziare la peculiarità di uno spazio e compararlo a qualsiasi altro luogo non ci dà l’opportunità di costruire questa differenza in maniera più dinamica, uscendo dalla dicotomia tra spazi liberati, ovvero luoghi utopici inesistenti per tutte quelle persone che vivono fuori dal mondo, e il resto del mondo, una totalità uniformata fatta di case, strade, città e paesi dove niente cambia.
Per iniziare, è necessario ideare forme concrete con le quali comunicare questo senso di cooperazione verso la libertà sessuale senza consigliare alle donne di andare in giro in gruppo e evitare i posti bui. Si dovrà, inoltre, forzare l’esistente e mettere in discussione l’abitudine.
La visibilità femminile e lgbt è un punto di inizio ma non basta. Inoltre, per diventare presenti è necessaria una certa complicità: non possiamo trattare tutto con i guanti o frequentando spazi liberati che liberati non sono. La creazione di questo sentimento passa necessariamente attraverso la cura delle situazioni che creiamo.
Questi discorsi nascono dall’aggressione-stupro subito da una ragazza poco tempo fa durante una festa a El Laboratorio che è passato, senza infamia e senza lode, alla storia degli incontrollabili orrori a cui ci siamo abituate. Affinché un centro sociale sia differente dalla strada (il suo obiettivo sarebbe quello di trasformarla la strada) si dovrà iniziare a pensare che non può entrarci tutto il mondo. Che non vogliamo essere compatibili con certi soggetti che a volte, purtroppo, ci sono troppo vicini. Chiaramente le buone modalità, per quel che concerne il rapporto tra centri sociali e antisessismo, si possono imparare e praticare in maniera più tranquilla senza alzare muri ma, comunque, chi agisce in un certo modo deve sentirsi scomodo, fuori luogo o terribilmente spinto al cambiamento.
E dato che questa aggressione è avvenuta durante una festa, parlerò proprio delle feste, e con particolare rabbia, perché, in quanto atto collettivo creato per divertirsi, le vedo come l’esempio più chiaro di un sacco di cose che mi fanno incazzare e che non hanno niente a che vedere con il tipo di luogo-situazione nella quale amo stare. Non che tutte le feste, concerti ecc. siano uguali (sarebbe bello domandare, soprattutto alle donne, che cosa succede nelle feste nelle quali non ci sentiamo a nostro agio) però è vero che abbiamo cristallizzato certe abitudini nelle feste nelle quali manca qualsiasi attenzione per quello che succede. Nella festa in questione, organizzata dal Progetto Ruido fortunatamente naufragato, ad eccezione delle pasticche e della decorazione allucinante, niente ha meritato particolare preparazione o attenzione. Dato che la festa era gratis non c’era nessuno all’ingresso, non tanto a controllare chi entrava ma ad esprimere quell’attenzione di cui parlavo prima: che ci sia gente lucida in mezzo alla folla in grado di rispondere o organizzare una risposta di fronte ad aggressioni o anche a cose meno gravi. Comunicare, in poche parole, che in quella situazione c’è un gruppo di persone interessate a quello che succede e che non si limita a crearla la situazione e vedere che succede. Se non siamo responsabili di quello che organizziamo o lasciamo che ad organizzare siano collettivi esterni, di che ci spaventiamo? E se pensiamo che non sia possibile, perché organizziamo cose? È molto duro stare tutto il tempo a osservare le mille forme in cui qualcuno può mancare di rispetto e non possiamo avvicinare qualsiasi persona che potrebbe essere vittima di un abuso... ma non quando un abuso si è già cristallizzato come questione individuale (ognuna se lo risolva come può e con chi vuole) per non dire normale. Le conseguenze del lasciare che le cose succedano già le conosciamo, perlomeno nel Laboratorio. C’è gente che si è stancata o sentita sola nello scontrarsi con casini di tutti i tipi, però neanche questo è stato sufficiente a dare una svolta e mettere la questione al centro dell’attenzione per recuperare in questo modo uno spazio che mano a mano si era perso nell’aneddotico.
Ci siamo abituate alle feste senza fine, perfettamente in sintonia con l’agonia che ci spinge a consumare i momenti senza riconoscere un principio e una fine. A nessuno va di tenere gli occhi aperti o mettere fine a quello che siamo stat* bravissim* ad iniziare. Invece di mettere fine a questa storia, si preferisce vedere le persone sparire a poco a poco per sfinimento o accoppiandosi in un angolo. Se le cose stanno così, la festa diventa l’attività più sacra del centro sociale. Poche cose possono interromperla: non basta che ci si prenda a testate, né che venga aperta la testa a qualcuno, né che una donna finisca in ospedale. È abbastanza paradossale che le persone che vanno alle feste non si rendano conto di quello che succede per quanto sia eclatante, come ad esempio una persona che sanguina in mezzo al cortile o con un attacco di panico. In questo senso, siamo arrivat* al punto che la festa risulta incompatibile con la possibilità di comunicare, di decidere ed agire collettivamente. Perché ciò sia possibile, dovremmo spegnere la musica ed interrompere l’iniziativa, cosa che causerebbe uno stato di allarme inutile.
Un’altra questione riguarda il modo in cui si affronta il consumo di sostanze. Abbiamo generalizzato la tesi per la quale c’è gente che va alle feste fatta e non si rende conto di niente e più sta fatta più diventa idiota. Mi rifiuto di credere che quando una persona sta fatta non percepisca quello che succede, bensì il contrario, lo percepisce e con una nitidezza che fa paura perché la visione diventa più rapida, si affina, tanto che si diventa capaci di leggere i movimenti impercettibili, i gesti, i comportamenti che esprimono forme di relazionarsi al mondo: la paura, l’impotenza... Per molte donne questo è molto chiaro ed è il motivo per cui a volte quando prendi qualcosa proietti e sperimenti le aggressioni sessuali anche impercettibili. A volte abbiamo preferito non guardare in una certa direzione, ma non per questo abbiamo smesso di vedere. E visto che, in ogni caso, ci vediamo, a questo punto è meglio farlo bene. Sappiamo quanto fanno male le bugie che ci raccontiamo... quando non si può o non si vuole o non ci si crede capaci di capire quello che succede intorno a noi, si dovrà contare sul contatto, a meno che non si preferisca contare sulla stupidità e a quel punto non ci sarebbe molto altro da aggiungere.
Se questa è l’abitudine, si dovrà intervenire a gamba tesa perché la denuncia a posteriori non è sufficiente: potrà lasciarci un sapore migliore in bocca ma non incide su quello che può succedere dopo. Un altro passaggio da rendere possibile è l’attenzione nei confronti della donna che ha vissuto l’aggressione. Anche su questo abbiamo fatto poco, soprattutto per capire e apprendere come si può sperimentare un’aggressione. Per fare questo è necessario partire dal fatto che un’aggressione è un’aggressione e punto e non aver paura dello scambio e dei fantasmi. Quando si verificano aggressioni bisogna creare gruppi di sostegno, di intermediazione che seguano la vicenda perché una volta avvenuta l’aggressione, chi l’ha subita continua a farsi vedere in giro e ha molto da metabolizzare. Assolutamente non invisibilizzare ma sapere, capire come si sente la persona aggredita, come definisce la violenza e agisce contro di essa, contro la violenza del momento e contro quella dei momenti successivi. Stare al passo e rispettare le esigenze di chi la vive. La mediazione con la collettività, ovvero col Centro sociale, è importante come esercizio contro l’oblio e per l’azione in positivo, per recuperare uno spazio maledetto che non si ha più voglia di attraversare.
Ripensare le definizioni a partire da quest’atteggiamento di ascolto e scambio, può permettere di far emergere alcuni stereotipi interessanti sulle aggressioni sessuali. Per esempio, cosa succede quando per la donna aggredita la priorità non è la violenza in sé ma il pericolo di morte, o quando la reazione passa per strategie di autodifesa così intelligenti e spontanee, come fingere sottomissione e accondiscendenza di fronte ad una violenza smisurata. In quel caso, continuiamo a parlare col nostro linguaggio o proviamo a tracciare una connessione reale con la violenza e i termini di chi ha molto di più da dire? Sarebbe bello mettere in comune le soggettività che entrano in gioco in tutto questo.
E ancora. Perché si chiede se davvero si è trattato di violenza e si insiste, come donne, che sì, che quello che è successo è il peggio che poteva succedere? Probabilmente perché con la forza delle parole si è stabilita una scala dei livelli di aggressione che trova nella penetrazione il suo punto massimo e che dovremmo ridefinire, anche per noi stesse. In questo modo potremmo evitare che quello che succede venga inevitabilmente sminuito senza renderci conto che utilizziamo inconsciamente le classificazioni e le definizioni in uso. Urliamo che il sentimento di vessazione più terribile non sempre coincide con la penetrazione e continuiamo a perpetuare i miti? Per avanzare in questa direzione è necessario coinvolgere e coinvolgersi con la donna aggredita.
E ancora, come decostruire una volta per tutte l’idea secondo la quale è compito nostro combattere contro questa questione, affermando chiaramente qual è la nostra area di intervento in un centro sociale misto? Ovviamente ci tocca da vicino, così come ci tocca la collettivizzazione di un comportamento distinto che potrebbe far sì che le aggressioni sessuali diventino una priorità di tutto il centro sociale, qualcosa che merita la massima attenzione e azione comune. La nostra decisione, come donne, di separarci e di accumulare iniziative su questo tema ha molti vantaggi ma anche svantaggi nel momento in cui si cerca di creare una pratica comune contro il sessismo e le aggressioni sessuali. In particolare se non si prevede e non si tiene in conto la parzialità alla quale riduciamo, noi per prime, la violenza contro le donne. La migliore autodifesa, oltre a quella per permettere di trasformare l’autostima in colpi sicuri, è quella che genera una spinta collettiva contro le aggressioni sessuali. La prima, l’autodifesa del colpo, ti difende, l’altra pone te, le tue compagne e la comunità in uno spazio differente.
ATTENZIONE AGGRESSORI, DONNE VIOLENTE!!
dalla Escalera Karakola, una ex compagna del CSO El Laboratorio
Lettera per un dibattito sulle aggressioni sessuali
Lo stato delle cose
L’aneddoto
Nel mese di febbraio-marzo, una donna di Cornellà de Llobregat è stata aggredita dal suo compagno, Fidel Salvador Sanchez. Era l’ultima aggressione, dopo una serie di minacce, intimidazioni e pedinamenti da parte del ragazzo. Questa volta, si è presentato al bar dove la donna stava bevendo una cosa con un’amica, le ha chiesto di uscire per parlare e, dopo aver discusso, l’ha picchiata. Lei ha deciso di denunciare l’aggressione, dopo essere andata all’ospedale per farsi fare il referto.
Il processo è iniziato il 24 maggio ed è stato triste e patetico come quelli di tutte le donne maltrattate dallo Stato. Per fortuna, era stato convocato un presidio e la ragazza è stata accompagnata da un gruppo di persone con uno striscione contro le aggressioni machiste e volantini informativi sui fatti. Ma ha incontrato l’aggressore sulla strada per il tribunale, ha dovuto aspettare un’ora in sua compagnia – con la tensione che questo comporta – e ha dovuto dichiarare e condividere il banco degli imputati con lui.
L’atteggiamento del ragazzo è stato di continua provocazione nei confronti di lei e delle circa 20 persone che la sostenevano. Non solo non ha riconosciuto l’aggressione ma l’ha giustificata con un raptus di rabbia, levandole importanza. In più, ha gridato alle donne riunite in presidio che ha incontrato e ha minacciato il ragazzo che diffondeva i volantini.
Il lunedì successivo, il tipo si è presentato all’assemblea dell’Ateneu de Cornellà fatto di cocaina e, dopo aver gridato e insultato tutti, ha minacciato con un martello una delle nostre assistenti per il processo. Durante le settimane seguenti ci ha sorpreso molto scoprire che alcuni ragazzi vicini a noi avevano contatti con lui, fino al punto che è entrato in uno spazio liberato.
La nostra posizione
Questi fatti e il resto dei patetici dettagli della vicenda, sono arrivati alle persone che hanno dato supporto alla donna aggredita – perlopiù donne – e ci hanno fatto sentire doppiamente arrabbiate: da un lato, minacciate dall’aggressore, dall’altro, messe in discussione e negate quando sono entrati in gioco un mucchio di commenti, critiche per aver optato per la via giudiziaria, speculazioni sulla relazione tra l’aggressore e la donna, falsità...tutto finiva col giustificare l’ingiustificabile e con la depoliticizzazione del dibattito, mettendo in discussione la decisione della ragazza e la risposta solidale. Le donne di Sants i Cornellà e molte altre che si sono aggiunte successivamente, si sono viste forzate a esigere una presa di posizione e a chiedere spiegazioni del comportamento di alcune persone negli spazi dove è esplosa questa merda.
In alcuni casi, questo è servito affinché le persone che avevano dei dubbi riflettessero e capissero di aver sbagliato. Però non volevamo che la storia si riducesse alla versione che ne davano nelle chiacchiere da bar o si fermasse al collettivo direttamente implicato (dove è stato fatto lo sforzo di parlare e analizzare a fondo la questione). Questa è la versione più “descrittiva” e libera dalla rabbia che siamo state capaci di scrivere. Ci siamo volute risparmiare i nomi e i commenti più pesanti per entrare a fondo nella riflessione che abbiamo portato avanti – uomini e donne – a partire da storie come queste, perché crediamo che è ciò che REALMENTE DOBBIAMO DISCUTERE.
Troviamo pessimo il fatto che si sia messa in discussione la decisione della donna di sporgere denuncia. Questa è la sua decisione e punto. Se ha denunciato è perché si sentiva sola, perseguitata e in pericolo. Infatti, molte persone sapevano dell’aggressione avvenuta e molto poche hanno fatto qualcosa fino al giorno del processo.
Una delle cose che hanno suscitato polemica è quella di aver fatto ricorso alla via giudiziaria per risolvere un problema, quando nessuno riconosce o crede nella giustizia penale e borghese.
Innanzitutto, pensiamo sia stata la scusa politica a cui si sono aggrappati coloro che hanno messo in discussione la decisione della donna e le dimostrazioni di solidarietà. Vogliamo mettere in chiaro che è una contraddizione di cui siamo coscienti, ma è una delle vie che abbiamo a nostra disposizione per fare fronte alle aggressioni machiste e di molti altri tipi. Perché questa non è né la prima né l’ultima volta che ci si è serviti del sistema giudiziario: denunce a nazi, alla polizia, contro gli sfratti illegali, ecc. Ma si fanno due pesi e due misure in base a chi si porta a giudizio.
Abbiamo molto chiaro che lottiamo affinché le risposte a queste aggressioni siano sociali. Se avessimo lavorato a fondo su questo tema, lo renderemmo pubblico, trascendendo la sfera del privato, della coppia, del gruppo di amici, delle voci e dei pettegolezzi. L’isolamento è una strategia che tenta, come minimo, di far sentire l’aggressore di aver fatto qualcosa di orribile e che, se non se ne rende conto, non avrà nessuna copertura. Molte donne sono morte per mano dei loro (ex) compagni perché le persone non pensano a reagire in tempo o in alcun modo. La risposta sociale implica anche offrire alla donna un supporto reale, accompagnarla, trasmetterle sicurezza e fiducia, copertura fisica ed emotiva. L’isolamento non è l’unica via, ma dipende soprattutto dall’atteggiamento dell’aggressore nel prendere coscienza di avere un problema e volerlo risolvere. Non vogliamo accanirci con questo tipo nello specifico, ma il suo comportamento, con i fatti, è stato abbastanza chiaro. Ci sembra molto significativo che per ripulirsi l’immagine e mettere in discussione la donna e il sostegno a lei, lui abbia cercato la complicità di altri uomini. Nella mente di questo omuncolo le donne non hanno credibilità e, quelle che ci mettono la faccia, vengono minacciate perché si credono più forti. Gli uomini, invece, li vede come pari, con i quali sviluppare un linguaggio cameratesco e risolvere i problemi di fronte a una birra, “da uomo a uomo”.
Ci ha fatto male che uomini che sentivamo vicini abbiano optato per la sua modalità e non abbiamo adottato un atteggiamento di rifiuto nei suoi confronti fino a che non abbiamo chiesto loro spiegazioni. Pensiamo che si possano evidenziare dubbi e contraddizioni sul boicottaggio collettivo senza giudicare troppo quello che la gente pensa e sente. Pensiamo che alcune persone si siano attaccate alle contraddizioni senza affrontare la questione essenziale: che il sessismo e le aggressioni machiste non sono vissute allo stesso modo da uomini e donne . Spesso, come donne, ci sentiamo toccate e ci mobilitiamo: ci mettiamo più facilmente nella pelle di una donna aggredita, violentata, minacciata o molestata, o perché ci siamo passate o perché siamo consapevoli di vivere in un corpo esposto a tali atti.
Vogliamo esprimere anche la nostra rabbia verso la responsabilità collettiva di questo tipo di aggressioni. Da un lato, vogliamo dire che non vogliamo che dipenda esclusivamente da noi che Fidel venga effettivamente isolato socialmente. Non vogliamo né fare le guardiane, né che la gente partecipi al boicottaggio perché lo diciamo noi. Vogliamo una presa di coscienza collettiva e reale. Niente di più e niente di meno. Dall’altro lato, ci hanno criticato per come è stata riportata la storia, specialmente per il fatto che si sia ridotta solo ad alcune donne. Per ogni altro tipo di aggressione (dei fasci, dei nazi, della polizia) la gente si organizza rapidamente, chiama e smuove cielo e terra per dare una risposta immediata, collettiva e organizzata. Anche se il fatto non è successo nel nostro giro più stretto, l’informazione circola rapidamente e ci sentiamo coinvolti. È meglio dare una risposta con delle contraddizioni che non darne nessuna.
Infine, apprezziamo che la rabbia che ha portato sia alla denuncia di un’aggressione machista sia alle dimostrazioni di solidarietà, abbia fatto emergere l’immaturità del discorso e, soprattutto, dell’azione collettiva rispetto alla lotta femminista, antisessista o come vogliamo chiamarla.
A Cornellà hanno diffuso un comunicato con la conclusione dei fatti: le persone si riempiono solo la bocca di parole. Più chiara, l’acqua.
Chiediamo che questo contributo fatto da alcuni collettivi di donne venga portato all’interno della discussione dei collettivi e che questi diano un qualche tipo di risposta: che sia apprezzandolo e quindi posizionandosi al rispetto o dando alcun tipo di alternativa.
Per farlo rivolgetevi al cso HAMSA (les tenses) o all’ateneo di Cornellà (donne di corneyà).
L’oppressione “al contrario”
Amigo Vespa
Mi piacerebbe parlare del tema dell’oppressione “al contrario”, nella quale credono alcuni anarchici, nonostante non esista.
Un giorno stavo parlando con due anarchici di Barcellona sui gruppi non misti di donne. L’occasione nasceva dal fatto che questi anarchici avevano ricevuto la proposta di un gruppo anarcofemminista di fare i loro allenamenti di autodifesa nel centro sociale occupato e gestito da loro. Rimasi molto sorpreso nel sentire la tesi per cui un gruppo di autodifesa di sole donne è sessista.
Una delle argomentazioni consisteva nel fatto che essere un gruppo non-misto costituisce una discriminazione contro gli uomini, e quindi sessismo; un’altra argomentazione era che, come anarchici, rifiutiamo il genere e tutte le categorie imposte e che le forme di organizzazione esclusiva di questo tipo rafforzerebbero il genere; oltre all’idea per cui le femministe odiano gli uomini e vogliono solo il potere (voglio sottolineare che queste due ultime argomentazioni non sono venute fuori lì per lì, e che non ho capito proprio tutto quello che si diceva; le cito perché questa critica è diretta a idee e non a persone specifiche). È stata una sorpresa per me sentire questi discorsi, dato che nel mio paese mi sono abituato ad ascoltarli da personaggi di destra (nonostante il mio paese non sia un paradiso di libertà e radicalità), invece qui mi arrivano dalla bocca di un compagno.
Rispetto al tema della discriminazione contro gli uomini direi che è un’analisi debole, quasi come opporsi al capitalismo solo perché le classi popolari soffrono una discriminazione. Le cose stanno molto peggio. La preoccupazione per la discriminazione è propria del razionalismo, tra l’altro perché alcune discriminazioni diminuiscono l’efficienza dell’economia. Funzionari di governo, che non ammettono mai l’oppressione sulla quale si basa il loro sistema, parlano di discriminazione e di come correggerla, senza menzionare le cause strutturali e la storia di quella discriminazione. Il problema è più profondo di quanto esprima questa parola. Ovviamente il patriarcato è una struttura e una cultura forte e insidiosa. È una gerarchia. Non esiste il sessismo “al contrario”. È possibile che esistano femministe che odiano gli uomini (anche se non ne ho mai incontrata una), ma sarebbero sentimenti generati dall’individualità, che non possono invertire una gerarchia potente, che non possono sottomettere gli uomini alla violenza quotidiana diretta contro le donne da millenni di patriarcato e soprattutto non sono sessismo. La reazione immediata degli uomini contro il femminismo credo provenga dalla paura di essere censurati, di perdere alcuni privilegi e comodità. Ma come uomini abbiamo anche molto da guadagnare dalla lotta contro il patriarcato.
Rispetto alla seconda argomentazione, sono d’accordo con la necessità di abolire il binarismo di genere. Ma come farlo? Non è né una lotta facile, né breve. Esiste un’eredità di disuguaglianza e di dolore creata da tutti i sistemi di oppressione, compreso il patriarcato. Siamo tutt* condizionat*, dalla nascita. Un risultato di questo è che spesso come uomini non sappiamo come esprimere i nostri sentimenti, la nostra sessualità risulta compromessa, ci insegnano a ferire e a oggettivizzare. Potremmo trarre un enorme beneficio dal partecipare a gruppi di soli uomini, per discutere della nostra socializzazione che ci danneggia.
Un altro dei tanti risultati del patriarcato, è che le donne non si sentono motivate ad imparare l’autodifesa o a usare la violenza fisica, nonostante subiscano tante violenze e minacce dalla nostra società. E spesso, nei gruppi di autodifesa misti, esiste la sensazione invisibile di stare nel territorio degli uomini, e quindi, anche senza esclusioni o riferimenti espliciti al genere, si possono escludere le donne. Se diciamo che il genere è una categoria opprimente e per questo non parliamo del genere, non agiamo contro i suoi risultati che “non vediamo”, ci riduciamo a proteggere l’eredità del patriarcato.
Abbiamo bisogno di affrontare l’abolizione del patriarcato come fine in sé stesso, come un sistema di oppressione incompatibile con la libertà. Non sparirà con l’abolizione dello stato o del capitalismo. Infatti, il patriarcato ha molti più anni rispetto a questi altri sistemi. Non è una tesi nuova né liberale (alcune persone apostrofano il femminismo come “liberale”). Durante la guerra civile, gli uomini della CNT [Confederación Nacional del Trabajo, una confederazione di sindacati anarchici spagnoli] dicevano che il sessismo sarebbe sparito con la rivoluzione (Marx ha argomentato la stessa bugia in relazione allo stato). Fortunatamente, donne come Lucia Sanchez Saornil non li ascoltarono, e diedero vita al gruppo “Mujeres libres”. Questo gruppo pubblicò una rivista, creò scuole e insegnò alle donne come usare le armi, per combattere il sessismo del movimento e il fascismo. E rappresenta una vittoria il fatto che dentro una società così patriarcale, migliaia di donne ottennero la fiducia necessaria in loro stesse per lottare contro gli uomini, convertirsi in guerrigliere, uccidere i fascisti. La rivoluzione era così forte che alcune anarchiche si scontrarono con il sessismo esistente dentro al movimento e crearono spazi comodi e sicuri.
Non dico che tutte le donne abbiano bisogno dei propri spazi (né che sia una necessità o che rappresenti una caratteristica di tutte le donne o di tutti gli uomini), né penso che le donne che vogliono avere il proprio gruppo di autodifesa, lo vogliono perché non sono capaci di scontrarsi con gli uomini (per una supposta debolezza o svantaggio fisico). Le donne hanno una storia di lotta forte e violenta. Ma se alcune donne esprimono la necessità di avere un proprio gruppo di autodifesa o qualsiasi altra cosa, dovremmo rispettarlo, lasciandoci guidare da sentimenti di solidarietà e confidando nel fatto che la persona che soffre un’oppressione sa meglio di chiunque altro quello di cui ha bisogno per combatterla.
Un’aggressione è quando mi sento aggredit*
Se mi sento aggredit*, reagisco come mi pare. In una situazione di aggressione la cosa che voglio reprimere è l’aggressione e non la reazione. Se mi sento aggredit* non voglio sentirmi sol* per il fatto che è la prima volta che mi trovo in un posto o perché non conosco nessuno o poche persone o per paura che non mi sostengano ecc.
E nel collettivo? Come funziona?
Non vogliamo essere il/la “macho” protettore/protettrice ma non vogliamo neanche usare questo come scusa per non fare niente. Non vogliamo guardare dall’altra parte quando ci troviamo di fronte ad un’aggressione. Un’aggressione non è solo una questione tra chi aggredisce e chi è aggredit*. Ci siamo anche noi! Vogliamo divertirci senza far finta di niente! Gli spazi “liberati” non sono liberi da aggressioni.
Questo volantino è stato scritto dalla Asamblea de Género ed è stato distribuito, insieme al flyer che trovate nella pagina successiva, ai centri sociali e agli spazi politici con la richiesta di appenderli in posti visibili. Barcellona, 2004
Gli spazi liberati non sono liberi dalle aggressioni.
È molto difficile smettere di vivere secondo valori, attitudini e comportamenti che abbiamo interiorizzato come fossero normali. Per farlo è necessario pensare, discutere, mettersi in discussione, a livello personale e collettivo. Creare un discorso, che è difficile da sostenere, che a volte fa male, che sia sincero, critico ma costruttivo...
Ci sono aggressioni nel gruppo?
Ci sentiamo sempre a nostro agio e sicure?
Che cos’è un’aggressione?
Di fronte al tipico viscidone, come abbiamo reagito?
Abbiamo/hanno reagito?
E come ha reagito la gente intorno a noi?
Stiamo attent* a quello che succede intorno a noi?
DAVANTI A UN’AGGRESSIONE C’E’ MAI STATA UNA DISCUSSIONE COLLETTIVA SU COME AFFRONTARLA?
Come possiamo reagire in modo adeguato se non ci poniamo mai la questione fino a che non avviene un episodio di violenza?
Crediamo alla persona che è stata aggredita?
Chiediamo spiegazioni/prove?
Esiste un modo di trattare questo tema senza entrare in un discorso di colpevolezza e vittimizzazione?
Non abbiamo mai vissuto un’aggressione durante una festa?
RIUSCIAMO A REAGIRE AD UN AGGRESSORE ANCHE IN UNA FESTA DOVE NON CONOSCIAMO CHI LA ORGANIZZA?
Riusciamo ad agire/reagire quando stiamo a una festa (fatt*, ubriach* ecc.)?
Siamo capaci di mettere in discussione le nostre reazioni senza che questo significhi non fare niente?
Che facciamo quando è un’amica che sta molestando un’altra persona?
La nostra realtà è centrata sull’uomo?
Dobbiamo assumere comportamenti etero-machisti per essere accettat* o ascoltat*?
La dominazione, il parlare tanto per, essere forte e convinto, non lasciare spazio a dubbi, sono comportamenti tipici delle nostre assemblee?
Come donne, tendiamo ad assumere ruoli tipicamente maschili per essere prese in considerazione?
Ci sentiamo a nostro agio nell’esprimere i nostri sentimenti, paure, frustrazioni o, come in qualsiasi altro luogo, è meglio nasconderli?
Reagiamo in modo diverso se a dire o fare una cosa è un uomo invece che una donna e viceversa?
Come uomini, teniamo conto della posizione di potere da cui partiamo a causa della nostra socializzazione?
Dovremmo fare più attenzione ai nostri comportamenti per questo motivo?
Come possiamo cambiare l’ambiente intorno a noi per renderlo un contesto dove ci sentiamo più a nostro agio e sicur* senza per forza introdurre una serie di regole su come bisogna comportarsi?
Fino a che punto vogliamo che arrivi la nostra “liberazione”?
Asamblea de Género, 2004, Barcellona
Dentro il gruppo...
Nonostante tutto quello che ci distingue, ci unisce l’idea della distruzione di tutte le gerarchie e, quindi, l’azione contro il fascismo, il razzismo, il sessismo. Crediamo che questo non significhi solo reagire in relazione a fasci e molestatori ma anche contro i comportamenti di tutt* e anche contro i nostri.
È LA NECESSITÀ E L’URGENZA DI REAGIRE E METTERE IN DISCUSSIONE noi stess*, nelle nostre relazioni, nelle nostre case e nei nostri centri sociali. In generale, nella nostra vita quotidiana.
Il personaggio del viscido viene percepito come qualcosa di lontano, che sta fuori del nostro contesto più prossimo e non come qualcuno che potrebbe essere nostro amico o come noi stessi. Anche perché è facile associare al sessismo solamente gli abusi sessuali e la violenza e non tutti i giochi di potere e le aggressioni di ogni tipo (psicologiche, verbali, fisiche).
La critica che poniamo non si applica solo alla società in generale ma anche ai gruppi e agli spazi di cui siamo parte. È molto difficile che riconosciamo, critichiamo e reagiamo di fronte ad atteggiamenti sessisti agiti da persone che riconosciamo come nostr* amic*, con le quali decidiamo di convivere e con le quali ci identifichiamo in molto di quello che pensiamo e di come vorremmo comportarci.
Nessuna persona, nessuno spazio – né centro sociale – è davvero liberat*. Però cerchiamo di cambiare noi stess* e cambiare i nostri spazi e le nostre relazioni. Da questo deriva l’importanza di metterci in discussione e parlare tra di noi, dei nostri dubbi, comportamenti ed esperienze. Perché quello che un* sente come aggressione, abuso, violenza è molto più difficile da riconoscere quando coinvolge persone che conosciamo o con le quali ci relazioniamo. Di fatto quasi tutte le violenze avvengono in relazioni di coppia, amicizia, familiari. Non sono tante le persone nascoste dietro un albero sulla strada di casa che ti attaccano; sono molte di più le persone che vivono in casa tua, che incontri alle feste, assemblee, manifestazioni, laboratori...
È molto importante che una persona, quando si sente aggredita, non dubiti del fatto che si tratti di un’aggressione e confidi nei suoi sentimenti, che riesca a parlarne e a sentirsi a suo agio, ascoltata e appoggiata in quello che decide di fare.
Nella maggior parte dei casi non abbiamo chiaro come reagire ma pensiamo che debba essere chiara, invece, la necessità di parlarne, discuterne e non mettere tutto sotto silenzio. Perché il silenzio significa accettare la situazione, ovvero, non dare visibilità al problema e non permettere che si trovino risposte collettive e individuali.
Tra di noi, non cerchiamo di evitare lo scandalo. Scandalizziamoci sempre!! Non NORMALIZZIAMO la musica sessista nei concerti, le posizioni di potere nelle assemblee e nelle relazioni, la superiorità della razionalità sull’emotività, i ruoli su ciò che si suppone essere il maschile e il femminile, il potere della forza fisica per imporre sé stess*, le scuse dei contesti di festa per cui “è ubriac*”, “è drogat*”, “sta scherzando” ecc.
Finiamola con la dicotomia tra buon* e cattiv* che impariamo dalle favole per bambini, gli eroi non esistono. Mettiamoci in discussione in ogni momento. Non accettiamo la situazione facile di sembrare tranquill* quando alcune cose ci infastidiscono. Non ci sono soluzioni perfette ma solo la possibilità di cercare di cambiare per convivere meglio tra di noi.
Noi siamo migliori ma vogliamo vivere meglio.
Manifesto pubblicato nel 2002 e diffuso tramite Contra-Infos.
L’autodifesa delle e per le donne è una risposta alla violenza di genere
Solo delle e per le donne a causa della socializzazione che riceviamo. Dal momento in cui nasciamo, siamo educate in un modo differente in base al fatto di essere considerate bambine o bambini. E anche la cultura nella quale cresciamo e ci relazioniamo ci percepisce e ci determina in un modo diverso. Questo si riproduce in tutti gli ambiti sociali come la famiglia, la scuola, il gruppo di amici, il lavoro, le relazioni di coppia, le feste... Non vogliamo dire che tutte le donne sono uguali ma sottolineare che esiste un’identità femminile creata e socialmente imposta che afferma che siamo sensibili, emotive, passive, docili, dedite alla cura, conciliatrici, deboli, ospitali, seduttrici, etero, gelose ecc.
Solo delle e per le donne perché esiste un dualismo di genere (donne/uomini). Questa è la realtà che viviamo. A partire dal momento in cui tutti gli spazi (o quasi) ti percepiscono come una donna, sei più soggetta a aggressioni per il semplice fatto che il genere maschile domina e il genere femminile è associato all’essere dominato – a livello di forza, desiderio, necessità ecc. Questo dualismo esiste, che ci piaccia o no. Noi partiamo da questa base per metterla in discussione e cambiarla. Cambiarla, ad esempio, cambiando le relazioni tra donne che sono molto frammentate e dominate dalla relazione con l’altro genere.
Vediamo l’autodifesa come un modo pratico e diretto di cambiare la costruzione del genere, la socializzazione, l’identità femminile, il ruolo maschile di dominazione tramite la voce e la forza fisica, di dominazione degli spazi pubblici (strade, bar ...), il ruolo femminile del silenzio, dell’accettazione, della simpatia...
Mettere in discussione tutto questo a partire dal quotidiano, dalle nostre esperienze e non da una base ideologica o teorica. Cercando la complicità tra donne. Questo non ha a che fare solo con quello che abbiamo in comune a causa dell’educazione, della cultura o di quello che è ma anche con il desiderio di creare relazioni differenti tra di noi. Relazioni differenti da quelle imposte dal modello eterosessuale. Che non siano di attrazione per i ragazzi e di competitività tra ragazze. Che non siano di confronto tra donne per cercare di piacere agli uomini.
Trovare spazi per parlare delle cose che generalmente tacciamo, come situazioni che ci fanno sentire insicure, comportamenti che ci infastidiscono e che non sappiamo come affrontare, non avere chiaro molte volte quello che ci piace, i dubbi sulle nostre reazioni – “non so che mi è successo...”, frustrazioni, “mi piacerebbe aver detto/fatto...” – paura del conflitto, paura del rifiuto, dare priorità alle emozioni delle altre sulle nostre, difficoltà a non sorridere, la facilità con cui separiamo le nostre emozioni dal nostro corpo – il desiderio di menare a qualcuno ma sentire di non avere la capacità fisica per farlo, che, quando qualcuno ti tocca in un modo che non ti piace, cerchi nella tua testa di non dargli importanza ... la difficoltà che abbiamo molte volte nel riconoscere le nostre potenzialità, la difficoltà nell’accettare quello che proviamo, la difficoltà nel riconoscere le aggressioni quotidiane.
Un’aggressione è quando una si sente aggredita. Non c’è un solo modo di affrontare un’aggressione. Ce ne sono tanti. Tanti come sono tante la situazioni, i momenti, gli stati d’animo. E in più siamo tutte diverse nel modo in cui reagiamo o vorremmo reagire.
Nell’autodifesa, impariamo insieme strategie e tattiche fisiche, verbali, psicologiche per difenderci. Queste sono strumenti che ognuna decide come e quando usare. Tu decidi come reagire, confidando in te stessa. Nessuna difesa è esagerata perché tu sai meglio di chiunque altro quello che provi e come vuoi esprimerlo, in maniera aggressiva o tranquilla. Quello che bisogna mettere in discussione sono le aggressioni e non le risposte ad esse. Vogliamo riconoscere e affrontare comportamenti violenti nelle altre e in noi stesse. Visibilizzare le aggressioni che in genere non riconosciamo come tali: ricatti emotivi, posizioni di potere...
Riconoscerle, rifiutarle, difenderci.
Per noi, un gruppo di autodifesa delle e per le donne, permette di creare risposte individuali e/o collettive alle aggressioni. È un’alternativa reale alle istituzioni e alle autorità che pretendono di avere la risposta o la soluzione. Non vogliamo rivolgerci né alla polizia, né ad avvocati o giudici. Vogliamo combattere la frustrazione e la sensazione di impotenza che possiamo provare di fronte ad un’aggressione.
Un gruppo di autodifesa è per noi un gruppo di affinità, con la possibilità di organizzarsi e agire di fronte alle aggressioni.
ABBANDONIAMO LA PAURA, TIRIAMO FUORI LA RABBIA!
Questo testo è stato pubblicato nel 2005 nella fanzine “de piernas abiertas” (“a gambe aperte”).
Nessuna aggressione senza risposta!
Si dice che il nemico più difficile da combattere è quello che vive dentro casa! Quanto è vero e quanto ce lo sentiamo addosso quando parliamo di sessismo! Ovviamente “noi” siamo compagne, persone più o meno politicamente corrette e il tema dell’antipatriarcato lo conosciamo bene. Certo è vero che ogni tanto diciamo “fica!” (in italiano “cazzo!”) e chiamiamo una guardia “figlio di puttana”, sono solo delle piccolezze che col tempo limeremo.
Alcune di noi si sono stufate di sentire queste cose, di sopportare l’ipocrisia, di credere che nel nostro piccolo mondo, microcosmo, giro alternativo, gli aspetti più forti del sessismo non si vedevano, o addirittura non esistevano. Ci siamo stancate delle voci, dei pettegolezzi insani che sono diventati abitudine nei bar, nelle feste e nelle serate libertarie, e per una volta vogliamo chiamare le cose con il proprio nome e denunciare:
-
che molte di noi compagne si sentono sistematicamente molestate da rastoni, capelloni, gente figa o semplici viscidoni che hanno ancora la sfacciataggine a un certo punto di alzare la bandiera dell’antipatriarcato, partecipare alle assemblee, associazioni, suonare in gruppi dall’innegabile contenuto antagonista ecc.. Quando una donna dice “NO”, o è un mezzo sì o un mezzo “no” e vuole lasciarsi convincere. Quando diciamo “NO” vuol dire “mi dispiace, lillo, ma stasera vai in bianco”.
-
In più alcuni compagni (?) non si vergognano di dire a chi denuncia: “Ma vi spaventate ogni volta che abbiamo un’erezione?”. A questi sveglioni vogliamo dire che non ci spaventa nessuna innalzata del “membro”. Quello che può spaventarci, farci schifo e/o farci vomitare è il “membro” che, di fronte al rifiuto, insiste, persiste, disturba e persino aggredisce invece di continuare con la sua erezione in solitaria o con chi vuole condividerla
-
Che molte compagne hanno vissuto abusi a cui hanno reagito in tempo, nei centri sociali, ai concerti, alle feste, negli spazi teoricamente liberati- Che molte persone, pur sapendo tutto questo, hanno coperto più volte maiali del genere o semplicemente ne hanno parlato sotto forma di pettegolezzo alla domanda “che si dice?”.
Se diciamo “di fronte al fascismo, autodifesa”, se gridiamo con pathos “nessuna aggressione senza risposta”, se scriviamo sui muri “contro il patriarcato, azione diretta”, se facciamo tutto questo, allora non c’è spazio per tutto quello che succede da anni tra di noi. Non c’è spazio per il viscido, per quello che abusa, per quello che esce a caccia di ragazze e non ci rispetta, trattandoci come prede “facili” su cui lanciarsi. Il problema è collettivo. La risposta anche deve essere collettiva. Puliamo la casa prima di spazzare il cortile.
Vogliamo che sia chiaro che non siamo un collettivo. A differenza loro, non portiamo avanti un lavoro continuo ma il nostro obiettivo è quello di combattere il patriarcato tramite risposte a problemi concreti. La forma di organizzazione che pratichiamo è quella conosciuta come gruppo di affinità, ovvero un gruppo chiuso di ragazze unite da un forte legame di fiducia che ci garantisce operatività ed efficacia.
Esortiamo tutte le ragazze a organizzarsi in questo o in un altro modo per lottare contro il patriarcato.
NESSUNA AGGRESSIONE SESSISTA SENZA RISPOSTA!
Anacondas Subversivas
Sull’azione diretta femminista
Durante gli ultimi mesi, alcune donne hanno dovuto conciliare lo svago notturno con la realizzazione di azioni dirette femministe, consistenti principalmente nell’espulsione (o tentativo di espulsione) di aggressori (nello specifico un aggressore, conosciuto con il soprannome Fer) dagli spazi pubblici.
Consideriamo quest’azione legittima specialmente quando viene portata avanti in un contesto politico, come nel caso in questione.
Nonostante questo, nei giorni successivi, abbiamo assistito a reazioni di sorpresa, allarme e, a volte, perplessità così come ad interpretazioni sbagliate dell’azione e dei suoi obiettivi. Questo ci fa pensare che forse negli ultimi tempi nel movimento sociale a Barcellona si sta perdendo (probabilmente per mancanza di abitudine) la sensibilità femminista che permette di capire nel loro contesto e in giusta misura, azioni come questa.
Per questo ci piacerebbe invitare varie assemblee a condividere una riflessione sul perché e il come dell’azione diretta femminista.
Perché?
Le aggressioni sessiste, i molestatori, gli stupri, sono forme di oppressione patriarcale che hanno luogo costantemente nella nostra quotidianità e nei nostri spazi politici, trovando riparo dietro a molteplici pretesti che hanno a che vedere con le stupidaggini sociali della presa a bene, del clima di festa, delle droghe e con l’idea che quello che succede in questi contesti rientra nell’ambito privato e non politico, nel quale vale tutto. Questo cocktail di elementi funziona nel legittimare il comportamento degli aggressori e delegittima i possibili sentimenti di malessere, protesta o risposta della persona aggredita, permettendo che queste forma di violenza vengano taciute, minimizzate e continuino a prodursi ogni volta con maggiore impunità.
Da un punto di vista antipatriarcale, questo tipo di aggressioni non sono aneddoti isolati ma fanno parte di una forma di violenza strutturale e, quindi, perpetrarle significa esercitare una forma di violenza fondata su un privilegio sociale. Denunciarle e combatterle è un modo di fare politica. Accettarle e giustificarle, quindi, è un posizionamento politico nel senso opposto.
Come?
Identificandole, segnalandole, rendendole visibili sia nel momento in cui accadono sia quando diventano visibili le loro conseguenze. Alcuni esempi.
Se in un contesto di festa, una donna viene molestata e, in primo luogo, comunica il suo fastidio all’aggressore invitandolo a smetterla; se questo non capisce, la donna lo comunica al suo gruppo di affinità e questo, in funzione del grado di ostilità del soggetto, insiste affinché la faccia finita o direttamente lo caccia dallo spazio.
Se, in questo stesso contesto, avviene un’aggressione sessista, innanzitutto si protegge la donna aggredita dalla violenza che viene esercitata su di lei. Una volta creato uno spazio di sicurezza per la donna, è lei a decidere come preferisce gestire la situazione e partire da questo, sempre in funzione dei suoi desideri, si possono mettere in campo modalità differenti.
Se, come nel caso da cui nasce questo testo, un gruppo di donne si trova in un’occasione di festa in uno spazio politico e vi incontra lo stupratore di una compagna, presente o meno (elemento irrilevante per il motivo che “se toccano una, toccano tutte”), una di loro va dallo stupratore e gli comunica che:
-
sa che è uno stupratore;
-
dato che è uno stupratore, la sua presenza in uno spazio di lotta politica che include la lotta femminista non è gradita;
-
di fronte a quanto detto e alla conseguente mancanza di rispetto che la sua presenza suppone per la coscienza politica delle persone presenti, deve abbandonare lo spazio.
Se l’aggressore esprime la sua contrarietà ad abbandonare da solo lo spazio, il gruppo di donne provvede a fargli abbandonare lo spazio con la forza, con il minor danno possibile al resto dei presenti e spiegando sempre a chi organizza la festa e a chi lo chieda cosa sta succedendo e perché.
Questi sono solo alcuni esempi che speriamo servano a spiegare il perché e il come dell’azione diretta femminista per il liberare il campo dalla sfiducia e dai dubbi che queste azioni possono produrre in chi non disponga dei dati sufficienti; così come per far sì che queste dinamiche diventino parte integrante del funzionamento dei nostri spazi quotidiani e dei centri sociali.
Se toccano una toccano tutte
Unas/LasOtras
Se durante la lettura di questo paragrafo tenti di visualizzare la situazione e ti sembra strana o difficile da comprendere, sostituisci il concetto di “sessista” con quello di “razzista”, vedrai come tutto risulterà più facile.
Questo scritto non è parte di una campagna pedagogica: è un AVVERTIMENTO
Succede che nei nostri spazi ci siano aggressioni.
Succede che il 90% di quelle che vengono riconosciute come tali diventano invisibili.
Perché sembra che non sia una priorità per il movimento o perché ci infastidisce mettere in chiaro responsabilità individuali e collettive.
Succede anche che alcune di noi siano stanche della “presa a bene”.
Se stai pensando...
...”ecco di nuovo le scassacazzi, le femministe tristone che continuano con la solita cantilena di sempre”
... “questi sono problemi tra le persone, questioni private e non politiche né collettive, non hanno così tanta importanza”
... “non immischiamoci in cose che non ci riguardano, non complichiamoci la vita”
... “e che di notte tutti i gatti sono grigi”
... “si, si”
... “ci sono cose più importanti, come ad esempio l’anticapitalismo che risolve tutto”
... “è che stavo strafatto”
... “stiamo così avanti che la questione di genere è un po’ superata”
... Se ti vengono in mente mille giustificazioni, se metti in discussione una donna che si è sentita aggredita e partecipi al processo popolare nei suoi confronti, allora abbiamo tantissima voglia di spezzarti le gambe!
Se questo, invece, ti fa pensare...
...”era ora, sono stanca che queste cose rimangano pettegolezzi”
...” il sessismo, la lesbofobia e la transfobia non spariscono quando decidiamo di fare parte di un centro sociale”
...” il femminismo non si è realizzato con le suffragette e il diritto al voto”
...”la lotta contro il potere patriarcale è una responsabilità collettiva”
...”quando aggrediscono una aggrediscono tutt*!!!”
Se reagisci con la stessa forza sia di fronte ad un’aggressione fascista e/o razzista sia di fronte alla violenza machista.
Se ti si contorce lo stomaco e provi rabbia.
Se pensi che l’azione diretta sia necessaria e legittima.
Se non vuoi startene zitt* e hai voglia di rispondere e difenderti, questo flyer è soprattutto per te.
Questo invece è uno scritto pedagogico:
Viscidume: definiamo così l’atto di invadere lo spazio di una donna con l’intenzione di far notare la propria presenza. Questo include: sguardi, sorrisi, movimento delle sopracciglia, pose da stallone, conversazioni vomitevoli ecc. Può addirittura arrivare a strusciamenti sulla pista da ballo, aggressioni verbali con tono di complimento, insistenza asfissiante... e può concludersi con un bicchiere rovesciato sulla testa del tipo, con piedi pestati, con grida nelle orecchie, con uno spintone o con l’espulsione immediata dallo spazio per mano della donna o delle sue amiche.
Violenza di genere: questa espressione viene utilizzata quando vediamo cose terribili in tv o leggiamo il giornale ma che pensiamo non abbia niente a che vedere con noi né con il nostro mondo
Consenso: quando due o più persone decidono liberamente e consapevolmente di avere uno scambio per desiderio e senza alcun tipo di forzatura, né approfittando del fatto che lei sia drogata, ubriaca o addormentata
Stupro: non è un incontro casuale tra due corpi
Vittima: questo termine permette di compatire e negare la forza e la capacità di lottare di una donna che ha vissuto un’aggressione
Uomo cattivo, aggressore, stupratore: serve ad apostrofare l’altro come matto, malato e differente dagli altri e liberarci dalla responsabilità
Presa a bene: lassismo, apologia del libero arbitrio e del tutto vale, giustificazione della miseria che ci circonda
Isterica: degradazione della rabbia delle donne
Aggressione: quando una donna si sente aggredita
Antipatriarcale: parola che usiamo in testi e discorsi senza però metterla in pratica nella nostra vita quotidiana.
Scassacazzi: semplificazione fallocentrica quando in realtà possiamo scassare qualsiasi altra parte del tuo corpo ;)
Flyer distribuito durante la campagna del 25 novembre 2007
Breve storia degli Oggetti Quotidiani
Sono tanto quotidiani quanto la violenza contro le donne, gli oggetti che possono servirci per difenderci.
Difenderci con quello che abbiamo vicino è una cosa tanto antica quanto le aggressioni che viviamo in quanto donne: è una cosa che viene da molto lontano... dai preparati di acqua e peperoncino usati come spray dalle donne messicane, alle spille per evitare sfregamenti indesiderati nella metro a Tokyo, alle confezioni di kajal per truccarsi gli occhi dotate ingegnosamente di una lamina di metallo delle donne marocchine, abbiamo sempre usato la nostra inventiva per rispondere alla violenza machista. Nelle tue mani hai solo un piccolo esempio che può permettere alla tua immaginazione di volare. Però ricorda che la fiducia in noi stesse e la solidarietà tra donne sono le nostre migliori armi.
Riprendiamoci le strade! Riprendiamoci la notte!
Riprendiamoci i nostri corpi! Perché tu vali!
Acciones descentralizadas, Barcellona 25 novembre 2008
Postfazione
La volontà di tradurre “Tijeras para todas” nasce dall’esigenza che abbiamo come compagne femministe, queer e antisessiste, di contribuire allo sviluppo di un ragionamento condiviso sul tema della violenza di genere negli spazi occupati, negli squat e in tutti quei luoghi che attraversiamo e che desideriamo vivere come spazi safe. ”Tijeras para todas” è una raccolta di testi elaborata dalle compagne di Barcellona: anche se le parole che vi troverete sono riferite ad altri luoghi e ad altre persone, ci riguardano da vicino e ci toccano nel profondo delle nostre esperienze quotidiane. Diffondiamo questa fanzine con la voglia di non partire sempre da zero nella riflessione e fare tesoro dell’elaborazione di altre compagne e di altri collettivi.
[1] Le testimonianze riportate con asterisco provengono dalla ricerca empirica alla base della tesi dottorale di Biglia (2005).
[1] Le testimonianze riportate con asterisco provengono dalla ricerca empirica alla base della tesi dottorale di Biglia (2005).
[1] Le testimonianze riportate con asterisco provengono dalla ricerca empirica alla base della tesi dottorale di Biglia (2005).
[1] Le testimonianze riportate con asterisco provengono dalla ricerca empirica alla base della tesi dottorale di Biglia (2005).