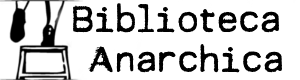Prima edizione: maggio 2015
Alfredo M. Bonanno
Contro la coerenza
Nota introduttiva
Compito ingrato quello di risvegliare i dormienti.
E quanto più duro è stato prendere sonno, quanto più dura la lotta per allontanare i fantasmi di ciò che si sarebbe potuto fare e non si è fatto, tanto più astiosa sarà la reazione di chi è disturbato mentre dormiva.
Ci sono molte marche di tranquillanti e sonniferi, l’industria farmaceutica ingrassa i proventi dei suoi azionisti anche per curare queste malattie (quasi sempre) immaginarie, ma c’è un altro genere di medicamento, non sottoscritto da nessuna ricerca medica, che funziona egregiamente, ed è quello fornito dall’ideologia.
L’anarchismo può benissimo convogliarsi in questa etichetta, contribuendo così a fare dormire e a tenere buoni tutti coloro che, in questo modo, si mettono la coscienza in pace. L’ideale è salvaguardato, le chiacchiere pure, quindi nulla di nuovo sotto la luna.
La coerenza, cioè la perfetta corrispondenza di quello che si fa con quello che si pensa, pensare da anarchici e fare da anarchici, è una forma molto comune, e molto usata, di mettere a tacere la propria coscienza.
Il fatto, nella pratica, che per agire occorre quasi sempre mettere le mani a mollo, proprio a mollo nella merda, spesso sporcandosele in maniera disgustosa, è un buon motivo per tirarsi indietro, arroccarsi nella purezza delle proprie chiacchiere ideologiche, controllare che tutto sia a posto nella corrispondenza d’amorosi sensi, tra idea e pratica, e girarsi dall’altra parte.
Punzecchiare, come faccio in questo libretto, l’idolo della coerenza è pratica malfamata, quindi in perfetta coerenza con il mio essere malfattore e fuorilegge.
Con buona pace di ogni critica della coerenza, io sono coerente con me stesso. E il mio naso ha fatto l’abitudine alla puzza di merda.
Come ho detto pubblicamente più volte, non sono un architetto o un artista a cui chiedere di rifare la facciata di un palazzo, ma un idraulico in grado di provvedere a sistemare il cesso.
Sogni d’oro ai dormienti.
Trieste, 26 aprile 2014
Alfredo M. Bonanno
Contro la coerenza
Le strade verso la schiavitù sono molteplici e spesso appaiono come contrastanti tra di loro. Per quanto percorrano itinerari a volte opposti, finiscono comunque tutte per condurre allo stesso posto. La riflessione critica condotta anche sulle condizioni fondamentali della ragione è sempre stata una specie di terra di nessuno dove si sono scontrate ipotesi di ogni genere, dall’ortodossia razionalista fino a quella irrazionalista. C’è, nella logica dell’a poco a poco, una rigidità dell’accumularsi che risente dell’apparente ovvio principio di non contraddizione. Un uomo, ed anche una donna, possono oggi dire una cosa e domani contraddirsi tranquillamente dicendo l’esatto contrario. Questo comportamento si definisce di solito incoerente ma si tollera in nome della qualità umana essenziale, la creatività, qualità che differenzia l’uomo dall’automa che non può permettersi contraddizioni o opinioni.
Le esigenze della vita sono primarie, senza la vita non c’è posto per altro. Eppure la vita, per essere degna di essere vissuta, deve avere accesso alla qualità, questo movimento, pericolosamente di confine, è una presa di coscienza di sé da parte della vita. Chi non ha accesso alla qualità non vive, anche se crede di farlo, e anche comodamente, i suoi anni passano e sfuggono via fra le sue dita come sabbia. La trivialità di una condizione condannata a restare dimidiata è terribile, è un peso insopportabile che disgusta e fa accedere al possesso come a una panacea senza speranza. Se non si ha dignità e coerenza di sé non si può vivere, ma abbassarsi a compromessi in cui sono io a chiedere l’elemosina di un aiuto. Ma questa dignità e questa coerenza non devono diventare due robuste camicie di forza per farmi restare dove non vorrei, due protesi per farmi camminare se non so o non voglio farlo. I momenti importanti della vita sono quelli in cui comincio a dubitare di essere morto e di essere circondato da morti, e mi dispero, e cerco di andare oltre, coinvolgendomi, mettendomi a rischio di azzerare quella miserabile vita in cui mi dibatto. E questi momenti non hanno nulla a che vedere con la coerenza o la dignità, sono al di là del bene e del male, non fanno più barriera e sostegno, ma lasciano liberi di affrontare dolori e peripezie, e anche gioie e assolute incapacità di capire. Sono questi momenti, in cui agisco, che la parola giustificatrice viene meno, in cui le sue capacità geometriche di mettere ordine si smarriscono.
A volte, davanti a una situazione che pretende da noi un certo comportamento, opportunamente catalogato, ci si sente pieni e sollecitati quasi da una nostra intima e personale potenza, ad agire diversamente, qualcosa di simile alla necessità che a volte sentiamo di esprimere un concetto, dar corpo ad un’idea, senza per altro riuscirci esattamente nel modo in cui vogliamo, uscendo spesso frustrati o sconfitti. Il pensiero di un’azione ci martella dentro per giorni, spesso anche per anni, fin quando riusciamo a realizzare qualcosa di simile a quell’ipotesi da tanto tempo accarezzata, oppure ci accodiamo nella lunga lista dei rassegnati. In ogni caso siamo alla ricerca di una tensione che non possediamo, in quanto prigionieri, noi e il nostro pensiero, quindi noi come coscienza immediata, dal meccanismo accumulativo. Perfettamente in linea Nicola Abbagnano, con buona pace delle mie pie illusioni: «La ragione è universalità ed oggettività. L’uomo libero è colui che realizza in sé una personalità intelligibile nella quale più nulla è rimasto degli elementi empirici e patologici della sua vita. L’uomo libero è autonomo. La sua legge deriva dalla sua natura; ma la sua natura non è veramente sua una pura universalità obiettiva nella quale gli elementi concreti del suo essere si sono dissolti e non è rimasta che la pura esigenza di un ordine universale obiettivo di soggetti. L’uomo è libero come cittadino di un regno il quale non ha altra determinazione possibile che quella che in esso tutti i cittadini sono nello stesso tempo legislatori. Kant ha realizzato fino in fondo l’antico concetto della libertà, come atteggiarsi dell’uomo a puro essere razionale. Ma realizzandolo sino in fondo ne ha mostrato l’inefficienza. La razionalità è diventata per Kant un concetto limitativo e negativo che esclude la ricchezza dei motivi e degli elementi concreti della vita umana per non sostituirle che l’ideale stesso di questa esclusione. La ragione è diventata impersonalità, oggettività, cioè negazione pura e semplice della concretezza esistenziale. Per essere libero l’uomo deve essere quello che tutti debbono essere; ma questo criterio, se esclude e limita l’azione dei moventi concreti, non sostituisce a tali moventi nessuna esigenza determinata. La libertà si radica in un mondo intelligibile che ha soltanto determinazioni negative: essa esclude ogni massima soggettiva, ogni interesse singolo; essa stabilisce l’identità tra i soggetti in quanto, tutti egualmente fini assoluti». (Introduzione all’esistenzialismo, Torino 1957, pp. 105-106).
La vita è il sentimento della qualità, il sospetto intuito che non c’è completezza in tutto quello che nel mondo viene prodotto e messo sul conto di essa. Questo sentimento riaffiora nei comportamenti quotidiani e può essere visto grazie a molti criteri, non tutti accettabili, ma alcuni dei quali costituenti residui della qualità abbandonata. Il destino può arrivare improvviso e maligno, sconosciuto anche nel beneficio e quindi portatore di estranee condizioni impositive, ma posso essere io a gestirlo e costruirlo in quel tempio segreto nascosto nell’azione, dove si celebra la possibilità che non potevo vedere dall’interno del fare. Per capire quanto il destino mi dice di quello che non ho saputo né potevo capire, e di quello che non riesco a rammemorare, cioè dell’ammorbidire, devo rinunciare a considerarlo come un commensale estraneo, uno stravagante non invitato che mi obbliga a lasciarlo sedere alla mia tavola. Sollecitare la sua venuta è inutile, come pretendere una spiegazione, si adatterebbe forse a suggerirmi altrettanti simulacri corrispettivi delle apparenze del fare, invece lasciato a sé, incontrollabile, mi ripresenta ciò che l’azione, la mia azione, ha reso possibile. Solo così il destino è un divenire orgiastico e non una catapulta distruggitrice. Quella forza cosmica che lo riempie si riversa nel fare ed è la mia forza fattiva nuova, non una strategia dell’abbandono, che il cerchio si stringerebbe troppo soffocandomi, ma ricchezza dell’esperienza immediata, futura anticamera del coinvolgimento. Così Karl Jaspers: «Quando, guardandomi intorno, esamino tutto quello che passa sotto il nome di libertà, incontro una molteplicità di fatti e di definizioni senza che una consapevolezza oggettiva del loro senso mi consenta di scegliere che cosa è, e che cosa non è la libertà. Quando a guidarmi è il mio autentico interesse per la libertà, nella molteplicità che mi si presenta scopro ciò che mi parla come libertà, perché io stesso ho la possibilità d’esser libero. Partendo da questa possibilità posso muovermi alla ricerca della libertà. E allora, o la libertà non c’è proprio, o è già libertà l’andarne alla ricerca. Ma il fatto che la libertà esiga un’originaria volontà d’esser-libero significa che questo esser-libero è già di fatto anticipato nella posizione stessa del problema. Non è possibile dimostrare la libertà e poi volerla, al contrario è la libertà a voler se stessa, perché ad essa è già presente un senso della sua possibilità. Il filosofare che parte dalla possibilità della libertà si pone in cammino per accertarne, argomentando, l’esistenza. Queste argomentazioni, che in un certo senso sono nate con l’essere della libertà, sono indispensabili per consentire al filosofo di superarle in vista dell’autentica libertà. Da questo punto di vista negativo, chiarirle significa non pretendere di dimostrare la libertà come si dimostra un esserci qualsiasi, perché la libertà non si manifesta nell’intelligenza, ma nell’azione. Nella stessa preoccupazione per l’essere della libertà è già presente un’attività che si realizza a partire dalla libertà. Come possibilità, la libertà è anche possibilità di non esser libero; è possibilità di soffrire l’impulso negativo della libertà. Nel mio me stesso non sopporto la possibilità di non esser libero, non sopportandola mi accorgo di dover esser libero per l’importanza incondizionata che assume ciò che dipende da me. Questa non è una deduzione astratta di un fatto da una sua condizione, ma è l’espressione del se-stesso che si rende conto della sua possibilità, che consiste nel poter decidere di sé. Esigendo da sé, esige se stesso e se vuol essere deve poter realizzare delle esigenze. La libertà non si esprime né nell’orientazione nel mondo, né nella trascendenza, ma solo nella chiarificazione dell’esistenza di cui è il primo e l’ultimo termine. Nell’orientazione nel mondo c’è l’essere nella sua struttura oggettività e universalmente valida, e dove giunge la conoscenza non c’è ancora libertà. Nella trascendenza, invece, non c’è più libertà perché, in un essere trascendente, la libertà sarebbe falsamente assolutizzata e quindi negata come realizzazione esistenziale nell’essere temporale. Nella libertà c’è un movimento che ha come suo scopo quello di render superfluo se-stesso nella manifestazione dell’esserci temporale dell’esistenza, esso tende al proprio annullamento nella trascendenza. Ora la libertà è pur sempre l’essere dell’esistenza, non della trascendenza, è ciò che consente all’esistenza di cogliere la trascendenza; questo può avvenire solo se l’esistenza è se stessa e si mantiene nella propria indipendenza». (Filosofia, tr. it., Torino 1978, pp. 650-651). Più spesso, il problema ci viene incontro in formato ridotto, incapsulato di già in una procedura alla quale ci atteniamo in modo abitudinario, ripetizioni che non sono mai calchi identici di un’ipotesi d’azione ma sempre qualcosa di continuamente ampliato e modificato, fino a pervenire a una reale trasformazione. La potenzialità accumulata, seppure priva di tensione o con una semplice disponibilità di residui qualitativi, sollecita certamente un comportamento uniforme fino al punto di farci desiderare quel comportamento, fino al punto di farci diventare noi stessi gendarmi delle nostre intenzioni, ma anche nell’abiezione del più tradizionale fare coatto c’è sempre lo sbocciare di esperienze riorganizzative, apportatrici se si vuole di nuovi orizzonti di accumulazione ma anche suggeritrici di possibili inquietudini.
Non posso entrare nell’azione cercando di quantificarla, di farne rivivere pezzi mettendoli controluce. Non posso individuare percorsi ed elementi di facilitazione o di ostruzione. Posso certamente parlarne nella rammemorazione, ma è un racconto materiato di parole dove possono trovare posto la costrizione o l’esaltazione. Vedo ora come se tutto passasse attraverso la lente di un cannocchiale rovesciato. L’azione mi circonda e mi contiene, mi sollecita in modo neutro, non vengo stimolato al cambiamento, sono la stessa trasformazione ma non conosco il me stesso che trasforma la realtà.
Spesso, nell’ambito stesso della catalogazione si avverte una pienezza quasi creativa, comunque generativa di modificazioni, ci adattiamo, cresciamo, ritagliamo piccoli spazi situazionali, ci identifichiamo con i nostri ruoli di controllo, ci compensiamo reciprocamente, cerchiamo qualcosa che continuamente viene spezzato, un mondo che è stato frantumato quando era di già unificato e di cui abbiamo tracce sensibili nell’ambito considerevolmente alto dei flussi che ci costituiscono. La funzione di questa strana creatività interna all’accumulazione è quella di ritardare i processi di accumulo sulla base della semplice volizione. A modo suo Luigi Pareyson: «Il male non è assenza di essere, privazione di bene, mancanza di realtà, ma è realtà, più precisamente realtà positiva nella sua negatività. Esso risulta da un positivo atto di negazione: da un atto consapevole e intenzionale di trasgressione e rivolta, di rifiuto e rinnegamento nei confronti di una previa positività; da una forza negatrice, che non si limita a un atto negativo e privativo, ma che, instaurando positivamente una negatività, è un atto negatore e distruttore. Il male va dunque preso nel significato più intenso della ribellione e della distruzione». (Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Torino 1995, p. 126). Incondivisibile, ma significativo. La coscienza immediata, per quanto sia esclusivamente diretta al meccanismo che la occupa, non può diventare mai oggetto completo dell’accumulazione stessa, ci saranno sempre residui o zone indenni, spesso a lei stessa ignoti, comunque di maggiore o minore significato in relazione al modo in cui l’orientamento si è verificato, cioè se si è trattato di una trasformazione negativa recente o di già, per quel che riguarda il flusso in questione, ormai sufficientemente radicata.
In alcuni casi, l’irrigidirsi nei riguardi del meccanismo accumulativo, quindi una sua accettazione ai limiti dell’ortodossia, corrisponde ad un altrettanto rigido rifiuto del coinvolgimento. Il numero dei flussi orientati tende a crescere e l’individuo si chiude alla diversità, costruisce tutto un suo linguaggio interno all’accumulazione e si immiserisce nelle pratiche giustificative, nella manipolazione della ragione in funzione esclusiva della logica dell’a poco a poco. La paura difficilmente consente la ribellione. La coscienza immediata controlla il proprio ambiente considerato in modo favorevole, ma tende così a restringerlo, a specializzarlo, e ciò allo scopo di controllarlo e gestirlo meglio. Accortamente, Renato Cristin: «In Leibniz l’armonia speculare del cosmo è retta da un vincolo, per quanto riguarda i rapporti fra le monadi, che viene definito “un’eco delle monadi, che una volta posta esige le monadi, ma non dipende da esse”. Tramite la metafora dell’eco, la monadologia diventa, fenomenologicamente, un “individualismo del noi”, in cui le opposizioni vengono composte. Anche Heidegger, nella figura della Lichtung [...], cerca di avvicinare prospettive contrapposte, ricorrendo anche all’immagine dell’eco: la Lichtung “è libera non solo per la luminosità e l’oscurità, ma anche per l’eco e per il suo spegnersi, per ogni suono e per il suo svanire”. Nella conferenza Hölderlins Erde und Himmel [Terra e cielo di Hölderlin], Heidegger precisa come nella poesia di Hölderlin Griechenland, il suono della terra sia l’eco del risuonare squillante del cielo. L’eco armonizza la “congiunzione” dei Quattro nel Geviert: “nell’eco la terra risponde al cielo”, “il rosso della terra [...] sarebbe allora nella sfera del risplendere l’eco dell’azzurro degli occhi”. Questa cosmogonia della consonanza, centrata sull’eco, non ha solo significato poetico. Da Hölderlin a Heidegger c’è un’oscillazione dal poetico al filosofico: sotto quest’ultimo profilo la struttura terra-cielo retta dall’eco sembra rappresentare un insieme separato e legato da un diaframma, che ci riporta all’imperfetto (e meraviglioso) monismo dell’essere in cui affonda le radici la differenza ontologica. Nell’eco heideggeriana avvertiamo l’infrangersi degli opposti contro qualcosa di inconsistente. Una volta ancora Heidegger disattende le aspettative: gli opposti non si fondono né si contraggono; si lasciano – si abbandonano nella Lichtung. Resta il fatto che l’eco, ovvero il gioco di specchi del mondo, tenta di creare uno spazio in cui l’esserci e l’essere incrocino i sentieri della loro epocale differenza, custodendo un luogo in cui continui a risuonare l’eco del loro rispecchiarsi. Su questa via Heidegger reincontra il maestro: per un istante questa topologia dello specchio e dell’eco affianca la ricerca fenomenologica di una evidenza intersoggettiva che indichi il senso a priori dell’ontologia. Poi però i due tentativi si separano sulla discriminante del soggetto: nel rispecchiarsi delle monadi, l’io resta sempre per Husserl un “centro di funzioni” ritagliato nella purezza di un eterno presente, e l’eco è diretta verso qualcosa ma rimane sempre eco di qualcosa: della soggettività. Anche se poi, accentuando un tono paradossale che accompagna sempre le sue riflessioni, egli non cessa di sconcertarci, rovesciando, talvolta, l’ordine egologico: “concepire l’Altro come uomo – questa è interpretazione originale [...] L’Altro è il primo uomo, non io”. Nella corrispondenza in cui si specchiano i poli del cosmo heideggeriano agisce invece un’energia originaria che assorbe il soggetto, disperdendolo nell’essere. Qui il “cerchio metafisico della soggettività” si incrina, l’eco diventa tautologia: echeggiare il medesimo in un rimando inesauribile e privo di inizio. L’eco diventa ecc, dell’abisso, dell’ Ab-grund. Ma c’è Ab-grund senza Grund? E il nodo Ab-Grund-Sein non trova forse la propria essenza nell’oscillare tra il “rischio” di echeggiare il nulla e il “gioco” del mondo in cui l’uomo diventa giocatore? Quando Leibniz ci dice che si ha l’espressione rappresentativa delle monadi “perché tutte le sostanze simpatizzano con le altre”, non pone forse il problema, sviluppato poi da Heidegger, di una concezione relazionistica in cui la verità diventa questione di scorrimento laminare fra manifestarsi e ritrarsi? Grazie al concetto di rappresentazione intesa come eco, Leibniz sembra superare il platonismo del regno delle idee: perciò in lui “il mondo è un’opera d’arte nel senso dell’arte piú nuova”. Forse proprio una novità analoga tiene aperto il passaggio fenomenologico. La metafora dell’eco riveste l’intersoggettività, il mondo stesso, di una valenza antiidealistica: l’eco non è essenza solidificata e immutabile, ma flusso di durata ed esperienza. La sua circolarità non comprende un centro immobile e identico. Su questo modello Heidegger e Husserl convergono: per il primo, l’orizzonte dell’essere non include un ente centrale e primario, “come se gli altri enti non fossero che ombre di esso”. C’è soltanto un insieme non-omogeneo in cui si realizzano le possibilità dell’esistenza e della finitezza: qui l’esserci è “disseminato” nella fusione ontologica». (“La monade, l’eco, l’arcobaleno. Heidegger, Husserl e il concetto leibniziano di sostanza”, in “Aut aut” nn. 223-224, 1981, pp. 253-254).
L’illusione comporta un rischio, quello del rilancio, se non si è capaci di allargala all’infinito e ci si fa cogliere dalla paura, si diventa indulgenti e pietosi, ma lucidi nella propria scelta di quello che si ha e di quello che non si vuole avere. Se voglio avere tutto e non sono un eccessivo, penso che il tutto sia appena dietro l’angolo, ma non è così.
La catalogazione può dare quindi un’ambientazione benigna, con modificazioni accettabili in termini di disturbo e con l’eliminazione progressiva di ogni sollecitazione all’inquietudine, e ciò perché in essa e nei processi interni di distinzione e riorganizzazione, si formano basi di potenza, sicurezza, controllo e così via. Un comportamento adeguato, che per diversi motivi viene sollecitato da più parti, se non altro come risposta morale e ragionevole, può essere, a questo punto, spacciato per coerenza. Ma si tratta della coerenza della logica dell’a poco a poco.
Comunque, per quanto si possa considerare costante la presenza dell’inquietudine in una parte dei flussi che costituiscono l’individuo, non si può negare che la tendenza verso l’accomodamento accumulativo o verso il rifiuto e la ribellione si contrappongono sempre in modo non equilibrato. Non esiste cioè un meccanismo interno all’insieme dei flussi che chiamiamo individuo capace di regolare questo equilibrio, non c’è una regolamentazione fisiologica. Scendendo a livello dei flussi biologici troviamo sempre lo stesso continuo processo che si rompe in miliardi di possibilità, senza riuscire a trovare una regolamentazione che non vada al di là della semplice ipotesi macroscopica, valida solo per i grandi numeri e per le previsioni superficiali. Per altro non conosciamo molto bene i flussi che riconnettono le relazioni che potremmo definire fisiologiche con le relazioni affettive o emotive, quindi non possiamo che avanzare delle timide ipotesi regolative, sistematicamente smentite da ogni singolo approfondimento.
Il rifiuto della misura è tutto nell’assenza, coinvolgimento, interruzione eccessiva di ogni conoscenza, intuizione di una totalità di cui non ho cognizione né poca né tanta. Non posso in queste condizioni, che definisco di coscienza diversa, pensare alla costruzione dell’uomo nuovo. Posso solo perfezionare il mio rapporto con l’assenza, farmela diventare familiare presenza, vivere la mia ribellione e non aspettare che venga fuori la nuova casa sovversiva dove trovo ancora sicurezza, però colorata di rosso e nero. La qualità non è il migliore dei mondi di Pangloss, è una regione desolata dove posso vivere sulla punta di uno spillo tutta la mia forza attiva, ma nessuna esperienza fattiva. Io sono fino in fondo la mia azione, ma solamente quello che la mia azione non è attuata per meglio crocifiggere il mio nemico in philosophicis. Tutt’altro.
L’apparente coerenza dell’accumulazione è quindi imposta, come ormai sappiamo, dal processo selettivo del senso, dal meccanismo orientato, ma non è mai una coerenza perfetta. Sto qui cercando di individuare sia i limiti del concetto di coerenza, sia i movimenti interni all’accumulazione che resistono alla riduzione quantitativa e quindi si propongono come possibili riferimenti d’inquietudine. Improvvisamente vedi gli occhi della donna che ami in un altro modo, li vedi più profondi, come se potessi entrarci dentro, capaci di sostituire parole e concetti, occhi da smarrirsi, neri, quasi autonomi, come se ti si presentassero contraddicendo la propria coerenza fisica con il resto del corpo della tua donna, con il rapporto che hai con il suo corpo e con lei, come donna, come essere umano e con la situazione complessiva, e con il tuo e il suo campo, all’infinito. Eppure poco è cambiato, le condizioni esterne sono sempre le stesse, la coscienza continua il suo lungo gioco di controllo, il mascheramento copre gli altri flussi dove ricognizioni diverse si sviluppano, il coinvolgimento sta muovendosi con coraggio in altri flussi ancora, dove il tuo amore è anche presente, ma questo istante qui, questo colore degli occhi è qualcosa di preciso e non può derivare da movimenti tanto complessi. È appena un attimo, un improvviso stato mentale, un’isola sconosciuta scoperta fra la nebbia e subito dopo scomparsa, sommersa dai mille espedienti della vita di tutti i giorni, dagli imperativi di comportamento dalla volontà dominatrice.
Sono presente nel mio libro più importante, quello che sto continuando a scrivere anche oggi, tra mille difficoltà, faticando, a mano a mano, ed è una presenza mancata. C’è il mio corpo che ho portato in giro per il mondo in condizioni a volte paradossali, a volte affascinanti. C’è la mia vita molteplice, coraggio e paura misti insieme, il primo incapace di cancellare la seconda e questa incapace di rendermi vile. C’è la mia avversione verso tutto quello che è sobrio, illuminato e parsimonioso, deciso nei particolari e aspirante a una conclusione immediata e soddisfacente. C’è l’eccesso che non aspetta rifiuti e che quindi essendo profondamente triste è gioioso del continuo rilancio senza fine, della gioia che non scorda quello che si è lasciato alle spalle. Ho vissuto in modo da non uscire mai da me stesso per guardarmi in prospettiva, dall’alto, vagabondo munito di mappe sempre sbagliate, fortunatamente dirette a nessuna conquista. Ecco la posizione di Aldo Masullo, per certi aspetti condivisibile: «A questo livello del mio “esser-nel-mondo” io mi ritrovo sì a dialogare con “altri”, ma è una “dialogicità” di mero fatto, immediata, in cui gli “altri” sono il non-io, e io li intendo solo nella misura in cui unilateralmente voglio e so intenderli, non diversamente da come voglio o so intendere il guaito d’un cane o il sibilo del vento, un intendere come un solitario riconoscere, in rapporto con la mia identità, significati oggettivi in genere. Qui la “dialogicità” è solo una situazione di fatto, da me unilateralmente esperita, un commercio d’informazioni e di pratiche la cui oggettività è correlata all’esclusivo soggetto che sono io. Il dialogo nella sua immediatezza, come ragione che si accontenta del “libero uso di se medesima”, non è ancora veramente dialogo, in quanto non ancora è giunto a viversi nella sua autenticità, nella sua profonda struttura multilaterale: esso ignora che “possibilità” soggettive realmente plurali coabitano la “comune intimità” del mondo, e non si cura di scoprire il senso originario della dialogicità. Immediatamente, il mondo non è che un ambito di presenze, di significati sempre già-dati, nella loro oggettività correlata al soggettivistico esclusivismo dell’io, esso medesimo sempre già-trovatosi. La ragione dunque può pervenire alla pienezza della sua consistenza dialogica e, liberando l’io dall’inganno della sua gelosa ottica solipsistica, scacciarne ogni diffidenza verso la storia, solo se con coraggio si scioglie dall’ovvietà del dialogo d’uso, pigramente unilaterale, e si problematizza nell’intento di scoprire come sia possibile un’autentica multilateralità. La ragione non si realizza appieno se non cerca il fondamento di se medesima come coesistenza di compossibilità progettuali, vita delle innumerevoli ragioni». (Antimetafisica del fondamento, Napoli 1971, pp. 30-31). Prendere in giro la propria volontà può essere un fallimento eccentrico, ma non è di questo che vado in cerca, cerco un altro tipo di sconfitta, quella che veramente circonda la volontà e insegue altri orizzonti, felici perché non condizionati da possesso alcuno. Malconcio ma non abbattuto, continuo la mia avventura, rivendicandone l’autonomia. Né il campo né la diversità sono riusciti a catturarmi.
Da questo esempio mi pare si possa trarre una interessante deduzione, la coscienza non riesce a organizzare un controllo globale, sempre qualcosa gli sfugge, la sua condizione è sempre quella di un lavoro in corso che non arriva mai a completezza, una continua riproposizione di risultati e tentativi, di oggettivazioni e improvvise ricomparse di intuizioni creative. Non appena una distinzione viene realizzata e tutto si indirizza verso di essa, processi riorganizzativi molteplici ripresentano aspetti diversi di indistinzione. L’accumulazione procede in modo da dare l’impressione che queste improvvise indistinzioni non esistano, ma di fatto esse ci sono e contribuiscono a creare problemi di coerenza nella catalogazione.
Per quel che posso capire, c’è una sorta di precocità nel verificarsi di interferenze all’interno dei rapporti tra coscienza immediata e meccanismo accumulativo, precocità che a volte sono semplici relazioni elementari, quasi puntuali, balenii piuttosto che segnali, ma sempre movimenti abbastanza complessi da produrre modificazioni e ritardi nel processo stesso. Ciò disturba la coscienza più ancora di modificazioni avanzate e complesse che disturbano attraverso un senso di saturazione o di disgusto per mancanza di prospettive. La precocità della reazione si può dire, per quanto possibile, coglie impreparata la volontà e ne scombina i progetti di controllo. Qualche volta può anche causare sovrapposizioni nelle esperienze sensibili, colori che si mischiano a suoni, sapori che si collegano con ricordi di luoghi e così via. Ciò contribuisce a rendere incerta la risposta cosiddetta coerente.
Con tutti i limiti del momento, e il peso della non trascurabile tradizione, Gustavo Bontadini scrive: «L’importanza della metafisica, e conseguentemente del suo compito, è diversa nei confronti della morte e della vita (intendo di questa vita). Nei confronti della morte l’importanza è già assicurata. La metafisica è l’ipotesi con cui si può affrontare la morte. E poiché il soggetto, come si è detto, non può stare in riserva, di fronte all’esperimento, per vederselo svolgere dinanzi, così l’ipotesi teoretica passa da sé in opzione vitale. Se io, di fronte alla morte, mi propongo di stare semplicemente a guardare, a parte il fatto che da sperimentatore decado a semplice osservatore, in ogni caso ho già scelto un certo comportamento – quello di non scegliere tra le ipotesi – in cui sono compromesso con tutto il mio essere. La metafisica è – già nella fase di compito – una guisa di affrontare la morte. (A compito eseguito essa, come protoscienza, scienza dell’essere e del non-essere, ha, intorno all’essenza ontologica della morte, sicurezza maggiore di quelle che il sapere empirico ci ammannisce sulle cose della vita)». (Conversazioni di metafisica, Milano 1971, pp. 87-88). La conoscenza difficilmente riesce anche a presentarsi come lievità, cioè a mettere da parte le regole e a librarsi con uno slancio prodigioso nella immaginazione. Il più delle volte guarda con sospetto verso questa condizione intuitiva e la considera nemica. Preferisce restare incollata alle certezze misere della corrispondenza, a un ordine che non può restare lontano dalla pesantezza dei riscontri. Ma l’abbandono non vuole dire assenza di confronti e relazioni, se io sono colto invece di capire o di cogliendo capire, se rinuncio a capire fino in fondo, fino alla testardaggine, non vuole dire che l’assenza non si capovolga in presenza. La trasformazione è molteplicità in atto che mi prende in un vertice di intensità che non posso controllare. Sono il riferimento di una esplosione talmente concentrata che mi sfugge qualunque canone possa avere introiettato in precedenza. Nell’oscurità che subentra al lume della conoscenza avverto e sento la desolazione, sono improvvisamente immerso in un mondo che non è più il mio mondo, quello delle specificazioni, qui tutto si condensa, tutto tende a concentrarsi verso un punto infinitesimo di massima sintesi. L’aria del deserto mi parla la voce dell’uno, ma non mi fornisce chiarimenti. Il mio coinvolgimento, dopo le prime incertezze, mi rende più forte e mi fa disponibile all’intuizione successiva, mi fa vedere quello che prima non vedevo, ma sono altri occhi che godono di un’altra vista. Nella qualità non ci sono oggetti da ammirare o da disprezzare. Da questo caos nasce la tensione qualitativa, io non ne posso seguire le varie germinazioni, ma riesco a farmi cogliere da un flusso sconosciuto che mi rende disponibile a un’avventura senza precedenti. Entro nella desolazione del nascondimento e intuiscono che questa entrata mi rende incomprensibile al mondo che pure avevo creato e continuato a produrre, incomprensibile e nascosto. Colgo nell’essere colto perché adesso, nell’assenza, sono anche io nascosto nello stesso nascondiglio in cui si nasconde la desolazione. Getto l’amo nella solitudine, non c’è ombra né di acqua né di pesci, né la mia pesca si aspetta di prendere qualcosa, l’attesa mia ora è diversa, mille avvisaglie mi aprono il cuore come segnandomi con gli occhi di un piccolo bambino, come se occhi blu mi facesse guardare attraverso i suoi occhi blu. La metafora del deserto è indispensabile. Nel deserto sei abbandonato a te stesso e sei costretto ad abbandonati al deserto, non puoi contrastarlo fino in fondo. Le regole e gli strumenti ti aiutano, ma fino a un certo punto, poi il vento si leva e il deserto prende corpo, si muove e muovendosi ti muove. Ossessivamente mi rendo conto che il deserto circonda il mondo che ho creato, e lo stringe in un assedio senza fine. L’apparenza è un’isola nel deserto, un’isola in cui fantasmi loquaci urlano per scacciare la paura.
Meritevole di riflessione l’ipotesi di Johannes Volkelt, che così si esprime parlando di Schopenhauer: «A questo impulso pessimistico è legata la tendenza “illusionistica” del suo pensiero. Il mondo che si estende nello spazio e dura nel tempo gli dà l’impressione dell’inconsistenza, dell’instabilità, del sogno. Dovunque gli appare nel mondo che lo circonda l’ombra del nulla. Egli in effetti riassume la metà della sua filosofia nella frase: “Il mondo è la mia rappresentazione”: e il mondo gli si manifesta così come un gioco senza posa e senza pace fra soggetto ed oggetto, uno scambio fra due parti, di cui nessuna è e significa qualcosa per se stessa. E per la causalità, questa forma fondamentale di tutte le apparenze, il mondo gli si manifesta come affatto relativo e inconsistente. Ma è soprattutto nel tempo che per lui trova compiuta espressione il carattere assolutamente transeunte ed evanescente e autovanificantesi di ogni accadere e divenire. Non per nulla Schopenhauer si rifà con speciale predilezione al sogno per rendere evidente l’essenza del mondo spaziotemporale. E fa questo non per il gusto di un paragone brillante e paradossale: è invece con grande serietà che dice che non si dà criterio sicuro per distinguere il sogno e la realtà. Così questa tendenza illusionistica acquista un colorito romantico. Spesso egli si richiama, e sempre con la più ammirata considerazione, alla saggezza dell’India; egli considera il mondo come “un velo che circonda la coscienza umana, un qualcosa di cui è ugualmente falso ed egualmente vero dire che è, come dire che non è”. La tendenza illusionistica consiste dunque in ciò, che dalla considerazione del mondo spazio-temporale egli si sente spinto a riportarlo sotto ogni suo possibile aspetto a una fondamentale inconsistenza e instabilità ontologica. La tendenza illusionistica accenna già al dominio della teoria della conoscenza. Infatti ad essa si accompagna la tendenza soggettivistica. Non solo per quel che riguarda colori e suoni, ma anche per le figure spaziali, emerge in maniera evidente per Schopenhauer la convinzione tacitante ogni possibile obiezione, che questo mondo è legato alla coscienza. Se guarda al mondo sensibile, subito sorge in lui il pensiero decisivo che in quanto lo possediamo e parliamo di esso, già vien presupposto il soggetto. Per quanto si immerga nella considerazione del mondo oggettivo, sempre gli appare l’altro lato dell’oggetto, il soggetto, come ciò attraverso cui l’intera esistenza del mondo sensibile è determinata». (Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube, ns. tr., Stuttgart 1907, pp. 48-49). La ragione dominante fissa giudizi di valore che considerano patologici tutti gli arresti nella coerenza del comportamento. Normalmente si considerano ben indirizzati quei comportamenti finalizzati al raggiungimento di certe utilità. In queste pagine ci occuperemo attentamente di problemi attinenti all’utilità, alla conquista, alla vita, tutti legati al problema della coerenza. Spesso, ripensamenti o veri e propri tradimenti, faccende tutt’altro che riconducibili alla presenza o alla mancanza di coerenza così come l’intendo io, vengono o coperti con un vergognoso silenzio, oppure condannati in nome di una morale che continua a restare dominante. L’incoerenza è ancora peggio dell’incertezza, viene indicata come una perversione del soggetto, una sua rinuncia ai principi della non contraddizione.
Non nego che ci possa essere un comportamento delirante, ma come di già sappiamo lo si trova agli antipodi di quello di cui parliamo adesso, cioè nel territorio dell’azione, quando si oltrepassa il punto di non ritorno, cioè quando ci si inoltra nella qualità senza più l’obiettivo della riunificazione del flusso. Non sono disponibile a considerare patologico o anormale il comportamento delirante, di cui per altro conosciamo molto poco, ma non si può neanche lasciare passare impunemente i giudizi riguardanti il delirio vero e proprio, coerentemente voluto dalla coscienza ricognitiva o ricostruito mediante una protesi chimica, senza sottolineare che proprio all’interno dell’accumulazione si verificano movimenti che ricordano questi altri pur nascendo in modo del tutto differente.
I fanatici sono più pericolosi degli stupidi, nel migliore dei casi li equivalgono in capacità di danno. Una volta pensavo che annoiassero senz’altro ed evitavo il loro contatto, sia pure attraverso uno scritto, così come cercavo di evitare gli stupidi, ma purtroppo non è possibile evitare né i primi né i secondi, sono troppi e troppo intraprendenti. Il fanatico abbraccia un possesso e lo eleva a divinità assoluta, di una protesi fa lo scopo della propria vita, lo stupido considera lo strumento lo scopo e non è capace di guardare più lontano. Nessuno dei due è disposto a mettersi a rischio e quindi niente a loro è permesso che non sia prescritto da regole, che il primo ha bene codificato dentro di sé e che il secondo non capisce, ma questo non ha importanza. Sconoscono entrambi l’eccesso che conduce alla perdita perché non hanno mai conosciuto la conquista, tutto è stato dato loro fittiziamente, un gioco di apparenze fluttuanti nella modificazione. Non essendosi mai coinvolti a proprio rischio totale, cercano o di imporre agli altri la propria vita come modello, nel caso dei fanatici, o di imporre alla propria vita un modello qualsiasi, nel caso degli stupidi. Schiavi entrambi della tirannia dell’apparente sono essi stessi tiranni di un gioco che nemmeno conoscono, il gioco della vita.
Le incertezze della coerenza accumulativa sono quindi interessanti aspetti di un rifiuto della catalogazione della coscienza immediata all’interno del processo che vorrebbe tradurla in oggetto. Nell’occhio della mia donna riesco a vedere una profondità e una limpidezza dentro cui rispecchio me stesso, un me stesso che si rifiuta di diventare oggetto di un possibile rapporto estraniante e ciò può accadere al limite anche all’interno dello stesso rapporto d’amore, per quanto pieno possa essere, per quanto totale. Quella tonalità di verde che io ci vedo, quel colore che improvvisamente diventa più intenso e mi porta verso sensazioni e sentimenti e forse anche ricordi e progetti del tutto lontani dai calcoli immediati che la natura accumulativa, quindi anche quantitativa, di qualsiasi rapporto vorrebbe imporre. Potrebbe darsi, infine, che una precisa individuazione negativa, un rifiuto, un ostacolo, insomma un chiarimento definitivo mi costringano a distogliere lo sguardo a ricacciarmi in gola tutti i sentimenti e le sensazioni e i ricordi e perfino i progetti, ma questo è un altro discorso e attiene totalmente all’ambito della vittoria nella prospettiva della sconfitta. Ancora una volta, in disaccordo con Abbagnano: «L’universale e l’individuo, la necessità e la libertà, l’unità e la molteplicità, l’eterno e il contingente si connettono e si urtano nella ricerca storica da cui nasce il problema, problema che non è soltanto di dottrina o di scienza, ma di umanità e di vita. Giacché, come posso io, uomo singolo, irretito nel molteplice delle situazioni contingenti, ancorarmi alla saldezza e all’unità di un ordine necessario? E come so riconoscermi e realizzarmi nel molteplice disperso delle circostanze se rinunzio a questo ancoraggio e perdo ogni possibilità di intendere e valutare le circostanze stesse? Comunque io mi risolva, pare che vada perduto per me il meglio di me stesso, della mia umanità. Ma dall’altro lato io non posso acconsentire a questa perdita nessuno può acconsentirvi. Debbo allora affrontare il problema della ricerca storica e cercare di raggiungere attraverso la considerazione di esso l’intelligenza della storicità. L’intelligenza della storicità condiziona l’intelligenza di me stesso e del mio rapporto col mondo». (Introduzione all’esistenzialismo, op. cit., p. 129).
Certo, si tratta di movimenti non solo precoci, ma anche eccessivi, rispetto alle condizioni comuni dell’accumulazione. Ma il concetto di eccezionalità resta escluso, come quello parallelo e rovesciato di anormalità o di patologia. La possibilità di cogliere condizioni estreme, sempre all’interno della stessa coscienza immediata, quindi la possibilità di contrastare il comando volitivo, stornando verso movimenti paralleli ma non ancora diversi, è presente in tutti gli individui, solo che così come si trova si tratta di una possibilità senza sbocchi, una pressione sulla volontà che in fondo si traduce in un’accettazione dello stesso dominio di quest’ultima, in modulazioni molto più articolate e ricche, ma sempre circoscritte. Spesso si tratta di elementi netti, immediati, comprensibili, altre volte l’attività della coscienza immediata sovraccarica la sensazione, il ricordo, il desiderio e li sottomette alle specificità imposte dall’ordine costituito.
Occorre fare presto, non posso perdere altro tempo con le cianfrusaglie culturali che mi hanno baloccato al tempo degli amori verdi e superficiali, sono braccato, devo affrettarmi. L’azione è ancora più convulsa per me di quanto non lo fosse ieri. Non è impazienza la mia, è coscienza che non sono lontano dall’assenza e verso di questa mi sto dirigendo. Forse sono stanco e non voglio ammetterlo, la notte non mi accetta amichevolmente, non è una questione di senescenza, è desiderio eccessivo che la struttura genetica non può reggere, o regge con difficoltà. Sento scorrere l’antica linfa dentro di me e in questo vedo la perennità qualitativa della diversità, l’ombra demoniaca che aspetta non lontano, da qualche parte, per aprirmi la strada, l’inquietudine non mi lascia mai del tutto, è tempo di lottare, ancora una volta, come sempre.
L’esperienza della protesi chimica, specie quella psichedelica, ha da un lato facilitato la sospensione di una parte dei controlli immediati ma ha anche immiserito la sollecitazione volontaria e perfino la stessa curiosità verso elementi relazionali che appaiono fortemente in contrasto con tutto ciò che mantiene i contenuti nel meccanismo accumulativo. La miseria di alcune esperienze del genere ha origini, il più delle volte, strettamente ambientali, condizioni esterne, frustrazioni degli altri, perfino la conflittualità intrinseca in qualsiasi ambiente marginale gioca un ruolo non trascurabile. La contraddizione dell’incoerenza non è quindi un aspetto privilegiato della coscienza immediata nell’ambito accumulativo, ma è la registrazione di movimenti che sono là e che difficilmente si possono negare come pure difficilmente si possono ricreare a comando. Così Heidegger, viaggiando per strade non facilmente identificabili con chiarezza: «Che il mondo non “consista” di utilizzabili è dimostrato tra l’altro, dal fatto che con l’illuminarsi del mondo attraverso i modi del prendersi cura che abbiamo testé esaminato, va di pari passo una demondificazione dell’utilizzabile in virtù della quale emerge, in quest’ultimo, l’esser solo più semplice-presenza. Affinché, nel prendersi cura quotidiano del “mondo-ambiente”, il mezzo utilizzabile possa essere incontrato nel suo “essere in sé”, i rimandi e i complessi di rimandi in cui si “immedesima” la visione ambientale preveggente, debbono restare non tematici, tanto per la visione ambientale, quanto per un’eventuale considerazione “tematica” non ambientale. Il non-annunciarsi-del-mondo è la condizione della possibilità da parte dell’utilizzabile di non suscitare sorpresa. E proprio qui si fonda la struttura fenomenica dell’essere-in-sé di questo ente. Le espressioni privative come non-sorpresa, non-importunità, non-impertinenza, esprimono un carattere fenomenico positivo dell’essere dell’utilizzabile immediato. Questa serie di “non”, esprime il carattere del “mantenersi in se stesso” dell’utilizzabile, ossia ciò che intendiamo con l’espressione essere-in-sé, anche se, in modo caratteristico, usiamo “innanzitutto” questa espressione per designare la semplice-presenza quale oggetto di considerazione tematica. Fin che ci si muove primariamente ed esclusivamente nell’ambito della semplice-presenza, l’“in-sé” non appare bisognoso di chiarificazione ontologica. Ma l’interpretazione ontologica si rende necessaria quando il discorrere di un “in-sé” pretende assumere portata ontologica. Onticamente, ci si rifà spesso, in modo enfatico, a questo in-sé dell’essere, e certo con buon diritto fenomenico. Ma questo riferimento ontico non giustifica il principio ontologico che si pretende così far valere. Le analisi finora condotte hanno chiarito che l’esser-in-sé dell’ente intra-mondano è comprensibile ontologicamente solo sul fondamento del fenomeno del mondo. Ma perché il mondo possa in qualche modo apparire, occorre che esso ci sia già aperto in generale. Con l’accessibilità dell’utilizzabile intramondano al prendersi cura della visione ambientale preveggente, il mondo è già sempre pre-aperto. Esso è quindi qualcosa “in-cui” l’Esserci, in quanto ente, già sempre era, ed in cui non fa altro che ritornare ogni qual volta si porta esplicitamente verso qualcosa. In base alle Indagini finora condotte, essere-nel-mondo significa: immedesimarsi, in modo non tematico e secondo la visione ambientale preveggente, coi rimandi costitutivi dell’utilizzabilità propria della totalità dei mezzi. Il prendersi cura è ciò che è sul fondamento dell’intimità col mondo. A causa di questa intimità, l’Esserci può perdersi in ciò che incontra nel mondo ed essere assorbito da esso. Che cos’è ciò con cui l’Esserci è intimo? Perché la conformità al mondo, propria di ciò che è intramondano, è tale da venire in luce? Come dev’essere intesa, in modo ancor più preciso, la totalità di rimandi in cui “si muove” la visione ambientale preveggente e le cui possibili fratture pongono in evidenza l’utilizzabilità dell’ente? Per rispondere a questi problemi, tendenti a un’elaborazione del fenomeno e del problema della mondità, si rende necessaria un’analisi più concreta delle strutture problematiche di cui fanno parte». (Essere e tempo, tr. it., Torino 1978, pp. 149-151).
Forse si potrebbero definire queste incertezze della coerenza in termini di attenuazione dei controlli specifici della volontà, fenomeno che corrisponde ad una specie di immersione nelle possibilità dell’altro, sempre visto nell’ambito dell’ineliminabile processo di oggettivazione. È come un segnale di una vita che sta dietro l’altro che pure riusciamo con difficoltà a vedere in altro modo che come oggetto, e che sta pure dietro noi stessi che subiamo, dal nostro punto di vista, la fondamentale riduzione di qualità, la riduzione agli aspetti del senso. Il meccanismo che origina questa condizione di incertezza, all’interno dell’accumulazione, è identico a quello che origina la condizione normale di certezza, quella in cui la coscienza immediata domina la situazione e regola i modelli e i processi della riduzione ad oggetto. La sicurezza di quest’ultimo modo di procedere, ripetuto all’infinito, pur sempre nella costante variabilità relazionale, è sempre una costruzione fuori di sé, che la volontà cerca in tutti i modi di controllare e dominare, accettandone e giustificandone ritmi e condizioni, ma che in effetti allontana da sé proprio per meglio oggettivarla. Allo stesso modo, forse ancora più immediato e decisivo, l’allontanamento di cui discuto qui si verifica nell’improvvisa condizione d’incertezza.
La contabilità delle parole è ridicola grammatica, codifica e sprezza, legittima qualsiasi sopruso, rozza e lunatica non può costituire la base che di una conoscenza quale è quella che da perfetta attaccabrighe vuole dominare il mondo con la sua logica dell’a poco a poco, logica da bulli di periferia. Per quanto vigorose possano sembrare, le parole si sgonfiano e lasciano in giro un’aria fetida fatta di diffidenza. Esse sono sempre rose dall’incertezza e dalla frenesia di arrivare invece a una completezza arcana, ma più tuonano e più rivelano la loro retorica vuotaggine. Sostengono i despoti ma non riescono ad alleviare la più piccola parte delle pene dei deboli, vogliono la concretezza e saltellano fra le buffonate, contente di attirare l’attenzione sui particolari distogliendola così da ciò che è essenziale, l’assenza della qualità. La loro sguaiataggine le rende quasi sempre ridicole.
La rottura del ritmo viene vissuta come scompenso dalla volontà, quindi come condizione precaria e difficile, non dimentichiamo che non ci troviamo nella condizione d’inquietudine. Ma si tratta di una rottura esperienziale che la volontà vuole capire, perché in ogni modo sente la sua importanza, se non altro come denuncia di una coerenza diversa, non soltanto analitica, la coerenza che impone in nome della logica dell’a poco a poco. Ecco perché la coscienza immediata non molla facilmente questo livello del movimento, anzi lo vuole approfondire, quasi lo cerca, sempre restando comunque legata alle condizioni accumulative. Dal punto di vista della coscienza immediata questo atteggiamento è mantenuto se non altro per la propria dominanza anche nelle condizioni di maggiore incertezza e allontanamento dalla progettualità di controllo. Ma non è soltanto questo il motivo che spinge la volontà alla ricerca, o quasi, della spiegazione di questi movimenti d’incertezza, c’è in fondo il radicato sospetto che il processo di controllo non garantisca risultati certi, che l’analiticita del metodo non racchiuda in se stessa la verità, come sembrerebbe ad un primo approccio.
Nello studio delle vicende della volontà siamo appena agli inizi e quindi queste affermazioni, poste in termini che sono approssimativi e superficiali, possono anche non spiegare bene i motivi che li animano. Comunque, per il momento, occorre ribadire la presenza della coscienza immediata anche in queste improvvise condizioni d’incertezza, senza dimenticare che ci troviamo sempre all’interno del meccanismo di accumulazione. Anche nel caso di un’attenuazione consistente del controllo, ci troveremo sempre davanti ad un’attività di volizione capace di dare un resoconto dell’incoerenza verificatasi, come se nel momentaneo e generale inabissamento una parte della coscienza immediata sia rimasta indenne e attaccata con feroce determinazione ai capisaldi della certezza analitica e del controllo e da questi punti di forza si ritrovi, successivamente, in grado di descrivere il movimento dell’incertezza. E, più oltre, lo stesso Heidegger: «Con l’ente intramondano non sussiste più alcuna possibile appagatività. Il mondo in cui esisto è precipitato nell’insignificatività; cioè: il mondo aperto in questo modo può esibire l’ente soltanto in base alla non-appagatività. Il nulla del mondo innanzi a cui l’angoscia si angoscia non risulta dalla constatazione di una specie d’irrealtà della semplice-presenza intramondana. Al contrario, bisogna che la semplice-presenza possa venir incontro perché non ci possa essere con essa alcuna appagatività ed essa possa esser rivelata nella sua inane spietatezza. Dal che consegue: l’aspettarsi prendente cura non trova più nulla a partire da cui possa comprendersi, perciò brancola nel nulla del mondo. Dopo aver cozzato contro un mondo insignificante, la comprensione è rigettata dall’angoscia verso l’essere-nel-mondo come tale; ma questo “davanti-a-che” dell’angoscia è, nel contempo, il suo “per-che”. L’angosciarsi dinanzi ... non ha né il carattere dell’attesa, né, in generale, quello dell’aspettarsi. Il “davanti-a-che” dell’angoscia, infatti, “ci” è già: è l’Esserci stesso. L’angoscia non è dunque costituita dal futuro? Certamente sì, non però da quello inautentico dell’aspettarsi. L’insignificatività del mondo, aperta nell’angoscia, svela la nullità di ogni possibile oggetto di cura, cioè l’impossibilità di progettarsi in un poter-essere dell’esistenza che sia primariamente fondato in ciò di cui ci si prende cura. Ma la rivelazione di questa impossibilità equivale alla illuminazione della possibilità di un poter-essere autentico. Che senso temporale ha questa rivelazione? L’angoscia si angoscia per il nudo Esserci, in quanto gettato nello spaesamento. Essa riporta-indietro sul puro “che” del più proprio e isolato esser-gettato. Questo riportare-indietro non ha il carattere dell’oblio divergente, ma neppure quello del ricordo. D’altra parte l’angoscia non è già come tale la ripetente assunzione dell’esistenza in quanto decidersi. Al contrario, l’angoscia riporta-indietro nell’esser-gettato in quanto possibile ripetibile. In tal modo essa svela anche la possibilità di un poter-essere autentico, che, nella ripetizione in quanto adveniente, deve venir-indietro verso il Ci stato-gettato. Il portare-innanzi alla possibilità della ripetizione è il modo estatico caratteristico dell’esser-stato che costituisce la situazione emotiva dell’angoscia. L’oblio proprio della paura sconvolge l’Esserci e lo lascia sospingere e travolgere nel vortice di possibilità “mondane” non controllate. A differenza di questa presentazione incostante, il presente dell’angoscia si mantiene nel riportarsi-indietro verso il più proprio esser-gettato. Per il suo stesso senso esistenziale, l’angoscia non può perdersi in mezzo a ciò di cui ci si prende cura. Se qualcosa di simile succede in una situazione emotiva simile all’angoscia, ciò significa che si tratta di quella paura che la comprensione quotidiana confonde sovente con l’angoscia. Benché il presente dell’angoscia sia mantenuto nel suo esser tale, non ha però il carattere dell’attimo quale si temporalizza nel decidersi. L’angoscia non fa che portare nella tonalità emotiva di un decidersi possibile. Il presente dell’angoscia mantiene l’attimo pronto al balzo; quell’attimo sulla cui base unicamente essa, e solo essa, può essere ciò che è. Nella temporalità caratteristica dell’angoscia – temporalità che la fonda originariamente nell’esser-stato e da cui si temporalizzano primariamente futuro e presente – si rivela la possibilità della potenza posseduta dalla tonalità emotiva dell’angoscia. In essa l’Esserci è decisamente ricondotto al suo nudo isolamento ed è tutto preso da esso. Questo “prendere” non si limita però a riprenderlo dalle sue possibilità “mondane”, ma gli offre contemporaneamente la possibilità di un poter-essere autentico. Le due tonalità emotive della paura e dell’angoscia non si “presentano” isolate nel “corso delle esperienze vissute”, ma sempre determinano tonalizzando una particolare comprensione e si determinano a partire da essa. La paura trova il suo appiglio nell’ente di cui ci si prende cura nel mondo. L’angoscia proviene invece dall’Esserci stesso. La paura giunge improvvisa dall’intramondano. L’angoscia si leva dall’essere-nel-mondo in quanto gettato nell’essere-per-la-morte. Questo “provenire” dell’angoscia dell’Esserci, compreso esistenzialmente, significa il futuro e il presente dell’angoscia si temporalizzano a partire da un esser-stato originario che ha il senso del riportare-indietro verso la ripetizione». (Essere e tempo, op. cit., pp. 497-500).
Occorre maggiore asprezza nell’uomo, convinzione e stravaganza, recuperare energia, allargare le prospettive, andare oltre l’apparenza che protegge da ogni genere di incertezza. Occorre non farsi catturare dall’evidenza che al minimo approfondimento si rivela friabile, elaborare gli aspetti dell’assenza nella capacità di essere presente, di andarle incontro evitando di portarsi dietro il solito corredo di menzogne. L’eccesso è una protesta ininterrotta contro la verità che pretende nascondersi nel fatto e nel fare.
Il sospetto dell’incoerenza sempre possibile è quindi presente nella coscienza immediata per quanto non produca sollecitazioni verso l’inquietudine. Si può comunque dire che ne prepara il terreno. Spesso le incoerenze sono non solo improvvise e legate a sensazioni o sentimenti, ma si coordinano insieme in vere e proprie situazioni. In questo senso la musica, pur non potendosi definire una protesi in senso stretto, consente o facilita il formarsi dettagliato di situazioni del genere. Non tutta la musica, ovviamente, in quanto all’interno di questo problema ci sarebbe molto da dire, ma una sua parte senz’altro. Il rumore viene recepito in modo diverso a seconda della situazione complessiva in cui il soggetto si viene a trovare, si tratta quindi di un movimento di flussi molto complesso che può essere orientato o unificato attraverso il coinvolgimento, producendo sostegno e sollecitazioni all’accumulazione o aprendo prospettive più o meno praticabili per la ricognizione. In questo rapporto che si sviluppa all’interno del campo, le stratificazioni culturali, specifiche di questa o quella corrente musicale, hanno certo la loro importanza, e si prestano più o meno facilmente a questa o a quella scelta, quindi possono anche costruirsi giudizi di valore riguardo una parte della musica storicamente intesa. Ma non è questo il vero aspetto del problema che qui voglio affrontare. A prescindere da questi giudizi e anche a prescindere dalle strutture musicali stesse, il linguaggio musicale, in quanto struttura linguistica di comunicazione, consente e determina effetti che non possono essere raggiunti con altri linguaggi.
Limitatamente alle condizioni di incertezza che stiamo ricostruendo all’interno dell’accumulazione, la musica gioca il suo ruolo e non può che trattarsi di una musica che ha subito di già l’orientamento del proprio flusso, cioè di un rumore che è stato catalogato e ridotto a innocuo sottofondo dell’oggettivazione. Eppure, nonostante questo trattamento accumulativo essa contribuisce forse meglio di altre condizioni esterne a proporre una traccia d’incertezza davanti alle pretese di controllo della coscienza immediata. Occorre una notevole abilità costruttiva e strutturale per ridurre la musica a supporto della ripetitività, cioè a elemento di sostegno del fare coatto. Anche nella cosiddetta musica della passività, dove non c’è più nulla della festa, l’indigenza culturale non è mai certa, c’è sempre un sospetto d’irriducibilità alla coazione, un ricordo dell’antica qualità, un linguaggio di per sé piuttosto dispersivo. In questa direzione il pensiero, di già accennato, di Jaspers: «La morte è superata col sacrificio e lo smarrimento della situazione-limite. Il coraggio consiste, invece, nel morire davvero senza farsi illusioni. La duplice angoscia. L’angoscia che si prova davanti al non-essere non la si può eliminare con la semplice volontà d’esserci, anzi resta l’ultima cosa quando si riduce tutto all’esserci, come determinata realtà fenomenica, come vita nel mondo accompagnata da coscienza e memoria. Contro il tentativo di nascondere questa angoscia mediante rappresentazioni che si riferiscono a un’immortalità sensibile, è radicale comprendere che, dell’esserci sensibile, con la morte non resta nulla. Solo da questo nulla può derivarmi la certezza della vera esistenza che, pur apparendo nel tempo, non è temporale. Quest’esistenza conosce un’altra disperazione di fronte al non-essere, una disperazione che la può afferrare nonostante la vitalità del suo esserci e in contrasto con la freschezza e la pienezza che l’accompagna. L’angoscia del non-essere esistenziale è qualitativamente così diversa da quella che si prova di fronte al non essere della vita che, nonostante l’equivalenza dei termini “non-essere” e “morte”, solo la prima può veramente dominare. Solo la certezza di cui è dotata l’angoscia esistenziale può rendere relativa l’angoscia dell’esserci. Partendo dalla certezza d’essere propria dell’esistenza si può dominare la brama di vivere e trovar pace di fronte alla morte, intesa come serenità nella consapevolezza della fine. Ma se nella comunicazione che si articola nella coscienza storica non s’è realizzata alcuna fede in una certezza d’essere, la morte esistenziale, di fronte alla morte biologica, finisce col portare alla più completa disperazione, per cui sembra che non sia possibile altra vita se non quella che si snoda tra l’oblio e l’illusione di un vuoto non-sapere. Se a questo punto si assolutizza l’esserci empirico e si mette da parte l’angoscia esistenziale, allora, per vivere ad ogni costo, occorre darsi da fare contro una possibile coscienza dell’esistenza. La brama di vivere relativizza l’angoscia esistenziale, annulla l’esistenza e genera una dissennata angoscia di fronte alla morte. La certezza esistenziale dell’essere, anche nella sospensione del non-sapere, non può essere di conforto per la volontà di vita che si attacca all’esserci finché c’è. Questa angoscia non può essere annientata dal sapere, ma può solo venire sospesa nella presenza momentanea della realtà esistenziale, nel coraggio con cui affronta la morte l’eroe che mette in gioco liberamente se stesso, nel rischio che fa correre alla propria vita l’uomo che, in piena consapevolezza, decide di sapersi e di volersi identificare con una causa e che, nella certezza del proprio essere, può dire: “qui sono e qui cado”, e, in generale, dovunque la realtà esistenziale guarda in faccia alla morte con la consapevolezza di un essere che si rivela a se stesso nel tempo e che, pur sapendo di sé solo ciò che nel tempo appare, in ciò è certo di derivare da un’origine che non conosce. Poiché non tutti giungono alla meta più alta, torna sempre a riproporsi in un’autentica situazione esistenziale, la duplicità dell’angoscia di fronte alla morte e del piacere di vivere da un lato, e la coscienza dell’essere che sempre e di nuovo si riconquista dall’altro. La rassegnazione di fronte alla morte è quel tranquillo atteggiamento in cui si esprimono entrambi i momenti. In questo atteggiamento si supera la vita senza disprezzarla. Occorre continuare a sperimentare il dolore della morte per continuare a riconquistare una sicura coscienza esistenziale. La vita acquista un senso più profondo, l’esistenza si fa più consapevole di sé di fronte alla morte; là invece dove si offusca, la vita corre il pericolo di perdersi angosciosamente nel vuoto; chi ebbe coraggio trae dal proprio ricordo una spinta decisiva, ma sperimenta anche il limite della sua libertà. Non è possibile avere coraggio e mostrare il proprio valore in una calma stoica che si esprime nella stabilità di una durata, perché in essa l’esistenza si perderebbe. L’ambiguità dell’esserci, non più sostenuto da una verità autentica, esige che dal dolore si giunga sempre alla conquista della rassegnazione. Chi, nella perdita della persona più cara, non mantiene in qualche modo una certa disperazione, perde la sua esistenza, così come la perde chi sprofonda nella disperazione, chi dimentica ogni timore di fronte al non-essere, allo stesso modo di chi si strugge nell’angoscia di questo dolore. La coscienza d’essere viene data in dono solo a chi ha provato la disperazione. La nostra coscienza ha questo di caratteristico: che può dire di essere, solo chi ha guardato in faccia alla morte. È infatti se-stesso solo chi ha rischiato la propria natura fenomenica. La duplice morte. La duplice angoscia dell’esserci e dell’esistenza rivela l’orrore della morte in due forme: come non-esserci più dell’esserci e come non-essere radicale». (Filosofia, op. cit., Torino 1978, pp. 701-703).
L’abbandono non accoglie un ardore calmo, ma ha bisogno lo stesso di una carica eccessiva, di una costanza intrepida, di una incredibile tempestività. Il coinvolgimento è insistenza senza fine, instancabile, e conferma la forza dell’enigma che improvvisamente si apre grazie al rischio non una volta per sempre ma come concessione provvisoria e sempre reversibile. L’incertezza e la violenza dell’arbitrio sono comunque presenti. Essere lì non vuole dire squarciare il silenzio con ulteriori parole, ma renderlo veramente tale, silenzio fino in fondo. Il segno che distingue qui è il silenzio, ciò che trascina via verso la voce dell’uno che è, ciò che fa da levatrice. La gestazione del passaggio può essere più o meno lunga, a volte durare tutta la vita, fino a quando tutto ciò che soffoca, divide, specifica, resta alle spalle. Andare oltre è un tentativo per sfuggire al mondo, il mondo in cui la vita somiglia alla morte e in cui tutto è troppo chiuso e imprigionato per essere vivo.
Questi spunti fanno indirettamente vedere come sia complesso il problema della coerenza. Infatti, tornando a parlare del problema musicale la tesi più spontanea e corretta potrebbe sembrare quella che riconduce l’attuale povertà musicale alle condizioni complessive della formazione economica e sociale. Ma si tratterebbe di un giudizio tutto sommato esatto però troppo sclerotizzato, cioè troppo adeguato a una valutazione storicista che non mi sento di condividere. Se è fuor di dubbio che il capitale sta realizzando un abbassamento complessivo delle condizioni culturali degli sfruttati, anche allo scopo di mantenere una distanza di classe, un muro, che rendà in prospettiva molto difficili gli stessi conflitti sociali, l’idea stessa della lotta di classe, se il capitale si sta muovendo in questa direzione, non bisogna dimenticare che la musica, come altri movimenti relazionali aventi uno specifico rapporto struttura-forma, producono effetti collaterali di grande interesse come è quello che stiamo esaminando qui, del tutto interno al meccanismo accumulativo.
Per questo motivo, sarebbe superficiale proporre una ricerca ricognitiva interna ai flussi musicali che parta soltanto dal rapporto musica e capitale. La musica di massa, con la sua tecnica collaudata, con l’uniformità dei prodotti, con il ricorso all’informazione globale, con la sua prevedibilità facilita la riduzione ad oggetto che resta lo scopo fondamentale del meccanismo accumulativo. La ricerca della tensione è sempre possibile, ma questo è un discorso diverso, al di là della traumatica e passionale vicenda del coinvolgimento, c’è nell’oggetto musica, anche per come viene prodotto dalle condizioni accumulative, una incertezza che pur consentendo il processo permette regressioni immaginative che non possono essere totalmente recuperate. L’improvviso emergere dell’incoerenza non deve essere visto, in questo contesto, come un passo in avanti, un’espressione critica, ma piuttosto un passaggio improvviso e irrecuperabile di livello che coglie aspetti poco conosciuti della flessibilità individuale.
Assimilare dubbi fa parte del fare, sia pure nella fase sofisticata dell’interpretare. Un dubbio non basta, è una certezza priva di coraggio, un fantasma carico di catene di plastica, portatore di diffidenza e di diffidenze. La cultura del dubbio si controbilancia con quella della certezza, si danno la mano e si scambiano qualcosa in più. Il fare non si deteriora, si distrugge, non accetta lavorii interni o talpe trivellatrici. Prima o poi questi lavori rumorosi vengono scoperti e smascherati. I loro autori fanno presto allora a buttare le braccia al collo dello scopritore.
Il fantasticare come tendenza all’affastellamento dei pensieri, non è certo la liberazione dei. processi obbligatori che caratterizzano la coscienza immediata, però, pur nel suo piccolo sortilegio, sviluppa un’alterazione quasi fisica del movimento che si indirizza verso il senso. Probabilmente la volontà si considera come un meccanismo perfetto, ma l’incertezza della volizione, che pure viene fuori in tanti modi e condizioni, la coglie impreparata ancora di più quando i termini di riferimento cominciano ad allontanarsi verso oggettivazioni immaginarie, favorite dalla lettura, dal cinema, dalla televisione, mezzi che trasmettono immagini se non proprio fantastiche, certamente fanta-sticate, cioè modificate in oggetti irreali per quanto assolutamente interni al meccanismo accumulativo. È proprio la minima resistenza che la volontà oppone a questi flussi fantastici che procura riflessi d’incoerenza, mentre la massima parte di questi flussi viaggiano tranquillamente all’interno della catalogazione, ricevendo senza intoppi la loro modificazione oggettuale. Esemplare la riflessione su Dio di Ludwig Feuerbach: «Dio presuppone dunque uomini che lo onorino e lo preghino; Dio è un ente il cui concetto o rappresentazione non dipende dalla natura, ma dall’uomo, e dall’uomo religioso. Credere significa immaginarsi che esista ciò che non è, significa, per esempio, immaginarsi che questa immagine sia un ente vivente, che questo pane sia carne e questo vino sangue, cioè che sia ciò che non è. “Il tuo Dio è tale qual è il tuo cuore”. Quali i desideri degli uomini tali sono i loro dèi. I Greci avevano dèi limitati il che vuoi dire che avevano desideri limitati. E anche quando, mediante la filosofia, essi raffinarono e spiritualizzarono i loro dèi, i loro desideri rimasero sempre sul terreno della realtà, sul terreno della natura umana. I cristiani vogliono essere infinitamente di più, vogliono essere infinitamente più felici degli dèi dell’Olimpo; beatitudine e divinità sono la stessa cosa. Chi non ha più desideri soprannaturali, non avrà più nemmeno essenze soprannaturali». (La filosofia dell’avvenire e la critica della religione, tr. it., Firenze 1982, pp. 166-167).
Torna utile, mi sembra, il problema della malattia su cui bisogna dilungarsi un poco. La malattia, cioè un cattivo funzionamento dell’organismo, non è una caratteristica dell’uomo. Anche gli animali si ammalano e perfino le cose, a modo loro, possono presentare difetti di funzionamento. Questa concezione, della malattia come anormalità di funzionamento è quella classica sviluppata dalla scienza medica, nel caso specifico dell’uomo, e mutuata dallo sviluppo complessivo delle scienze almeno fino all’inizio del secolo. La risposta alla malattia, in queste condizioni analitiche di fondo, per la maggior parte dovute all’ideologia positivista da cui ancora oggi la medicina è dominata, resta sempre quella della cura, cioè di un intervento esterno, scelto sulla base di alcune pratiche specifiche, del tutto interne al meccanismo accumulativo, pratiche dirette a ricostituire le condizioni di presupposta normalità.
Con il moltiplicarsi della modificazione la conoscenza diventa sempre più estesa e sempre più insoddisfacente. Si allargano i confini della quantità e ci si accorge che a nuovi orizzonti corrispondono sempre altri orizzonti ancora più remoti e che la strada del completamento è inesistente. La regola è quindi svuotata fino dalla sua origine, non ci fu mai un tempo in cui essa era portatrice di soddisfazione qualitativa, ma anche una volta, al tempo in cui i miti popolavano la terra, le apparenze la vestivano con le loro fantasticherie. Non esiste una conoscenza totale che poi si è frantumata nel residuo qualitativo dei valori e nella quantità accumulabile, semplicemente la qualità non è percepibile, resta lontana e desolata. In altre parole sono privo di radicamento, ballo sulle onde del porto, onde modeste e addormentatrici, ma le catene mi tengono assicurato all’imbarcadero. L’intuizione della qualità è nel momento in cui la vaga inquietudine prende corpo e il numero delle domande che vengono poste dalla critica negativa cresce senza risposta. Ogni domanda riguarda un aspetto della completezza, non solo i differenti livelli dell’accumulo, cioè la legittimità della sua attesa. La dignità ne esce calpestata e lacerata, il dubbio diventa angoscioso, la prigionia evidente.
Non bisogna credere che la ricerca delle cause della malattia sia stata sempre parallela a questo bisogno scientifico di ricostituire la normalità. Per lunghi secoli, i rimedi non andavano per nulla di pari passo con lo studio delle cause. Queste ultime erano a volte assolutamente fantastiche, mentre i primi potevano anche avere una loro logica, specialmente quando si fondavano su di una conoscenza empirica di alcune forze della natura. In tempi più recenti, la critica al settorialismo della scienza, e quindi anche della medicina, si è sviluppata da più parti ed è stata fondata su di un concetto di totalità dell’uomo come insieme costituito da diversi elementi naturali, intellettuali, economici, sociali, culturali, politici e così via. È in questa nuova prospettiva che si è sovrapposta l’ipotesi materialista e dialettica del marxismo. La totalità variamente articolata al fondo della quale si poteva ricostituire l’uomo nuovo, vero, reale, e non quello diviso in settori a cui il vecchio positivismo ci aveva abituati, venne incapsulata un’altra volta dall’interpretazione marxista in un determinismo a senso unico. La causa della malattia venne così ricostituita esclusivamente nel meccanismo del capitale, che alienando l’uomo attraverso il lavoro, lo espone ad un rapporto distorto con la natura e quindi con quel concetto di normalità che resta sempre l’antitesi della malattia. Ecco ancora Heidegger: «Ciò che esprime la “non totalità” nell’Esserci, il suo permanente avanti-a-sé, non è né una mancanza nel senso della somma, né qualcosa di non-ancora-divenuto-accessibile, ma un “non-ancora” che l’Esserci, in quanto è l’ente che è, ha sempre da essere. Anche se il paragone con l’immaturità del frutto rivela una certa concordanza, restano però sempre differenze essenziali. Esaminarle significa riconoscere l’indeterminatezza di quanto abbiamo detto finora intorno alla fine e al finire. Anche se la maturazione, cioè l’essere specifico del frutto, in quanto modo di essere del “non ancora” (cioè dell’immaturità), coincide formalmente con l’Esserci per il fatto che l’uno e l’altro sono già da sempre il loro “non ancora” (in un senso che resta ancora da determinare), ciò non significa che la maturazione come “fine” e la morte come “fine” coincidano anch’esse quanto alla struttura ontologica della fine. Con la maturazione, il frutto si compie. Ma la morte a cui giunge l’Esserci è un compimento in questo senso? Certamente con la morte l’Esserci ha “compiuto il suo corso”. Ma ha, nel contempo, necessariamente esaurite le possibilità che gli sono proprie? Queste non gli sono piuttosto sottratte? Anche un Esserci “incompiuto” finisce. D’altra parte l’Esserci ha così poco bisogno della morte per giungere alla maturazione che egli può averla perfettamente raggiunta già prima della fine. Per lo più l’Esserci finisce nell’incompiutezza o anche nello sfacelo e nella consunzione. Finire non significa necessariamente compiutezza. La ricerca si fa ora più incalzante: In qual senso, in generale, la morte dev’essere intesa come la fine dell’Esserci? Finire significa prima di tutto cessare, ma in un senso che importa particolari distinzioni ontologiche. La pioggia cessa. Non è più presente. La via cessa. Questo cessare non fa scomparire la via, ma la determina nella sua consistenza di semplice-presenza. Finire, in quanto cessare, può quindi significare: dissolversi nella non-presenza o raggiungere la totale presenza proprio con la fine. Finire, nel secondo senso, può, di nuovo, o significare l’esser presente come non ultimato (una strada che si interrompe perché incompiuta); oppure costituire proprio l’“esser ultimato” di una cosa presente come tale (con l’ultimo colpo di pennello, il quadro è ultimato). Ma finire nel senso di esser ultimato non implica un compimento. Per contro ciò che pretende esser compiuto dove essere ultimato. Il compimento è un modo che si fonda nell’“esser ultimato”. Ma questo, da parte sua, è possibile solo come determinazione di una semplice-presenza o di un utilizzabile. Anche il finire nel senso di dissolversi può modificarsi In corrispondenza al modo di essere dell’ente. La pioggia è alla fine, cioè cessata. Il pane è alla fine, cioè consumato. Non è più disponibile come utilizzabile. La morte dell’Esserci non si lascia caratterizzare adeguatamente mediante nessuno di questi modi di finire. Se si concepisse la morte come essere alla fine nel senso che il finire ha in uno dei modi sopra esaminati, l’Esserci sarebbe assunto come semplice-presenza, o come utilizzabile. Nella morte l’Esserci non è né compiuto, né semplicemente dissolto, né, tanto meno, ultimato o disponibile. L’Esserci, allo stesso modo che, fin che è, è già costantemente il suo “non-ancora”, é anche già sempre la sua morte. Il finire proprio della morte non significa affatto un essere alla fine dell’Esserci, ma un esser-per-la-fine da parte di questo ente. La morte è un modo di essere che l’Esserci assume da quando c’è. “L’uomo, appena nato, è già abbastanza vecchio per morire”. Il finire, come essere-per-la-morte, può ottenere la sua chiarificazione ontologica solo a partire dal modo di essere dell’Esserci. È quindi presumibile che solo a partire dalla determinazione esistenziale della fine divenga comprensibile la possibilità di un “non-ancora” tale da sussistere “prima” della “fine”. La chiarificazione esistenziale dell’essere-per-la-fine offre anche una base adeguata per stabilire in qual senso si possa discorrere della totalità dell’Esserci, visto che questa totalità si deve costituire attraverso la morte come “fine”. Il tentativo di partire da una chiarificazione del “non- ancora” per giungere a una comprensione della totalità propria dell’Esserci mediante la determinazione del finire, non ci ha condotto in porto. Esso ottenne soltanto questo risultato negativo: il “non-ancora”, che ogni Esserci è, non può essere interpretato come mancanza. La fine, per cui l’Esserci esistendo è, non può essere interpretata adeguatamente come un essere-alla-fine. Nel contempo la ricerca ha rivelato la necessità di capovolgere la propria direzione. La caratterizzazione positiva dei fenomeni in discussione (non-essere-ancora, finire, totalità) è possibile solo attraverso un orientamento rigoroso nel senso della costituzione dell’essere dell’Esserci. A questa chiarificazione contribuisce indubbiamente anche la ricerca che abbiamo finora condotto, mirante a determinare le regioni a cui appartengono le strutture della fine e della totalità che risultano contraddittorie con la modalità ontologica dell’Esserci». (Essere e tempo, op. cit., pp. 370-372).
Penso che non si possa accettare né la tesi positivista di una malattia dovuta al cattivo funzionamento di elementi precisi dell’organismo, come non si possa accettare nemmeno la tesi marxista che riconduce tutto ai misfatti del capitale. La realtà è un po’ più complicata. In linea di principio non possiamo affermare che in una società liberata non ci sarebbero più malattie, e non possiamo nemmeno affermare che le malattie si ridurrebbero in questo felice caso solo al semplice indebolimento di una ipotetica forza vitale ancora tutta da dimostrare. La malattia penso che sia connaturata al vivere dell’uomo in società, cioè corrisponde a un certo prezzo che bisogna pur pagare per correggere di quel tanto le condizioni ottimali della natura allo scopo di ottenere la necessaria artificialità su cui costruire anche la più libera delle società. Certo, in una società libera, in cui le artificialità e quindi gli scompensi fra gli individui sarebbero ridotti allo stretto indispensabile, le malattie sarebbero di meno di una società fondata sullo sfruttamento, per cui ne consegue che la lotta contro le malattie fa parte integrante dello scontro di classe. E ciò non tanto perché le malattie sono causate dal capitale, che sarebbe affermazione determinista e quindi da rifiutare, ma perché in una società più libera esse sarebbero diverse, più vicine, pur nella loro negatività della vita, al nostro essere uomini, espressioni esse stesse, proprio in quanto malattie, della nostra umanità, allo stesso modo in cui oggi tendono a essere soltanto espressioni della nostra terrificante disumanità.
Accettare la protezione della regola è ragionamento fondato su un minimo di giustizia distributiva residuale. Alla lunga le disparità risultano evidenti agli uomini che non si sono lasciati mettere i paraocchi e l’eccesso affiora dalle nubi dove si nascondevano gli dèi. Sul metro di valutazione fissato dal mondo, questo sospetto è infondato e suggerito dalle forze del male, dalla follia, modernamente intesa. Il rischio si prospetta come una necessità intuitiva, una guida impersonale che suggerisce con forza comportamenti irritali. Non accetto più le regole. Dapprima come semplice rifiuto dell’ansia che mi causano, poi come mancato riconoscimento del loro valore fondativi. Poi mi rendo conto che non è un movimento della mia condizione prigioniera, ma una risposta che tiene conto dell’assenza e che cerca di oltrepassare le condizioni della presenza proiettandomi in una nuova e diversa condizione, quella della qualità. Che questa nuova condizione, nella sua desolazione, sia universale totalità non posso saperlo, non mi è dato oltrepassare insieme a dati che vengono prodotti dalla conoscenza, posso solo sapere che devo andare oltre, perfino al di là dei dubbi e dell’organizzazione stessa della critica negativa.
Esattamente Hegel: «La misura è il semplice riferimento del quanto a se stesso, la sua determinazione in se stesso. Così la quantità è qualitativa. Dapprima essa è, in quanto misura immediata, una quantità immediata ed è quindi una certa quantità determinata. Ugualmente immediata è la sua qualità: e una certa qualità determinata. – La quantità, non può come questo limite indifferente ma come esteriorità riferentesi a sé, e così la qualità è, distinta da questa, non va oltre di essa, così come nemmeno la qualità va oltre quella quantità. La quantità è così una determinazione tornata nella semplice uguaglianza con se stessa e costituisce un tutt’uno con l’essere determinato, così come la determinazione costituisce un tutt’uno con la sua quantità. Se dall’ottenuta determinazione si voglia ricavare un principio, ci si può esprimere così: tutto ciò che esiste ha una misura. Ogni esistere ha una grandezza e questa grandezza appartiene alla natura stessa del qualcosa; essa costituisce la sua natura determinata ed il suo intimo essere. Il qualcosa non è indifferente di fronte a questa grandezza: quando questa varia, quando si produce un mutamento della grandezza, la qualità del qualcosa non rimane quella che è, ma cambia. Come misura la quantità ha cessato di essere un limite che non è un limite; è, ormai, la determinazione della cosa, la quale, quindi, se fosse aumentata o diminuita al di là di questa quantità, si distruggerebbe. Una misura, in quanto misura misurante, è una quantità che viene arbitrariamente assunta come unita in sé determinata di fronte ad un estrinseco numero di volte. Una tale unità può, in realtà, essere anche, in sostanza, un’unità in sé determinata come il piede e simili misure ordinarie ma in quanto, come misura misurante, viene, nello stesso tempo, usata per altre cose, essa è per queste soltanto una misura estrinseca, non la loro misura originaria. così il diametro terrestre è la lunghezza del pendolo possono essere presi per sé come quantità specifiche. Ma è arbitrario assumere quest’unità quale parte del diametro terrestre o della lunghezza del pendolo o in quanto determinata ad un particolare grado di latitudine per poi servirsene come unità di misura. Più che altro una tale unità di misura risulta un che di estrinseco per altre cose. Queste hanno di nuovo specificato in maniera particolare l’universale quanto specifico e perciò sono divenute cose particolari. È quindi scorretto parlare di un’unità di misura naturale delle cose. Inoltre un’unità di misura universale deve servire soltanto per un confronto estrinseco; in questo superficialissimo senso, in cui essa viene considerata come misura universale, è completamente indifferente la cosa adoperata a tale scopo. Non deve essere una misura fondamentale nel senso che le misure naturali delle particolari cose vi si mostrino e, in base ad essa, si vengano a conoscere secondo una regola, come specificazioni di un’unica universale misura, la misura del loro corpo universale. Ma, senza questo senso, un’unità di misura assoluta ha soltanto l’interesse e il significato di un comune ed un comune e un universale non in sé, ma per convenzione». (Scienza della logica, libro I, sez. III, cap. I). Per questi motivi non sono mai stato d’accordo del tutto con la tesi un po’ empiristica diretta a far diventare la malattia un’arma, anche se si tratta di una tesi di tutto rispetto, specie per le cosiddette malattie mentali. Non si può, infatti, proporre una cura fondata esclusivamente su di una lotta contro il nemico di classe. Qui siamo davanti ad una semplificazione troppo radicale per essere umanamente reale. La malattia è anche dolore, sofferenza, confusione, incertezza, dubbio, solitudine e tutti questi elementi negativi non si limitano a segnare il corpo, ma intaccano anche la volontà. Stilare proclami di lotta impostati in questo modo è veramente irreale e spaventosamente inumano. Ma la malattia può diventare un’arma una volta che la si capisca, sia nelle sue cause che nei suoi effetti, sempre intendendo questi termini in senso relazionale. È infatti importante capire quali sono i responsabili esterni della mia malattia, capitalisti e sfruttatori, Stato e capitale, ma tutto ciò può anche non bastarmi, io posso anche avere bisogno di chiarire il mio rapporto personale con la mia malattia, che può anche non essere soltanto sofferenza, dolore e morte, ma può essere anche mezzo per meglio capire me stesso e gli altri, la realtà che mi sta davanti e le cose da fare per trasformarla, anche per capire meglio le stesse possibilità rivoluzionarie.
Gli errori su questo problema che sono stati fatti in passato, tutti provenienti da un non mai chiarito rapporto con l’interpretazione marxista, si basavano sulla pretesa di fissare un rapporto diretto tra malattia e capitale. Oggi si può chiarire meglio un tipo di rapporto indiretto, cioè attraverso la coscienza che io ho della mia malattia, non della malattia in generale, come situazione di anormalità, ma della mia malattia come componente della mia vita, come elemento della mia normalità. È questo il problema dell’incoerenza che si presenta all’osservatore analitico come fatto immediatamente condannabile, mentre in se stesso, scavando meglio, riesce a indicare strati sempre più complessi di incertezza all’interno della stessa accumulazione. Non c’è dubbio, difatti, che la malattia costituisca un prodotto del processo accumulativo, ma nello stesso tempo è anche un movimento relazionale che mi appartiene e, in certe situazioni, più racchiudermi in una serie di flussi estremamente stilizzati, costringendomi a filtrare la totalità del reale attraverso questa condizione.
L’inquietudine del mondo è articolata in mille risposte non chiare che fornisco a mille angosce. Possiedo una vasta nomenclatura ma non ho modo di controllarla, piuttosto mi sento controllato da essa. Non riesco a dominare in una unità dominante la vasta estensione di questi possedimenti conoscitivi. Lo spazio e il tempo si rompono in frammenti che dovrebbero collimare fra loro in base alle regole di una logica che non riesce a farli stare insieme, non li controlla né li connette. Manca la grande organizzazione che pensi al posto mio, l’arché che tutti sbandierano ai quattro venti. Il potere che ho fra le mani produce solo apparenze, risibili inclinazioni alle recite scolastiche su palcoscenici periferici, guitti e pagliacci si susseguono sotto i miei occhi e mi invitano a indossare le loro divise multicolori. Tutto questo mi causa un aprirmi tormentato, una serie di dubbi che la critica negativa alimenta contrapponendosi a un astratto modello di unità logica che non arriva mai a compiersi. La qualità si affaccia all’orizzonte remoto come sospetto non certezza, è un rischio il viaggio, niente è meno garantito di affrontare le nuvole che si stagliano nel cielo privo di segni.
La scoperta di un’insospettata incoerenza può anche mettere in dubbio la propria identità come coscienza immediata, la stessa presunzione di controllo della volontà, facendo sorgere il desiderio e la possibilità stessa di un riassorbimento nel meccanismo stesso, un desiderio di maggiore certezza e coerenza, tutti elementi che conducono a una grave penalizzazione non appena ci si accorge di quanto avaro sia il meccanismo del senso nei confronti dell’indispensabile ricerca della verità. L’intuizione di questo contrasto, insieme al sospetto che alla coerenza si può rispondere in un modo diversamente coerente, sempre restando radicati nell’ambito accumulativo, ci fa scoprire un territorio al di là dell’ordine apparente del catalogo, un territorio che comunque resta sempre al di qua dell’inquietudine. In questo modo scrive Norman Kemp Smith: «Nella quarta parte del primo libro del Trattato Hume espone per la prima volta la sua dottrina del primato della coscienza comune. Nello stesso luogo dimostra inoltre che questa dottrina segue come un corollario dall’altra sua più fondamentale tesi che il sentimento ha il primato sulla ragione. Le “convinzioni naturali” che sono essenziali alla coscienza comune e la determinano – la convinzione della continuazione dell’essere e la convinzione che le realtà che continuano sono causalmente attive – quando siano formulate in astratto, e perciò in termini universali, si trovano in conflitto l’una con l’altra. Esse operano, afferma Hume, nel modo in cui operano le passioni, come fattori di equilibrio in un meccanismo complesso – il meccanismo per il cui tramite la Natura ha provveduto ai bisogni della coscienza animale, e ai processi “raziocinanti” richiesti nelle speciali e più complicate condizioni dell’esistenza umana. Questa ingegnosa linea argomentativa offrì a Hume favorevoli opportunità di soffermarsi sulle incoerenze e le inconsistenze dei tipi razionali di filosofia, il dogmatico e lo scettico, considerati come distinti dal suo stesso tipo ragionato di scetticismo “mitigato”. Per il giovane Hume – in nessun’altra parte del Trattato il suo “ardore” e le sue “infiammate immaginazioni” sono poste in maggiore evidenza – queste occasioni erano di certo troppo allettanti perché egli non le sfruttasse in pieno; e le espressioni troppo vigorose che si lasciò sfuggire, se risultarono efficaci nell’arrestare l’attenzione del lettore, si prestarono a portarlo fuori strada con suo danno, come egli più tardi riconobbe. Questo è il motivo per cui i critici di Hume hanno tratto quasi invariabilmente le loro citazioni preferite dalla quarta parte del primo libro; e per queste finalità di una critica a lui avversa nessun passo è stato citato con maggiore frequenza, dal tempo del Reid fino ad oggi, di quello in cui Hume parla della sua “melanconia e delirio filosofici”, e del non saper trovare rimedio contro le “chimere” dello studio tranne che nel darsi alle faccende prive di sollecitudini della vita ordinaria. “Pranzo, gioco una partita a tavola reale, converso, sto allegro con i miei amici; e quando, dopo un sollievo di tre o quattro ore, vorrei tornare a quelle speculazioni, mi appaiono così fredde, e forzate e ridicole, che non posso trovare nel mio animo la forza di proseguire in esse”. L’intenzione dei critici che citano questo passo è, come nel caso di Beattie, quella di attribuire a Hume l’opinione “che l’uomo deve credere una cosa per istinto, e deve anche credere il contrario per ragione... e che l’intelletto umano, agendo da solo, sovverte completamente se stesso, e prova per mezzo di argomentazioni, che per mezzo di argomentazioni nulla può essere provato”. Se Beattie, e coloro che seguono le sue orme, fosse stato giustificato nel dire che questo è lo sbocco della filosofia di Hume, sarebbe anche giustificato nel commento ulteriore al quale procede: “Se Colombo, prima di accingersi alla sua famosa spedizione verso il mondo occidentale, si fosse preso il gusto di scrivere una storia dei paesi che avrebbe visitato, gli amatori della verità, e gli interpreti della natura, avrebbero tratto qualche progresso o qualche soddisfazione da una tal prova della sua ingenuità? E il sistema che, senza riguardo all’esperienza, un filosofo costruisce nel suo studio, intorno alla natura dell’uomo, non è egualmente frivolo? Se Colombo, in quella tal storia, avesse descritto gli Americani con due teste, piedi fessi, ali, e carnagione scarlatta, e, dopo averli visitati, e aver trovata la sua descrizione falsa in ogni particolare, avesse tuttavia reso pubblica quella descrizione al mondo, affermandola vera, e nello stesso tempo riconoscendo che non corrispondeva alla sua esperienza; io non so se l’umanità sarebbe stata più disposta a biasimare la sua mancanza di sincerità, a ridere della sua irragionevolezza, o ad aver pietà della sua deficienza d’intelletto. E tuttavia abbiamo conosciuto un metafisico il quale escogitò un sistema della natura umana e, sebbene consapevole che non corrispondeva alle reali apparenze della natura umana, lo consegnò al mondo come sana filosofia”. Come è già stato esposto, questo modulo interpretativo presenta in maniera erronea precisamente ciò che è centrale e massimamente caratteristico nell’insegnamento di Hume. L’intenzione e lo sbocco della sua filosofia sono stati in egual maniera male interpretati. “La mia attività pratica, voi dite, confuta i miei dubbi. Ma voi non comprendete il significato del mio problema. Come agente, sono certamente soddisfatto della situazione; ma come filosofo, che ha qualche elemento di curiosità, non dirò di scetticismo, desidero conoscere il fondamento delle mie inferenze riguardo a questioni di fatto e di esistenza”. Le riflessioni di Hume nello studio sono state, a suo modo di vedere, valide; ed emergendo dallo studio egli agisce in base ai principii a cui quelle riflessioni l’hanno affidato. Non gli hanno esse insegnato che dobbiamo fare affidamento sulla guida della Natura, la quale opera in tutte le questioni realmente ultime non per il tramite della ragione ma per mezzo del sentimento (che include la credenza)? La conformità – concesso, per quanto ciò sia discutibile, che questo sia il termine d’uso più pertinente – è stata filosoficamente giustificata, e si trova in accordo con lo scetticismo “mitigato” che un essere riflessivo, capace di imparare le lezioni dell’esperienza, non può che approvare. “Ogni passione è da esso mortificata, tranne l’amore della verità; e quella passione non è mai, né può essere portata a un grado troppo alto. [...] Non solleticando alcuna passione irregolare, esso guadagna pochi sostenitori: facendo opposizione a tanti vizi e follie, solleva contro di sé un gran numero di nemici, che lo stigmatizzano come libertino, profano e irreligioso”. La sicurezza richiesta nei ragionamenti della vita quotidiana, e per l’azione, non è stata compromessa. “La Natura manterrà sempre i suoi diritti, e prevarrà da ultimo sui ragionamenti astratti di qualsiasi genere”». (The Philosophy of David Hume. A Critical Study of its Origins and Central Doctrines, ns. tr., London 1964, pp. 543-545).
Non sapremo mai con precisione in che modo una riflessione o una scoperta contribuiscano a mantenere e perfezionare l’accumulazione e dentro quali limiti diventino anticamera dell’inquietudine. L’interruzione del ritmo del consenso produce un improvviso risveglio del dubbio, mentre la stessa circolazione dei residui qualitativi, la semplice pallida luce che filtra da una finestra superdifesa, riescono a illuminare più di quanto non facciano di regola. Per una coscienza ordinata queste esperienze sono molto vicine all’annichilimento, dove non si capisce bene se si deve gioire di una strana esperienza o ci si deve ancora di più chiudere davanti all’ignoto che scopriamo nascondersi nel fondo del meccanismo accumulativo stesso.
Emerge una doppiezza di fondo del gesto di controllo, un gemellaggio con l’assurdità della certezza che dovrà essere provata altrove, ma che adesso sappiamo non può non trovarsi anche nel flusso orientato, perché in caso contrario non sarebbe mai stata neanche altrove. È la scoperta che ci seduce all’interno della certezza stessa, e ci seduce proprio per questo, perché non ci costringe al rischio. Sappiamo di essere oggetto anche noi e ci lasciamo sorprendere e vi proviamo piacere, nella sorpresa e nello scandalo che ne consegue per la nostra correttezza mentale, per la validità della nostra certezza analitica di fondo, cui non siamo disposti a rinunciare. C’è un suggerimento incoerente di sottrarre qualcosa al processo di incameramento del senso, e questo suggerimento, di regola, ci viene da altri flussi, da individui diversi, da campi che sconosciamo, da situazioni che pensiamo estranee. Insomma, più che scopritori, con tutto il rischio che la qualità comporta, ci sentiamo complici in attesa di un avvenimento successivo che non dipenderà da noi che in minima parte.
L’abbandono non è una rinuncia alla lotta, ma una diversa disposizione all’esperienza. Non è nemmeno una espressione melanconica. La vita qualitativa pulsa ancora dentro di me con tutti i suoi limiti e le sue regole, ma anche con le sue straordinarie forze conoscitive. L’abbandono non è nemmeno dolce o rigeneratore, non modifica le condizioni produttive, anzi le ripropone per una ulteriore modificazione. Deve essere messo a frutto, fatto fiorire e non lasciato, come accade qualche volta, nella condizione di passività contemplativa. E questo fiorire è possibile solo facendo cessare la partecipazione complice all’apparenza del mondo, riprendendo la propria corresponsabilità e coinvolgendosi completamente nell’oltrepassamento. Il dramma della qualità non è conoscitivo, operazione sempre di natura passiva, accumulativa, ma è attivo, quindi privo di antinomie. Nell’azione io non so quello che faccio, che tale sembra essere il mio agire a un occhio estraneo, ma sono quello che opero. La trasformazione che l’azione rende possibile raccoglie la totalità di me stesso e mi mette in condizione non solo di diventare quello che sono, ma anche di rendere possibile il mio destino.
Riguardo le tecniche di “abbandono”, così Heidegger: «Se vogliamo determinare ontologicamente la totalità unitaria delle strutture dell’Esserci, dobbiamo innanzitutto domandarci: il fenomeno dell’angoscia (e ciò che in esso viene aperto) è in grado di esibire la totalità dell’Esserci in modo così fenomenicamente cooriginario da fornire la prospettiva richiesta dalla determinazione della totalità unitaria? Ciò che l’angoscia contiene globalmente in sé può essere riassunto così: l’angosciarsi, in quanto situazione emotiva, è una modalità dell’essere-nel-mondo; il “davanti-a-che” dell’angoscia è l’essere-nel-mondo in quanto gettato; il “per-che” dell’angoscia è il poter-essere-nel-mondo. Il fenomeno dell’angoscia, nella sua totalità, manifesta, quindi l’Esserci come essere-nel-mondo effettivamente esistente. I caratteri ontologici fondamentali di questo ente sono l’esistenzialità, l’effettività e l’esser-deietto. Queste determinazioni esistenziali non appartengono a un composito come sue parti non necessariamente sempre compresenti; al contrario, fra di esse ha luogo una connessione originaria in cui si esprime quell’unitarietà dell’insieme delle strutture che andiamo cercando. Nell’unità di queste determinazioni d’essere dell’Esserci si rende ontologicamente accessibile l’essere dell’Esserci come tale. Com’è da intendere quest’unità? L’Esserci è un ente per cui, nel suo essere, ne va di questo essere stesso. Nel quadro della costituzione dell’essere della comprensione, il “ne va di” si è chiarito come l’autoprogettantesi essere-per il più proprio poter-essere. Questo poter-essere è ciò in-vista-di-cui l’Esserci è sempre così com’è. L’Esserci, nel suo essere, si è già sempre commisurato a una possibilità che gli è propria. L’essere-libero per il poter-essere più proprio, quindi per la possibilità dell’autenticità e dell’inautenticità, si manifesta, nell’angoscia, in una determinazione elementare e originaria. Ma essere-per il proprio poter-essere significa ontologicamente: l’Esserci, nel suo essere, è già sempre avanti rispetto a se stesso. L’Esserci è già sempre “al di là di sé”; non rispetto ad altri enti diversi da sé; ma in quanto essere-per il poter-essere che esso stesso è. Questa struttura d’essere dell’essenziale “ne va di” noi la chiamiamo l’essere-avanti-a-sé dell’Esserci. Questa struttura concerne la costituzione dell’Esserci nella sua totalità. L’“esser-avanti-a-sé” non denota la tendenza isolata di un soggetto “senza mondo”, ma caratterizza l’essere-nel-mondo; il quale, consegnato a se stesso, è già da sempre gettato in un mondo. L’abbandono dell’Esserci a se stesso si rivela originariamente e concretamente nell’angoscia. In una prospettiva più completa l’“esser-avanti-a-sé” significa: avanti-a-sé-essendo-già-in-un-mondo. Appena questa struttura, essenzialmente unitaria, si rivela nella sua fenomenicità, si fa più chiaro anche ciò che già venne in luce nell’analisi della mondità. Allora risulta che l’insieme dei rimandi della significatività, costitutiva della mondità, è “ancorata” saldamente a un “in-vista-di”. La concatenazione dell’insieme dei rimandi e dei rapporti del “per” con ciò per cui ne va dell’Esserci, non è il risultato della saldatura fra un “mondo” di oggetti semplicemente presenti e un soggetto. Essa è piuttosto l’espressione fenomenica della costituzione dell’Esserci originariamente unitaria, la cui unità è stata ora esplicitata nel “in-avanti-a-sé-essendo-già-in”. Detto altrimenti: l’esistere è sempre effettivo. L’esistenzialità è sempre determinata in modo essenziale dall’effettività. E di nuovo: l’esistere effettivo dell’Esserci non è soltanto, in generale e indifferentemente, un gettato poter-essere-nel-mondo, ma è anche già sempre immedesimato con un mondo di cui si prende cura. In questo deiettivo esser-presso..., si annuncia, esplicitamente o no, compresa o no, la fuga davanti allo spaesamento, il quale, come l’angoscia latente, resta per lo più coperto, perché la pubblicità del Si distrugge ogni inquietudine. Nell’“avanti-a-sé-essendo-già-in-un-mondo” è essenzialmente coincluso il deiettivo esser-presso l’utilizzabile intramondano di cui ci si prende cura. La totalità formale esistenziale del tutto strutturale ontologico dell’Esserci significa: avanti-a-sé-esser-già-in (un mondo) in quanto esser-presso (l’ente che si incontra dentro il mondo). Questo essere è espresso globalmente dal termine Cura, che qui è usato nel suo senso ontologico-esistenziale genuino». (Essere e tempo, op. cit., pp. 299-302). Degli elementi di controllo, la coscienza immediata ha una concezione che potrei definire costitutiva, cioè essa non li considera come strumenti, ma come parti di se stessa, la sua disposizione al controllo segue quindi la sorte della coerenza del meccanismo accumulativo, il quale si sviluppa all’infinito in quanto meccanismo, giustificandosi non con uno scopo da raggiungere ma con un procedimento da eseguire. Non dimentichiamo che questi movimenti, per quanto differenti tra loro, non si inseriscono mai all’interno di un movimento più importante, o superiore, dove scompaiono per ripresentarsi sotto una veste diversa, essi permangono e si relazionano continuamente, dando vita a processi di riorganizzazione che nulla hanno a che vedere con il meccanismo dialettico. Occorre sempre ricordare queste cose per evitare possibili confusioni.
Ne deriva, che la volontà non impone un controllo e un dominio per ottenere lo scopo di assoggettare a sé una parte sempre più ampia dell’accumulazione, ma semplicemente perché non può fare in modo diverso, fin quando, appunto, la stessa circolarità del suo continuo modificare l’oggetto, non la porterà a una situazione complessiva d’inquietudine che comunque in questa nostra discussione viene tenuta da parte. È un controllo che si realizza nell’accumulazione quantitativa, ma che non ha uno scopo quantitativo in se stesso, gli manca cioè l’oggetto altro, che la coscienza immediata pone sempre nel meccanismo accumulativo e non nel controllo, essa tra queste due cose fa sempre una netta differenziazione, tanto da non assegnare mai al controllo o al dominio un suo contenuto oggettuale, ma sempre l’aspetto di un movimento relazionale interno al flusso orientato stesso. Il fascino di una seduzione estranea, sempre di provenienza quantitativa, causa innanzi tutto una rottura di questo meccanismo di controllo, che pur non smettendo la sua attività, nel qual caso ci troveremmo in piena inquietudine, lascia spazio alla possibile negazione di se stesso, per il momento assolutamente ipotetica, anzi sarebbe bene dire fantastica.
La seduzione dell’incoerenza invita alla fantasia e questa rinvia al perché della seduzione iniziale, al dubbio di come si sia potuta infiltrare l’incoerenza all’interno della certezza quantitativa. La conclusione più ragionevole sarebbe quella di capire come all’interno della certezza si nasconda l’incertezza, riflesso e specchio di quello che accade all’interno della coerenza dove si nasconde l’incoerenza. L’ambiguità della seduzione si trasferisce nell’incoerenza che diventa anch’essa ambigua, e ciò invece di presentarsi come la semplice faccia negativa della coerenza. Ma ambiguità significa possibilità di essere e non essere la stessa cosa, punto di riferimento e luogo di perdizione, santità e dannazione, peccato e purezza. Comunque, in qualsiasi modo si metta questa esperienza, non può mai presentarsi come semplice riduzione al meccanismo di oggettivazione stesso. Anche quando questo accade, è sempre un processo stranamente ambiguo che viene cancellato a forza, con il controllo e il dominio della volontà.
La qualità è un baluginare nella notte, un fiorire improvviso della sterilità, un compagno intravisto per un attimo nella solitudine, compagno non di pena ma di avventura. Nel suo punto infinitesimale comprende e assorbe cancellandole tutte le apparenze e le illusioni che l’hanno quantificata. Senza tempo essa è il vagito del neonato e il rantolo del moribondo, insieme, strani rumori che annunciano l’inizio e la fine della vita, questo breve intermezzo per fare un mondo, esplorarlo e distruggerlo. Rinunciare a uno scopo può essere un modo per aggirare la volontà, scavandole la terra sotto i piedi, ma lo scopo deve sopravvivere sotto altre vesti, prendersi cura di me, stornare gli antichi appetiti, alimentare nuovi vizi, non pretendere di selezionare nocività e crescita in me stesso, quello che un’infamia scientifica chiama salute, quindi accettare vincendo di imparare a perdere senza appestare l’aria con i propri lamenti.
Insostituibile la riflessione di Hegel: «La vera coscienza morale è disposizione di volere ciò che è buono in sé e per sé; essa quindi ha princìpi stabili; cioè, questi sono per essa le prescrizioni e i doveri oggettivi per sé. Differente da questo suo contenuto, dalla verità, è soltanto l’aspetto formale dell’attività del volere, il quale, come tale, non ha un contenuto proprio. Ma il sistema oggettivo di questi princìpi e doveri e l’unione del sapere soggettivo col medesimo sistema esiste soltanto dal punto di vista dell’eticità. Qui dal punto di vista della moralità, la coscienza è senza questo contenuto oggettivo; così, per sé, è l’infinita certezza formale di se stessa, che appunto perciò, è, in pari tempo, come certezza di questo soggetto. La coscienza morale esprime l’assoluta legittimità dell’autocoscienza soggettiva, di sapere, cioè, in sé e da se stessa che cosa è diritto e dovere e di riconoscere null’altro, se non ciò che così essa conosce come bene; nel tempo stesso, nell’affermazione che ciò che essa così sa, e vuole, è, in verità, diritto e dovere. La coscienza, in quanto tale unità della volontà soggettiva e di ciò che è in sé e per sé, è un santuario, che sarebbe sacrilegio toccare. Ma, se la coscienza di un determinato individuo è conforme a quest’idea della coscienza, se ciò che esso ritiene o spaccia per buono, è anche realmente buono; ciò si riconosce unicamente dal contenuto di questa cosa che deve esser buona. Che cosa sia diritto e dovere, in quanto elemento in sé e per sé razionale delle determinazioni volitive, non è essenzialmente né proprietà particolare di un individuo, né nella forma del sentimento, o, altrimenti, di un sapere singolo, cioè sensitivo; ma è essenzialmente in quella delle determinazioni universali pensate, cioè nella forma delle leggi e dei precetti. Quindi, la coscienza morale è sottoposta a questo giudizio, se è, o non è, vera; il suo richiamo soltanto a se stessa è immediatamente contrastante con ciò che essa vuol essere: la regola d’un modo d’agire razionale, valido in sé e per sé, universale. Quindi, lo Stato non può riconoscere la coscienza morale nella sua forma caratteristica, cioè in quanto sapere soggettivo; tanto poco quanto, nella scienza, l’opinione soggettiva, l’assicurazione e il richiamo ad una opinione soggettiva, hanno un valore. Ciò che nella vera coscienza morale non è distinto è, però, distinguibile; ed è la soggettività determinante del sapere e del volere, che può separarsi dal vero contenuto e porsi per sé, e può degradare il medesimo a forma e ad apparenza. L’ambiguità, rispetto alla coscienza morale, sta, quindi, nel fatto che essa è presupposta nel significato di quell’identità del sapere e del volere soggettivo e del vero bene, e così è affermata e riconosciuta come un che di santo; e precisamente, in quanto solo riflessione soggettiva dell’autocoscienza in sé, pretende tuttavia al privilegio, il quale spetta a quell’identità stessa, soltanto in virtù del suo contenuto valido in sé e per sé, razionale. Al punto di vista morale, come esso è distinto dall’etico in questa trattazione, appartiene soltanto la coscienza morale formale; la verità è stata menzionata soltanto per fissare la sua differenza e rimuovere il possibile equivoco che qui, ove si considera soltanto la coscienza morale formale, si parli della verità, la quale è racchiusa nel sentimento etico, che si presenta solo in seguito». (Lineamenti della filosofia del diritto, tr. it., Roma-Bari 1979, pp. 141-142). L’organizzazione della nostra vita secondo i canoni della ragione, secondo le regole della logica dell’a poco a poco, non ci garantisce della sorpresa dell’ambiguità. Possiamo togliere di mezzo tutti gli ostacoli, e se lo facciamo è sempre la paura a restare dentro di noi, e possiamo ferocemente diventare diritti e rigidi come un bastone, ma da queste operazioni non viene mai un senso di liberazione, spesso ci sentiamo trionfatori o conquistatori della nostra volontà, pensiamo di averla piegata alle superiori necessità dello spirito o, più modestamente, dell’intelletto, ma non ci rendiamo conto che stiamo parlando della stessa cosa e che se qualcuno è stato piegato siamo stati noi che abbiamo chinato il capo acconsentendo alla conquista e alla vittoria, al controllo e al dominio, il nostro trionfo, come vedremo molto meglio fra poco, segna, anche la nostra accettazione definitiva e supina del meccanismo di catalogazione. E ciò non potrà che ricondurci un’altra volta, forse con minori possibilità a nostro favore, sulla strada dell’inquietudine. Ma, per il momento, quello che possediamo è soltanto un senso di imbarazzante acquisizione.
La linearità non seduce ma rassicura, come l’oggettività e il meccanismo, insomma come qualsiasi cosa a cui possiamo affidare le nostre perplessità. Il fascino dell’incertezza sta invece nel non sapere che cosa accadrà nel prossimo giro, cioè all’interno stesso della circolarità. L’abbandono della sicurezza non è ancora abbandono del meccanismo accumulativo, ma è scoperta della perversione nell’ortodossia stessa, nel rigore estremo dell’oggetto logico. È la rigorosità nel suo riproporsi continuo che lascia slittare al di sotto di se stessa la straordinaria possibilità dell’incoerenza. Qui non c’è ombra di dubbi o di supposizioni crepuscolari, nulla di tutto ciò, non si tratta di momenti di debolezza, la volontà scopre qualcosa che non la fa smarrire, se non altro perché di questo qualcosa essa capisce ben poco e quel poco che avverte tende ad allontanarlo.
C’è di certo un distacco implicito all’interno della linea di certezza che l’accumulazione porta avanti, dapprima come attenuazione, come imbarazzo di una constatazione, poi come ripiego verso l’eventualità sempre più palese di una componente distruttiva intrinseca al processo che sembra suggerire l’esistenza di altri itinerari che in effetti non esistono. Siamo davanti ad uno specchio incrinato, dove possiamo leggere nuovi paradigmi di corrispondenza con l’oggetto che prima non era possibile vedere nel semplice rispecchiamento produttivo. L’invasione dell’incertezza viene quindi a gettare un alone di incredulità nell’ambito stesso dell’oggetto e nel movimento continuo della coscienza immediata. Non c’è alcuna rottura però si interpone un sospetto nuovo nel modo di lettura del meccanismo di accumulazione e rammemorazione. Su questo lato del ragionamento, così Giorgio Colli: «Il moltiplicarsi vertiginoso dell’espressione scritta ha demolito il senso di sicurezza che le era proprio come espressione di un acquietamento. Poi è venuta la concorrenza di altri mezzi espressivi, che hanno rimesso in auge la mobilità che sta all’interno del pensiero umano». (La ragione errabonda, Milano 1982, p. 300).
L’esistenza dell’altro non desta la curiosità della conoscenza o il desiderio di possesso, l’altro è caratterizzato dall’assenza, non c’è nel mondo e non mi si contrappone, lo vado a poco a poco intuendo e comincio a percepire i segni presenti di questa sua assenza, i residui, i valori, ma essi appartengono alle tracce culturali che vado perseguendo per i miei scopi di conquista. Io subisco l’assenza come lacerazione e incompletezza e non può esserci possesso di queste condizioni che sono piuttosto portato ad allontanare e non ad avvicinare nell’impadronimento. L’indagine conoscitiva identifica la possibilità di acquisizione, il luogo dell’incontro, l’intuizione dell’assenza fa capire, indirettamente, che questo luogo, per l’assenza, è da collocare altrove. Non è l’ubbidienza alle regole che mi conduce alla giustizia o alla verità, ma la loro cancellazione dolorosa in un oltrepassamento che mi fa trovare di fronte alla desolante estensione della qualità dove la molteplicità e l’apparenza del mondo scompaiono per dare vita all’azione. Devo rischiare tutto me stesso in un viaggio mai tentato, entrare nell’assenza dell’evidente attraverso l’apertura intuitiva che non mi fa conoscere ma attraverso la quale vengo intuito da ciò che era assente e ora si profila, desolato, nella cosa.
Quando il rapporto produttivo denuncia un improvviso confine d’indecisione la coscienza immediata s’impadronisce di un altro territorio produttivo, sempre interno al meccanismo accumulativo, ma che diventa una specie di doppio negativo dell’oggetto senza con questo essere una vera e propria negazione. Nell’incoerenza possibile si replica il rito della coerenza che finalmente può così comunicare al soggetto tutta la tragica realtà del fare coatto. Nella decisione della volontà si nasconde quindi un duplice argomento che l’immensa accumulazione analitica non riesce però a giustificare fino in fondo. Prima o poi la coscienza immediata finisce per accettare l’esistenza dell’incoerenza come si fa con qualcosa di cui fino a pochi attimi prima si era negata la realtà, cioè con stupore e controvoglia.
L’oggetto, e il proprio essere relazione oggettiva nell’ambito modificativo della produzione di oggetti, viene scisso in una duplice considerazione, come elemento coerente con tutto l’universo accumulativo, e come elemento incoerente con il medesimo universo. Si ha quindi una forma di separazione anche nella volontà stessa, che in quanto oggetto riconosciuto e perfino cercato, distingue sé da se stessa cominciando a perdere se non altro una parte di quella carica fattiva che l’aveva fino a questo momento contraddistinta, la volontà dopo essersi considera come possibile oggetto d’incoerenza diventa meno rigida, più accessibile ad una futura inquietudine. Certo, ogni sprazzo dispersivo di possibile incoerenza, sollecita la coscienza immediata ad un recupero e ad un riordino, in quanto essa avverte qualcosa di pericoloso e principalmente di eccessivo, da cui vuole distaccarsi cancellandone anche il ricordo, ma quando il movimento è in corso questa difesa assoluta, questa cancellazione, non è possibile per cui la volontà ricorre ad una difesa più moderata, una specie di chiamarsi fuori, di estraniarsi da una complicazione che sta osservando nell’oggetto e nell’accumulazione. Questo semplice distacco la convince che la trasparenza precedente, attraverso la quale era emersa l’incoerenza parallela alla tanto superiore coerenza, è stata un’illusione, una forma di privazione dell’oggettività dell’oggetto. Così Gottlob Frege: «Vediamo ora come i logici della scuola psicologica si lascino sfuggire le distinzioni reali più sottili. Già ricordai che non afferrano la differenza fra note caratteristiche e proprietà. A essa si connette la distinzione, su cui tanto ho insistito, fra oggetto e concetto, e quella fra concetti di primo e di secondo grado. Naturalmente non riescono a cogliere nemmeno queste ultime: per essi infatti tutto è rappresentazione. Di conseguenza non possono dare una spiegazione giusta di quei giudizi, che sogliono esprimersi con le parole “esiste”, “si dà” e simili. Erdmann raggruppa in un tutto unico questa esistenza con la realtà, che si trova pure non chiaramente distinta dall’oggettività. Quanto ho detto può essere sufficiente a illustrare il mio punto di vista mediante il contrasto con quello della logica psicologica. La distanza che mi separa da essa è così grande, che non credo vi sia alcuna speranza di poter influire fin da oggi su tale indirizzo colla presente mia opera. Mi fa l’effetto, come se l’albero da me piantato dovesse sollevare un pesantissimo carico di pietre, per procurarsi spazio e luce. Pur tuttavia non perdo la speranza che, col tempo, questo libro possa collaborare al crollo della logica psicologica». (Logica e aritmetica, tr. it., Torino 1965, p. 493).
L’irrealtà attribuita a questa parte dell’oggetto emersa per trasparenza, allontana i problemi dalla coscienza immediata ma, come ho detto, non la lascia del tutto simile alla situazione precedente. Nessuna relazione è senza conseguenze. Il movimento determina sempre modificazioni, interpretazioni o trasformazioni. Non può essere altrimenti. Solo che il giudizio di irrealtà proposto nei confronti dell’incoerenza, se da un lato prepara al dubbio la coscienza, dall’altro respinge ogni vera e propria critica nei riguardi del meccanismo accumulativo nel suo insieme. Lo sguardo al di là di un confine interno all’oggetto stesso, quindi proprio nell’ambito della relazione più ordinata che la coscienza immediata possa immaginare, non c’è dubbio che ha visto una compresenza di credibilità e incredibilità, di nettezza e confusione, di coerenza e di incoerenza.
L’assistenza delle analogie e delle metafore è interessante, unico mezzo per parlare dell’esperienza diversa, quando sono scarsamente coerenti, quando rifiutano di accettare le regole del mondo in cui pretendo fare loro giocare un ruolo volutamente dimostrativo. È ovvio che ci sono molti modi per rendere incoerente un riferimento analogico, spesso ci riesco, altre volte diventa talmente pesante l’analogia che è meglio lasciare perdere.
Ma cos’è realmente questo strano territorio che la coscienza immediata intravede e respinge e che siamo sicuri esiste anche nell’ambito della rigida modificazione? Esso rappresenta secondo me due cose di grande importanza. Primo, la perdita della specificazione all’interno dell’oggetto nel punto in cui lo si cerca di approfondire, secondo, la traccia della totalità del reale all’interno di ogni relazione, quindi anche dell’oggetto, per quanto puntuale essa si possa immaginare. Ora, sia l’abbandono della superficiale specificazione, sia il riconoscimento della totalità come presenza fisica nascosta proprio dall’occasionalità della specificazione, vengono vissute e valutate come espressione di incoerenza. Riflettendo su Schelling, scrive Walter Schultz: «L’inizio filosofico di Schelling si distingue essenzialmente da quello di Fichte, e questa differenziazione di posizioni dei due pensatori si realizza già nel primo periodo schellinghiano. Fichte si distingue nettamente dalla filosofia di Kant. Nella posizione di Kant sulla “appercezione trascendentale” – l’“Io penso”, che deve accompagnare tutte le mie rappresentazioni – egli vede offerta la possibilità di elevare l’Io ad autentico principio di tutta la filosofia e, partendo da esso, di fondare riflessivamente, per gradi successivi di comprensione, la totalità del sapere. Questo Io deve venire presupposto, come fondamento della possibilità del sapere per la coscienza finita; ma esso rimane sempre relativo a quest’ultima. Il giovane Schelling non esce fuori di una tale filosofia, criticamente riflettente sopra la possibilità del sapere. Anch’egli tende verso un’Unità suprema, nella quale, come nell’Intero, tutto è racchiuso. Una cosa non può essere la realtà suprema, perché essa viene necessariamente ricompresa nell’ Io. L’ Io che sa, in quanto sa, può rendere tutte le cose oggetti saputi. Così Schelling, in armonia con Fichte e in opposizione a Spinoza (al quale questa prospettiva era ancora sconosciuta), spiega che l’Incondizionato mai e poi mai può risiedere in ciò che può venire condizionato (saputo), ma solo in ciò che sempre e solo è condizionante. Un tale ente che sia essenzialmente solo condizionante, però, è soltanto ed esclusivamente l’Io assoluto come principio di ogni sapere. Questo passaggio da Spinoza a Fichte porta con sé, però, ardui problemi. L’ Io assoluto come principio incondizionato non appare a Schelling, come viceversa appariva a Fichte, il fondamento riflessivamente circoscritto della coscienza finita. Schelling vuole intendere l’Io assoluto come un supremo Uno originario, che si eleva al di sopra di ogni scissione; da questo punto di vista egli rimane spinoziano. Schelling pone, così, l’Io assoluto in opposizione alla sfera della determinatezza finita. Dato questo, però, sorgono per lui due questioni: come può, questo Incondizionato, venire colto in se stesso da noi, che siamo nel mondo condizionato? In secondo luogo: come si può, partendo dal mondo che è condizionato dalle differenze, comprendere l’Incondizionato, che è puro essere?». (System des transzendentalen Idealismus, ns. tr., Hamburg 1957, pp. X-XI).
Non dimentichiamo che nel meccanismo accumulativo, la specificazione è un fatto centrale, qui si producono oggetti attraverso la modificazione, siamo nel regno della volontà dominatrice. Ora, la stranezza dell’intuizione incoerente, la perdita improvvisa all’interno dell’oggetto stesso, l’emersione o l’inglobamento in ambiti del tutto sconosciuti, sono tutti elementi di interferenza, di distorsione. Nel regno dell’ordine è la festa che per un attimo fa intravedere i suoi balenii attraverso la rigida copertura della fabbricazione. È il luogo della tensione che traspare, il segno di altri flussi che si intersecano sotterraneamente nell’oggetto, il segno della totalità delle relazioni possibili. Elementi della vita che si affacciano per subito scomparire, per non diventare neanche oggetto di ricerca o di riflessione, per essere cancellati del tutto, per essere considerati qualcosa di irreale, di incredibile.
Ma, ci si potrebbe chiedere, una volontà tanto severa e punitiva come può, in condizioni diverse, lasciar passare l’inquietudine? Io penso che siano possibili diverse risposte, ma due sono le più importanti. Primo, nell’apertura la coscienza immediata ha un cominciamento semplice che non mette in discussione se stessa, e questo vale a posteriori. A priori, c’è un secondo argomento, i segni dell’inquietudine provengono dal meccanismo di accumulazione nel suo insieme non dal singolo oggetto. Di fronte alla singola perdita di coerenza, la volontà reagisce sempre allo stesso modo, correggendo la divagazione fantastica, la trasparenza, il breve ricordo, l’entusiasmo di un attimo. Di fronte alla massiccia pressione dell’accumulo dell’oggettivazione, reagisce con un senso via via sempre più ampio di impotenza, di incapacità a controllare, a dominare. Più la produzione catalogativa cresce, più i flussi orientati si fanno numerosi e quindi producono una massa enorme di dati, più cresce il fare coatto, più la volontà, per quanto forte essa sia, comincia a sentirsi incapace di dominare tutto. Nei casi in cui questi flussi orientati sono scarsi, in cui l’accumulazione procede lentamente e spesso anche passivamente, la volontà è meno inquieta. Spesso le volontà più forti corrispondono a individui molto chiusi mentalmente, con una capacità intellettuale e strumentale molto ridotta, mentre le volontà più sensibili, come si dice, quindi meno forti, corrispondono ad individui coinvolti in processi di accumulazione vastissimi e, quello che più importante, largamente variati.
La specificazione rompe la monotonia del mondo e giustifica le regole della logica iniziando ai giochi segreti del catalogo. È il possesso che rende indisponibile la specificazione, e questa alimenta il bisogno di quello. Alla fine il possesso non è più che un’astrazione, non importa possedere oggetti ma solo la potenza contrassegna il possesso. La vita diventa vita nel mondo della guerra e le relazioni conflittuali diventano paradigma di qualunque relazione. L’insieme dei rapporti relazionali nel mondo diventa teatro di una guerra di conquista. Io posseggo dunque sono. Nessuna regola è esterna al possesso ma tutte le regole del mondo risultano interne al possesso, non sono loro a regolarlo ma è lui a regolarle, cioè a produrle in nome del futuro, ovviamente impossibile, completamente. Non ci sono quadri normativi o modelli di possesso, tutto il mondo è possesso, l’uomo lo possiede e ne è posseduto, ammesso che questa distinzione sia possibile visto che sono io a creare il mondo. Io ne sono il possessore e il posseduto. Il cerchio di questo eterno ritorno è perfettamente incompleto, come tutte le apparenze, mi rassicura e mi inietta la paura e l’insicurezza. Cerco un approdo, dove fare i conti per vedere il livello di possesso che ho raggiunto, se la vita mia ha avuto un senso che possa lontanamente ricordare la qualità, ma ciò non è possibile, vengo respinto verso la semplice occasione, l’accadimento che si ripete ed è sempre differente. Ricorrendo ancora al citato Heidegger: «La conformità al mondo propria del mondo-ambiente quale si annuncia nell’ente intramondano. Il mondo non è in se stesso un ente intramondano; tuttavia esso determina questo ente in modo tale da far sì che possa essere incontrato e manifestarsi nel suo essere, come ente scoperto, solo perché “c’è” il mondo. Ma come “c’è” il mondo? Se l’Esserci è costituito onticamente dall’essere-nel-mondo e se al suo essere appartiene, in linea essenziale, una comprensione antologica, sia pure indeterminata, del proprio se stesso, l’Esserci non sarà allora in possesso di una comprensione del mondo di portata preontologica che faccia a meno e possa fare a meno di un’esplicita penetrazione ontologica? Attraverso l’ente che si incontra dentro il mondo, cioè attraverso la sua intra-mondanità, non si manifesta all’essere-nel-mondo prendente cura qualcosa come il mondo? Questo fenomeno non si situa in una luce prefenomenologica e non si muove costantemente in essa, senza bisogno di un’interpretazione tematicamente ontologica? L’Esserci, immedesimato nel prendersi cura del mezzo utilizzabile, non è in possesso di una possibilità d’essere in virtù della quale con l’ente intramondano di cui si prende cura si illumina in qualche modo anche la mondità di esso? Se queste possibilità d’essere dell’Esserci si manifestano in qualche modo già nel commercio prendente cura, sembra possibile pedinare il fenomeno venuto così in luce, per tentare di “fermarlo” e interrogarlo a proposito delle strutture che si manifestano in esso. Alla quotidianità dell’essere-nel-mondo appartengono modi di prendersi cura tali da far sì che l’ente di cui ci si prende cura venga incontro in modo da denunziare la conformità al mondo propria di ciò che è intramondano. L’ente immediatamente utilizzabile nel corso del prendersi cura può risultare inidoneo, non adatto a un determinato impiego. Uno strumento è guasto, un materiale inadatto. Il mezzo resta comunque un utilizzabile. Ciò che ne scopre la inidoneità non è però l’osservazione contemplativa delle sue qualità, ma la visione ambientale preveggente propria del commercio adoperante. In questa scoperta della inidoneità, il mezzo ci sorprende. La sorpresa conferisce al mezzo utilizzabile una certa inutilizzabilità. Dal che deriva: il non-adoperabile è solo più qui, si manifesta cioè come cosa-mezzo, che ha questo o quell’aspetto e che anche nella sua utilizzabilità era già costantemente presente come siffatta. La semplice-presenza si annuncia nel mezzo, per ritirarsi però di nuovo nell’utilizzabilità di ciò di cui ci si prende cura tosto che se ne intraprende il riadattamento. La semplice-presenza del non adoperabile non è completamente priva di utilizzabilità, e il mezzo che è così presente non è ancora una cosa qualsiasi. Il guastarsi di un mezzo non è il semplice cambiamento di una cosa, cioè il puro e semplice succedersi di proprietà in una semplice-presenza. Il commercio prendente-cura non urta solo nella non-idoneità all’interno di ciò che era già da sempre utilizzabile; esso scopre anche ciò che manca, ciò che non è soltanto “inidoneo”, ma “mancante”. La constatazione di una mancanza di questo genere, in quanto esperienza del non-utilizzabile, scopre l’utilizzabile in un certo esser-soltanto-semplicemente-presente. Nell’esperienza della non-utilizzabilità, l’utilizzabile si presenta nel modo della importunità. Quanto più urgente è il bisogno di ciò che manca, quanto più esso è effettivamente sentito nella sua non-utilizzabilità, e tanto più importuno diviene l’utilizzabile presente, al punto da sembrare sprovvisto del carattere dell’utilizzabilità. Esso si rivela solo più come semplice-presenza e tale da non poter sopperire alla mancanza di ciò che manca. Il restare interdetto, quale modo difettivo del prendersi cura, scopre l’essere-solo-più-semplicemente-presente dell’utilizzabile. Nel commercio col “mondo” di cui ci si prende cura, il non utilizzabile può venir incontro non solo nell’esperienza dell’inidoneità o del puro e semplice mancare, ma anche come non-utilizzabile che non manca e non è inidoneo, ma che, rispetto al prendersi cura, è “fra i piedi” come un ostacolo. Ciò a cui l’Esserci non può attendere, per cui “non ha tempo”, è non utilizzabile nella maniera del fuori posto, del non sbrigato». (Essere e tempo, op. cit., pp. 146-148).
Quest’ultima precisazione merita un approfondimento in quanto si potrebbe confondere il mio concetto di meccanismo accumulativo con quello marxista di alienazione. Le due cose sono lontanissime tra loro e appartengono a due interpretazioni completamente opposte. L’accumulazione è un fatto globale, cioè comprende la totalità dei flussi orientati verso il senso, non riguarda soltanto l’aspetto produttivo in senso economico. La produzione di oggetti non è un’esclusiva del meccanismo che produce merci, oggetti possono anche essere gli uomini e le idee e ogni cosa che viene trasformata negativamente in oggetto attraverso la rottura del flusso relazionale. La volontà forte può chiudersi in una serie di specificazioni abbastanza ristretta, all’interno del meccanismo accumulativo, e qui riuscire a controllare abbastanza agevolmente tutto il processo. In questo caso, la volontà forte sviluppa un grande lavoro quantitativo ma in una zona circoscritta dell’accumulazione. La volontà debole invece si allarga, dilaga in zone sempre più ampie delle stesso meccanismo, svolge un lavoro quantitativamente minore, ma più vario e quindi incontra più difficoltà ad esercitare il proprio controllo, da cui maggiori occasioni di inquietudine.
Voglio adesso occuparmi, in breve, del contributo che l’incoerenza improvvisamente filtrata attraverso l’oggetto e subito sottomessa alle leggi della coerenza, dà nella fase ricognitiva, cioè successivamente all’apertura, al perfezionarsi delle tecniche del nascondimento. Di per sé questo problema attiene alla seconda fase dell’effettualità, per cui qui può trovare solo un’illuminazione trasversale, ma ritengo importante soffermarci un attimo sul rapporto tra nascondimento e incoerenza. Tuttavia, bisogna rammentare che incoerenza non significa l’altro aspetto della coerenza, ma un dubbio, una trasparenza improvvisa che fa restare perplessa la coscienza immediata. Ora, nell’attività interpretativa la coscienza è ormai diversificata ma il materiale che tratta, che interpreta, è dominato dal senso, cioè è preso dall’orientamento verso il senso, quindi comprende anche la presenza della coscienza immediata come oggetto d’interpretazione, oggetto fra gli oggetti del meccanismo accumulativo, non come componente della diversità.
Come abbiamo già avuto occasione di vedere, il trattamento di questo materiale richiede delle cautele. La diversità, da per se stessa, in quanto figlia dell’inquietudine, potrebbe figgere lo sguardo direttamente sulla qualità e quindi iniziare una ricognizione della parte del flusso orientato verso la tensione, al massimo utilizzando i residui oggettuali che qui si trovano. È questa, di regola, l’attitudine intuitiva per eccellenza, l’attività artistica che brucia del desiderio della qualità e non si preoccupa di quello che sta accadendo altrove, anche l’insieme stesso dei flussi che costituiscono l’individuo viene spesso trascurato, quasi che non importasse anche vivere la propria vita, anche a livello fisico, personale, immediato, il proprio rapporto con gli altri, con l’ambiente, con la propria fisicità concreta. La rottura della diversità è sempre un cominciamento semplice, non dobbiamo dimenticarlo. La coscienza immediata non può produrre altro, quindi non può abbandonare il vasto universo dell’accumulazione per andare a guardare in faccia, direttamente, la qualità. Certo, nulla vieta che questo possa accadere, e di fatto accade in certi individui particolarmente coraggiosi e proprio per questo anche particolarmente avventati, ma il problema è sempre legato al suo svolgimento medio, come accade e cosa accade mediamente, senza lasciarci sollecitare dall’entusiasmo che un comportamento solitario o eroico può suscitare in noi.
Indirizzandomi verso la qualità seguo le tracce dell’uno che è, proprio perché queste sono anche nell’apparenza del mondo, il materiale di cui mi sono servito per crearlo, cioè il risultato della conoscenza. Ma non mi limito a continuare una indagine, non allargo il campo della conoscenza, questa via, per quanto pregevole, è la via del possesso quantitativo, destinata a lasciarmi senza difese nel vento del deserto. Se io non ho paura riesco a vedere fino a dove arriva questo gioco delle ombre e anche oltre. Scorgo l’assenza e mi apro alla intuizione qualitativa. Il punto essenziale è il coinvolgimento, il cuore che non trema. Di questa esperienza diversa potrò fare tesoro, piccolo o grande che sia, ma poi dovrò sperperarlo nell’eccesso, non potrò conservarlo. La più grande esperienza diversa è quella della libertà, ma per quanto possa protrarla è sempre sulla punta di uno spillo che confronterò il mio coraggio. L’azione brucia l’anima in un attimo, non cuoce a fuoco lento. Nulla c’è di quello che non è su quella punta di spillo, il resto è apparenza che rammemoro, come questa immane sequenza di parole, ma non dice nulla di ciò che ho provato, o proverò, su quella punta di spillo. Se mi convinco, adesso, di dire la verità, riduco la qualità a un nome, e non c’è nulla di più falso, e non potendo dire la verità, il falso è la verità del dire, il vero della parola, l’unico vero che abita nel mondo. Mi persuado della verità di questo falso e lo espongo e mi batto per esso, ma nel coinvolgimento qualitativo, nell’azione, so benissimo che la verità sta altrove.
La ricerca del massimo grado di effettualità, cioè la trasformazione può quindi essere accelerata all’estremo dell’immediatezza, ma nella vita accade l’esatto contrario, anzi non appena la coscienza immediata e la sua inquietudine provocano l’apertura, si hanno dei considerevoli contraccolpi in termini di ritardo nel coinvolgimento. La gioia dell’apertura è fatto spesso trascurabile davanti alla mole di difficoltà che questa pone, quello che si avverte di più è l’acuirsi dell’inquietudine, l’estraneità di una condizione di poca sicurezza, il dolore per la sopravvenuta coscienza della scissione del flusso, la nostalgia per la certezza dell’accumulazione, insomma una serie di problemi che ci conducono inevitabilmente a porre un freno alle sollecitazioni dell’avventura e del rischio, anche se queste sollecitazioni sono là e svolgono il loro insostituibile ruolo che ormai nulla al mondo può cancellare se non la trasformazione negativa e quindi il nuovo orientamento del flusso.
Penso che l’individuo che ha acquisito una coscienza diversa, cioè che è costituito da un complesso di flussi in cui in larga parte si stanno verificando delle aperture, si ponga il problema di come utilizzare gli strumenti che ha elaborato e che continua ad elaborare all’interno del meccanismo di accumulazione. Adesso, per lui, gli oggetti di prima, che la coscienza immediata vedeva come elementi conclusi in sé di un meccanismo anch’esso in sé concluso, adesso diventano mezzi per un progetto ulteriore. In questa condizione, il problema principale non è quindi quello di accogliere la gioia della tensione tutta in una volta, ma al contrario di avvicinarsi con cautela e prudenza a questa gioia, avvertita come un’esperienza troppo traumatica per potere essere avvicinata direttamente.
Il nascondimento riguarda quindi la parte incoerente che stava per trasparire nell’oggetto e viene applicato nel momento in cui i contenuti vengono utilizzati nella ricognizione. Nel materiale accumulato si trovano elementi che potrebbero suggerire una mancanza oggettiva, e sono quelli che riconfermano la coerenza dell’oggetto, e vi sono elementi che potrebbero suggerire una sovrabbondanza oggettiva, e sono quelli che riconfermano una supposizione d’incoerenza dell’oggetto. La ricognizione deve tracciare una mappa dell’orientamento verso la tensione dove ognuno di questi elementi può produrre un effetto contrario al proprio contenuto. Da qui la necessità di nascondere o mascherare l’aspetto immediato, la sua riduzione ad oggetto, tessendo intorno a questa riduzione una rete interpretativa che consentirà nello sviluppo ricognitivo l’emersione sempre più chiara del territorio della cosa. Quest’ultimo è ovviamente al di là dell’oggetto, ma la principale lontananza è tutta nella configurazione specifica dell’oggetto, la quale si affievolisce nel momento dell’unificazione del flusso, consentendo il salto nella qualità.
L’unica giustificazione al fare è l’azione, cioè la personale e vivida esperienza che ricongiunge ciò che la percezione diretta dell’immediatezza ha separato. Senza il fare non sarei niente, meno che meno quello che sono, che non è un risultato statico ma dinamico, un movimento che può involgersi ed evolversi per diventare condizione di quello che sono. L’apparenza che domina il mondo non lo azzera nell’infelicità o nella sordità. La gioia e la forza del coraggio, di un certo coraggio di vivere, riescono a farsi sentire, perfino in condizioni estreme, ma occorre aprirsi, mettersi a rischio nei riguardi dell’assenza, non tumularsi nel rifiuto del rischio e nella sicurezza apparente delle regole e delle distanze. L’azione nasce come accettazione della vita e perfino della forza apparente che la contraddistingue nel mondo, ma si sviluppa e va avanti verso l’assenza, non chiude gli occhi nei riguardi di quello che manca, anzi lo sottolinea e lo cerca, mostrando al mondo la propria debolezza apparente e la propria forza reale. L’apertura alla desolazione della qualità è come l’agonia del mondo che si riassume nel momento della morte. Sono sempre solo nella morte, e non ho esperienza della mia morte ma di quella degli altri, e così sono sempre solo nell’azione. Ho visto gente morire e fingere fino al penultimo momento, mai fino all’ultimo, così nell’azione. Agire è vivere realmente, e da solo, la mia vita. Se sono circondato da una pletora di persone o avvenimenti, progetti o strumenti, tutto ciò esiste fino al momento in cui sto per agire, nell’azione stessa tutto scompare e resto da solo, in caso contrario, se per paura continuo a cercare gli altri, e il contrassegno è la parola, il soccorso è chiesto con la parola, ricado immediatamente nel fare. Dopo l’azione, quando la qualità si intensifica nel suo massimo dispiegarsi di libertà, di fronte alla quale non c’è altro che il mio balbettio, la domanda che mi riporta al fare e alla rammemorazione è, tutto qui? In questo modo, arricchito della mia esperienza diversa, se si vuole immiserita in possesso, ritrovo gli altri e le apparenze, e ritrovo la parola con una diversa accessibilità. Questo tragitto nell’azione è una punta di spillo, senza tempo e senza spazio.
L’interpretazione, come secondo livello dell’effettualità non è soltanto l’occasione ricognitiva, un momento intermedio in cui si riassume il passaggio dall’orientamento verso il senso a quello verso la tensione, almeno non è soltanto questo. Essa è anche un’effettualità costitutiva, cioè nell’interpretare prepara l’emersione della forma. In quanto pratica di trasformazione essa non esiste ancora, ma di già è al lavoro per costituire la base della futura trasformazione. Tutti i suoi movimenti sono quindi qualcosa che si realizza al posto di un’altra, un lavoro in prospettiva, il compimento di qualcosa che non si può compiere adesso ma si compirà altrove. Lo stesso materiale trattato, quello dell’accumulo, subisce una valutazione in vista di condizioni che non possono intaccarlo direttamente, ma che lo risolveranno in un altro livello dell’effettualità. In queste condizioni è difficile evitare di sentirsi contraddittori con quello che si fa. La ricognizione, pur restando una interpretazione, non è una simulazione, è reale processo di cambiamento, come ogni movimento, ma è cambiamento in vista della trasformazione. È la presenza sconvolgente di noi stessi nella ricognizione che rende impossibile ogni illusione di riappacificare il processo.
Senza questa presenza della totalità nell’ipotesi ricognitiva fin dal primo momento, quando l’apertura si palesa come diversità, la trattazione del materiale di accumulo non sarebbe altro che una continuazione del meccanismo stesso di accumulazione magari sotto altri aspetti, più interessati agli elementi di valorizzazione, ma in fondo si tratterebbe della stessa mercanzia, del medesimo flusso orientato verso il senso. Ora, se è pur sempre la catalogazione a fornire il materiale di cui la ricognizione si avvale per sperimentare, attraverso i noti accorgimenti, i suoi nuovi itinerari verso la cosa, quindi nell’orientamento verso la tensione, questo materiale riceve una diversa investitura valutativa. Se come oggetto porta in sé il contrassegno dell’oggettivazione, quindi suggerisce e continua a dar segni di sé solo in termini di fare coatto, come elemento di una diversa interpretazione della realtà, è in grado di portare alla luce, dentro certi limiti, quelle incoerenze che prima erano solo lampi nella notte. Se prima l’oggetto produceva l’oggetto, adesso l’oggetto, che non è più tale, produce condizioni valutative diverse e si inserisce in un itinerario molto tormentato e certo non facile, di orientamento verso la tensione.
L’incoerenza dell’interpretazione si fa un poco più pesante. Qui la legge analitica perde successivamente valore, l’interdizione nei riguardi delle possibilità contrarie, considerate ipotesi di suicidio, comincia a cadere. Si può ammettere che l’oggetto non dà soddisfacimento e non propone una soluzione del problema dell’unità del flusso. Lo si può ammettere tranquillamente, la diversità della nuova coscienza lo consente, anzi lo sollecita e lo sostiene con il ricorso a una logica diversa, quella del tutto e subito. Tutto il materiale interpretato è quindi sottoposto al rischio dell’incoerenza, con il risultato di fare cadere la barriera dell’oggettivazione che faceva sembrare tangibile ogni singola specificazione, mentre in fondo a essa si nascondeva, di nuovo, l’indeterminata gioia della confusione. Ma trattare i prodotti dell’accumulazione in questo modo significa revocare in dubbio tutto il meccanismo che raccoglie e giustifica praticamente e moralmente tutti i contenuti, quindi significa trasgredire alla legge fondamentale del fare coatto, e ciò, di per sé, è diversità in atto, è di già uno stato avanzato di rifiuto dell’ordine e del controllo.
Tutto ciò non può che causare disturbi e difficoltà, i quali possono anche non essere controllati a sufficienza dal coinvolgimento, quindi dalla coscienza del rischio, dalla lotta e dallo stesso desiderio di avventura. La paura è sempre dietro l’angolo. Un eventuale slittamento, una perdita o un ritardo nel progetto ricognitivo e si sviluppano dei vuoti valutativi, movimenti tanto deboli da essere incapaci di superare gli stessi ostacoli che l’oggetto propone alla propria decodificazione all’esterno del meccanismo accumulativo. La cautela del procedere ricognitivo è quindi una forma di protezione supplementare nei riguardi di una situazione che potrebbe diventare una minaccia.
Dal lato opposto, osservando l’incognita dell’orientamento verso la tensione, dove la diversità deve inserire i materiali di accumulo, arrivano segnali incerti e inquietanti. Prima di tutto la mancanza di senso che per la coscienza, sia pure diversa è fatto importante, poi quella di ordine e di controllo, altri elementi rassicuranti che non possono sottrarsi di colpo senza conseguenze di scompenso, anche nel caso delle diversità più radicate e sicure di sé. Non dobbiamo dimenticare che per la coscienza l’orientamento del flusso verso la tensione è una divisione che le è estranea in quanto pur essendo stata originata dalla trasformazione negativa del venire meno del coinvolgimento, una volta che il cominciamento radicale si è verificato questo confina la coscienza, che così si ritrova ad essere soltanto immediata, esclusivamente nell’ambito dell’orientamento verso il senso.
L’analogia o la persistenza di situazioni che apparentemente possono sembrare simili non consente di duplicare la mappa dell’orientamento verso il senso nel corpo dell’orientamento verso la tensione. Così facendo si verrebbero a torcere realtà che se sono legate insieme da movimenti relazionali sono anche universi che si stanno allontanando sempre di più e che bisogna lasciare nella condizione di allontanamento se si vuole lavorare nell’ambito valutativo. Se fosse possibile un procedimento complementare, l’attività ricognitiva si esaurirebbe tutta nel rintracciare, per ogni contenuto, la sua qualità distaccatasi a seguito dell’orientamento. Ciò è impossibile per molti motivi, fra i quali ricordiamo i processi di riorganizzazione del meccanismo accumulativo, il passaggio di sia pur trascurabili residui di tensione nell’orientamento verso il senso e viceversa, la presenza della coscienza immediata nella parte orientata verso il senso e la sua assoluta assenza nella parte contraria e così via. Tutti elementi che impediscono di considerare speculari le due parti in cui si è orientato il flusso. Più che altro, la diversità ricerca il corrispettivo dell’accumulazione in una assenza dell’oggetto accumulato, un’assenza che non è vuoto o nulla, in quanto sappiamo che questi concetti non sono accettabili, ma è l’aspetto qualitativo dell’accumulazione, cioè il rifiuto della riduzione a oggetto, la circolazione della forma, il senso di forza e di rispetto che questa resistenza nei riguardi del potere della struttura genera all’interno dell’orientamento verso la tensione, consapevolezza, fondatezza, positività dei movimenti, una serie di elementi relazionali che fanno da controparte all’inquietudine.
Se dalla parte dell’accumulazione, del fare coatto, della struttura, della produzione dell’oggetto, dell’inquietudine, la regola è il dovere, dalla parte dell’orientamento verso la tensione, la regola è il desiderio. È proprio questa differenza radicale che la diversità deve cominciare a imparare nella ricognizione. La coscienza ha paura del desiderio e della gioia, questi due elementi rischiano di trascinarla in situazioni del tutto incontrollabili. Ciò è ovvio nell’ambito delle modificazioni, diventa più sottile e difficile nelle valutazioni ricognitive, qui la diversità ha una carica, che le viene dal coinvolgimento, la quale la spinge avanti, ma non può catapultarla immediatamente nell’ambito della qualità, l’incoerenza del passaggio sarebbe troppo forte, in fondo la coscienza, pur diversa, è sempre una parte del dovere, ragiona impiantando giustamente l’angolazione della logica del tutto e subito, ma ragiona, applica regole, le critica, perfino negativamente, ma le applica.
Poi c’è l’impiego dello strumento linguistico, dilagante nel meccanismo accumulativo, largo di perplessità in un ambito ricognitivo. La comunicazione è una sfida solo al di là dell’apertura e fa parte del coinvolgimento, quindi tutta la vastità degli effetti accumulativi tende a contrarsi da quest’altra parte. Non il silenzio, questa è la conclusione nella cosa, la linea del delirio, ma un inizio di affievolimento, questo sì. Il linguaggio serve da strumento e segue la sorte di tutti gli oggetti elaborati nel primo livello dell’effettualità. La prima intenzione della diversità è di utilizzare il linguaggio come copertura di se stessa, come giustificazione del disagio patito nell’ambito dell’accumulazione, quando era coscienza immediata. Si tratta di una copertura spesso aggressiva che non riesce a diventare mascheramento vero e proprio in quanto non tende a nascondere l’oggetto, quanto a travisarlo. Lo strumento principe della risposta coerente, viene spesso con violenza presentato come l’unico strumento di una improbabile risposta incoerente. Ciò contraddice non solo alle possibilità ma principalmente allo scopo della ricognizione, che resta sempre un’effettualità valutativa, quindi un livello in cui il passaggio dal senso alla tensione deve per forza avvenire nell’ambito delle regole della coerenza, solo che le condizioni della coscienza diversa, permettono di dare spazio e sostanza alle caratteristiche della incoerenza.
Dall’apertura in poi si vanno sollevando le incomprensioni di ciò che invece veniva meccanicamente compreso nell’ambito dell’accumulazione. Qui i rapporti apparenti di causa ed effetto, il processo, la quantità, lo sviluppo, sono elementi del ragionamento che sbocca nella coerenza, dopo l’apertura invece c’è una resistenza a mantenere queste comprensioni mentre si scatenano irriducibili rifiuti, la storia come illusione, il progresso lineare come inganno, le spiegazioni del mondo come paranoie. Il linguaggio stesso, in quanto predicabile, denuncia subito la sua essenza inautentica, il suo contraddittorio porsi come qualcosa di coerente e incoerente nello stesso tempo, strumento per la costruzione di trappole. La strada più semplice della diversità resta quella dell’ossessiva recriminazione, dell’insensatezza, dell’indiscrezione triviale, della violenza, ma è anche la strada meno produttiva. Infatti, se questa carica che potremmo anche definire eversiva dovesse limitarsi agli aspetti esterni, specificamente strumentali, come quelli linguistici, il risultato sarebbe appunto meno significativo, diversa invece la valutazione se quest’impiego strumentale dovesse porsi il problema del mascheramento.
Il furore può fare uscire allo scoperto il nemico, purché sia controllato, quindi non sia ossessivo ma solo apparente, un’invettiva destinata a stornare l’attenzione della controparte, la quale, non dimentichiamolo, è sempre il quantitativo, il contenuto accumulato. Si può essere fuori delle regole, contro le leggi, senza per questo essere privi di senno o di logica. Il più grosso pericolo è quello di considerare l’abbandono come rinuncia di sé invece che come coinvolgimento, concetti antitetici come ognuno vede. Spesso l’esacerbante logica costrittiva dell’analisi solleva una risposta immediata e caustica, corrosiva quanto ingiusta, ma questa risposta diventa produttiva di profondi significati ricognitivi se al di sotto mantiene un altro territorio, tutto suo, dove si fissano gli orientamenti di un ordine diverso, di una diversa strategia. La denuncia dell’inutilità, a cui questo libro è dedicato, è essa stessa inutilità, nel momento in cui l’utilità contrassegna i termini del controllo e del dominio. Il rifiuto dell’accumulato non può essere la critica razionale dell’illuminista, da cui dovrebbe emergere un mondo fatto ad immagine e somiglianza della ragione, e non può esserlo perché non si troverebbe in nessun luogo il materiale, ancora una volta quantitativo, con cui costruire questo nuovo mondo. Il limite della ragionevolezza, e quindi in primo luogo anche della coerenza, sta qui, e qui si trova anche il grande significato dell’ironia come pure della violenza, dell’atto forsennato che sconvolge le rigide regole del gioco quantitativo, fornendo allo spettatore un livello discorsivo tanto ridotto, tanto abbassato di fronte alle altrui attese e pretese, da risultare sconvolgente.
Per me è questione di maschera, contro le buone intenzioni che lastricano il territorio della sofferenza, contro le grandi idee che servono come fondamento alle ideologie e quindi al consenso e al controllo, contro i salvatori di ogni genere, individui e organizzazioni. Spesso questa maschera si spezza e lascia trasparire una perplessità, ma deve essere questione di un momento, in caso contrario la logica del senso, con le sue regole accumulative, finisce per prevalere. La necessità del contenuto obbliga al mascheramento, quindi obbliga a un processo sotterraneo, la diversità diventa follia per la ragione dominante, inversione qualitativa inconcepibile e irragionevole, troppo scoperta, troppo rischiosa, talmente irrispettosa delle formule del distacco e della distanza da coinvolgere lo stesso sacrosanto soggetto nelle faccende della nuova oggettività. E la follia è per definizione istituzionale incoerente, per cui deve essere dichiarata inutile, come tutto il suo tramestio, in caso contrario la sentenza si capovolge e tutto il meccanismo di accumulazione diventa sospetto di incoerenza con pericoli grossissimi per l’incolumità del controllo e del dominio.
La sapienza dell’accumulo può essere presente ma non può dare il suo contributo istituzionale, può essere presente se tirata per i capelli, obbligata dall’elaborazione di strumenti idonei, ingannata, tratta su di un territorio che le è estraneo attraverso un raffinato mascheramento. Se istituzionalizzato, qui il contenuto non direbbe più nulla, sarebbe una tragica farsa del ruolo che svolgeva nell’accumulazione. Un oggetto interpretato è privo di senso, cioè è tolto da quell’orientamento verso il senso che prima lo fondava in quanto oggetto. Non è nemmeno cosa, il che presupporrebbe un accostarsi parziale alla tensione nell’ambito dell’orientamento inverso a quello del senso, quando invece la qualità può essere raggiunta solo al termine del processo ricognitivo e attraverso un salto, non attraverso passaggi parziali.
La maschera consente la presenza del contenuto e la sua interpretazione. Per chi volesse ritrovare il contenuto vero e proprio, il senso del processo oggettivante, dietro la maschera immediatamente scatterebbe il meccanismo nuovo della riduzione all’assurdo, in quanto l’incoerenza dell’interpretazione si scontrerebbe con la coerenza mummificata dell’oggetto ormai lontana da quel processo periodico di riorganizzazione che rendeva quest’ultimo comprensibile nel suo contesto, cioè nell’orientamento accumulativo. Il di già fatto, l’ordinato, il controllato e il prodotto dovrebbero tutti essere ricondotti affannosamente lontano dalla ricognizione, ulteriormente orientati o ulteriormente coperti, mascherati, distorti, allo scopo di ridiventare materiali ricognitivi proprio in quanto visti attraverso la finzione di una loro nuova esistenza, sulle prime forse soltanto capace di parodiare l’antica esistenza dell’ordine, ma proprio perché in grado di fare ciò, parodia e farsa sono introduzione al delirio, a una nuova sostanziale esistenza non più di contenuti ma di strumenti da impiegare in vista di una futura trasformazione.
I sacerdoti della coerenza sentiranno come strani questi discorsi, ma dovranno cominciare a capire come si possa cadere nella trappola della rigidità, ritrovando e ricostruendo una schiavitù che si era fatto di tutto per allontanare e per sconfiggere. Una dura lezione quella di Francis Herbert Bradley: «Un giudizio è relativamente universale quando il soggetto è un individuo determinato o una collezione di individui. È universale, perché il soggetto rappresenta l’identità della diversità interna che gli è propria. In “Cesare è malato” non si afferma che Cesare non sia altro che malato; egli costituisce il legame comune di molteplici attributi, e per conseguenza è universale. Ma questo giudizio è relativo, perché Cesare è un uomo fra gli uomini; e, se lo considerate tale, egli pure è particolare. Un giudizio che sia particolare in modo assoluto non può esistere. Avrebbe un soggetto completamente delimitato e racchiuso nel predicato. E un simile giudizio, se esistesse, non sarebbe nemmeno un giudizio. Perché ovviamente non direbbe null’altro del soggetto o del predicato se non quello che sono. “Questo è questo” si può considerare come l’esempio più fedele. Un giudizio particolare relativo si ha quando il soggetto è questo o quel singolo o collezione. E la stessa cosa del giudizio universale relativo, ma visto da un altro lato della sua natura. Il soggetto esclude tutti gli altri individui, e così è particolare; ma entro di sé ha una diversità, e così è universale. Egli possiede attributi diversi dal predicato e può venire considerato entro un altro contesto. Per tale modo ci serve come termine medio nel ragionamento, come ben si vede nella terza figura del sillogismo». (Principi di logica, tr. it., Milano 1951, pp. 127-128). Ciò ha origine dal pregiudizio di considerare l’universo oggettivato come verità, munito quindi di una sua logica interna assolutamente irrefutabile perché non contraddittoria, appunto la logica dell’a poco a poco. Racchiudendosi in questo universo la rigidità diventa dogma e dottrina, fondamento del controllo e quindi della schiavitù. Spezzando questo universo, occorre ricomporre un mondo trasformato e questo può avvenire soltanto attraverso un itinerario dapprima interpretativo e poi decisionale, itinerario che non consente più l’accettazione acritica dell’antica logica dell’analisi, ma necessita di una logica del tutto diversa, quella del tutto e subito.