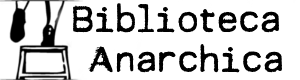Camillo Berneri
L’operaiolatria
Introduzione
Questo opuscolo di Camillo Berneri è apparso a Brest (Francia) nel 1934, anche se non è datato come altri lavori usciti durante il periodo del fuoriuscitismo antifascista. È stato ripubblicato da Pier Carlo Masini e Alberto Sorti, nel libro “Pietrogrado 1917-Barcellona 1937” nei tipi Sugar Editore, e in altra veste in offset, da Luigi Assandri di Torino nel 1972.
Rileggendolo in questi ultimi giorni dei rimi di marzo 1987, mi è venuta l’idea di ristamparlo perché il contenuto venga messo ancora in discussione e serva a modificare la mentalità della gente che lavora e talvolta non pensa che ai propri immediati interessi dimenticandosi che non vive isolato.
È risaputo che noi operai, parlo di me e degli altri operai come me, non sempre e non tutti abbiamo avuto ed abbiamo un’anima proletaria e pure una cultura proletaria degna di essere chiamata tale. Finiamola tutti di considerare i lavoratori della terra come degli inferiori che non siano capaci di avere il senso umanitario e solidaristico che molte volte ho lamentati ai miei compagni di lavoro (non di idee) operai.
È tempo che si cessi di farsi concorrenza nei luoghi di lavoro e di farsi spioni dei propri compagni al solo scopo di far “carriera” o di tentarlo.
È tempo di finirla di pensare a se stessi pur di lavorare anche quando si è chiamati ad eseguire un lavoro dannoso per sé e per gli altri e di chiedere sovvenzioni dal governo quando la produzione è in perdita, non rende.
È tempo di finirla con i circoli chiusi dei posti di lavoro talvolta divenuti ereditari come quello di certe categorie di portuali, al lavoro delle Compagnie alle quali non si accede se non si è parenti dei “titolari” che ne hanno fatto una proprietà dei soci. E così per altre categorie.
È tempo di finirla di produrre armi di ogni genere con la scusa che gli operai che lavorano nelle fabbriche di armi, ci presentano. I lavoratori operai non si rendono conto che è meglio perdere il lavoro che produrre strumenti che poi vengono rivolti anche contro di loro.
È ancora tempo che chi produce veleni dannosi alla salute pubblica, la smetta e si trovi altro lavoro unendosi agli altri per reclamare la diminuzione delle ore di lavoro per dar posto a milioni di disoccupati e degli altri che sono candidati.
È tempo che il lavoratore di ogni mestiere pensi, rifletta, si acculturi e divenga un essere umano anziché pronto a divenire belva contro i propri simili.
Il contenuto di questo opuscolo serve anche a quei compagni che prediligono pensare come tanti sindacalisti illustrati da Berneri e negativi sul piano umano. Serve anche per tutti gli altri di noi che trascuriamo che l’uomo deve avere non un’anima proletaria, ma un’anima umanizzata.
Aurelio Chessa
Pistoia, 9 Marzo 1987
L’operaiolatria
Leggendo il libro di Carlo Rosselli, Socialisme libéral, Paris 1930, ho segnato in margine questo passo (traduco):
« Il giudizio pessimista sulla massa implica in realtà un giudizio pessimista sull’uomo poiché la massa non è altra cosa di una somma di concrete individualità. Dal momento che si dichiara la massa incapace di afferrare, sia pure mediante intuizioni grossolane primitive, il valore di una lotta per la libertà, per ciò stesso si dichiara l’uomo chiuso ad ogni istinto che non sia di natura strettamente utilitaria. Si taglia alle radici, ad un tempo, qualsiasi bisogno di redenzione sociale, si soffoca sinanco la fede negli istinti democratici, questa fede fondata sulla tesi di fondamentale identità fra gli uomini e su di un ragionevole ottimismo sulla natura umana. »
Non ho mai tollerato senza reagire certi atteggiamenti … nietzschiani di taluni individualisti, destinati a finire segretari di Camere del Lavoro o peggio, ma, d’altra parte, non ho mai lucidate le scarpe al proletariato “evoluto e cosciente”, neppure in comizio. E non capisco il linguaggio aulico dei bonzi bolscevichi.
In un articolo (cito un esempio tra mille) di Azione antifascista (Giugno ‘33), leggo che Gramsci è un’anima proletaria. Dove ho udito quest’espressione? Frugo nella memoria. Ah, ecco! Fu a Le Pecq, mentre in costume e in fatica da manovale muratore mi aveva sorpreso uno dei “responsabili” comunisti. “Ora la puoi conoscere, Berneri, l’anima proletaria!” Così mi aveva apostrofato. Tra una stacciatura di sabbia e due secchi di “grossa” riflettei sull’ “anima proletaria”. E come sempre, a chiarire il problema sorgevano, dalla memoria del cuore, i ricordi. I primi contatti con il proletariato: era lì che cercavo la materia della definizione. L’ “anima proletaria” non la trovai. Ritrovai i miei primi compagni: i giovani socialisti di Reggio Emilia e dintorni. Vi erano dei cuori generosi, delle menti aperte, delle volontà tenaci. Poi conobbi degli anarchici. Torquato Gobbi mi fu maestro, nelle sere brumose, lungo la via Emilia, sotto i portici che risuonavano dei miei tentativi di resistere alla sua pacata dialettica. Lui era legatore di libri, io studentello di liceo, ancora “figlio di papà” dunque, e ignaro di quella grande e vera Università che è la vita. E dopo allora, quanti operai, nella mia vita quotidiana! Ma se nell’uno trovavo l’esca che faceva scintilla nel mio pensiero, se nell’altro scoprivo affinità elettive, se all’altro ancora mi aprivo con fraterna intimità, quanti altri aridi ne incontravo, quanti mi urtavano con la loro boriosa vuotaggine, quanti mi nauseavano con il loro cinismo! Il proletariato era “la gente”: quella media borghesia in cui ero vissuto, la massa studentesca nella quale vivevo; la folla, insomma. E gli amici e i compagni operai più intelligenti e più spontanei mai mi parlavano di “anima proletaria”. Sapevo proprio da loro, quanto lente a progredire fossero la propaganda e l’organizzazione socialiste. Poi entrato nella propaganda e nell’organizzazione, vidi il proletariato, che mi parve, nel suo complesso, quello che ancor oggi mi pare, un’enorme forza che si ignora; che cura, e non intelligentemente, il proprio utile; che si batte difficilmente per motivi ideali o per scopi non immediati, che è pesante di infiniti pregiudizi, di grossolane ignoranze, d’infantili illusioni. La funzione delle élites mi parve chiara: dare l’esempio dell’audacia, del sacrificio, della tenacia; richiamare la massa su se stessa, sull’oppressione politica, sullo sfruttamento economico, ma anche sull’inferiorità morale ed intellettuale delle maggioranze.
Sì che presentare la borghesia ed il proletariato con il demagogico semplicismo delle caricature scalarinesche dell’Avanti! e degli “oratori da comizio” mi parve di cattivo gusto e dannoso.
Vi fu, e purtroppo vi è ancora, una retorica socialista che è terribilmente ineducativa. I comunisti contribuiscono, più di qualsiasi altro partito d’avanguardia, a perpetuarla. Non contenti dell’ “anima proletaria”, hanno tirato fuori la “cultura proletaria”. Quando morì Lunaciarski fu detto, da certi giornali comunisti, che “egli incarnava la cultura proletaria”. Come uno scrittore di origine borghese, erudito (e l’erudizione è il capitalismo della cultura), alquanto prezioso come il Lunaciarski potesse rappresentare la “cultura proletaria” è un mistero analogo a quello della “ginecologia marxista”, termine che ha scandalizzato perfino Stalin. Le Réveil di Ginevra, insorgendo contro l’abuso dell’espressione “cultura proletaria”, osservava:
« Il proletario è, per definizione, e molto spesso in realtà, un ignorante, la cui cultura è necessariamente limitatissima. In tutti i campi, il passato ci ha fatto eredi di beni inestimabili che non potrebbero venire attribuiti a questa o a quella classe. Il proletariato, lui, rivendica anzitutto una più larga partecipazione alla cultura, come ad una delle ricchezze delle quali non vuole essere più privo. Dei sapienti, degli scrittori, e degli artisti borghesi ci hanno dato delle opere di un’importanza emancipatrice; invece, degli intellettuali sedicenti proletari ci cucinano dei piatti spesse volte indigesti. »
“La “cultura proletaria” esiste, ma essa è ristretta alle conoscenze professionali e all’infarinatura enciclopedica raffazzonata in disordinate letture. Carattere tipico della cultura proletaria è di essere in arretrato con il progresso della filosofia, delle scienze e delle arti. Voi troverete dei seguaci fanatici della monismo di Haeckel, del materialismo di Buchner, e perfino dello spiritismo classico, tra gli “autodidatti”, ma non ne troverete tra persone realmente colte. Una qualsiasi teoria comincia a diventare popolare e a trovare eco nella “cultura proletaria” che è golosa di lussi. Come il romanzo popolare è pieno di principi, di marchesi e di ricevimenti salotteschi, così un libro è tanto più ricercato e gustato dagli “autodidatti” quanto più è indigesto ed astruso.
Molti di costoro non hanno mai letto La conquista del pane, o il dialogo Tra contadini, ma hanno letto Il mondo come volontà e rappresentazione e La critica della ragion pura. Una persona colta che si occupi, ad esempio, di scienze naturali e che non abbia conoscenze di matematica superiore, si guarderà bene dal giudicare Einstein. Un autodidatta, in generale, ha in materia di giudizi un fegataccio grosso così. Dirà di Tizio che è un filosofucolo, di Caio che è un “grande scienziato”, di Sempronio che non ha capito il “rovesciamento della prassi”, né la “noumenicità”, né l’“ipostasi”. Ché l’autodidatta, sempre in generale, ama parlare difficile.
Fondare una rivista, al mezzo-colto, non fa paura. Non parliamo poi di un settimanale. Scriverà della schiavitù in Egitto, delle macchie solari, dell’ “ateismo” di Giordano Bruno, delle “prove” dell’inesistenza di Dio, della dialettica hegeliana; ma della sua officina, della sua vita di operaio, delle sue esperienze professionali non dirà una parola.
“L’autodidatta” cessa di essere tipicamente tale quando giunge a farsi una vera cultura. Quando, cioè, ha ingegno e volontà. Ma, allora, la sua cultura non è più operaia. Un operaio colto, come Rudolf Rocker, è come un nero portato in Europa bambino e cresciuto in una famiglia colta o in collegio. L’origine, come il colore della pelle, non conta, in questi casi. In Rocker, nessuno immaginerebbe l’ex-sellaio, mentre quando Grave esce dalla volgarizzazione kropotkiniana fa pensare, con rimpianto, che è stato calzolaio.
La cosiddetta “cultura operaia” è, insomma, una simbiosi parassitaria della cultura vera, che è ancora borghese e medio-borghese. E più facile che dal proletariato esca un Titta Ruffo, o un Mussolini, che uno scienziato od un filosofo. Questo non perché l’ingegno sia monopolio di una classe, ma perché al 99 per cento dei proletari, lasciata la scuola primaria, è negata la cultura sistematica dalla vita di lavoro e di abbrutimento. L’istruzione e l’educazione per tutti è uno dei più giusti canoni del socialismo, e la società comunista darà le élite naturali; ma, per ora, è grottesco parlare di “cultura proletaria” del filologo Gramsci o di “anima proletaria” del borghese Terracini. La dottrina socialista è una creazione di intellettuali borghesi. Essa, come osserva De Man in Au de là du marxisme, “è meno una dottrina del proletariato che una dottrina per il proletariato”.
I principali teorici dell’anarchismo, da Godwin a Bakunin, da Kropotkin a Cafiero, da Mella a Faure, da Covelli a Malatesta, da Fabbri a Galleani, da Gori a Voltairine de Cleyre, uscirono da un ambiente aristocratico o borghese, per andare al popolo. Proudhon, di origine proletaria, è di tutti gli scrittori anarchici il più influenzato dall’ideologia e dai sentimenti della piccola borghesia. Grave, calzolaio, è caduto nello sciovinismo democratico il più borghese. Ed è innegabile che gli organizzatori sindacali di origine operaia, da Rossoni a Meledandri, hanno dato, proporzionalmente, il maggior numero d’inserimenti.
Il populismo russo e il sorelianismo sono due forme di romanticismo operaista delle quali è continuatrice, formalmente, la demagogia bolscevica. Gorki, che è uno degli scrittori che ha vissuto più lungo e più profondamente in mezzo al proletariato, scrive:
« Quando costoro (i propagandisti) parlavano del popolo, lo sentii subito che essi lo giudicavano differentemente da me. Ciò mi sorprese e mi rese diffidente verso me stesso. Per essi il popolo era l’incarnazione della saggezza, della bellezza spirituale, della bontà e del cuore, un essere unico e quasi divino, depositario di tutto quello che è bello, grande e giusto. Non era affatto il popolo che io conoscevo. »
Arturo Labriola, al quale tolgo la citazione sopra riportata (Al di là del capitalismo e del socialismo, Parigi 1931), la fa seguire da questi ricordi:
« Potrei aggiungere la mia esperienza personale, essendo io nato in una classe di artigiani-artisti, che vivevano in contatto immediato con le classi del lavoro materiale, ed erano essi stessi dei proletari. I lavoratori che io ho conosciuto fin dai primi anni della mia vita, erano degli uomini in tutto e per tutto degni di pietà, ingenui e istintivi, creduli, inclini alla superstizione, volti alla vita materiale, affettuosi e creduli nello stesso tempo con i figliuoli, incapaci di ricavare dalla propria vita di lavoratori un solo elemento di pensiero particolare alla loro classe. Quelli di essi che, spogliandosi dalla superstizione e dalle prevenzioni del loro ceto, giungevano al socialismo, non lo vedevano che sotto il suo aspetto materiale di un movimento destinato a migliorare la loro sorte. E naturalmente questo miglioramento attendevano dei capi, i quali passavano indifferentemente dallo stato di idoli allo stato di traditori secondo i momenti e le occasioni senza merito o demerito loro. È indiscutibile che il socialismo li migliorasse sotto tutti gli aspetti; ed oso dire che la mia prima spinta a favorire questo movimento, mi venne dalla grande pietà che la miseria dei miseri m’ispirava, e dalla esperienza del beneficio che il movimento recava ad essi. »
Malatesta stesso non vedeva il proletariato attraverso gli occhiali rosa di Kropotkin e Luigi Fabbri scriveva in un suo articolo, riferendosi al periodo insurrezionale del dopoguerra: “Troppa gente, fra la povera gente, troppi lavoratori credevano sul serio che stesse per venire il momento di non lavorare o di far lavorare unicamente i signori.”
Chiunque ripensi alla storia del movimento operaio vedrà prevalervi un’immaturità morale spiegabilissima, ma tale da imporre la più evidente smentita ai ditirambici esaltatori delle masse.
“Il giochetto di chiamare “proletariato” i nuclei di avanguardia e di élites operaie è un giochetto da mettere in soffitta. Le allegoriche demagogie lusingano la folla, ma le nascondono delle verità essenziali per l’emancipazione reale. Una “civiltà operaia”, una “società proletaria”, una “dittatura del proletariato”: ecco delle formule che dovrebbero sparire. Non esiste una “coscienza operaia” come tipico carattere psichico di un’intera classe; non vi è una radicale opposizione tra “coscienza operaia” e “coscienza borghese”. I greci non hanno combattuto per la gloria, come pretendeva Renan. E il proletariato non si batte per il senso del sublime, come si affannava a sostenere il Sorel nelle sue Réflexions sur la violence.
L’operaio ideale del marxismo e del socialismo è un personaggio mitico. Appartiene alla metafisica del romanticismo socialista e non alla storia. Negli Stati Uniti e nell’Australia sono le Unions operaie che richiedono la politica restrittiva dell’immigrazione. All’emancipazione dei neri degli Stati Uniti, il proletariato americano (vedi Mary R. Beard, A short history of the american labour movement, New York, 1928) non ha dato che un misero contributo e ancora oggi i lavoratori di colore sono esclusi da quasi tutte le organizzazioni sindacali americane. I movimenti di boicottaggio (contro le dittature fasciste, gli orrori coloniali, ecc.) sono scarsi e non riescono. E rarissimi sono gli scioperi di solidarietà classista o a scopi strettamente politici.
Questo carattere utilitarista, questa grettezza, questa inerzia generale caratterizzano particolarmente il proletariato industriale.
Ogni qual volta mi accade di leggere, o di udire, esaltare il proletariato industriale come la élite rivoluzionaria e comunista, reagiscono in me dei ricordi di vita, cioè delle personali esperienze e delle osservazioni psicologiche. Sono condotto a sospettare negli assertori di quello che a me pare un mito, o un’infatuazione di “provinciali” inurbati in qualche grande centro industriale o, in altri casi, un’infatuazione d’ordine professionale. Quando leggevo l‘Ordine Nuovo, specialmente nel suo primo periodo, quando era periodico, la suggestione delle sue continue esaltazioni della grande industria come formatrice di omogeneità classista, di maturità comunista degli operai di officina, ecc., era in me respinta da considerazioni d’ordine psicologico.
Immaginavo, ad esempio, Gramsci piovuto a Torino dalla nativa Sardegna, e preso tutto dagli ingranaggi della metropoli industriale. Le grandi manifestazioni, la concentrazione di operai specializzati, la vastità febbrile del ritmo della vita sindacale della città industriale – mi dicevo – l’hanno affascinato. La letteratura bolscevica russa mi pareva pantografare lo stesso processo psichico. In un paese come la Russia, dove le masse rurali erano enormemente arretrate, Mosca, Pietrogrado e gli altri centri industriali dovevano parere delle oasi della rivoluzione comunista. I bolscevichi dovevano, quindi, spinti dall’industrialismo marxista, essere condotti a infatuarsi della fabbrica, come i rivoluzionari russi dell’epoca di Bakunin erano condotti ad infatuarsi della cultura occidentale.
In Italia, la mistica industrialista di quelli dell’Ordine Nuovo mi appariva, quindi, come un fenomeno di reazione analogo a quello del futurismo.
Un altro aspetto che mi pareva esplicativo era quello della naturale tendenza che hanno i tecnici industriali, tendenza che ha corrispettivi in tutti i campi della specializzazione, a vedere nel fatto “industria” l’alfa e l’omega del progresso umano. E mi pareva significativo che gli ingegneri fossero numerosi fra gli elementi direttivi del Partito Comunista.
A questo angolo visuale sono ancora posto, e trovo una nuova conferma nell’atteggiamento di alcuni tra i repubblicani che sono influenzati dall’ideologia dei comunisti.
Tipico è il caso di A. Chiodini, che nel numero del febbraio 1933 dei Problemi della rivoluzione italiana, criticando l’indirizzo rurale e meridionalista del programma di Giustizia e libertà, proclama:
« Il proletariato industriale è l’unica forza oggettivamente rivoluzionaria della società. Perché solo il proletariato è nella condizione e nella possibilità di liberarsi da ogni mentalità chiusa di categoria e di assurgere a dignità di classe, cioè di forza collettiva che ha coscienza di un compito storico da realizzare.
La rivoluzione italiana, come tutte le rivoluzioni, non può essere l’opera che di forze omogenee e capaci di muoversi per ideali a largo respiro.
Ora, l’unica forza omogenea che possa battersi per un ideale di libertà concreta e che per questa battaglia possa essere disposta ad un’azione lungimirante, non a scadenza fissa, è la forza operaia. È questa che può porre, oggi, dopo tante prove e tante tragedie, la propria candidatura come classe dirigente rivoluzionaria. »
Che il proletariato industriale sia una delle principali forze rivoluzionarie in senso comunista è troppo evidente perché ci sia da discutere a questo proposito. Ma è, d’altra parte, evidente che l’omogeneità di quel proletariato è più nelle cose che negli spiriti e più – vale a dire – nell’agglomerato di individui che sono in grandissima maggioranza dei salariati senza grandi differenze attuali o possibili ed a contatto con una proprietà di sua natura indivisibile (quindi necessariamente atta a divenire il capitale di un lavoro necessariamente associato) che nella coscienza di classe, di forza collettiva destinata ad attuare un grandissimo compito storico.
Il particolarismo degli operai delle industrie è troppo evidente perché ci si lasci andare alle generiche e generalizzatrici esaltazioni che di essi fanno taluni dei marxisti e dei marxisteggianti.
L’egoismo corporativo negli Stati Uniti ha condotto ad una vera e propria politica xenofoba, e le corporazioni tipicamente industriali si sono mostrate sempre tra le più accanite nel richiedere al governo l’interdizione all’immigrazione operaia. Lo stesso nella Nuova Zelanda. Ma limitiamoci all’Italia. Gli operai delle industrie hanno sempre favorito il potenziamento industriale. Il libro di G. Salvemini, Tendenze vecchie e necessità nuove del movimento operaio italiano (Bologna, 1922), è ricco di esempi, a questo proposito. Né scelgo alcuni, che mi sembrano i più tipici.
Nel 1914, gli operai dell’industria zuccheriera che erano 4.500, cioè una piccolissima categoria, venivano protetti dai socialisti riformisti, che chiedevano al governo la protezione doganale dello zucchero, senza curarsi dell’industria danneggiata dall’alto prezzo della materia prima. Tale richiesta veniva a danneggiare tutti i consumatori italiani, costretti a pagare a prezzo più alto non solo lo zucchero, ma anche le confetture e le marmellate. Non solo; essa limitava il consumo interno delle seconde, ne impediva la esportazione, quindi diminuiva il lavoro degli operai di queste industrie. Gli operai degli zuccherifici avrebbero, quindi, dovuto: o richiedere la protezione per tutte e due le industrie o richiedere il libero scambio per lo zucchero, potendo essi essere assorbiti dallo sviluppo dell’industria delle confetture e della marmellata. Questo nell’interesse generale. Ma come pretendere che gli operai degli zuccherifici che guadagnavano “salari elevati, ignoti ad altre categorie di lavoratori” (Avanti!, 10 marzo 1910) rinunziassero alla loro posizione privilegiata?
Un altro esempio. Prima della guerra, funzionavano in Italia 37 miniere di lignite, che produssero, nel 1913, 700 mila tonnellate di combustibile. Durante la guerra, salito a prezzi altissimi il carbone estero, fu conveniente sfruttare giacimenti ligniferi anche poverissimi; e le miniere salirono a 137 ma la produzione non crebbe che di quattrocentomila tonnellate, parte delle quali date da una più intensa produzione delle vecchie miniere. Finita la guerra, discesi i prezzi del carbone estero, le richieste di lignite scemarono, sì che le 37 miniere ridivennero sufficienti.
I minatori aggiunti, quasi tutti i contadini dei paesi circostanti, si videro minacciati di licenziamento e di diminuzione di salario. Grandi agitazioni, il cui motto d’ordine era: Niente licenziamenti! E un deputato socialista, presidente di un consorzio cooperativo minerario chiese al governo di mantenere la produzione lignitifera alle cifre del periodo di guerra, anzi che la facesse salire a 4 milioni di tonnellate annue; che l’amministrazione delle ferrovie trasformasse un certo numero di locomotive per adattarle all’impiego della lignite; che i fuochisti delle ferrovie fossero meglio pagati per compensarli dell’aumento di fatica dato loro dall’uso della lignite; che l’uso della lignite fosse imposto per legge a tutti i servizi dipendenti da pubbliche amministrazioni in tutti i casi in cui la lignite potesse senza danno sostituire il carbone; che il governo finanziasse le società che si proponessero l’impianto di centrali elettriche a base di lignite; che esentasse dall’avocazione dei sopraprofitti di guerra gli impianti di questo genere.
Il deputato socialista chiedeva cioè che si consumassero milioni per far lavorare qualche centinaio di minatori, moltissimi dei quali potevano tornare ai campi. I quali minatori avrebbero lavorato col pesante piccone a consumare milioni tolti a Pantalone!
Bisogna rilevare che le agitazioni dei minatori del bacino carbonifero del Valdarno erano capitanate da organizzatori dell’USI. Il caso sopra citato è quindi doppiamente interessante, e richiede riflessione, perché ci richiama ad un lato trascurato dagli anarchici operanti nelle unioni sindacali (il protezionismo) e perché ci fa intravvedere quali problemi del genere si possano affacciare per noi in un periodo rivoluzionario (tendenza di particolari categorie di operai a far sopravvivere industrie non redditizie dal lato dell’economia nazionale). Quale è stato l’atteggiamento degli anarchici incorporati nella Confederazione Generale del Lavoro e nell’Unione Sindacale Italiana di fronte al collaborazionismo socialista-padronale? Quando i dirigenti della FIOM anteponevano l’interesse di trentamila operai, impiegati nella siderurgica, viventi all’ombra del protezionismo doganale e del sovvenzionamento statale, all’interesse di 270 mila operai occupati in industrie del ferro di seconda e di terza lavorazione (metallurgiche e meccaniche), le quali avrebbero tutte da guadagnare dall’avere a propria disposizione la materia prima a buon mercato, quale è stato l’atteggiamento degli anarchici organizzati nella FIOM? Mi pare che non ci sia stata da parte degli anarchici facenti parte delle organizzazioni operaie una chiara idea della loro funzione di educatori. Opera di educazione classista sarebbe stata quella di ricordare che i milioni dati alla protezione delle industrie parassitarie venivano estorti nella massima parte alle altre moltitudini lavoratrici d’Italia. Gli anarchici si sono lasciati fuorviare dai socialisti, che, per ragioni demagogiche, rinunziarono a quella giusta e bella intransigenza dei tempi in cui l’elettoralismo, il mandarinismo e il collaborazionismo con la borghesia non erano ancora trionfanti. Agli industriali liguri, che licenziavano tremila operai e minacciavano di licenziarne entro un mese ventimila, se il governo non avesse rinunziato a diminuire i premi alla marina mercantile, l’Avanti! allora diretto dal riformista Leonida Bissolati, rispondeva:
« Gli operai sanno che i milioni dati alla protezione dell’industria navale sono estorti nella massima parte alle altre moltitudini lavoratrici d’Italia; e perciò, si rifiutano di formulare il desiderio che continui uno stato di cose, in cui il pane degli operai di una regione sia pagato con la fame dei lavoratori del resto d’Italia. » (Avanti!, 24 gennaio 1901)
A quali degenerazioni sia giunta la collaborazione operaia-padronale nei centri industriali lo dimostra il fatto che elementi cosiddetti rivoluzionari inscenarono agitazioni per ottenere dal governo lavoro per l’industria di guerra. Così, ne scriveva il Salvemini, sull’Unità dell’11 Luglio 1913:
« La Camera del Lavoro di Spezia, amministrata da sindacalisti, repubblicani e socialisti rivoluzionari, ha promosso uno sciopero generale.
Per protestare contro la uccisione di qualche operaio? No.
Per protestare contro una iniqua sentenza di classe, pronunciata dall’autorità giudiziaria? – No.
Per solidarietà con qualche gruppo di operai-scioperanti? – No.
Per resistere a qualche illegalità delle autorità politiche o amministrative? – No.
Perché dunque? – Per protestare contro il governo che minaccia di togliere all’arsenale di Spezia l’allestimento della corazzata Andrea Doria.
Va da sé che alla prima occasione i sovversivi di Spezia insceneranno anche a casa loro qualche “solenne comizio” contro le spese “improduttive”.
È da notare che a capo di questo movimento di protesta... rivoluzionaria, si trovava una cooperativa, quella degli operai metallurgici (Giornale d’Italia, 24 aprile). E va notato pure che l’agitazione di Spezia si è manifestata nello stesso tempo in cui il consiglio di amministrazione della Casa Ansaldo lamentava nella relazione annuale di non avere sufficiente lavoro. Nello stesso tempo gli operai del cantiere Orlando di Livorno facevano dimostrazioni addomesticate per reclamare che lo stato desse lavoro al cantiere Orlando (Avanti!, 14 maggio 1913). E i deputati di Napoli si recavano dall’On. Giolitti a chiedere “nuovi ordinativi per affusti, cannoni, spolette e proiettili” agli stabilimenti di Napoli, affinché non avvenissero nuovi licenziamenti di operai metallurgici (Corriere della Sera, 24 maggio). E i giornali clerico-moderati-nazionalisti spingevano avanti la campagna, affinché il governo impostasse nei cantieri quattro nuove grandi corazzate. »
Durante la settimana Rossa i centri industriali si mantennero fermi. Durante l’agitazione interventista, i centri industriali furono al di sotto delle campagne nelle manifestazioni antiguerresche. Durante le agitazioni del dopoguerra i centri industriali furono i più lenti a rispondere. Contro il fascismo nessun centro industriale insorse come Parma, come Firenze e come Ancona, e la massa operaia non ha dato alcun episodio collettivo di tenacia e di spirito di sacrificio che eguagli quello di Molinella.
Gli scioperi agrari del modenese e del parmense rimangono, nella storia della guerra di classe italiana, le sole pagine epiche. E le figure più generose di organizzatori operai le hanno date le Puglie. Ma tutto questo è misconosciuto. Si scrive e si parla dell’occupazione delle fabbriche, e quella delle terre, ben più grandiosa come importanza, è quasi dimenticata. Si esalta il proletariato industriale, mentre ognuno di noi, se ha vissuto e lottato nelle regioni eminentemente agricole, sa che le campagne hanno sempre alimentato le agitazioni politiche d’avanguardia delle città e hanno sempre dato prova, nel campo sindacale in ispecie, di generosa combattività.
Facile previsione: vi sarà un mandarino che scriverà che non ho un’“anima proletaria” e vi saranno dei lettori che capiranno che ho inteso svalorizzare il proletariato.
Per me risponde un’eco: quella dei calorosi applausi che salutano nei cantieri e nelle officine dell’industria di guerra l’annuncio del sottomarino da costruire o dei cannoni da fondere.
Per me risponde la tattica comunista consigliante di agire all’interno delle corporazioni e per le rivendicazioni economiche.
Per me risponde, anzitutto la rassegnazione del proletariato italiano, specie di quello industriale. Attendere che il popolo si risvegli, parlare di azione di masse, ridurre la lotta antifascista allo sviluppo e al mantenimento di quadri di partito e di sindacato invece di concentrare mezzi e volontà sull’azione rivoluzionaria che, sola, può rompere l’atmosfera di avvilimento morale in cui il proletariato italiano sta pervertendosi interamente, è viltà, è idiozia, è tradimento.