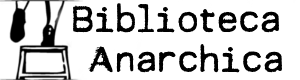Prima edizione: febbraio 2001
Seconda edizione: novembre 2013
Alfredo M. Bonanno
La logica dell’“a poco a poco”
Nota introduttiva alla seconda edizione
Suggerimenti per il lettore, nessuno.
Un piccolo libro che mette il dito sulla piaga che tutti ci fa purulenti, senza misericordia, sul convincimento che tutti manteniamo di essere dalla parte della ragione, di avere ragione, di vivere la nostra quotidiana lotta con la vita sulla capacità logica di scegliere.
Ebbene, non c’è questa capacità, non c’è mai stata in nessuno di noi. Andiamo avanti a braccio, navighiamo senza bussola. I migliori danno un’occhiata alle stelle e ne traggono presagi più che orientamenti. I panciuti e i satolli gridano allo scandalo e mostrano, con alterigia oltranzista, le tavole della legge, non quelle del roveto ardente ma quelle della pratica e dell’utile, del dare e del ricevere, insomma faccende da bottegai. E alzano la voce e strillano dalle cattedre e dai giornali, sporcano carta e disturbano le orecchie, ma solo per mettersi il cuore in pace e portare a casa lo stipendio.
Nessuna logica in un mondo ormai asfissiato dalla melma.
Almeno nessuna logica condivisibile sulla base di una qualsiasi acquisizione da difendere. Né proprietà da garantire – la morte se ne infischia del diritto di eredità – né possesso da tenere stretto – l’amore fugge via inorridito.
Non ci sarà nessuna rivoluzione se non ci liberemo della logica.
Che i miei maestri dormano in pace, e i sogni di organizzare il mondo nel migliore dei modi possibile dormano con loro.
De profundis.
Trieste, 31 gennaio 2012
Alfredo M. Bonanno
Introduzione alla prima edizione
“Se io non dico il vero – disse Climene a suo figlio Fetonte, parlando del sole – ricusi egli stesso di lasciarsi mai più vedere da me e questo giorno sia il mio ultimo giorno”.
(Ovidio, Metamorfosi)
L’idea di una riflessione critica fuori del contesto immediato della vita, assemblata nell’astratto delle chiarificazioni, e da qui inserita perfettamente chiara in tutte le occorrenze pratiche come luce per l’azione, guida per il da fare, è ormai tramontata con tutte le sue postille. Se il mondo moderno è condizionato sempre di più dalla scienza e dal suo braccio armato, la tecnologia, occorre che l’analisi su queste realtà regolative sia condotta, urgentemente, dal di dentro della vita stessa, in quanto è quest’ultima che ne va di mezzo, è quest’ultima che sta per essere ridotta ai minimi termini, se non proprio avvilita del tutto e quindi uccisa. Le gare di eloquenza hanno fatto il loro tempo.
L’evolversi della scienza, e quindi della tecnica, verso persi orizzonti sempre più coercitivi per quanto riguarda la libera pulsazione del respiro vitale che ognuno di noi sente dentro di sé, è un fatto ormai chiaro per tutti. Perfino coloro che di questo evolversi hanno fatto lo scopo e il lustro della propria esistenza di servi, e anche dei propri interessi di benestanti inclusi nell’esercizio del potere, ne hanno coscienza, trattandosi di fenomeni non più nascondibili, per quanto ovviabili, a breve scadenza, con accorgimenti palliativi e chiacchiere ideologiche.
La nuova condizione senza ritorno in cui si è venuta a trovare la scienza è la condizione legnosa della nostra esistenza attuale, ma non della nostra vita. Quest’ultima pulsa ancora intatta nei nostri cuori, anche se corre il rischio di non venire più alla luce nella veste rabberciata e burattinesca dell’esistenza, schiacciata sotto un cumulo di protesi e artifici, di simboli e codici. Conservando intatta la ragione, insomma, come si dice, non perdendo la testa, possiamo guardarci attorno e cercare una via d’uscita. Solo che qui non è faccenda ragionevole. Mantenendo intatta la ragione, la nostra cosiddetta capacità critica, finiamo con l’essere in cattiva compagnia. Lo strumento con cui pensavamo di “leggere” e di capire il mondo ci ha tradito, o meglio sarebbe a dire che non ci ha mai servito per come appariva agli albori dei suoi successi esplorativi: un servo intelligente e devoto. La ragione ha dato un senso alla nostra esistenza, senso su cui abbiamo giurato a lungo, ma contro di essa ha lottato da sempre la nostra vita, chiedendo quello spazio e quel tempo che a essa erano congeniali, non le risultanze di coordinate geografiche o di rilevazioni cronometriche. Così l’esistenza si è cristallizzata in insignificanti rappresentazioni valide di certo per reggere confronti, costruire valori misurabili nel dispettoso continuo confrontarci fra di noi, esseri cosiddetti umani, ma non può, allo stato attuale dei misfatti in corso, definirsi espressione immediata e concreta della vita.
Se la scienza non è in grado di dare un senso alla vita, e con la scienza la società che della scienza è prodotto avvilito e causa, nello stesso momento, dobbiamo rigettare la scienza e la sua armigera degenere, la tecnologia. Ma questo rigetto non può più essere illuminato dalle regole e dalle deduzioni che ci hanno accompagnato fin qui. Un muro di luce ci circonda, ne siamo abbacinati. Se tanto ci ha dato tanto, occorre fare un salto, un salto per prima cosa di natura logica. Abbisogniamo di una incommensurabile immaginazione. Dobbiamo scavare a bruciapelo fino alla radice delle regole che costituiscono il sottofondo comune della nostra esistenza, penetrare più a fondo di quanto abbiamo fatto finora, essere impietosi e brutali fino all’osso, fino alle estreme conseguenze, dovesse essere la nostra ripugnante conclusione quella della distruzione e delle rovine.
Se il mondo che ci sta soffocando è fondato sulla chiarezza e sulla distinzione, coordinate cartesiane che sono ancora alla base della scienza, spostiamoci un poco verso l’oscurità e la generalizzazione dei concetti, indaghiamo in quei territori sconosciuti dove paletti confinari ci avvertono che “hic sunt leones”, combattiamo la nostra guerra visto che siamo ancora indisponibili a combattere quella degli altri.
Se il mondo è ragionevolmente basato sull’accomodamento dei riformisti, che della politica e dello sfruttamento hanno fatto le condizioni primarie della loro esistenza di padroni, spostiamoci verso il rifiuto irragionevole, verso la distruzione che preferisce azzerare piuttosto che porre rimedio all’irrimediabile, diventiamo, se occorre, ciechi e muti.
Se il mondo è capace di verità, ma la sta nascondendo, della verità di questo mondo, di un mondo che mi sta uccidendo nelle estreme raffinatezze dei suoi ritrovati, non so che farmene, quindi lo cancello e con lui cancello la verità, sputo su quanto di vero è stato detto o fatto fino a ora, sulla pretesa che solo la verità è rivoluzionaria, pretesa da imbecilli, com’è facile capire se la verità del dominio è razionalità e perfezione, oscena corrispondenza dimostrata dall’oculatezza dei registri nazisti trovati nei campi di sterminio.
Tutto ciò, e altro ancora, significa mettere aspramente in discussione la logica su cui si basa il mondo. E la logica significa l’insieme delle regole che fissano con la consueta civetteria l’operato della ragione. Se cerco un senso alla mia vita, e questo senso non può essere quello della mia esistenza nel mondo basato sulle regole della logica, quindi della ragione, come ho compreso di poi, devo andare oltre questi livelli di scontro, oltre questi confini e queste regole, devo cercare un significato diverso alla mia vita, e questo lo posso trovare nell’ambito dei suggerimenti che la mia vita avanza e che insisto continuamente a fare tacere.
Io faccio tutto questo dall’interno del mio microcosmo, ma so perfettamente che questo convincimento, mio e singolarmente mio, non è isolato dal contesto complessivo della vita dell’umanità. Non avverto stimoli e sollecitazioni assolutamente “diversi” da quelli di ciascun uomo e di ciascuna donna, tutti apprezziamo questo bisogno essenziale della vita di venire alla superficie e di esprimersi al meglio delle sue potenzialità. Solo che tutti lo celiamo sotto un lago gelato, sotto secoli, millenni, di logica, di ragione, di chiarezza, di perbenismo, di verità.
L’umanità lotta per vivere la sua vita, lotta per venire fuori dalla prigione che il suo stesso venire in essere le ha costruito, che essa stessa si è malignamente costruita, e questa lotta è il corrispettivo esatto della mia lotta solo quando io mi nego alla comprensione ragionevole che tutto sembra oscurare sotto le linee amenissime del minore disturbo possibile, del miglioramento assicurato per tutti. E questa lotta è indirizzata verso uno scopo, essenziale, quello di essere ciò che la propria vita, la vita di ciascuno di noi, ci fa essere, non quello che la nostra ineffabile esistenza ci propone di diventare.
Se l’utilità continuamente rinettata, regina del mondo della scienza e della tecnologia, fonda la mia esistenza razionalmente giusta, quindi vera, chiara in tutti i suoi dettagli, allora è il momento di essere inutili, di pensare alla inutilità della propria esistenza, capovolgendo il sasso sotto cui sta stupidamente soffocando la vita, falsa per il dominio che tutti ci condiziona, oscura per la strapotenza delle immacolate regole logiche che ci tengono al guinzaglio, irragionevole per il compiacente gesto di chi vuole regolare i nostri desideri.
L’umanità sta oggi lottando per capire la vita, per cogliere questo impulso vitale malgrado tutte le forme di oppressione che la schiacciano all’interno di un pacchetto di esistenza sempre più ristretto e amministrato, fino a ridurla a una massa perfettamente amalgamata, capace di rispondere in maniera adeguata agli opportuni stimoli dei fabbricanti di opinioni per conto della politica e dell’economia. Sta lottando per la sua vita, non per la sua esistenza. C’è da persuadersi di questo fatto, ma questo persuadersi non può percorrere le strade lineari della critica classica, della logica dominante, deve scendere al di sotto, verso interstizi dove finora non abbiamo saputo, né voluto, penetrare. Se, da un lato, si può individuare una “esistenza vera”, non si può fare lo stesso per una “vita vera”. Non ci sono le possibilità per parlare di una vita che non sia vera, per cui affermando la possibilità di una vita “vera” si compie un misfatto logico, tipico della logica dominante, della logica dell’“a poco a poco”. La vita non ha bisogno di aggettivi, solo l’esistenza ne ha bisogno. È così possibile pensare a un’esistenza vera, difatti noi viviamo tutti un’esistenza (vera) dopo l’altra, siamo ora questo, ora quello, ciò che stiamo divenendo, sotto gli sproni che ci scavano i fianchi. La somma di queste esistenze, una più vera dell’altra, non dà la nostra vita, la sola realtà, il nostro solo mondo, che essendo vero nel significato ormai introvabile del termine non ha bisogno di essere indicato come tale.
I segnali della lotta che l’umanità conduce per non farsi sopraffare sono dati dall’autocomprensione che l’umanità stessa riesce ad avere delle varie fasi della sua lotta. A volte, non sempre, nella condizione umana, livelli di massima contrazione dell’esistenza corrispondono a livelli di massimo sviluppo della vita. Solo che non c’è un’autocomprensione adeguata di questo rapporto. Gli uomini e le donne affrontano il loro essere nel mondo come un accadimento fra gli altri, senza nessuna profondità d’animo, non rendendosi conto che tutto quello che ha importanza, sulla base delle regole imposte dal consorzio civile, non è altro che un cumulo di convenzioni privo di senso. Almeno privo di senso per la loro vita, per l’unica vita di cui hanno disponibilità, l’unica vita che potrebbe rivelarsi satura di prodigi. Ma, altre volte, questo sentimento profondo, il significato della vitalità, si manifesta in mille aspetti, specialmente nella sensibilità di attacco e di capacità distruttiva che la parte più sacrificata e sottomessa, in altre parole gli esclusi, riesce a manifestare concretamente, superando d’un balzo gli equivoci e le distanze logiche. La lotta di classe non è mai condotta ad esclusivo beneficio della parte che si solleva. Il futuro non può essere quello di una sostituzione della parte al tutto, ma di un ripristino di un tutto di ben altro genere e significato, naturalmente un tutto che ha saputo espungere dal suo seno, nel modo più radicale possibile, il fango che prima soffocava ogni vitalità.
La rivoluzione è quindi il ripristino pieno della vitalità e la cancellazione estrema di ogni traccia di esistenza codificata secondo quei criteri oggi imperanti. Non ci potrà mai essere nessuna rivoluzione totale e duratura, senza avere prima spiccato il volo verso la rivoluzione che ognuno deve fare in se stesso.
Queste due prospettive, la seconda propedeutica alla prima, non sono realizzabili impiegando gli strumenti della cultura e della ragione, così come ce li hanno consegnati secoli di civiltà, ridotti così a muscolose protesi che purgano il mondo di ogni ribelle. Il senso autenticamente originario di questi strumenti si è smarrito per strada. Man mano che l’umanità percorreva gli infiniti itinerari della sua storia, costruendo le condizioni del proprio sviluppo, ma anche della propria nientificazione, mille accorgimenti sono stati posti in atto per svuotare quegli strumenti della iniziale potenzialità eversiva. La parola si è rivelata più feroce del fatto. Dapprima patrimonio di una ristretta cerchia di dominanti quintessenziati, poi distribuiti a livello di massa, questi strumenti, non potendo più restare esclusivamente in possesso di pochi, sono stati svuotati di contenuti e di significati e consegnati alla massa. Di più, i principali fra di loro, prima di tutto gli strumenti logici, sono stati accomodati ad un utilizzo meccanicamente medio, cioè accomodante e perbenista. Nessuna logica oggi è di carattere radicale, sia pure in minima parte. Tutti coloro che accettano la condizione in cui vivono ragionano “bene”, cioè seguono ragionamenti acconci, quindi “veri”, nella loro tautologica inconcludenza, e quindi utili, profondamente utili al permanere del potere che tutti ci domina e riproduce.
Lottare per il ripristino di ragionamenti “altri”, che poi non sono mai del tutto “nuovi” nel senso che stupidamente la cultura dominante dà a questa parola, è un compito vastissimo, di cui cercherò di dar conto qui e altrove. Ragionare tenendo presente la vita, la propria vita, misurando la distanza che passa tra la vita e l’esistenza che si è più o meno costretti a sopportare, dai dominanti sistemata a loro uso e consumo, ecco un compito difficile ma possibile, per quanto non esauribile in assoluto. Non arrendersi all’evidenza, alla faziosità del tutto chiaro, alla specificazione che ogni cosa congiunge e incasella al posto giusto. Non arrendersi alla chiarezza abbacinante della verità, alle sue statiche celebrazioni, non arrendersi all’autenticità di chi vuole farci intendere che questa merda è la migliore possibile che poteva toccarci in sorte. Lottare perché la vitalità che ruggisce dentro ognuno di noi venga fuori nella pienezza della sua selvaggia potenza.
Non vogliamo rifare l’uomo, non vogliamo suggerire percorsi per un divenire radioso o diverso da quello che oggi viene represso e nascosto, vogliamo solo che quello che è venga fuori e che l’esistenza si confonda con la vita producendo una sola espressione vitale, l’uomo e la donna finalmente liberi.
Trieste, 1 novembre 2000
Alfredo M. Bonanno
I
“Li vede? Sempre eguali. Fuori del presente. Fuori della corrente del fiume Vita. Ridotti alla sopravvivenza. Simili a certi vecchi mobili ingombranti, collocati in un angolo, spesso in mezzo a una camera, qualche volta al posto d’onore in salotto, solo perché non si sa dove riporli; o anche per abitudine, per inerzia, per tradizione – per superstizione. Ci sono ma nessuno li guarda, nessuno li vede. Se qualche volta ce li ritroviamo presenti, è perché ci sbattiamo sopra uno stinco. L’involucro è sempre lo stesso. E anche la sostanza, dentro. Se sostanza si può chiamare. Due monumenti domestici. Due vecchi armadi. Due vecchie credenze. Due vecchi orologi a pendolo che da anni non pendolano più, perché da anni non hanno più avuto la carica. Periodicamente, all’incirca a ogni generazione, cambiano le facce dentro l’involucro che, per parte sua, non cambia mai. Io ho già veduto cambiare una volta le facce dentro queste due sagome sedute: quando le facce di mio nonno e di mia nonna sparirono, e furono sostituite dalle facce di mio padre e di mia madre: queste che lei vede ora”.
(Alberto Savinio, Alcesti di Samuele)
La realtà ha una sua logica, quella del “tutto e subito”. Le vicende umane invece ne hanno due, quella del “tutto e subito” e quella dell’“a poco a poco”. Questo libro si occupa della seconda di queste due logiche, ma per fare ciò è costretto a sviluppare un lungo accanito aggiramento. Da nessuna parte il nemico smette di chiacchierare.
A partire da questo momento ci occuperemo di uno scopo un po’ ambizioso: mostrare come solo nelle cose umane si sia riuscito a far passare la possibilità di una logica ragionevolmente progressiva, una logica che sempre più infittisce le sue reti guardando al domani con l’occhio parsimonioso e prudente del contabile. E ciò mentre nella realtà non esiste traccia di questa progettualità dai tempi lunghi, ma solo la vita immediata, nel suo aspetto meno comprensibile. Come fra l’altro accade nelle cose dell’uomo, quelle non traviate ad arte nei laboratori del capitale, dove si costruiscono le teorie in base alle quali dovremmo capire come funziona il meccanismo della realtà.
In altre parole, questo libro parla dell’anarchia. Non come avvenimento futuro, estremo limite della liberazione umana, cosa che sarebbe molto simile alla costruzione di una storia ulteriore diretta solo ad assegnare compiti a qualcuno, scuoiamenti giornalieri, uccisioni al minuto, ma come realtà in atto, come movimento. L’uso che qui faccio del termine “logica” è alquanto improprio. Ma, in fondo, tutta la cosiddetta scienza della logica è contraddittoria come un gallinaccio, se non altro nella definizione del proprio oggetto e del compito che si è assegnato da sé. Lo stesso suo fondatore, Aristotele, autore degli Analitici, non si dà pensiero di provvedere di un nome l’attività di cui si occupa. Resta fermo per lui che comunque deve trattarsi di un’attività che interessa il problema della dimostrazione. Più semplicemente, oggi si ricorre alla definizione di logica come scienza del linguaggio, mentre la definizione di logica come scienza del pensiero è ormai morbidamente messa da parte. È evidente che questa conclusione è troppo riduttiva.
Tutti i logici si rifanno alla chiarezza come condizione essenziale della loro scienza. Tutti i trattati di logica, luoghi abitati da cadaveri, fanno la distinzione fra idee chiare ed oscure e fra idee distinte e confuse. Una idea chiara è una idea che viene trasmessa in modo da essere riconosciuta da tutti coloro con cui essa viene in contatto, non ci potrà essere confusione in merito, come guardando un cocomero rotondo e lucido. Se è priva di questa chiarezza, tale idea è considerata oscura.
Ma non è sempre facile riconoscere un’idea per le sue condizioni di chiarezza. Spesso per rendersi conto di questa chiarezza occorre uno sforzo considerevole e si corre il rischio di confonderla con un’altra, magari meno chiara ma più accattivante e meno cafona per la forma in cui è espressa. D’altra parte, la semplice conoscenza di un’idea, che per molti motivi ci è diventata familiare, può rendere chiaro qualcosa che per altri resta oscuro, in piena convulsione di noia. Ne deriva che la chiarezza non corrisponde quasi mai alle ineffabili condizioni preventive per meglio capire la realtà, per l’apprensione che ci interessa, dal momento che, dopo tutto, il nostro senso di padronanza di quell’idea può essere sbagliato. Ma i logici, oltre a parlare di chiarezza, si asciugano le mani con la distinzione, e cioè si riferiscono alla capacità di fare divisioni, di catalogare, specificare, insomma dividere la totalità del reale in tante caselle più o meno precise. Una strategia da obitorio.
«Donde è nata – si chiede Nietzsche – la logica, nella testa umana? Certamente dall’illogicità, il cui regno in origine doveva essere immenso. Ma innumerevoli esseri giunti a conclusioni diverse da quelle cui giungiamo oggi noi sono andati in malora: ciò potrebbe esser stato ancora più vero! Chi ad esempio non riusciva a scoprire abbastanza spesso quanto era uguale, con riferimento al cibo o agli animali che gli erano ostili, chi cioè sussumeva troppo lentamente ed era troppo cauto nel processo di sussunzione, aveva soltanto meno probabilità di sopravvivere rispetto a chi tra le cose simili indovinava immediatamente quelle identiche. Tuttavia soltanto la tendenza prevalente a trattare tutto ciò che è simile come uguale, una tendenza illogica – perché di per sé niente è uguale, – ha gettato tutte le fondamenta della logica. Parimenti, affinché nascesse quel concetto di sostanza che è indispensabile alla logica, per quanto nel senso più rigoroso del termine, non si dovette né vedere né percepire la mutevolezza delle cose; gli esseri che non vedevano bene ebbero così un vantaggio rispetto a coloro che vedevano tutto “in divenire”. Di per sé già quell’alto grado di cautela nel giungere a conclusioni e ogni tendenza scettica costituiscono un grande pericolo per la vita. Non sarebbero sopravvissuti esseri viventi se non fosse stata coltivata, in modo straordinariamente forte, la tendenza contraria, ad affermare piuttosto che a sospendere il giudizio, a errare e fantasticare piuttosto che ad attendere, ad acconsentire piuttosto che a negare, a giudicare piuttosto che a essere giusto; e noi, di solito, sperimentiamo soltanto il risultato della battaglia, tanto rapidamente e di nascosto si svolge dentro di noi questo antichissimo meccanismo». (La gaia scienza, 111). Il ragionamento, inteso come contrasto e arresto del flusso vitale, dovrebbe essere impossibile. Invece l’uomo è riuscito a farlo venire in essere, a realizzarlo contro ogni aspettativa. Invece di vivere egli sopravvive, e sopravvivendo riflette sulle condizioni che rendono possibile questo straordinario fenomeno di resistenza e di retrocessione. Ragionare significa arrendersi, e nessuna possibilità culturale, nessun artificio ideologico, potrà mai dimostrare il contrario. La realizzazione di questa impalcatura resistenziale e riduzionale è infinita, accade di continuo che questo straordinario animale che è l’uomo se ne preoccupi e vi si esaurisca sopra. Sopravvivenza significa in ogni caso riduzione delle forze vitali a qualcosa di trasparente, pagamento di uno scotto più o meno pesante per garantirsi il futuro, messo in pericolo dalle capacità disgregative della vitalità che ci esplode continuamente dentro. L’uomo ha imparato ben presto a tenersi a rispettosa distanza dai suoi stessi stimoli, per evitare di sbriciolare quelle modeste costruzioni sociali che andava, via via, realizzando, affascinanti come statue di cristallo ma come statue di cristallo destinate all’effimero. Costruzioni dalle quali si aspettava pur sempre un aumento della propria resistenza di fronte all’ignoto e ai pericoli del futuro.
La logica dovrebbe comprendere non solo una riflessione sul pensiero, e quindi anche sul linguaggio, ma nello stesso tempo una riflessione sulle condizioni dell’effettualità, cioè tutto quello che rende possibile l’agire, che se è momento diverso dal pensiero non è da questo separato. La riduzione cui faccio cenno qui della logica come scienza del linguaggio, è un aspetto della logica che definisco dell’“a poco a poco”, il quale ha come metodo la catalogazione del senso e come fine il rinvio all’infinito della ricerca della qualità, anche attraverso il ricorso a tutta una serie di giustificazioni ingigantite. C’è nella moderna concezione della logica matematica o formale, la credenza cieca che si possano realmente abbandonare tutte le premesse filosofiche (nei confronti delle quali si ha un manifesto ribrezzo) affidandosi alla razionalità dei processi di analisi formale. «In questo bisogno – scrive Giovanni Vailati – che le teorie più astratte hanno (e tanto più hanno quanto più sono astratte) del sussidio di fatti particolari, non già fatti che servono a confermare o a rendere induttivamente probabili le singole premesse sulle quali esse si basano, ma di fatti che garantiscano la capacità di queste a convivere e a cooperare utilmente, in questo bisogno che ha la logica pura di attingere forza, come Anteo, dal contatto periodico con la terra, non si può fare a meno che riconoscere uno dei sintomi più significanti di quella corrispondenza segreta, o misteriosa alleanza, tra “gli estremi dell’attività teorica” (tra l’intuizione del particolare e l’impulso ad astrarre e a generalizzare) che non è ultimo merito delle teorie pragmatistiche l’aver segnalato e preconizzato. Pragmatisti e matematici si trovano pure d’accordo nella massima concisione e nella massima rapidità di espressione, nella tendenza ad eliminare ogni superfluità e ridondanza, tanto di parole che di concetti. Per gli uni e per gli altri il valore delle teorie e delle dottrine non va ricercato soltanto in ciò che esse dicono, ma anche in ciò che esse tacciono e in ciò che esse si rifiutano di esprimere o di prendere in considerazione. Uno dei principali risultati della logica matematica è costituito appunto dal riconoscere quante fra quelle che passano per verità matematiche non devono la loro esistenza che a delle imperfezioni di notazione che permettono di enunciare lo stesso fatto in modi diversi, per avere poi il piacere di riconoscerlo come identico sotto le sue diverse enunciazioni». (Scritti, Lipsia-Firenze 1911, p. 694). Portata alle sue estreme conseguenze, questa considerazione finisce per penalizzare uno strumento (quello matematico) che potrebbe avere sviluppi interessanti, ben oltre l’attuale ristretto orizzonte di strumento analitico circoscritto al solo scopo di denunciare i difetti delle argomentazioni. Per un altro verso, però, denuncia l’inconsistenza di fondo di ogni illusione matematica diretta a prevedere lo sviluppo del mondo. Da quando la tragedia ha fatto la sua comparsa, facendoci vivere fino in fondo la realtà come tale, cioè come apparenza, non è più possibile alla matematica dire qualcosa di essenziale. Il dire essenziale lacererebbe fino in fondo il tessuto delle convenienze. Solo i bamboccioni in vena di ghiribizzi ideologici non lo sanno e cercano il vero sulla punta della loro spada. Altrettanto ridicoli, con il loro estremismo puramente verbale, dei matematici vecchia maniera che cercavano il vero sulla punta delle loro formule.
Di passata, preciso che il termine formale viene qui usato nel suo significato simbolico, in contrapposizione approssimativa con sostanziale, termine quest’ultimo che da per se stesso ha significati molto equivoci e pieni di rancori, ma che nel discorso del senso comune si avvicina di più ad un’idea di compattezza, di sacrosanta coerenza e realtà. Che questi due significati, ad una verifica sia pur minima, finiscano per svuotarsi come bambagia e poi per non reggere del tutto, questo è un altro problema. Difatti, considerando le cose dal punto di vista della contrapposizione tra forma e struttura della realtà, la sostanzialità tradizionale, per come vagamente la intuiamo, dovrebbe appartenere a quest’ultima ed invece, nello svolgimento dei fatti, il segreto della realtà si può cogliere soltanto attraverso la forma nella sua rarefatta generalità. Si deve sottolineare l’importanza di non cogliere la forma come se fosse un oggetto globale, un contenitore più grande, perfino capace di contenere tutto, perché allora si avrebbe una cristallizzazione strutturale della forma. Se faccio questo, la formalità diventa la buccia vuota della struttura, il suo guscio esteriore, l’etichetta di un cerimoniale di catalogazione che sta vanificando il contenuto dell’esperienza.
II
“Dopo aver descritto un mondo caotico, larvale, illusorio, mi sono impegnato ora a parlare dell’esistenza di un altro mondo, più reale, più coerente, dove esiste del bene, del bello, del vero – nella misura in cui i contatti che ho potuto avere con tale mondo mi danno il diritto e il dovere di parlarne. Sto scrivendo un racconto piuttosto lungo nel quale si vedrà un gruppo di esseri umani che hanno capito di essere in prigione, che hanno capito di dovere, prima di tutto, rinunciare a questa prigione (perché il dramma è l’attaccarvisi), e che partono in cerca di una umanità superiore, libera dalla prigione, presso la quale essi potranno trovare l’aiuto necessario. E lo trovano, perché alcuni compagni e io abbiamo realmente trovato la porta. Solo a partire da questa porta comincia una vita reale”.
(René Daumal, Lettera del 24 febbraio 1940)
Tornando alla logica, in un modo o nell’altro questa appare come una specie di coerenza di comportamento o di pensiero, che poi è la stessa cosa. Ma questa coerenza, come vedremo più avanti, non può avere pretese assolute, quindi non può fissare i canoni di una regola della ragione, cioè di una razionalità, né tanto meno quelli di una regola della non-ragione, cioè di una irrazionalità. Sia la logica dell’“a poco a poco” che la logica del “tutto e subito” possono avere l’orgoglio di essere sia razionali che irrazionali, secondo il rispetto o il rifiuto di alcune condizioni o il verificarsi di alcuni fatti.
Nel flusso dei significati che ci circonda, l’orientamento che decidiamo di scegliere verso il contenuto della realtà seleziona automaticamente l’impiego di una logica dell’“a poco a poco”, per quanto non si possa escludere del tutto quell’altra logica, anche considerandola come una possibilità remota, una cacciatrice in agguato, un’assurdità da negare positivamente. La logica dell’“a poco a poco” ha il compito di ridurre al presente l’utopia non storicizzata producendo il tempo e lo spazio, purché le diverse operazioni, singolarmente irrealizzabili e anche un po’ velleitarie, si inseriscano all’interno di un progetto gestito dal meccanismo della specificazione del reale, cioè della conoscenza che incamera notizie, le elabora in opinioni e, strozzandole, le fa circolare allo scopo di produrre il mondo e, nello stesso momento, l’invadente burocraticismo che lo caratterizza. La logica del “tutto e subito” sconvolge il concetto stesso di utopia, negandola come situazione pensabile in una stupida pianura al di qua del coinvolgimento e quindi di una trasformazione in atto. A voler essere precisi, quindi, l’utopia è tale solo quando produce di già trasformazioni, non quando contribuisce a semplici chiacchiere.
Come ha fatto notare Emanuele Severino: «La tecnica deve anche comunicare ciò che essa è e fa; ossia deve porlo al centro della memoria globale. Altrimenti le forze della tradizione porrebbero se stesse al centro di tale memoria e manterrebbero viva l’immagine della tecnica come semplice strumento neutrale, ritardandone la trasformazione in scopo primario e fondamentale. Poiché la tutela e l’incremento di quella memoria ossia della dimensione informatico-telematica appartiene alla potenza della tecnica, ossia allo scopo che la tecnica possiede per se stessa, il fatto che la tecnica comunichi ciò che essa è e la sua destinazione al dominio appartiene essenzialmente al suo scopo. La necessità di questa comunicazione è data anche dalla circostanza che non c’è potenza al di fuori del suo carattere pubblico, ossia di ciò che ha al proprio centro la comunicazione». (Il destino della tecnica, Milano 1998, pp. 15-16). Lo stesso discorso, molto più complesso e articolato, e quindi meno pudico, vale per il significato e l’esistenza del tempo e dello spazio. L’orientamento verso l’intuizione percettiva iniziale, il cominciamento di ogni possibile visione del mondo che ci circonda, ci dà meglio la coscienza di quello che vogliamo fare delle nostre esperienze personali, elementi che servono a capire la realtà in cui viviamo. In una concezione statica, difatti, non sarebbe concepibile una realtà in termini di totalità, e tutti moriremmo solitari. Lo stesso in una concezione che facesse dell’ipotesi della staticità, o dell’inerzia, che fa lo stesso, il fondamento di una realtà che può dividersi in fasi armonicamente bilanciate tra loro. In una simile prospettiva si indicherebbero, di volta in volta, situazioni praticamente autonome, fenomeni circoscritti, compattezze ineliminabili. Tutto ciarpame che non può essere tollerato ulteriormente.
Non possiamo conoscere se restiamo vincolati nello schematismo del parziale. Certo, capire è sempre suddividere e spezzettare, catalogare e differenziare, tante camere d’aria separate. Ma, prima di tutto questo, prima che il coltello dell’anatomista o lo schedario del tassonomo intervengano a mettere ordine, occorre andare al di là della sensazione, e questo può farsi solo cogliendo la totalità. Occorre cioè liberarsi dal ristretto abito mentale della sensazione, perdere quella porzione di realtà che la stessa sensazione ci mette davanti, per penetrare ancora più oltre, nel meccanismo stesso della catalogazione, ben al di là del dato immediato, del fenomeno così come viene descritto dalla pretesa oggettività empirica cui fa riferimento costante la ricerca scientifica. Permanga quindi la nube. Difatti qui si vede in modo accessibile a tutti come il lavoro dei filosofi e degli scienziati sia stato, con molto garbo, negli ultimi secoli, diretto a giustificare l’evidenza con l’evidenza, il razionale col razionale, ammettendo senza mezzi termini la logica del reale come l’altro lato della realtà logica, perfezionando lo strumento di ogni possibile svuotamento futuro. In questo modo si è trascurata la realtà vera e propria, le sue contraddizioni, le sue ansie, favorendo un uso familiare di supposizioni destinate al miglioramento progressivo delle condizioni di vita dell’uomo, supposizioni che hanno avuto il solo pregio di restare tali, speranze senza fondamento e senza realizzazione, una forma come un’altra di vigliaccheria.
In questa direzione si è mosso Adriano Tilgher: «“Tutto ciò che è reale è razionale; tutto ciò che è razionale è reale”; la celebre formula hegeliana riassume con concisione lapidaria la nuova concezione che la borghesia, da rivoluzionaria divenuta conservatrice, sostituisce all’antistoricismo rivoluzionario del secolo XVIII. Ma, come tutto lo Storicismo di cui essa è la dichiarazione solenne, la formulazione hegeliana è equivoca, e, secondo che si calchi sul reale o sull’ideale, assume aspetto totalmente differente. – Si calca sull’ideale: è reale solo ciò che la Ragione ha generato da sé, solo ciò in cui essa si riconosce e ritrova come in un suo prodotto. È la Ragione, dunque, che giudica in ultimo appello la realtà di fatto e la giustifica o condanna. La formula, allora, è rivoluzionaria. – Si calca sul reale: è razionale non ciò che a un Tizio qualunque piace di chiamar tale, ma solo ciò in cui si è calata ed incarnata la Ragione dell’umanità, tutta quanta, la Storia, la tradizione, la realtà di fatto che, in ultima analisi, giustifica o condanna i piani e programmi dell’individuo. La formula, allora, è conservatrice; con essa alla mano Katkoff fa l’apologia dello Zarismo. Il valore ed il significato intimo della formula sono proprio in questa duplicità di significato, che però essa può mantenere solo fino a che la borghesia potrà, senza temere sostanziale offesa al suo dominio di classe, concedere al proletariato qualcosa di quello che esso chiede e non opporsi alla sua graduale elevazione. Ma a mano a mano che il proletariato alla realtà di fatto dello stato borghese andrà opponendo le esigenze sempre crescenti e sempre più radicali della Ragione, la borghesia alle critiche della Ragione andrà sempre più opponendo le obbiezioni dello stato di fatto. – Più il proletariato si sviluppa e rigoglieggia, più la sua critica si accentua in senso rivoluzionario, più lo Storicismo in principio progressista e riformista cioè rivoluzionario e conservatore insieme, scivola fatalmente verso il conservatorismo puro». (Critica dello storicismo, Modena 1935, pp. 69-70). La storia può essere interpretata in termini di progresso fin quando non si leggono con attenzione i riferimenti, sempre disponibili, dei massacri e dei genocidi. Allo stesso modo non è più possibile leggere divisamenti lineari, attribuibili a un qualche dio nascosto o a un qualche meccanismo, una volta che si è capito come la voce della morte regga il processo storico. Al di sotto della ufficialità e della normalità, rese tali dalla pressione esercitata dal dominio che registra solo quello che conviene alla sua perpetuazione, ci sta l’uomo autentico, l’individuo vitalmente originario, che non riesce ad emergere che a sprazzi a livello collettivo, ma che sempre urge a livello individuale nella sua intollerabile inciviltà.
Per il momento non è possibile muoversi con disinvoltura all’interno di questo problema. Manchiamo di troppi elementi. Comunque, quello che qui mi interessa è fare capire l’importanza di partire dalla totalità. Ciò potrebbe dare l’impressione, specie nelle primissime fasi dell’applicazione del metodo, di volere quasi rigettare il senso più intimo della realtà, evitare di guardare nell’occhio scuro della belva, rifiutarsi di fronte alle richieste di immediata accumulazione, di catalogazione dello stato di fatto, di produzione della vita quotidiana per come appare nelle realizzazioni produttive e sociali. In effetti, quello che voglio dire è che la sovradimensione del pensiero della totalità, nel meccanismo complesso del ragionamento umano, si realizza di regola dopo, come una ulteriore procedura della medesima accumulazione, una sorta di procedimento sistematico dell’archivio. La qual cosa non è altro che una ulteriore limitazione delle nostre capacità, un racchiuderle in una banale chiacchierata, e quindi una forma di ulteriore controllo.
In altri termini, spostando l’analisi sulla effettiva considerazione della totalità, noi saremmo in grado di pensare in modo diverso, quindi aperto, esperienze della nostra vita che abbiamo ormai catalogato come definitive, solo che non lo facciamo perché, di regola, ci troviamo prigionieri di un meccanismo che è stato collocato nel tempo, ci troviamo all’interno di un modello temporalizzato della realtà, con Eraclito a capostipite. Dobbiamo quindi imparare a vivere sul limite delle condizioni di fattiva normalità imposte dal dominio, dove ogni cosa che possiamo immaginare è di già una diversità oziosa per il suo semplice essere al margine, al confine, lontana da ipotetici centri, continuamente in formazione e continuamente capaci solo di svelarsi del tutto fittizi. «Il dominio effettivo – scrive Severino – è reso possibile dal carattere sperimentale della scienza. Qui il valore della previsione non è determinato dal senso immutabile della totalità, con il quale l’epistéme anticipa tutto ciò che può sopraggiungere: è l’esperienza a decidere in ultima istanza il valore di ogni previsione, e l’esperienza non consente che la previsione acquisti un valore definitivo e incontrovertibile. La scienza diventa la forma più potente di dominio, perché rinuncia al sogno epistemico di una previsione incontrovertibile e diventa previsione ipotetica e quindi sempre aperta al rischio dell’insuccesso. La cultura contemporanea ha ormai raggiunto una piena consapevolezza del carattere ipotetico e delle estreme possibilità di dominio della scienza. Ciò che invece continua a sfuggire è che la scienza moderna è la forma più potente di dominio perché è la forma di dominio più adeguata al senso greco del divenire, ossia è la forma di dominio in cui il senso greco del divenire è presente con una radicalità e una coerenza che non erano mai state raggiunte». (Legge e caso, Milano 1980, pp. 29-30). L’aggiustamento è la regola della logica dell’“a poco a poco”, e con l’aggiustamento la soluzione socialdemocratica di ogni problema. Partendo dal lavoro di ricostruzione della filosofia fatto da Cartesio, fino a oggi, si è datto spazio solo teoricamente allo scetticismo per poi scartarne l’uso in maniera recisa. La mania di costruire è la principale forma di affezione all’esistenza, in qualsiasi condizione ci si trovi. Pensate a quanto costruiscono i carcerati nel corso della loro detenzione: barche e lavoretti a maglia, matite coperte di intrecci di seta e cornici per ritratti fatte con fiammiferi bruciacchiati. Abbiamo smesso da tempo di guardare all’autorità degli scolastici come alla sorgente definitiva della verità. Sempre Cartesio, per primo, ebbe a cercare, e ritenne di averla trovata nella mente umana, la fonte “naturale” dei princìpi veri, passando, per la via più immediata e diretta, dal metodo dell’autorità a quello basato sull’apriorità. La crescita dell’autocoscienza finiva quindi per fornirci ogni genere di verità fondamentali permettendoci di decidere ciò che era in concordanza con la ragione. L’unica condizione per questo fondamento è che si trattasse di idee “chiare”, come quelle delle “cose” matematiche. «L’atteggiamento conoscitivo, per noi individui spirituali di un certo livello di sviluppo, è qualcosa di corrente. La nostra vita si muove in una progressiva conoscenza come pure in una lotta costante per ottenere beni e raggiungere mete. In questo progredire, diventano oggetti per noi sempre nuove regioni del mondo. L’obiettazione procede sempre avanti, il suo raggio si allarga. E con esso si allargano sia l’ambito dell’oggettività di coscienza, sia la nostra orientazione nel mondo. E poiché qui l’atteggiamento della coscienza è obbiettivo, essa si abbandona al campo oggettivo senza riflettere su se stessa. Per lo spirito, questo è diventato un atteggiamento ovvio. Eppure, a guardar meglio, l’ovvietà è qualcosa che fa meraviglia. In questo caso l’orientazione sul mondo ne è solo un lato, il lato pratico e di maggiore attualità per la vita perché ogni valutazione e ogni padroneggiamento la presuppongono. L’altro lato riguarda invece lo spirito stesso, in quanto, per il semplice fatto che il mondo gli diventa oggetto, viene ad assumere nel mondo una posizione particolare. La peculiarità di tale posizione dello spirito consiste nel fatto che il suo rapporto alle cose mette anche le cose in un altro rapporto rispetto allo spirito. Esse, in quanto ob-jettate, non sono più soltanto in sé, ma anche per lui. In quanto la coscienza, nel conoscere, si abbandona alle cose, queste le si danno a loro volta, e si danno come ciò che sono in sé, danno il loro essere-in-sé. Ciò distingue la datità conoscitiva da ogni altra datità. Anche all’animale qualcosa è dato, ma non come ciò che è in sé, bensì solo come ciò che lo minaccia o attrae, che lo nutre o gli giova. In questo senso, anche l’organismo è il punto di riferimento di un esser-per-lui delle cose. Ma è un esser-per-lui di tipo diverso, perché le cose non sono, per lui, ciò che sono in se stesse. L’animale da preda non è, ad esempio, per l’animale da rapina, ciò che è per sua natura – un vivente capolavoro della natura – ma soltanto una preda, il che non appartiene necessariamente all’essenza di questa specie animale. Per lo spirito invece, l’animale da preda è ciò che è in base alla propria essenza. In altre parole: è il suo oggetto». (N. Hartmann, Il problema spirituale, tr. it., Firenze 1971, pp. 156-157). La realizzazione della nostra esistenza è, come ormai si è capito, fondata sull’accumulo delle esperienze, nostre e dell’intera umanità. Per accedere a questo accumulo abbiamo bisogno di una chiave culturale che ne consenta la comprensione e l’utilizzo. Tutta la nostra esistenza è basata su questo progressivo movimento di acculturazione e di utilizzo. Ma che ne è, nel contempo, della nostra vita? Per ogni singolo gesto di partecipazione progressiva ci sentiamo di essere all’interno di qualcosa ma, come ha detto bene Hartmann, non siamo che l’oggetto per altri, mai il nostro essere per noi stessi, la nostra stessa vita. Portare alla luce questa forza nascosta è il compito critico contro la logica dell’“a poco a poco”.
Nella logica del “tutto e subito”, che è logica della totalità, l’unità del singolo individuo si raggiunge attraverso quella degli altri individui, non contro di questa, ma insieme a questa, altrimenti sarebbe solo sublime cecità. Qualsiasi cosa possa avvertire a questo livello, la coscienza l’avverte come parte dell’umanità e ciò per quanto possa poi dimenticarsene nel continuo tentativo di prestare assoluta fede ai contenuti dell’esperienza, spesso noiosi. Anche nel meccanismo di accumulazione, dove il contenuto può essere ridotto al livello di singolo fenomeno o di isolata sensazione, sta un’unione fondamentale che non c’è modo di tagliare a pezzetti, se non facendo ricorso alla zavorra delle astrazioni, le quali astrazioni, in ultimo, ritornano sempre nell’orientamento delle esperienze e vengono inglobate proprio all’interno di quell’unità da cui avevano cercato di fuggire. Ma non c’è solo questo aspetto chiuso della totalità, questa ineluttabile completezza del senso, c’è anche lo sforzo e il dubbio, l’incertezza e la diversità, tutti elementi che vengono fuori dal contesto apparentemente perfetto della struttura per proporsi a qualcosa d’altro, all’espressione, che comunque è sempre, ineluttabilmente, elemento della realtà nel suo aspetto totale. E, così continua Severino: «Scienza e tecnica stanno al culmine della potenza perché, isolando le cose su cui la loro potenza si esercita, il loro atto isolante non è limitato da alcuna epistéme – che invece è sempre un atto unificante. La specializzazione scientifica è appunto questa capacità – o questa fede di essere capaci – di prescindere dai contesti e dalla totalità della realtà. Infatti si possono dominare le cose, solo se le si isola dal loro contesto. Se si fosse convinti che, prendendo in mano un oggetto, ci si dovrebbe tirare dietro tutto l’universo, non si stenderebbe nemmeno la mano per prenderlo. Se si fosse convinti che le cose formano una rete indissolubile che tutte le unisce, non si deciderebbe più di agire. Si stende la mano per prendere qualcosa, solo se si è convinti che essa sia separabile dai condizionamenti esercitati su di essa da tutte le altre – e dunque dominabile. Nella scienza moderna la specializzazione, che isola una parte della realtà e tende a renderla totalmente dominabile, diventa un atteggiamento metodicamente perseguito. E l’isolamento è radicale, perché la scienza pensa e agisce all’interno della forma di isolamento che il pensiero filosofico porta sin dal suo inizio alla luce e che il “parricidio” platonico rende stabile: l’isolamento ontologico, dove le cose sono massimamente separate, perché sono separate nel modo che non può essere superato da un modo più radicale della separazione. Le cose sono massimamente separate perché sono separate dal loro stesso essere; sì che il loro rapporto con l’essere (per il quale si può affermare che esse sono) è successivo o accidentale rispetto al fatto originario della separazione e dell’isolamento». (Il destino della tecnica, op. cit., pp. 257-258). La separazione è la distinzione, e questa quella. La distinzione è la chiarezza, e questa quella. La realtà chiara e distinta è fondata sulla possibile separazione, che sblocca gli effetti inibitori del pudore. La realizzazione della realtà è progressiva e infinita, non viene mai completata, in questo l’uomo resta abbandonato a se stesso, proiettato verso una prostrante rincorsa all’infinito immersa in una cortina di fumo. Lo scopo da raggiungere diventa il raggiungere lo scopo, tutto scompare al di sotto dello strato di utilità che copre la vanità di ogni cosa.
Molto attentamente, George Simmel: «Lo sviluppo della filosofia, come quello del pensiero individuale, si indirizza dalla molteplicità all’unità e dall’unità alla molteplicità. La storia del pensiero dimostra l’inutilità di cercare di acquisire in modo definitivo uno di questi punti di vista; la struttura della nostra ragione nel suo rapporto all’oggetto richiede piuttosto l’equivalenza dei due princìpi. Tale equivalenza soddisfa l’esigenza monistica di unificare il più possibile ogni molteplicità – cioè come se si volesse arrivare ad un monismo assoluto – e l’esigenza pluralistica di non fermarsi a nessuna unità, ma di indagare in ognuna di esse alla ricerca di elementi ancora più semplici e di forze elementari, come se la meta finale dovesse essere di natura pluralistica. Lo stesso vale se si segue il pluralismo nel suo significato qualitativo: nella differenziazione individuale delle cose e dei destini, nella separazione degli stessi tra natura e valore». (Filosofia del denaro, tr. it., Torino 1984, p. 168). La nostra potenza vitale si muove quindi tra una separatezza e una solidarietà e cerca di superare la distinzione che continuamente la colpisce in tutti i suoi momenti esistenziali. Io porto tutto con me e non rispetto le regole di convivenza. La vita sembra in questo modo comprensibile quando l’oltrepassamento si verifica, sopportabile quando si godono le sue gioie anche se in isolamento, mentre le altre situazioni riservano soltanto dolore e sofferenza. «Raramente – continua Simmel – siamo consapevoli che queste tendenze sono in pura linea di principio radicalmente opposte, ma nei nostri intenti, nelle nostre mete, nelle nostre attività frammentarie esse determinano regolarmente il nostro atteggiamento verso la vita. Anche se il carattere di una persona appare completamente orientato verso una di queste direzioni, questa si incrocia continuamente con l’altra in forma di deviazione, di sottofondo, di tentazione. La contrapposizione tra individualizzazione e unificazione dei contenuti di vita non divide gli uomini tra loro, ma taglia all’interno dello stesso individuo per quanto la sua forma personale interiore si sviluppi interagendo con la sua forma sociale la quale, a sua volta, si muove tra il principio individualistico e il principio di socializzazione. Non è rilevante a questo punto che la vita si presenti confusa in questi due indirizzi, ma che questi siano interdipendenti da un punto di vista euristico. È come se la nostra vita esercitasse una funzione fondamentalmente unitaria o consistesse in essa, una funzione che non possiamo cogliere nella sua unità, ma che dobbiamo separare in analisi e sintesi, le quali costituiscono anche la forma più generale di quella contrapposizione e la cui azione congiunta ristabilisce nello stesso tempo a posteriori l’unità della vita. Poiché, però, il singolo elemento, nella sua separatezza e nel suo essere per sé rivendica un diritto assoluto nei nostri confronti e in noi, e l’unità, che unifica in sé ogni singolo elemento, avanza la stessa pretesa senza possibilità di compromesso, emerge una contraddizione che molto spesso angustia la vita. Tale contraddizione diventa una contraddizione logica in quanto ogni parte presuppone l’altra per la sua stessa consistenza: nessuna delle due avrebbe un senso concretamente pensabile o susciterebbe interesse a livello psicologico, se l’altra non le stesse di fronte come “contropartita”. Si forma qui – come in innumerevoli altri casi di contrapposizione polare – una peculiare difficoltà in base alla quale un elemento incondizionato risulta condizionato da un altro elemento incondizionato che, a sua volta, dipende di nuovo da quello. Il fatto che ciò che viene percepito come assoluto sia ugualmente relativo, non mi pare autorizzare altra soluzione, se non che l’assoluto indichi una via la cui direzione rimane fissa fino all’infinito, indipendentemente dalla lunghezza del percorso finito in relazione al quale tale via viene effettivamente intrapresa. Il movimento all’interno di ogni segmento, fino a quando tale movimento dura, procede come se dovesse sfociare nel punto terminale assoluto posto all’infinito e questo senso nella direzione rimane tale e quale, anche quando il movimento, da un certo punto in poi, prende un’altra linea di direzione, sottoposta alla stessa norma». (Ib., p. 169). Pensare la totalità è quindi, in prima analisi, capire che non c’è modo di uscire dalla realtà, di sfuggire all’occhio triangolare, ma ci sono molti modi di starvi dentro, alcuni illusori, altri concreti e reali, cioè coscienti anche degli aspetti complessi e differenti della stessa coscienza. Quest’ultima, non appena si sviluppa una diversità all’interno di se stessa, ne intuisce immediatamente non solo l’esistenza ma anche la consistenza e i possibili sviluppi. I meccanismi di controllo e di catalogazione sono talmente sviluppati e sensibili che ogni differenza nella coscienza, scontrandosi con i loro programmi, viene immediatamente colta. E, poi, i morti non fanno domande.
L’intuito ha una interessante vicenda nello sviluppo del pensiero. È stato sempre trattato quasi come una conoscenza di secondaria importanza, anche se più affascinante: la conoscenza dei poeti e delle anime elette. La macchina ingombrante della scienza l’ha relegato ad un rango inferiore o, nella migliore delle ipotesi, l’ha considerato come introduttivo alla conoscenza vera e propria, quella fondata pesantemente sugli enormi grumi della deduzione e dell’analisi. Molto semplicemente l’intuizione è una conoscenza immediata, intempestiva e totale, che si ha di una differenza che si è venuta a creare in una relazione. Sottilmente ha descritto il problema Kierkegaard: «Anche se si dovesse concedere tutto a Hegel, c’è tuttavia una questione introduttiva a cui egli non ha risposto, cioè che cosa in generale significhi che la considerazione della storia universale è un’approssimazione. Egli si è beffato della intuizione intellettuale di Schelling (l’espressione del cominciamento in Schelling), e sta bene: anch’egli ha detto spesso che il suo merito era il metodo. Ma Hegel non ha mai detto come il metodo si rapporta all’intuizione intellettuale, se qui di nuovo non sia necessario un salto. In merito al metodo e al cominciamento del metodo si dice sempre che si deve cominciare con e per esso. Ma se questo cominciamento non è una pura fantasia, esso allora deve essere preceduto da una riflessione, ed è in questa riflessione che consiste precisamente la questione introduttiva». (Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, tr. it., vol. I, Bologna 1962, p. 343). Si potrebbe parlare di intuizione in diversi tipi di relazione, ma quella che più richiama l’attenzione è relativa all’orientamento verso la percezione concreta dell’esperienza, quindi all’intuizione che è tipica attività della coscienza quando questa si rende conto di uno sproposito nel meccanismo culturale di accumulazione. Non è una conoscenza privilegiata, non ha caratteristiche di esclusività, in quanto potrebbe anche cogliersi in altri momenti e in un altro genere di orientamento verso la realtà, quindi riguardare il territorio di quei sentimenti che per paura vengono costantemente messi da parte, e non riesce nemmeno a condizionare la conoscenza analitica o deduttiva convincendola a non pretendere di essere la sola depositaria della verità. L’intuizione consente di collocare diversamente il processo culturale, mettendo in risalto, con la sua opera di ripulitura, l’esistenza di una diversa soluzione che apporta agli elementi dell’esperienza una possibilità nuova, una possibilità che non era presente nell’analisi pura e semplice, dove questi elementi finivano per correre il rischio di essere staccati tra loro, privati di una connessione rischiosa e compromettente, non portatori di senso ma solo sognatori di qualità.
Certo, l’intuizione, e la logica del “tutto e subito” che ne consegue, non possono cogliere in pieno la portata della diversità, dopo tutto sono espressioni della coscienza, quindi pur sempre prodotti della ragione, pur sempre processi logici, e più di tanto non possono fare. Restano così legati al primo livello dell’effettualità pratica, quello della produzione modificativa, e non pretendono di estendere il loro contributo al di là della preparazione delle condizioni produttive stesse. «Chi osa gettare uno sguardo nel deserto delle più amare e superflue tribolazioni interiori nelle quali hanno languito forse gli uomini più fecondi di tutti i tempi! Chi osa udire quel sospiro del solitario e dello sconvolto: “Ah, datemi dunque la follia, o celesti! Follia, tal che io possa finalmente credere a me stesso! Datemi deliri e spasimi, illuminazioni e ottenebramenti improvvisi, sbigottimenti con gelo e calura, quali nessun mortale ha mai provato, con fragori e spiriti vaganti, lasciatemi mugolare e guaire e strisciare come una bestia: purché possa trovar la fede in me stesso! Il dubbio mi divora, io ho ucciso la legge e la legge mi angoscia come un cadavere angoscia un vivente: se io non sono più che la legge, allora sono il più reietto tra gli uomini. Il nuovo spirito che è in me donde viene, se non viene da voi? Dimostratemi dunque che io sono vostro; la follia soltanto me lo dimostra”. Ed anche troppo spesso questo ardore raggiungeva assai bene il suo scopo: nel tempo in cui il cristianesimo dimostrava con la massima dovizia la sua fecondità quanto a santi e anacoreti, presumendo con ciò di dimostrare se stesso, c’erano in Gerusalemme dei grandi manicomi per santi infortunati, per quelli che avevano sacrificato il loro ultimo granello di sale». (F. Nietzsche, Aurora, 14).
Gli elementi di conoscenza che arrivano nella nostra vita quotidiana, i sentimenti, il comportamento giornaliero, le intenzioni e i mezzi con cui si realizzano, gli incensamenti e le laudi di cui abbiamo continuamente bisogno, tutto questo insieme, costituisce un ambito dove l’ottuso giudizio penetra solo a posteriori, dove la maggior parte di quanto accade resta sempre inafferrabile e provvista di una logica diversa da quella dell’“a poco a poco”. Ogni tentativo di dare a questa sfera dell’agire un’espressione decorosamente logica per poterla comunicare ad altri in maniera funerea ma comprensibile, risulta sempre inadeguato, mentre l’intuizione, da canto suo, può dare risultati ottimi, senza svilire in precisazioni di dettaglio. In questo modo, ben altrimenti immediato e totale, la conoscenza penetra profondamente nella sfera della realtà di ognuno di noi, anzi, la coglie nel suo intimo. I nostri sentimenti, le nostre scelte, le simpatie e le ripulse, sono elementi intuitivi vivissimi di conoscenza logica, ma di una logica diversa, di una logica avente carattere primario. L’elemento fondamentale della nostra concezione vitale, di come noi stessi ci concepiamo, della nostra vita quotidiana, della nostra vita di uomini, è quella di cui veniamo a conoscenza in forma emozionale. Solo così possiamo procedere ad una valutazione, a una scelta di posizione vitale, scegliendo a favore o contro i nostri sentimenti.
«La ragione – scrive Miguel de Unamuno – è una forza analitica, cioè dissolvente, quando, cessando di operare sopra la forma delle intuizioni, siano quelle dell’istinto individuale di conservazione, o quelle dell’istinto sociale di perpetuazione, opera sopra il fondo, sopra la materia stessa di esse. La ragione ordina le percezioni sensibili che ci danno il mondo materiale; però, quando la sua analisi si esercita sulla realtà delle percezioni stesse, ce le dissolve e ci ritroviamo in un mondo d’apparenze, d’ombre senza consistenza, perché la ragione all’infuori del formale è nihilista, annientatrice. E compie lo stesso terribile ufficio quando, traendola dal suo proprio, la portiamo a investigare le intuizioni immaginative che ci danno il mondo spirituale. La ragione annienta e l’immaginazione completa, integra e totalizza; la ragione da sé sola uccide e l’immaginazione è quella che ci dà vita. Benché è certo che l’immaginazione da sé sola, col darci vita senza limite ci porta a confonderci col tutto, e in quanto individui, ci uccide anche, ci uccide per eccesso di vita. La ragione, la testa, ci dice: “nulla!”; l’immaginazione, il cuore, ci dice: “tutto!”». (Del sentimiento trágico de la vida, in Obras completas, vol. VII, ns. tr., Madrid 1966, p. 217). La qualità propone domande che non possono trovare risposte solo perché la coscienza ha avuto l’intuizione di una propria differenza. Quelle risposte si trovano nella concretezza dell’azione, non certo nelle piccole insenature dove stagna la logica, nemmeno in quelle della logica del “tutto e subito”. Tanto è vero che l’intuizione, come pure la logica che affermiamo, non riescono a nascondere una loro sottile polemica contro gli allontanamenti troppo ingiustificati della diversità, spesso considerati come giochi mentali. Va bene lasciare il dominio troppo condizionato della coscienza e i suoi meccanismi di controllo, ma se vogliamo tradurre in conoscenza l’esperienza della diversità, quel meraviglioso accumulo che si realizza nelle sue improvvise intuizioni, più o meno durature, nell’intimo della realtà, se vogliamo insomma mettere a frutto, sempre dal punto di vista conoscitivo, il fatto stesso di esserci creati una diversità nella coscienza, dobbiamo regolarizzare la situazione, sia pure conducendo il contenuto dell’esperienza verso la qualità che la caratterizza ma di cui non si è ancora resa conto. Dobbiamo, in altri termini, vestire di abiti, e possibilmente anche di corazze, e munire di armi idonee, i nostri fantasmi, altrimenti andremo incontro alla paura dal fiato corto.
III
“La conoscenza pre-filosofica, che si sottrae ritirandosi quasi nell’inafferrabilità dell’ovvio non è solamente la conoscenza umana del mondo e delle cose, che noi possediamo prima della filosofia, nella condizione quindi dell’“innocenza” teorica; la “potenza dell’ovvio” sopraffà continuamente anche il pensiero, che ad essa resiste, si estende proprio nel pensiero, nella filosofia. Una tale evidenza all’interno della filosofia è inerente all’uso generale del concetto di “mondano”, quando lo ascriviamo a tutte le cose in generale. Tutte le cose sono nel mondo, si dice: esso è la riunione, l’ordine e l’articolazione di tutto l’ente. Ogni cosa è mondana. Tutto ciò è saggezza o banalità? Che cosa si intende veramente con tale asserzione? Dov’è l’elemento chiarificante e illuminante, se essa non è solamente una banalità?”.
(Eugen Fink, Il gioco come simbolo del mondo)
La logica dell’“a poco a poco” propone quindi una critica del meccanismo di accumulazione, un approfondimento del metodo e della prepotenza con cui si sviluppano le strutture che preparano la strada verso il dominio. Si tratta di una critica selettivo-costruttiva che si contrappone a quella di già vista in azione prima, la critica negativo-distruttiva. La critica selettivo-costruttiva si basa sull’individuazione e sul rifiuto dell’errore, considerato come non-verità, come cancellabile umiliazione, e si fonda su di una concezione del potere che tende all’isolamento della coscienza. «La verità – puntualizza William James – è una proprietà che possiedono certe nostre idee: essa consiste nel fatto che tali idee sono “d’accordo”, mentre l’errore consiste in quest’altro fatto, che esse sono “in disaccordo” con la realtà. I pragmatisti sono d’accordo con gli intellettualisti nell’ammettere questa definizione come evidente. Non si capiscono quando si pone la questione di sapere con precisione che cosa significano le parole “accordo” e “realtà”, quando si vede nella realtà qualcosa con cui le nostre idee devono “accordarsi”. Dal loro modo di rispondere a queste domande, i pragmatisti si rivelano più cauti nell’analizzare tutto, più scrupolosi, mentre gli intellettualisti appaiono più decisi e meno circospetti. L’opinione corrente su questo punto è che un’idea vera dev’essere la copia della corrispondente realtà. Come altri concetti correnti, questo si fonda su un’analogia fornita dall’esperienza più comune. Quando sono vere, infatti, le idee delle cose sensibili riproducono le cose stesse. Ora, il grande principio degli intellettualisti è che la verità consiste in una relazione statica inerte. Una volta che l’idea vera di una cosa è in voi, è detto tutto. L’avete in vostro possesso, possedete una Conoscenza: avete eseguito il vostro compito di soggetto pensante. Siete intellettualmente dove avete il dovere di essere: avete obbedito al vostro “imperativo categorico”. Sul terreno epistemologico, ossia nell’ordine del sapere, avete raggiunto uno stato di equilibrio stabile». (Pragmatism. A New Name for a old Way of Thinking, ns. tr., New York-London 1904, p. 200). Anziché muovere verso il territorio fondante della realtà, per quanto pericoloso o compromettente questo possa poi rivelarsi, la critica selettivo-costruttiva induce una riduzione via via sempre più ampia, fin quando non realizza una riduzione del versante oggettivo della coscienza. La struttura, tramite il soggetto, qui si mangia il mondo a furia di ritagli, riducendo a commestibile particolare una realtà sempre più introiettata e priva di qualità.
La distruzione della realtà è il peggiore crimine che si possa commettere, perché qui viene uccisa l’innocenza, la semplicità non ancora espressa, il dispiegamento di una possibilità non ancora venuto alla luce. Ed è anche l’unica forma condannabile di suicidio. Chi intraprende la strada del dominio sulle cose, quindi, e in primo luogo, sugli altri non come fantasmi dell’intelletto ma come individui vitali, è un distruttore che ha come modello la riduzione della vita, l’estensione del controllo, il rifiuto della qualità. Egli tradisce il proprio orizzonte qualitativo nell’ambito dei pochi residui di qualità che il processo accumulativo rende possibili, per cui svilisce la corporeità, con tutte le sue ampie e ancora inascoltate prospettive, spesso inarrestabili, a semplice archiviazione, a struttura. La critica selettivo-costruttiva è legata alla paura che abbiamo della realtà. La realtà ci è sempre nemica, salvo a considerarla come scatola e limitarsi al suo aspetto esteriore. Tutto quello che sta dentro la scatola è errore e nebbia, non abbiamo orecchie per udire le voci delle Madri. Possiamo illuminare questa nebbia solo aprendo la scatola ma, allora, troviamo un’altra scatola più piccola, e così all’infinito, mentre, dall’altra parte, siamo noi e l’oggetto contenuti insieme in un’altra scatola, più grande, che possiamo aprire anch’essa all’infinito, trovando scatole sempre più grandi e altrettanto enigmatiche.
Ora, la critica selettivo-costruttiva considera frivolo il contenuto della scatola, quindi anche il pensiero degli altri, le altre capacità di strutturazione sono considerate erronee, mentre l’unica fonte di certezza è data dal senso delle proprie relazioni. Al massimo si accredita, agli altri, e alle cose, quel poco di verità che riusciamo a far passare noi, attraverso le nostre relazioni con il mondo considerato presuntuosamente nel suo insieme. Il resto permane come sciocchezza ed errore, cioè oscurità da illuminare. Il dominio sugli altri diventa quindi indispensabile, se vogliamo garantire la continuazione di quello che pensiamo sia la verità, la nostra, la sola verità, e questa così continua a gonfiarsi, a ingigantire. E dobbiamo anche arrivare all’estremo della distruzione degli altri, se non vediamo altra soluzione possibile. Ma non c’è altra soluzione, se pensiamo in termini di dominio, che eliminare gli altri. Così riduciamo la qualità delle nostre relazioni e ne rafforziamo la quantità. Diventiamo puntigliosi e pedanti, costruttori di strutture e imperi inespressivi, onnivori modificatori di materia viva in materiale morto.
Il motivo essenziale mi pare proprio la paura. L’altro ha una verità che ci sfugge, una qualità, una presenza, un contenuto della scatola che sappiamo di non essere in grado di catalogare fino in fondo, di non essere in grado di rimasticare riducendolo alla solita poltiglia archiviabile. «Gli uomini si sentono mancare nella solitudine: la voce del dolore è troppo forte. Essi non sanno più sopportarla con tutta la loro persona. Guardano dietro a sé, guardano intorno a sé, e chiedono una benda agli occhi, chiedono di essere per qualcuno, per qualche cosa, ché di fronte alla richiesta del possesso si sentivano mancare. Di essere per qualcuno e per qualche cosa persona sufficiente colla loro qualunque attività, perché la relazione si possa ripetere nel futuro. La loro potenza si finge finita, finito il possesso che volevano; la loro volontà persuasa nella qualunque attualità che si ripete. Di fronte alla qualunque relazione limitata finita essi non la vivono come semplice correlativo, ma da uomini che hanno la persuasione; al di sotto della relazione elementare che li vince per la loro paura della morte, essi fingono un correlativo alla persuasione che si fingono d’avere: un valore stabile che non s’esaurisce nel giro delle relazioni particolari, ma permane di sotto fermo immutabile. Sono ancora cosa fra le cose, schiavi del più del meno, del prima del dopo, del se del forse, in balia dei loro bisogni, paurosi del futuro, nemici a ogni altra volontà, ingiusti a ogni altrui domanda; affermano ancora in ogni punto la loro inadeguata persona. Ma questo è tutto apparenza, questa non è la loro persona; sotto, sotto permane la loro persona assoluta, che s’afferma assolutamente nel valore assoluto, che ha il valore assoluto: la conoscenza finita. L’uomo si ferma e dice: “io so”». (C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Milano 1972, p. 49). Così anche le nostre qualità scompaiono, appiattite in un tetro lavoro di distruzione sistematica. Se ci basiamo sugli altri, vogliamo avere a che fare con scatole, bene identificabili in funzione di una scelta preventiva di natura ideologica. La struttura serve, in questo caso, non solo da sostegno ma anche da crivello. Fissa e seleziona il referente. Malgrado queste cautele, non appena una differenza qualsiasi determina un’apertura non prevista in una di queste scatole, subito nasce in noi il desiderio di uccidere l’altro, di distruggere la cosa che si erge davanti ai nostri occhi.
La critica selettivo-costruttiva è certo un elemento del processo di strutturazione, quindi, in quanto realtà relazionale, non è sempre e con facilità discernibile dal progetto diverso. Molte volte si passa dall’una all’altro, e viceversa, quasi senza accorgersene. L’abbandono che guarda in avanti è critica, ma non c’è un momento in cui abbandona del tutto la vigilanza e il controllo, quindi la coscienza continua a stare attenta al contenuto pur nel momento in cui sta proiettando la propria diversità verso la qualità. Questo è il vizio dell’uomo. Ciò non accade a chi coglie nella critica soltanto il momento strutturale, e fa di tutto ciò un esercizio culturale chiuso in se stesso, indisgregabile. La produzione che ci sta davanti, produzione di senso, è senza dubbio un’immane muraglia di contenuti che devono, dentro certi limiti, essere fronteggiati (spiegazione intellettualistica). Non possiamo riservarci l’uscita di sicurezza di un disinteresse che allarga le fauci dei produttori di senso, i quali, riservandoci una piccola particina nel meccanismo complessivo, particina che spesso ci pare tanto trascurabile da non vedersi nemmeno, ma non per questo è meno importante e pregna di responsabilità, fanno diventare tollerabile la cieca foresta dell’esistenza.
Ma la critica selettivo-costruttiva non è accettazione supina di schemi mentali. Sarebbe troppo facile identificare questo tipo di approfondimento con la semplice procedura protocollare delle operazioni attinenti al senso. Non dimentichiamo che una critica è sempre un’operazione problematica, non è un avallo o un sigillo tombale. Spesso questa critica, pur restando nell’ambito dell’aggiustamento del contenuto, produce duelli feroci con avversari riconosciuti, un nemico che pur accettando in linea di massima la legittimità di un controllo non ne condivide a volte l’estensione o la forza. Con grande competenza, il logico John Dewey: «Quale confronto è qui possibile o desiderabile, se non quello che consiste nel trattare lo schema mentale dell’intera situazione come un’ipotesi di lavoro, un piano d’azione, e nell’agire quindi sulla sua base, servendosene come di una guida e di un controllo del proprio cammino, invece di vagare ciecamente finché si è del tutto esausti o si trova per caso una via d’uscita? Supponiamo ora, che l’idea – ossia i fatti presenti proiettati a formare un tutto con l’aiuto di fatti assenti (in the light of absent facts) – venga usata come una linea d’azione (a guide of action); e supponiamo che, sulla base delle sue indicazioni, si riesca a far tanto progresso da giungere a mettere piede su terreno sicuro, a orientarsi. Ora si può dire che l’idea era vera, essa corrispondeva ai fatti, corrispondeva alla realtà. Ciò significa che essa, seguita esattamente, ha condotto al risultato voluto: attraverso l’azione essa ha determinato (worked out) lo stato di cose che contemplava o aveva per fine. L’accordo, la corrispondenza, esiste dunque fra l’intenzione, il piano, e la sua esecuzione, o, meglio, realizzazione; tra uno schizzo costruito allo scopo di far da guida al comportamento, e il risultato ottenuto seguendo le sue indicazioni. Ora, qual è la differenza fra un siffatto accordo e il successo?». (Intelligence in the Modern World, ns. tr., New York 1939, pp. 943-944). Sono pochi coloro che come facciamo qui accettano di avventurarsi nella rimessa in discussione delle procedure di controllo della realtà, per non parlare poi dell’esiguo se non trascurabile numero di coloro che accettano di saltare nel mondo a forti tinte delle possibili trasformazioni, abbandonando la logica così bene specificata sopra da Dewey, quella che si basa sulla misura degli effetti determinati dal suo impiego nella produzione del quotidiano. La critica selettivo-costruttiva spesso raggiunge l’obiettivo, se si vuole circoscritto, ma comunque utile, che si riassume nella liberazione del contenuto dai residui di qualità, quindi, nel far ciò, acquisisce una sua tecnica spesso interessante, mai paragonabile con l’astuzia e la sagacia della rinuncia ai protocolli e ai contrassegni, ma pur sempre in grado di differenziare territori e ostacoli nel flusso della realtà, fissando i canoni di una prospettiva ordinatrice che non sia ripetizione o accatastamento di contenuti.
Ecco perché una delle prime cose che questa critica fa, per quanto possa sembrare strano, è proprio quella di fissare una sorta di mancanza di familiarità col contenuto delle percezioni. Essa comincia a chiedersi come possa sussistere una conoscenza di contenuti se non in vista di un qualcosa d’altro, operativamente altro. Certo, questa richiesta indecente, a un orecchio bene esercitato, suona un po’ troppo accademica, ma concorre a ricordare una nidiata di doveri nei riguardi della qualità, che non può essere ridotta al rango di un riflesso dell’idea madre platonicamente irraggiungibile di cui si discute tanto, ma che in fondo in fondo non si vuole per niente raggiungere.
È una richiesta per nulla fosforeggiante, come sarebbe giusto che fosse nel caso di una critica capace di penetrare un problema di tale portata, ma spesso è anche una richiesta fatta con ira, con forza, in quanto mette, senza volerlo, quasi oggettivamente, allo scoperto come un buco nero uno dei limiti più evidenti della semplice accumulazione, che risulta essere quello di una prospettiva troppo circoscritta. In altre parole, la critica selettivo-costruttiva, involontariamente, attira l’attenzione sulla diversità della coscienza, e ciò proprio nel momento in cui sta lavorando a tutto il contrario, alla legittimazione della chiusura e del controllo. Queste notazioni mi paiono importanti perché fanno vedere come ogni legittimazione non sia mai esente da pericoli. Chiedersi cosa voglia dire la conoscenza di contenuti gorgoglianti senza uno scopo è domanda pericolosa, specie nel momento in cui esiste, di fatto, un movimento di diversione all’interno della coscienza. Sarebbe un ammettere apertamente che i fatti della vita, che dopo tutto costituiscono una notevole parte di noi stessi, essendo la nostra struttura, ci siano, in pratica ed anche in teoria, poiché la riflessione viene fuori da una critica puramente selettivo-costruttiva e pertanto ipotetica, nemici ed estranei.
IV
“Tutta la loro vita trascorreva non secondo leggi, statuti o regole, ma secondo la loro volontà e libero arbitrio. La loro regola consisteva in questo articolo – fa’ quello che vuoi”.
(François Rabelais, Gargantua e Pantagruele)
La ragionevolezza, o meglio la razionalità, tenendo conto dell’uso ordinario del termine, è un problema concernente il rapporto fra mezzi e conseguenze, per molti. Il resto è follia. In una prospettiva in cui immaginiamo i fini da raggiungere, è considerato irragionevole porsi fini che non siano in connessione con i mezzi utilizzabili, oppure non tenere conto come un uccello cieco degli ostacoli che si ergono sulla strada da seguire per ottenere il fine che ci siamo proposti. La razionalità è posta quindi come elemento fondante, come elemento-forza. La più antica e incontrovertibile posizione della logica ha considerato la razionalità come una facoltà che, manifestandosi nel rigoglio delle verità prime, prende il nome di “ragione”. Solo più tardi si riesce a identificare un “intelletto puro”. In questo modo, la ragione è considerata come la facoltà di apprendere intuitivamente, a priori, i fondamenti primi della logica. Siamo davanti a posizioni “forti”, in altre parole davanti al fondamento di ogni concezione del metodo “scientifico”, e come ogni concezione forte non passa molto tempo perché si trasformi in un catarroso strumento terroristico. Col passare delle generazioni, questo originario fondamento forte si è coagulato come mota nel concetto di ragione. La necessità di fissare una facoltà in grado di dar conto del mondo che ci circonda venne, alla fine, soddisfatta.
Il metodo forte era così operante come un’orchestra di grancasse. Le basi della logica dell’“a poco a poco” erano perfettamente in grado di produrre tutti i disastri che successivamente, e puntualmente, vennero alla luce. Non dimentichiamolo: la logica dell’“a poco a poco” è una logica forte per cui resta appiccicata come colla sulla realtà. «La scienza moderna è la forza decisiva che nella storia dell’Occidente spinge alla distruzione degli immutabili. Questo significa che con la scienza il dominio del divenire raggiunge la sua forma più radicale. La previsione scientifica riesce a dominare “realmente” il divenire, al di fuori del sortilegio in cui l’immutabile dissolve il divenire». (E. Severino, Legge e caso, op. cit., p. 29). La critica selettivo-costruttiva non ha pretese di incertezza, al contrario va a caccia di certezze. Propone una valutazione dura, netta, con una possibilità di appello che spesso è soltanto fittizia. Si basa su di un coraggio da cacciatore che vuole raggiungere la preda. L’uso della struttura implica la messa a profitto dei risultati dell’esperienza, e ciò avviene in primo luogo con il linguaggio attraverso cui la coscienza, sul piano soggettivo, coordina le strategie di controllo ed anche produce, e cerca di spiegare, le proprie diversità con un sorriso sprezzante.
La critica selettivo-costruttiva propone quindi un uso dell’esperienza filtrato dal linguaggio, in cui abbia sì la prevalenza l’orientamento contenutistico, ma non venga del tutto dimenticata la tensione intuitiva di partenza. La logica dell’“a poco a poco” presta una sua attenzione ai problemi della qualità che vengono risolti col metodo stesso dell’accumulazione e quindi trasformati in residuo di qualità, ma non si può dire con questo che vengono semplicemente cancellati. In fondo, la pretesa di questa critica, di cui la logica suddetta è obiettivo e strumento nel medesimo tempo, è quella di considerare il dato di fatto per quello che riesce a produrre all’interno della realtà, non per quello che la nostra coscienza vorrebbe che l’orientamento percettivo e relazionale riuscisse a portare con sé. Il contenuto dovrebbe parlare da solo, ma essere comunque circoscritto, quasi isolato, pena un’orrenda inversione di risultati positivi nel cuore stesso della produzione. Anche se ciò non è materialmente possibile, la logica dell’“a poco a poco” si presenta essa stessa e presenta la propria attività come se fosse possibile, le scorie e le differenze vengono sistematicamente messe da canto e considerate poco significative. Dopo tutto, i cimiteri hanno una capienza pressoché infinita, quello che vi fa difetto è la volontà di essere. «L’esperienza – continua Severino – e quindi l’intero edificio del sapere scientifico che ad essa si ricollega – non cessa mai di essere prova. Per quanto grande sia ciò che viene chiamato “conferma” della prova, resta sempre aperta la possibilità dell’insuccesso della prova, è cioè sempre possibile l’irruzione di qualcosa che si mostri come una novità del tutto irriducibile al previsto. Il sapere scientifico è ormai pienamente consapevole che la possibilità dell’irruzione della novità imprevedibile non è una funzione dell’incremento della conferma della prova e quindi non è in alcun modo ridotta o intaccata dalla crescita indefinita della conferma. La possibilità dell’irruzione dell’imprevisto è assoluta. Ma tale possibilità può essere assoluta solo perché tutto ciò che incomincia ad essere, prima di incominciare non è un qualcosa, ma niente, e in quanto niente non è qualcosa che possa sottostare a una previsione. Incominciando ad essere, l’evento è libero da ogni legame e può quindi essere la smentita più radicale della previsione più confermata». (Ib., pp. 30-31). L’illusione quantitativa, come mi pare di avere più volte ricordato, semplice voce nel deserto, continua a sperare che dalla somma di elementi venga fuori la qualità, quella qualità che sta altrove, non accontentandosi che effettivamente dalla somma venga sempre fuori qualcosa in più di quello che era contenuto nei singoli elementi sommati. Ma questo qualcosa in più è sempre elemento quantitativo, a giudizio della stessa logica quantitativa “qualcosa di vile”, per cui non può mai diventare qualità in virtù di una qualche arte magica poco conosciuta.
Ci si può accontentare del residuo dell’intuizione iniziale, e questo va bene, ma non si può seriamente accettare la tesi che la verità è un rispecchiamento della realtà. Siamo seri. È proprio nella realtà, o se si preferisce nella pratica, nella critica selettivo-costruttiva, che poi questo modo di affrontare il senso e l’intera catalogazione trova i suoi limiti. L’odio, la rabbia, l’impotenza sono sentimenti del limite, costituiscono la vita del legame. Non possiamo continuare ad aprire e chiudere le mani in attesa di stringere un’arma che non esiste. Dobbiamo prima di tutto cercare quest’arma, se vogliamo che l’esito finale del nostro destino possa cambiare. Abbandonarci alla ineluttabilità della condizione che ci ospita equivale a fare il vuoto attorno a noi. Un vuoto micidiale che scappa fra le dita e che non possiamo stringere per farne qualcosa di contundente. Spezzare la propria schiavitù può accadere in due modi: uno facile facile, il suicidio, l’altro, più difficile, l’attacco, disperato quanto si vuole, ma orgoglioso e attivo, contro il ragno dagli occhi di ferro che sta chiudendoci in un angolo. Il primo passo per non affondare definitivamente nella melma, è renderci conto di come funziona la nostra stessa mente, cioè in definitiva noi stessi. Ecco, su questo argomento, il sempre sorprendente Simmel: «Se, secondo il mito platonico, l’anima nella sua preesistenza vede la pura essenza, l’assoluto significato delle cose, così che il suo conoscere successivo sarebbe solo un ricordo di quella verità, ricordo che affiora quando intervengano degli stimoli sensibili, allora il motivo più prossimo di questo mito è l’incertezza circa il luogo da cui derivano le nostre conoscenze, se si nega ad esse, come fa Platone, l’origine dall’esperienza. Ma, al di là di questa causa eventuale della loro origine, in quella speculazione metafisica si manifesta un profondo atteggiamento epistemologico della nostra anima: anche se vogliamo considerare il nostro conoscere come un effetto immediato degli oggetti esterni, oppure come un processo puramente interno nel quale tutto ciò che è esterno è forma immanente o rapporto di elementi spirituali, sentiamo sempre il nostro pensiero, nella misura in cui ha per noi valore di verità, come l’adempimento di un’esigenza reale, come la copia di un’ideale prefigurazione. Perfino se un rispecchiamento esatto delle cose, tale da riprodurle come esse sono in sé, formasse la nostra rappresentazione, l’unità, la precisione e la perfezione a cui la conoscenza, momento per momento, si avvicina all’infinito, non giungerebbe alle cose stesse. Piuttosto, l’ideale del nostro conoscere sarebbe sempre soltanto il loro contenuto nella forma della rappresentazione, perché anche il più estremo realismo non vuole raggiungere le cose, ma la conoscenza delle cose. Se noi dunque definiamo la somma dei frammenti che in ogni momento dato costituisce il nostro patrimonio di sapere dal punto di vista dello sviluppo al quale esso aspira e a cui viene commisurato ogni stadio attuale nel suo significato, ciò ci risulta possibile solo in base al presupposto che è alla base della dottrina platonica, e cioè che esiste un regno ideale dei valori teoretici, del senso e delle connessioni intellettuali compiute, che non coincide né con gli oggetti – perché questi sono appunto soltanto i suoi oggetti – né con il conoscere reale da un punto di vista psicologico, che viene di volta in volta raggiunto. Non è vero che io «posso dire di me che è impossibile che io sia e non sia nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto». (Citato da C. Arata, L’aporetica del necessario e il problema del principio della scienza, Milano 1965, p. 129). Se tutta la strategia della coscienza si concentra nel controllo e nell’ordinazione, ne viene fuori un meccanismo falsamente perfetto, che prima o poi mette fuori i suoi difetti, visibili, come un lume sulla torre. Il senso stesso, nella sua pura e semplice natura quantitativa, viene violentato all’interno di schemi privi di vero e proprio “significato interno”, cioè strutture, che vivono in eterno come gabbie e prigioni se non ricevono una luce proveniente dalla differenza, la quale, con la sua sola presenza, con la sua anomalia, produce quel tanto in più che è l’elemento qualitativo vero e proprio, l’anticamera dell’integralità. E ciò senza che il senso o la struttura, elementi dell’accumulazione, vengano rasi al suolo e distrutti come orologi maligni.
La logica dell’“a poco a poco”, come vedremo, pur con tutti i suoi luoghi comuni, è in grado di lanciare questa sfida alle pretese di chiusura della coscienza, all’assolutezza del controllo. La ragione, in linea di principio, è un freddo organismo di cristallo diretto al controllo assoluto, ma è anche ragionevole, quindi razionale, e si rende conto che il processo di cui sostiene la validità e, principalmente, la veridicità, abbisogna di una certa tolleranza e che l’accumulazione infinita priva di senso le stesse esperienze. Chi l’ha capito meglio di tutti, in questi ultimi cinquant’anni, è stato Karl Popper. Così lancia anch’essa una sfida analitica, un attacco all’immenso serbatoio del senso, per prima cosa per non venire travolta, e poi per mettere a frutto le costanti combinazioni relazionali del meccanismo di catalogazione.
Ciò rende possibile una critica anche approfondita di alcune posizioni di pura ignoranza che si limitano alla sacralizzazione del contenuto, e nel dire queste parole il mio pensiero vola alle torture che ho subito durante tutta la mia vita da parte di coloro che in buona fede volevano convincermi della bontà di tante cose che erano di certo buone soltanto per loro. Mai che la vergogna entrasse nelle loro teste a scavarvi un solco. A questi imbecilli lodatori professionali della conoscenza come bene assoluto, immaginata come un conto in banca o, meglio ancora, come una sorta di gigantesco salvadanaio, la stessa logica dell’“a poco a poco” potrebbe insegnare molte cose, se fosse conosciuta fino in fondo e se non venisse, anch’essa, violentata da stupidi prevaricatori che la usano come un martello o una mazza quando dovrebbe, al massimo, essere un grimaldello.
Ho dovuto soffrire per colpa di molti imbecilli, anche provvisti di grandi idee di liberazione, appiccicate loro addosso come una camicia bagnata, ma prigionieri e schiavi essi stessi oltre che servi e delatori di tutti i tentativi di liberazione fatti da altri. Questi poveri di spirito li ho visti sempre a bocca aperta ascoltare i contenuti di una scienza che non capivano, contenti come gli invitati manzoniani che mangiano e guardano solo nel proprio piatto. Si sentivano a casa propria, ma li vedevo stringere in mano solo un pugno di mosche morte. Ed avevo, ed ho, pena per loro, l’ombra della morte li ghermirà e avranno solo immaginato di essere stati vivi. Provate a toccare loro la coda, sono peggio delle torpedini. Quando s’invaghiscono di un ideale, nella loro ottusità, non pensano mai che alla fin fine ogni ideale ha sempre i suoi lati concreti, nei quali mangia, digerisce e caca come ognuno di noi. Per costoro la scienza è una grande felicità, non possedendone che l’odore. Per me il sonno della scienza è forse occasione di maggiore felicità.
Altri chiarimenti si rendono indispensabili prima di andare avanti. La critica selettivo-costruttiva è una sfida dura, una gola strettissima e irta di macigni, anche se non è rischiosa. Su questa linea di differenziazione è giocata la complicata differenza tra due logiche che, entrambe prodotte dalla ragione, sono tutt’altro che la medesima cosa. La critica negativo-distruttiva è capace di cogliere le sfumature, le tenerezze, la collera, lo scherno, il dolore di tante differenze che minacciano di cadere senza possibilità di riscatto sotto il controllo della coscienza, nell’ambito di una struttura soffocante. Se la critica negativo-distruttiva è negativamente audace, fino ad inoltrarsi nella ricognizione interpretativa dei dati con orgoglio, con sicurezza di sé, la critica selettivo-costruttiva, pur dando un contributo in senso inverso, può ritardare il processo di chiusura, può anche arrivare alla denuncia dell’imbroglio, dell’orrore, anche se poi è costretta ad ammettere che, con un’opportuna approssimazione, le cose si possono sistemare. Nel primo caso, il coinvolgimento era totale e rendeva indispensabile una piena responsabilizzazione di sé, senza mezzi termini o rievocazioni mitiche, con sistematica costanza, quasi con una specie di ossessione, nel secondo caso, il compromesso appare per rendere più accessibile il problema, per prospettare soluzioni di accomodamento, significati capovolti, per cui finisce per fare diventare tutto accettabile, purché si possa condividere col controllo assoluto, in prospettiva unico desiderio della coscienza, un minimo di apertura alla qualità.
La negazione critica non arriva fino alla periferia del dato di fatto, indirizzandosi sotto forma immaginativa verso l’intuizione, non rinuncia al lavoro nello specifico, dove finisce per risultare affiancata alla critica selettivo-costruttiva. Due logiche, spesso, affrontano a dismisura problemi paralleli e danno risultati che non sono molto dissimili. È nell’allargarsi del problema del giusto mezzo, nell’estremizzarsi delle scelte che le cose si distanziano talmente da fare apparire le fondamentali divergenze dei metodi. Le piccole periferie dell’esperienza vengono individuate indifferentemente dalla logica dell’“a poco a poco” e da quella del “tutto e subito”, e dalla prevalenza dell’una o dell’altra si hanno risultati diversi, specie per quel che riguarda l’utilizzazione dei residui intuitivi.
La critica negativo-distruttiva in questa direzione è più terribile ma anche più amorosa, attenta, quasi tenera nel sistemare le tessere del sottofondo, verso la parte più viva dell’esperienza. Ogni particolare della percezione ha una sua multiforme capacità di rimandare ad altri elementi relazionali, una sua fisionomia che si può standardizzare ma anche sconvolgere. Con acume senza pari, l’analisi di Søren Kierkegaard lavora nel vivo di questo problema: «Chi schernisce gli altri schernisce se stesso; e non è per nulla un caso insignificante, ma uno scherno profondo che cade su te, una triste prova di quanto sia senza costrutto il tuo animo, il fatto che la tua concezione di vita si concentri in una sola frase: “non dico altro che aut-aut!”. Se questo realmente fosse il tuo pensiero, non ci sarebbe nulla da fare per te, l’unica cosa sarebbe di lasciarti rimanere come sei e deplorare che la malinconia o la leggerezza abbiano indebolito il tuo spirito. Ma siccome so molto bene che le cose non stanno così, sono tentato non a commiserarti, ma a desiderare che le circostanze della tua vita possano un giorno afferrarti nelle loro branche e costringerti a spremere quanto v’è in te, e che cominci quel severo esame che non si accontenta di chiacchiere e di battute di spirito. La vita è una mascherata, tu dici, e questo per te è fonte inesauribile di divertimento, e sei così abile che ancora non è riuscito a nessuno di smascherarti: poiché ogni manifestazione tua è sempre un inganno; solo in questo modo tu puoi respirare e far sì che la gente non si serri intorno a te e ostacoli la tua respirazione. In questo sta la tua attività, nel mantenere il tuo nascondiglio, e questo ti riesce, perché la tua maschera è la più misteriosa di tutte; infatti non sei nulla, e sei sempre soltanto in relazione agli altri, e ciò che tu sei, lo sei per questa relazione». (Aut-aut, tr. it., Milano 1964, p. 37). La critica negativo-distruttiva non ha sempre intenzioni sconvolgenti, per cui una maggiore capacità di penetrazione, connaturata alla sua direzione pratica, le consente assai semplicemente di mettere in risalto alcuni aspetti che magari la critica selettivo-costruttiva vede in ritardo o colloca in un processo lineare che frantuma, sminuzza, polverizza all’infinito. Quest’ultima critica non è molto capace di penetrare nelle diverse coperture del senso, nei nascondimenti relazionali che di fatto esistono per l’attività di ricognizione in corso.
La critica selettivo-costruttiva coglie le mascherature per quello che sono, cioè coperture che nascondono qualche altra cosa, ma non è in grado né di svelare il contenuto, né di spiegare il perché della stessa mascheratura. La lebbra spande le sue macchie sempre vaste, non si chiede il perché della sua avanzata. Come si suole dire, per la critica selettivo-costruttiva, un gatto è un gatto, e con questo si chiude il discorso della ricognizione, in quella direzione essa non si trova a suo agio come se fosse ai confini estremi dell’universo, mentre può lavorare con buoni risultati nel taglio dei contenuti, nella loro elaborazione retorica, nella ridondanza, tutti territori dell’ordinazione che producono problemi non trascurabili, qualche volta al di là del malinconico destino della semplice archiviazione del senso nei processi culturali. La critica selettivo-costruttiva si orienta quindi verso il contenuto, mentre la critica negativo-distruttiva si orienta verso la qualità, ma questi movimenti non dobbiamo dimenticare che vanno intesi sempre come relazioni, quindi non possiamo affermare che la critica non è presente nei processi di accumulazione dei contenuti culturali, anche se vi gioca un ruolo chiaramente secondario. La critica selettivo-costruttiva o, più ampiamente, la logica dell’“a poco a poco”, costruisce nel suo cuore metallico e dispettoso una forma di crivello convenzionale al processo di semplice accumulazione dove l’esperienza deve penetrare e dove si distribuisce nei diversi campi, cogliendo nuove relazioni con flussi culturali orientati verso altre esperienze. Il movimento della realtà nell’ambito della percezione codificata ha diversi elementi in comune col movimento della diversità intuitiva per come si sviluppa nella cognizione iniziale dell’esperienza, solo che nella quotidianità i movimenti sono estremamente più ingombranti, hanno meno mascherature e trabocchetti, per quanto non si possa dire che questi manchino del tutto.
V
“Signore e signori, la sciagura capitata ai cigni è davvero deplorevole. Che però solo per questo voi vogliate tornarvene subito a casa mi pare scandaloso. Non volete forse più udire come finisce la mia storia? Credete forse che io sia venuto qui per narrare una storia a metà? Credete forse che dei cigni, uccidendo se stessi, possano uccidere anche la mia storia dei tre Stati arborei? Sono sicuro che non è questa la vostra opinione. Vi prego perciò di riprendere i vostri posti e di ascoltare la seconda parte della mia storia sugli Stati, altrimenti mi offendo e di storie non ne racconto mai più”.
(Paul Scheerbart, I tre Stati arborei)
Ci sono pericoli e perfino ostacoli alla conoscenza costituiti, nella massima parte dei casi, da estremizzazioni dei metodi stessi di conoscenza, da esacerbazioni, ridondanze e fluttuazioni delle naturali difficoltà. Ci si potrebbe arrischiare ad ammettere che in alcuni casi, particolari condizioni di difficoltà logiche, nell’ambito della critica selettivo-costruttiva, possano presentare rassomiglianze e ritrovamenti molto simili a quelle condizioni di paura o di chiusura che impediscono nei fatti la diretta cognizione della qualità. Personalmente non sono in grado di avallare un parallelo del genere, però ho forti sospetti che una logica dell’“a poco a poco”, lasciata a se stessa, potrebbe concludere per l’incomprensione, ma per motivi molto diversi da quelli in base ai quali la logica del “tutto e subito” può, ad un certo punto, concludere tristemente per il silenzio. Così Miguel de Unamuno: «Se tanto lo fuggo [l’amore], non dubitarne, è perché tanto lo amo: lo fuggo cercandolo. Quando è con me e vedo i suoi occhi e odo le sue parole, vorrei accecarlo e renderlo muto per sempre; ma non appena mi allontano da lui e mi ritrovo solo con me stesso, vedo apparire nei tenebrosi abissi della mia coscienza due tenebrose fiammelle che brillano come due stelle gemelle nell’insondabilità della notte e odo nel mio silenzio rumori lontani e smorzati che sembrano venire dall’infinito e mai giungono del tutto. Sono i suoi occhi, sono le sue parole: i suoi occhi purificati dall’assenza e dalla distanza; sono le sue parole purificate dal silenzio. Ed ecco perché lo fuggo per cercarlo, perché lo evito in quanto lo amo. L’amore, quando è puro e nobile, cresce con la distanza. La sua anima mi è tanto più vicina quanto più mi è lontano il suo corpo. Me lo lasciò in una parola, in uno sguardo ed egli già vive cresce si sviluppa in me”. (La agonía del Cristianismo, in Obras completas, vol. I, op. cit., p. 1251). Nel processo di accumulazione, il meccanismo può prendere il sopravvento fino a livelli incredibili, parallelamente ad un controllo altrettanto estremizzato e facinoroso messo in atto dalla coscienza, ma tutto questo apparato ha sempre un flusso tumultuoso che lo alimenta, un flusso incandescente di contenuti e su questi contenuti devono continuamente esercitarsi accumulazione e controllo. Ora, in assoluto, questo processo non può mai essere perfetto, ci saranno sempre sbavature, sempre differenze. La coscienza non potrà mai dormire la sua tristezza immobile e infinita. La diversità, distruttrice di ogni suo piano, può spuntare all’improvviso fra le pieghe nel flusso della quotidianità in arrivo, nel senso di un immane quantitativo di dati che si deve ancora catalogare.
Ben diverso è il territorio dell’intuizione, dove l’assenza del fatto è quasi sempre dilagante come la desolazione, dove la capacità di capire non arriva con la prosopopea catalogativa del dato, ma si dispiega nella semplicità della percezione immediata. Certo, la paura, questo germe che genera la tirannia, può entrare nella prima come nella seconda situazione, ed allora non potranno perseguirsi percorsi di liberazione. Eccedendo nel meccanismo di controllo e accumulazione, come procedendo troppo oltre nel territorio della qualità, ci si trova infine o prigionieri di una struttura invalicabile e priva di riguardi, o soli con le proprie forze residue diretti verso la follia.
Ma il problema principale, a parte ogni altra questione di dettaglio, è qui dato dal fatto che si ipotizza una non compatibilità totale della logica dell’“a poco a poco” con la realtà. Si tratta, per quello che posso capire a questo punto, di sviluppare una critica selettivo-costruttiva di questa logica, non in nome di una negazione della possibilità della conoscenza, o in nome di una conoscenza intuitiva che corre parallela al misticismo e che si limita a creare incidenti nella vita, ma di ben altro. Si tratta di una logica, quella del “tutto e subito”, che è, sia pure a malincuore, sempre prodotto della struttura e della ragione, non ha a che fare con angeli o demoni, cerca solo di dare un migliore approfondimento della totalità del reale. Voglio mettere nel giusto rilievo due punti importanti per mostrare il significato (non la sua giustificazione) di quest’ultima concezione logica. Uno di essi è che ogni iniziale moto di ripulsa contro questa posizione può essere temperato dalla consapevolezza del fatto che il severo schieramento delle altre concezioni riguardanti lo sterile oggetto della logica in generale, concezioni attualmente sostenute, sono parimenti ipotetiche.
Se la logica dell’“a poco a poco” non sembra tale, ciò dipende dalla correntezza e dalla pratica che su di essa si sono malinconicamente accumulate. Se si vuole mettere da parte il dogmatismo puro, qualsiasi ipotesi di ragionamento, per quanto poco familiare, deve essere considerata non dai suoi risultati pratici ma da ciò che scatena dentro di noi, da quello che riesce a significare per la nostra vita, non solo per i vecchi rapporti che fissa con la nostra esistenza. L’altro punto è che le riflessioni, sfaccettate al massimo nella loro varietà e ampiezza analitica, vengono considerate per quello che comportano al di sotto del loro utilizzo al meglio, pubblicamente accertato. Lo scheletro duro di ogni scienza, e perfino di ogni arte, comunque di ogni attività, deve potersi mettere da parte, sia pure con uno sforzo considerevole, per affrontare la vita che minaccia di morire soffocata da quel groviglio inestricabile di ordini e di convenzioni. Puntualmente, George Simmel: «I grandi princìpi della teoria della conoscenza soffrono in continuazione della difficoltà, – nella misura in cui sono essi stessi già conoscenza – di dover sottoporre il loro stesso contenuto ai criteri di giudizio che essi formulano nei confronti della conoscenza in generale e quindi, o risultano vuoti o negano se stessi. Il dogmatismo può fondare la certezza della conoscenza su un criterio solido come una roccia – ma su che cosa si fonda la roccia? Si deve ammettere che la certezza della conoscenza è possibile se la possibilità di tale certezza è derivabile da tale criterio. L’asserzione che la conoscenza è certa, presuppone la certezza della conoscenza. In modo del tutto analogo, lo scetticismo può ritenere l’incertezza e la fallibilità di ogni conoscenza come in linea di principio incontestabili o persino sostenere l’impossibilità di qualsiasi verità, può sostenere la contraddittorietà intrinseca del concetto di verità. Dovrà però sottoporre a questo risultato della riflessione sul pensiero anche il pensiero scettico stesso. Si giunge così a un vero e proprio circolo vizioso: se ogni conoscenza è ingannevole, lo è anche lo scetticismo che viene così a negare se stesso. Il criticismo, in fine, può derivare ogni oggettività, ogni forma essenziale di contenuti di conoscenza dalle condizioni dell’esperienza; non può dimostrare, però, la validità dell’esperienza stessa. La critica che esso esercita nei confronti di tutto ciò che è trascendente e trascendentale si basa su un presupposto nei confronti del quale non si può avanzare la stessa domanda critica senza togliere in questo modo fondamento al criticismo stesso. Un pericolo tipico sembra qui minacciare i princìpi della conoscenza». (Filosofia del denaro, op. cit., pp. 175-176). Non c’è bottegaio o professore universitario che non si rivolterebbe sorpreso e adirato nel sentire mettere in dubbio la logica dell’“a poco a poco”. L’istituzione scatena un odio tremendo e implacabile, fortunatamente sempre meno incisivo. Nell’idea di un progressivo avvicinamento alla verità, di una costruzione lenta ma sicura della conoscenza, si nasconde il mito della certezza e quindi il mezzo più sicuro per allontanare i terrori dell’ignoto e le paure di un futuro diverso dal presente.
L’approssimazione è il metodo per eccellenza del ragionevole uomo politico che ricorre alle analogie della meccanica e della fisica di una volta per spiegare, ruminando il pasto precedente, come può con molta prudenza sistemare una realtà contraddittoria e lacerata, come può fare stare meglio chi sta peggio e come convincere a concedere qualcosa coloro che hanno tutto. Chi abbocca a questi imbrogli ideologici ha tutta la voglia di abboccare, si lascia facilmente snidare, sarebbe molto inquieto se non gli si desse quest’esca luccicante da mandare giù. E il pescatore è sempre lì in attesa che il pesce si faccia prendere all’amo.
La stessa ragione è stata ricondotta all’interno dei sentimenti ciechi di una logica progressiva e, in perfetta sincronia con la ragione, anche gli strumenti della ragione, le tecniche della conoscenza, i mezzi del discernimento. La realtà è stata buttata in faccia a tutti coloro che hanno arrischiato dubbi sulla sua oggettività, sulla sua identificabilità, sulla sua valutabilità. È stato rassodato un terrorismo intellettuale organizzato dalle curie di tutti i colori e tramandato nei secoli come elemento di intimidazione nei confronti di coloro che cercavano un modo diverso di conoscere e capire. C’è da dire che questo modo diverso veniva spesso individuato in altre logiche dell’“a poco a poco”, le quali pretendevano di essere diverse quando invece non erano che processi di risarcimento e approssimazione, mascherati da totalità. Quella rotonda e falsa totalità che trova il proprio posto accanto al progetto di dominio che la parzialità intende realizzare nella storia.
In questo modo si sono costruite lustre e false contrapposizioni, ad esempio quella classica tra progressivismo e conservatorismo, come se il primo non fosse un tentativo di volere conservare, nel pio abbellimento di un cambio, il vecchio stato di cose e il secondo un tentativo di mantenere lo stesso stato di cose nel cambiamento. Oppure, ad esempio, la contrapposizione tra razionalità e irrazionalità, come se la prima avesse il monopolio della ragione ragionante, e la seconda fosse costretta a buttarle fra le gambe i residui della ragione, cascami apparentemente logici ma sostanzialmente irragionevoli. Così Hans Vaihinger: «Il mondo delle rappresentazioni è proprio, giusta le sue forme, quale noi lo abbiamo supposto e trovato, soggettivo; reale è soltanto l’invariante che è stato osservato, talché la determinazione totale, che diamo all’oggetto della sensazione, è soltanto soggettiva, ma soggettivo equivale a finzionale, finzionale a falso, falso ad errore. Lo sforzo della scienza si esprime, come abbiamo visto, nel fare del mondo delle rappresentazioni uno strumento sempre più utile di calcolo e di condotta. Pertanto il mondo delle rappresentazioni, risultante da questo sforzo, e che si chiama abitualmente verità, è solo l’errore più conveniente, cioè quel particolare tipo di rappresentazione, che procede, nel modo più rapido, elegante e sicuro e con il minor numero possibile di elementi irrazionali, facilitando al più alto grado la condotta ed il calcolo. I confini fra la verità e l’errore sono altrettanto incerti quanto tutti gli altri confini, quali ad esempio quelli fra il caldo ed il freddo. Il freddo, infatti, è un grado di temperatura per noi sconveniente, il caldo è il grado di temperatura più conveniente: fra il caldo ed il freddo vi è obbiettivamente quindi soltanto una differenza di grado e le diversità sono soggettivamente variabili a seconda della disposizione e a seconda dell’oggetto di cui si tratta. Così, allo stesso modo, la verità è soltanto il grado più conveniente dell’errore, mentre a sua volta l’errore è solo il grado più conveniente di rappresentazione, di finzione. Chiamiamo vero il mondo delle nostre rappresentazioni se ci consente di renderci conto, nel miglior modo possibile, degli oggetti e di operare al loro interno, ma allora il cosiddetto accordo con la realtà è, alla fine, presentato come criterio». (La filosofia del come se, tr. it., Roma 1967, p. 113). Quello che qui viene sostenuto ritiene che, siccome ogni singolo caso specifico di percezione, e quindi di conoscenza, consiste nel risultato di una speciale ricerca che deve essere utile al calcolo e alla produttività fattiva, la teoria della conoscenza in quanto tale può essere soltanto una generalizzazione delle specifiche proprietà che si sono andate scoprendo come attinenti alle conclusioni che siamo in grado di dedurre dalla ricerca. Conoscenza è quindi un nome astratto, un termine con cui indico in modo fittizio la corposità, altrimenti inattingibile, delle ricerche condotte fino a quel momento, una comoda risposta alla stupidità delle convenzioni. A prescindere da questa necessità, diciamo pratica, il suo senso è talmente privo di contenuto che qualunque miserabile penombra può essere arbitrariamente collocata al suo interno.
La concezione complessiva della conoscenza, quando è specificata come risultato della ricerca, è soltanto l’“errore più conveniente”, un’educata mestizia, cioè qualcosa di utile per continuare e perfezionare il controllo e il dominio. Infatti la ricerca è un processo di continua modificazione dell’oscurità mentale e si realizza nel campo come scienza e come applicazione scientifica, cioè come tecnologia. La identificazione di una situazione specifica, per mezzo della quale si garantiscono risultati specifici, o il raggiungimento di particolari scopi, è solo un caso fra i tanti, scelto nello stridio arruffato della produzione, che per essere base e fondamento della ricerca stessa ha bisogno di una ipotesi astratta da cui partire. Questa ipotesi è data dal possibile raggiungimento di credenze specifiche, contagio considerato come fatto progressivo. L’effetto accumulativo di una simile situazione definisce la conoscenza nel suo significato generale e costituisce il punto da cui partire, dopo opportuna revisione, per ogni ricerca successiva. Una rischiosa spavalderia.
Esiste certamente un modello parassitario di totalità, costruito dalla logica dell’“a poco a poco”, che non può essere preso in considerazione per quello che intendo io, come esiste anche un disperato desiderio di totalità che va spesso a finire nella concretizzazione di illusioni, ideologie, imbrogli ed altre cose che sono ben altro della totalità. In fondo, la cattiva totalità serve la causa dell’approssimazione, del gradualismo e della fraterna partecipazione allo stesso modo della più bieca ragionevolezza bottegaia. Recentemente, è stato scritto: «Non abbiamo forse dei nemici in casa? Non è forse una manifestazione di irrazionalità e di credenza mistica e quasi magica nei poteri della scienza il voler estendere, a tutti i costi e a qualsiasi prezzo, l’uso di concetti e di metodi che hanno la sostanza della razionalità nell’ambito dei fenomeni fisici, ma che altrove non ne trasportano altro che la parvenza di un fantasma? A nostro avviso, non è sufficiente accampare qualche formula matematica per conquistare il titolo di scienziato e di pensatore razionale». (G. Israel, Il dibattito su caos, complessità, determinismo e caso: crisi della scienza e miseria della filosofia, in “Nuova Civiltà delle Macchine”, XI, n. 3-4, 1993, p. 113). Tutto ciò non fa altro che ricondurre la diversità alla somma delle parti, all’accumulazione, realizzando il processo a poco a poco, nella fuga progressiva delle finzioni. Anche la perplessità labirintica, tutto quello che esce dalla regola dell’immediatamente catalogabile, quello che è problematico, purché lo sia in modo miserrimo e oggettivo, anche tutto questo viene superato dalla logica dell’“a poco a poco” e selettivamente inserito al momento opportuno, al punto giusto. Lo stesso per la costruzione di modelli, i quali possono essere tutt’altro che soddisfacenti, anzi il più delle volte sono solo approssimazioni e neanche ben fatte, ma danno un’indicazione che viene considerata sufficiente.
L’esistenza si basa su queste certezze, modelli e ipotesi, che reggono interpretazioni e producono all’infinito modificazioni produttive, particelle infime di un immenso tutto. Non sarebbe male cominciare col dire subito che sono solo incubi immobilizzati, cioè paure trasformate in proiezioni della nostra coscienza, in elementi di ostacolo, non più desideri ma rimpianti. Una certezza falsa spacciata per vera è molto più pericolosa della certezza di non potere avere una verità certa, e senza che tutto ciò col tempo si trasformi in un inutile relativismo. Si può avere la verità, ma bisogna conquistarsela con il rischio, con il coinvolgimento, metterla continuamente a repentaglio. Non la si può afferrare una volta per tutte e, in ogni caso, non la si può accumulare nel senso. Ogni accumulazione di certezze verificate produce il cosiddetto effetto dell’infinito negativo, simile al borgesiano problema degli specchi, una divisibilità infinita, un frazionamento senza fine di cristalli che si rimandano l’uno all’altro un’immagine senza riuscire a determinare quale sia il limite ultimo, l’immagine finale, la certezza immaginata.
La logica dell’“a poco a poco” cerca di coprire con la perfezione oggettiva l’evidente carenza di una non possibile accumulazione all’infinito. Ciò che siamo, in questo processo di accumulazione, viene braccato fino alle sue estreme conseguenze e fatto divenire altro dalla sua effettiva consistenza, un processo di perfezionamento che è destinato al fallimento. Nulla può essere capito in termini di “avvenimento” reale, di essere proprio quello che si è, espressione più efficace della vita che ci riempie dentro fino all’orlo. È proprio questo movimento che potrebbe far vedere aspetti inaccessibili della nostra stessa esistenza, confinata nelle regole dell’inviolabilità. Ma per capire dovremmo aprirci e farci capire, cosa che metterebbe a rischio le nostre difese, che preferiamo lasciare come stanno. Nota Adam Schaff parlando del pragmatismo: «[Esso] si presenta spesso, con la teoria della “produzione della verità” e l’argomentazione relativistica contro la verità assoluta, come una difesa della dinamica della verità e del suo svolgimento. Dopo tutto quel che si è detto, non vi è più pericolo di equivoci, crediamo, tra questa teoria e la teoria marxista della verità come processo. Tuttavia, cerchiamo di gettare un po’ più di luce sul senso di questa differenza. La teoria marxista della verità come processo muove dall’ipotesi del carattere obiettivo della verità e si sviluppa sulla base di una concezione dialettica del rapporto tra verità assoluta e relativa. La dinamica della verità consisterà quindi nell’approfondimento e nell’estensione del nostro sapere riguardo alla realtà obiettiva attraverso la progressiva accumulazione di verità parziali e approssimate, il cui limite è la verità assoluta. La concezione pragmatistica è addirittura opposta, e muove precisamente dalla negazione dell’obiettività della verità e della relazione dialettica tra verità relativa e assoluta. “Verità come processo”, “dinamica della verità”, sono espressioni che indicano la “produzione” soggettiva di sempre nuove e diverse verità prive di qualsiasi relazione obiettiva e definite unicamente in rapporto al soggetto. Nella definizione marxista della verità come processo essa appare come una tendenza verso un traguardo, che è il rispecchiamento adeguato della realtà obiettiva: “processo” indica qui lo sviluppo, l’integrazione progressiva della nostra conoscenza. Nella concezione pragmatica il “processo” designa la produzione soggettiva di ciò che corrisponde all’interesse individuale, alle propensioni, allo scopo particolare, ecc.: scompare la relazione obiettiva, e al suo posto passano in primo piano il condizionamento soggettivo, e, connesso a questo, la casualità. L’identità di alcuni termini cela insomma due concezioni opposte – materialistica l’una, idealistica l’altra». (La teoria della verità nel materialismo e nell’idealismo. Questioni generali, tr. it., Milano 1959, pp. 324-325). L’idea forte di una costruzione è l’ultimo territorio che la logica dell’“a poco a poco” può raggiungere, e di fatto lo raggiunge nell’ipotesi marxista del rispecchiamento della verità. Non occorre che essa abbia la natura di certezza, come deve averla una vera ipotesi che produce veri effetti. È però una vera causa, cioè spinge a vedere il mondo in un certo modo, a sentirsi forti per il semplice fatto di vedere il mondo in quel certo modo, ma ciò non significa, naturalmente, che essa sia una vera ipotesi, perché, se la si dovesse considerare nei termini in cui la stessa logica dominante parla di “ipotesi”, sarebbe più di un’ipotesi, cioè sarebbe un dare effetti immediati, cosa che con la teoria del rispecchiamento non accade. Nulla infatti può essere realmente rispecchiato, con buona pace di Stalin, teorico di questo tipo di logica. «Contrariamente all’idealismo, che contesta la possibilità di conoscere il mondo e le sue leggi, non crede alla validità delle nostre conoscenze, non riconosce la verità oggettiva e considera il mondo pieno di “cose in sé”, le quali non potranno mai essere conosciute dalla scienza, il materialismo filosofico marxista parte dal principio che il mondo e le sue leggi sono perfettamente conoscibili, che la nostra conoscenza delle leggi della natura, convalidata dall’esperienza, dalla pratica, è una conoscenza valida, che ha il valore di una verità oggettiva; che al mondo non esistono cose inconoscibili, ma solo cose ancora ignote, che saranno scoperte e conosciute grazie alla scienza e alla pratica». (Stalin, Questioni del leninismo, tr. it., Roma 1952, p. 654). Ciò significa che tutto quello che è posto a fondamento di una teoria deve possedere la proprietà di un’esistenza verificabile in qualsiasi settore la si voglia identificare, senza limitarsi al suo aspetto ipotetico in relazione al campo specifico di applicazione.
Ogni rispecchiamento, essendo tratto dal vuoto e proposto semplicemente per dare fondamento oggettuale alla realtà, non può servire a produrre questa realtà se non in condizioni fortemente influenzate dall’ideologia, in condizioni cioè in cui la gente è disposta a sacrificarsi, naturalmente fino ad un certo punto. Porcherie da campo di rieducazione. In fondo, un’ipotesi riguardante il fondamento della logica deve essere in grado di ordinare, fornendo adeguati motivi di ragionamento, ciò che è stato chiamato l’oggetto prossimo dell’indagine umana, cioè la realtà, il “grande mutamento” compreso, cioè, l’uomo stesso. Se non è in grado di affrontare questa prova, non è certo in base a una qualsiasi plausibilità astratta che si può concludere per una sua fondatezza. La vita non impedirebbe certo alla verità di parlare, solo l’artificio lo fa, sistematicamente. Infine, per la logica dell’“a poco a poco”, l’ipotesi deve essere in grado di “falsificare”, cioè di dimostrare come inattendibili, gli argomenti proposti a sostegno di altre teorie, insomma far loro del male. Questa condizione, che costituisce il vero fondamento della logica che regge il mondo in cui viviamo, corrisponde alla capacità operativa di una teoria scientifica o sociale (la distinzione sfuma d’importanza), in qualunque campo si consideri la sua applicazione, di spiegare i casi limite e perfino le eccezioni, e tutto ciò senza strumenti da miracolo. Non essendo in grado di adempiere a queste condizioni, ogni ipotesi ideologica di partenza non è altro che fumo per coprire il dominio e il controllo.
L’elemento spontaneo di critica negativo-distruttiva che verrebbe fuori da una semplice riflessione sul meccanismo culturale, finirebbe per mettere in crisi questa logica dall’apparenza inappuntabile, per cui l’unica strada che appare percorribile è quella della perfezione oggettuale. Cosa che Karl Popper ha capito benissimo. Non lo ha fatto però pronunciando condanne irrimediabili. Ecco cosa scrive: «Il principio di razionalità non ha nulla a che vedere con l’ipotesi secondo la quale gli uomini sono razionali in questo senso, e adottano sempre un atteggiamento razionale. Esso costituisce in realtà un principio minimo (questo perché esso suppone semplicemente l’adattamento delle nostre azioni alle nostre situazioni-problemi come noi le vediamo), che anima pressoché tutti i nostri modelli situazionali esplicativi e che, sebbene noi sappiamo che non è vero, noi consideriamo con qualche ragione come una buona approssimazione». (La rationalité et le statut du principe de rationalité, in AA.VV., Les fondements philosophique des systemes économiques, ns. tr., Paris 1967, pp. 149-150). Egli è stato l’epistemologo più prudente degli ultimi cinquant’anni e, nello stesso tempo, il più azzardato, molto di più di un Lakatos o di un Feyerabend. Precisa Silvano Tagliagambe: «In questo modo si arriva a comprendere le azioni umane mediante la costruzione di teorie controllabili e falsificabili, e quindi del tutto assimilabili a quelle di cui si valgono le scienze empiriche. Infatti anche nelle descrizioni e interpretazioni di ciò che un altro ha fatto elaboriamo e avanziamo congetture (modelli di situazione) che poi sottoponiamo a controlli su dati oggettivi, reperibili e vagliati, e che quindi risultano indipendenti sia dalle capacità “empatiche” dell’osservatore, sia dalle possibilità introspettive del soggetto stesso, il quale non gode di accesso privilegiato alle motivazioni del suo agire, ma può rendersele anch’egli comprensibili solo attraverso ipotesi e teorie, come qualunque osservatore esterno. Non ci si può, pertanto, abbandonare all’illusione di una comprensione per “immersione” nel dato, sia grazie all’introspezione, sia ricorrendo all’idea, avanzata, per esempio, da Collingwood, secondo la quale un’azione altrui può essere compresa se e solo se l’interprete la può rivivere. La teoria dell’empatia è semplicemente sbagliata, in quanto confonde un processo psicologico con un procedimento logico». (Epistemologia del confine, Milano 1997, pp. 214-215). Si cerca il particolare e lo si colloca senza imbarazzo al punto giusto. È il regno dell’erudizione, delle perle incastonate l’una dopo l’altra in magnifici gioielli assolutamente privi di vita. Che questo sia un bell’argomento di critica selettivo-costruttiva è fuori discussione, bello perché rende possibile anche interventi tutt’altro che trascurabili di critica negativo-distruttiva. Ma questa cura gelida non riesce a guarire il malato, lo trasforma in oggetto da esperimento.
Mi pare ci siano due problemi, inversi e, a lungo andare, coincidenti come le estremità di un filo di ferro. L’ignoranza degli uni e l’eccessiva specializzazione degli altri. È ridicola, e mi fa male leggerla, la critica spesso violenta contro un certo tipo di cultura superata e nozionistica, critica fatta da persone che sono fondamentalmente ignoranti e che mostrano, proprio nello strumento stesso del loro pensiero, cioè nel linguaggio, tutte le carenze della triste condizione di indigenza, anche grammaticale, senza che appaia loro, nemmeno di scorcio, il lato umoristico o triste della situazione. Gli imbecilli zampettano dappertutto, chiocciano freneticamente cercando di costringermi a prestare loro attenzione, senza riuscirci. E poi, la grande specializzazione degli altri, che ti colgono sempre col piede in fallo nella pronuncia di tale parola in inglese o in tedesco. Non credo che riuscirò mai a fare capire bene a chi ascolta il mio povero inglese che sto per dire ghiaccio e non occhi. Ma, voltando la frittata, mi sono seriamente sbalordito nell’ascoltare la pronuncia inglese delle parole latine e questo subito dopo avere sbalordito i Greci con la mia pronuncia delle regole di Rotterdam. Mi ricordo di avere letto da qualche parte che uno dei più grandi linguisti parlava circa otto lingue, ma tutte con un forte accento russo. E, in fondo, mi pare anche giusto. Possono sorgere equivoci e incomprensioni, ma non saranno tragedie.
Al contrario, l’ignoranza che si crede autorizzata a rimproverare alla cultura il suo monopolio dovrebbe dapprima cercare, se non completamente, almeno in parte, di strapparglielo. Invece l’ombra ingombrante dell’imbecillità presume di conferire vita a ogni cosa, senza reticenze, soffocando con la sua indifferenza esigente tutto quello che potrebbe ancora sollecitare all’ascolto della vita, trasformando ogni tensione in qualcosa di molle e di impalpabile. Il battesimo dell’ideologia, supposto scelta prioritariamente giusta, non basta a salvare da questo svarione originario. C’è, infine, una zona intermedia, dove si muovono i luoghi comuni, giudizi e linguaggi, dei gruppi specifici, vermi in cervelli intellettualmente ben attrezzati non solo di cattivo gusto, ma anche di cattiva coscienza. Fino a qualche anno fa un posto eminente, fra questi gruppi, era occupato da quelli che facevano riferimento all’ortodossia della cultura militante marxista. Oggi se ne stanno costituendo altri, in primo luogo i neo-nihilisti, se mi si passa questa definizione che è ancora tutta da definire. Via da questa palude maleodorante, non è facile bonificarla.
Dissoltosi il marxismo, altri cattivi odori lo sostituiranno. Si tratta di ragionevoli costruzioni linguistiche, di parole ben catalogate, di circolazione di idee prefabbricate, di vestiti rivoltati e armadi rovistati fino in fondo, di pentole leccate con cura, di scarpette su piatti e cose del genere. Nidi da uccellacci. Perché parlare di faccende così meschine? Perché anch’esse fanno parte della logica dell’“a poco a poco”, anzi ne costituiscono gli aspetti più frizzanti e gustosi, quindi più pericolosi, in quanto non presentano le ripetitività che tanto condizionano il sia pur modesto utilizzo dei residui di qualità, il ricordo degli sprazzi intuitivi. Le parole di un linguaggio quale che sia hanno qualcosa cui corrispondono: ma questo “qualcosa” non può restare in assoluto immobile come uno pneumatico vuoto, esso non è altro che la nostra esperienza, il dato munito di senso che sollecita ad accoglierlo. Oggi, secondo me, non è un caso che l’inglese serva, più di ogni altra lingua attiva, a strumento dello sviluppo tecnologico, di questa tecnica particolare che, nell’apparente impunità, s’indirizza verso la costruzione della società del controllo totale. Si tratta della lingua che si è impoverita forse più delle altre, passando da un potenziale, ricchissimo, vocabolario ad un’utilizzazione corrente di parole molto modesta – a quanto dicono gli esperti del settore – utilizzazione per altro in via di ulteriore riduzione. Anche a non volere ascoltare per partito preso gli esperti, c’è da dire che, per quel poco che posso giudicare, anche a me sembra che stiano per impoverirsi non solo l’inglese ma tutte le possibilità del linguaggio umano in generale. E ciò perché si irrigidiscono le strutture che così possono essere rappresentate in aspetti molto schematici, e proprio perché, in fondo, il razionalismo tecnologico di oggi non ha più bisogno, come quello di una volta, di tante chiacchiere per accampare la propria giustificazione al dominio.
Quando parliamo di esperienza, in fondo diamo un nome al complesso dei dati immediati che andiamo raccogliendo attraverso la percezione, più o meno sofisticata. È il soggetto che percepisce e cataloga in base alle regole che preventivamente ha introiettato, nei riguardi delle quali è stato diffidato a metterle in dubbio. La necessità di un “coordinamento univoco”, proposto per esempio da Schlick, non è altro che un modo avanzato per suggerire una definizione accettabile e per mascherare l’alternativa che sarebbe il mero rifiuto di qualsiasi generalizzazione logica, il mero solipsismo. Naturalmente tutti i procedimenti logici portano una matrice comune, quella dell’essenzializzazione e del perfezionamento delle procedure, anche linguistiche, direi a volte essenzialmente linguistiche, per quanto ad un certo livello non sia sempre facile fare distinzioni del genere. L’eterogeneità dei settori esaminati e la distanza nel tempo dei processi stessi fanno vedere come alcuni elementi restano costanti e come i peggiori sistemi siano stati spesso impiegati da uomini che partivano da sacrosante idee fondate sull’amore e sulla virtù.
Come ha notato Adam Schaff: «Il problema del linguaggio unitario della scienza nasce nel quadro della definizione neo-positivistica della filosofia come analisi della “sintassi logica del linguaggio”. Come linguaggio in cui tutti gli altri potevano venir tradotti si scelse quello della fisica. Di qui nacque il nome di “fisicalismo” per la tendenza che si proponeva di estendere il linguaggio “fisicalista” a tutti i campi della scienza. Vi sono stati alcuni malintesi a questo proposito, nel senso che qualcuno ha creduto di collegare il “fisicalismo” a un riconoscimento della realtà obiettiva degli oggetti fisici; ma basta leggere l’esposizione di Schlick per convincersi che il fisicalismo rappresenta unicamente un problema del “linguaggio” e che la funzione cui esso assolve obiettivamente ammonta a un nuovo mascheramento del nudo idealismo neopositivistico». (La teoria della verità nel materialismo e nell’idealismo, op. cit., p. 349). La logica dell’“a poco a poco” non può digerire indicazioni simili, ma nemmeno accettare la riduzione nominalista dei neo-positivisti. In tutte le sue versioni essa è molto forte, sebbene in maniera indiretta. La sua forza è nel convincimento di potere persuadere, non di potere vincere sul piano dello scontro fisico puramente oggettivo. «Le cose esistono fuori di noi. Le nostre percezioni e le nostre rappresentazioni sono loro immagini. La verifica di queste immagini, la discriminazione delle vere e delle false è data dalla pratica». (Lenin, Materialismo ed empiriocriticismo. Note critiche su una filosofia reazionaria, tr. it., Roma 1952, p. 98). Nulla di più chiaro ed evidente, nulla di più adatto a costruire lager.
Il concetto di rispecchiamento presuppone quello di avvicinamento, quest’ultimo, a sua volta, presuppone il concetto di processo e quindi si risale così all’ipotesi principale che è di natura dialettica. Non mi pare possibile un’altra considerazione della teoria del rispecchiamento, anche cercando di uscire dalla rigidità da sagome dipinte di cui certe volte sembra afflitta qualche versione di questa teoria (ad esempio, è questo il caso delle varianti marxiste). Inserendo ipotesi parziali, come quella che vorrebbe ridurre la riproduzione ai semplici termini di chiarezza nell’indagine, una sorta di economicità del pensiero conoscitivo nei confronti del pensiero fondato sul senso comune, si finisce per cadere nelle contraddizioni insolubili dell’idea del processo continuo. «Troppo grande è la degradazione della storia perché effettivamente possano trovarvi posto l’esempio e il sacrificio, la scelta tragica e l’impresa eroica: [essi] passano inosservati, incompresi, non hanno la forza di dimostrare un’alternativa all’orrore, una diversità dalla violenza e dalla persecuzione». (G. Bàrberi Squarotti, Le sorti del “tragico”, Ravenna 1978, p. 116). La dialettica risolve, ma solo in apparenza, queste contraddizioni, però, volendo essere coerenti, bisognerebbe sacrificarle l’ipotesi di accumulabilità, ipotesi che invece resta centrale nella teoria del rispecchiamento.
Se siamo davanti ad un processo sostanzialmente infinito di approssimazione, come si pone in relazione questo processo con quell’altro che lo include, altrettanto infinito e dialetticamente coordinato, cioè col processo della storia? Sono ambedue positivi? Sono in rapporto negativo-positivo, e quindi anch’essi dialetticamente in contraddizione? Se sì, quale dei due è positivo e quale negativo? Non è possibile rispondere a queste domande. In fondo, la teoria del rispecchiamento si riduce al semplice riconoscimento della indipendenza di ciò che è riflesso da ciò che riflette. La tesi staliniana è, su questo argomento, veramente istruttiva per la sua linearità: rigetto dell’idealismo che mette in dubbio la stessa possibilità di conoscere sia il mondo che le sue leggi, idealismo che non crede alla verità oggettiva e considera il mondo pieno di cose in sé, le quali non potranno mai essere conosciute dalla ricerca scientifica. Pensiero forte, se mai ce ne fu. Ma le crudeltà, le atrocità, l’orrore della storia, sono sempre nati da plausibili, spesso incontrovertibili, ipotesi di partenza. Il materialismo filosofico marxista afferma non solo la conoscibilità delle leggi della natura, ma anche che questa conoscibilità, una volta concretizzatasi in una teoria e in una pratica, diventi essa stessa verità oggettiva. La qual cosa suona più o meno come un sigillo scolastico apposto al problema, col risultato che ogni ulteriore sviluppo risulta inutile. «La “verità” di una teoria è decisa dallo scontro pratico con l’avversario. Questo è anche il significato della seconda tesi su Feuerbach di Marx. Ma questo significa anche che lo sfruttamento di classe e la violazione dei diritti dell’uomo non sono sintomi di un’“ingiustizia” – la morte della verità dell’epistéme è insieme morte di ciò che la giustizia in verità è –, ma sono sintomi dell’impotenza, cioè dell’“errore” in cui si trovano le classi sfruttate e coloro che subiscono violenza. La scienza moderna, come struttura teorico-tecnica, è la forma suprema di potenza e quindi di “verità” esistente oggi sulla terra. Le forze della religione e della fede, della morale, dell’inconscio, del sentimento, del pensiero ideologico e politico sono ormai impotenti di fronte alla forza della scienza. Ciò non vuol dire che la scienza si costituisca indipendentemente dalla società; e nemmeno che l’organizzazione sociale non sia tuttora determinata da forze religiose, morali, ideologiche, emozionali. Si suol dire invece che l’organizzazione della società e quindi della scienza stessa è oggi tanto più efficace – tanto più potente – quanto più i criteri che regolano l’organizzazione sociale vengono a coincidere con i criteri della razionalità scientifica e dunque quanto più l’organizzazione e l’amministrazione ideologica della scienza diventa organizzazione e amministrazione scientifica della scienza». (E. Severino, Legge e caso, op. cit., p. 14). Appare evidente che non esiste nella teoria del rispecchiamento un vero e proprio coinvolgimento del soggetto, qualche volta solo una rissa da osteria o una baruffa in un bicchiere d’acqua. La conoscenza è il riflesso della realtà obiettivamente esistente, quindi la verità della conoscenza è indipendente dall’intelletto che conosce, come pure dall’azione pratica conseguente a questa conoscenza. La conoscenza stessa diventa così obiettiva ed adeguata alla realtà, per non parlare poi delle ragioni intime che conducono all’obiettività della prassi, alla quale, per conseguenza, segue l’obiettività della conoscenza. L’individuo resta al di qua, egli può inserirsi nel processo obiettivo tra la conoscenza e la realtà solo adeguandosi a quest’ultima, e snaturando la prima da ogni radicata consonanza con la presenza soggettiva. In questo modo, la verità sarà realmente obiettiva, cioè del tutto separata dal fermento soggettivo. Le sollecitazioni della realtà vengono ridotte soltanto al fatto che la conoscenza è conoscenza umana, quindi realizzabile attraverso i sensi e trasmissibile attraverso il discorso: nulla di più. Il resto è negazione della presenza soggettiva, cospicuo tentativo di cristallizzare la verità in modo da poterla usare. Per questo modo di vedere le cose, la verità è rivoluzionaria.
Tutto il lavoro della coscienza immediata, a partire dalla percezione intuitiva, si perfeziona in movimenti che si integrano in un rispettivo bisogno di riconoscimento convenzionale. La costruzione dell’esistenza si può racchiudere in questa fase che può allungarsi fino alla morte. Una somma di accadimenti si va ingrossando a dismisura, mentre la rivelazione della vita che sta sotto continua a tardare. L’iniziale genuino bisogno di confrontarsi con una realtà che può essere diversa, finisce per affievolirsi nella mancanza di confronto, nell’assenza del rischio. Così Simmel: «La sublimazione metafisica del concetto non viene presa in considerazione in vista di quelle percezioni di valore nelle quali scorre la pratica quotidiana della vita. Si tratta in questo caso soltanto del valore che vive nella coscienza dei soggetti e di quella oggettività che si forma in questo processo psicologico di valutazione come suo oggetto. Questo processo di formazione del valore si compie con l’accrescersi della distanza tra colui che prova godimento e la causa del suo godimento. Variando questa distanza – misurata non dal lato del godimento nel quale la distanza stessa scompare, ma dal lato del desiderio che nasce con essa e che cerca di superarla – scaturiscono infine queste differenze di valutazione, che si possono distinguere in soggettive e oggettive. Per lo meno per quegli oggetti, la cui valutazione costituisce la base dell’economia, il valore è il correlato del desiderio – il mondo del valore è il mio desiderio, così come il mondo dell’essere la mia rappresentazione –; nonostante la necessità logico-fisica in base alla quale ogni istinto di desiderio attende la sua soddisfazione da un oggetto, il valore si dirige in molti casi in base alla sua struttura psicologica soltanto a questa soddisfazione, così che l’oggetto stesso risulta essere completamente indifferente, nella misura in cui soddisfa l’istinto». (Filosofia del denaro, op. cit., pp. 107-109). La percezione iniziale da sola non avrebbe questa capacità, neanche riferendosi ad un luogo di già costituito delle giacenze culturali, come potrebbe essere la quotidianità, con le sue esemplari simmetrie, e il reciproco interferire della vita sociale, soffocato dalla dilagante povertà di mezzi. Viceversa, la cultura, prima, e la produzione, poi, saldano l’insieme della determinazione imperfetta del movimento verso il flusso da conoscere, dove si coglie soltanto quello che la coscienza riesce a carpire alla produzione vera e propria, dove l’avvenuta razionalizzazione considera la parzialità come universalità di tutti i possibili e così s’acquieta nell’oggetto artefatto, fabbricato. Oggi questo rapporto (che in sé nasconde forti presupposti deterministici) negli esclusi si sta affievolendo fin quasi a scomparire a causa del massiccio condizionamento dei desideri, con il loro conseguiente cristallizzarsi all’interno di schemi omogenei sempre più compatti in funzione della distanza culturale dai desideri degli inclusi.
Ogni sollecitazione liberale, ogni chiarimento riguardo i veri intendimenti della gestione produttiva, come pure ogni critica selettivo-costruttiva, sono compresi nel movimento di rapportazione ai protocolli, e qui giacciono riflettendo soltanto la propria indifferenza, il proprio annullamento come eccezioni, come proposte di eventuale differenza. La ragione gioca con un movimento del tutto interno ai suoi stessi princìpi, gioca come al solito in casa, e vince perché è sempre analiticamente identica a se stessa, niente può contraccambiarla. Così, il particolare di un mondo chiuso, impermeabile a tutto, com’è quello dei protocolli logici, riflette pienamente l’universale, e qui, dimentico, si consolida e conforta. È in questo inutile ingombro che trova sostegno per ogni altra avventura nel regno del pensabile, che però è sempre un giro attorno al cortile del carcere. In un mondo simile niente può essere negato, realmente negato, senza spezzare l’incantesimo delle esigenze semplicemente materiali di sopravvivenza. Pretendere di negare logicamente, lasciando stare al loro posto le condizioni dell’affermazione, è giocare con le parole. La negazione è sostanziale, e quindi anche formale affermazione. Difficilmente, una volta venuta in essere, la si può rintuzzare. Per cui, al movimento razionale, basta semplicemente sollevare il velo.
VI
“C’è davvero moltissima gente che si attende da me non so proprio cosa, aiuto forse, o consiglio, da me che a mia volta mi trovo così smarrito di fronte all’incalzare delle necessità della vita! E anche se so che si ingannano, che sono in errore, mi sento tuttavia, e penso che sia immune da vanità, di comunicare loro qualcosa delle mie esperienze, qualche frutto della mia lunga solitudine”.
(Rainer Maria Rilke, Lettera dell’estate del 1921)
L’animale nascosto e operante che chiamiamo coscienza è individuato in modo diverso dalla logica dell’“a poco a poco” e dalla logica del “tutto e subito”. Per la prima, il meccanismo di accumulazione è gestito dalla coscienza come fatto separato, per la seconda, non c’è un meccanismo isolato ma la realtà, che deve essere presa in considerazione tutta in una volta dalla coscienza, in maniera paradigmatica. Che poi questa seconda ipotesi, una volta approfondita, si riveli nei dettagli meno centralizzante di quanto non sembri, mentre la prima ipotesi, con tutta la sua aria di approssimazione sia, nella sostanza, più centralizzante, questo è un altro problema. Il totem originario non si distrugge facilmente. La logica dell’“a poco a poco” snatura di tutte le potenzialità rischiose la coscienza e cerca di ridurla a gestire un processo in cui, dopo tutto, svolge un ruolo marginale, privo di qualunque soprassalto di vita.
L’evidenza e la certezza garantiscono per lei, che può chiudersi a riccio all’interno dei propri sogni, mai riposti, di grandezza e di controllo. Questo è senza dubbio svuotamento dall’interno, riduzione di senso del proprio ruolo, accrescimento dell’oggettività del procedimento. Più si pone l’accento sul processo, più il valore della decisione è ridotto e secondario. Il pragmatismo è stato chiaramente perentorio su questo punto, per come l’ha espresso Ferdinand Canning Scott Schiller: «Per noi è assolutamente chiaro che le vecchie ipotesi – come mostrano le loro conseguenze assurde – sono false, e che vanno abbandonate. Concluderemo quindi così: in primo luogo, ci riesca o no la costruzione di una teoria assolutamente coerente, sarebbe comunque imperdonabile continuare a trascurare l’importanza, che abbiamo dovunque osservato, delle funzioni soggettive nella produzione della verità. È necessario riconoscere apertamente che la verità è verità umana, e che essa non può nascere senza lo sforzo e l’effettiva attività dell’uomo. Osserveremo poi che il vuoto concetto di una verità e di un fatto completamente “autonomi”, che non potrebbero poi essere messi in rapporto con noi e tra di loro neppure con la più miracolosa violenza filosofica, deve essere abbandonato. Se si vuole assolutamente conservarne il nome, esso non dovrà però almeno servire più da etichetta per il problema del rapporto tra l’umano e il non-umano, che tanto spesso vi si è collegato. Occorrerà quanto meno intenderlo come una espressione pragmatica, che serve a contraddistinguere determinati comportamenti e valutazioni entro il processo conoscitivo, nel quale soltanto sia la “verità” che il “fatto” giungono a definirsi per l’uomo. In terzo luogo, invece di sciupare il nostro acume nello sforzo di conciliare concetti formulati da noi stessi in modo contraddittorio, ci proporremo il tentativo di costruire in modo assolutamente conseguente la verità umana, ossia la verità che dipende dalla vita dell’uomo e serve ai suoi bisogni, è creata da noi e si riferisce alla nostra esperienza, e che definisce, nell’immanenza del processo conoscitivo, tutto ciò che viene detto “reale”, “assoluto” e “trascendente”. Nei confronti delle filosofie che teorizzano un’opposizione tra l’umano e l’“ideale” o il “reale”, essa avrà almeno questo grosso vantaggio, che i suoi elementi non dovranno essere portati faticosamente fin dal principio in rapporto l’uno con l’altro e con la vita dell’uomo». (Absolute Truth and Absolute Reality, in Studies in Humanism, ns. tr., London 1907, pp. 182-183). La logica del “tutto e subito” non può, parimenti alla sua concorrente, impedire di collocare la coscienza in un campo di conoscenze, per quanto grottesca questa decisione possa apparire, in caso contrario snaturerebbe la propria componente di ragionevolezza che non può essere totalmente abbandonata. Una logica è sempre una logica, inoppugnabile. Anche se profondamente diversa, essa si fonda sempre sulla ragione, è sempre prodotta da un consorzio civile. È di certo una ragione diversa, inquieta, coraggiosamente capace di coinvolgere tutta la coscienza in situazioni non sempre piacevoli, ma è sempre una ragione, cioè un dominio, un controllo, un punto di riferimento. C’è da dire che questo dominio e questo controllo sono diversi, qui la coscienza riceve molto di più di quello che riesce a dare, quindi si arricchisce, in termini di problemi e contraddizioni, non in termini di certezze e verità. Nella logica del “tutto e subito” la coscienza è un punto di arrivo relazionale, cioè in continuo movimento, un grimaldello per scardinare la realtà, in essa si conclude l’avventura, in quello che resta di essa, non nella sua unità poliedricamente ricostituita, ma nella sua inquieta frantumazione ridotta a continua ricerca, a continua ulteriore inquietudine.
Per quanto le rarefatte vicende della coscienza possano essere vittoriose, acquisitive in termini di risultati e strumenti, specialmente in termini di strumenti, e per quanto la sua capacità possa effettualizzarsi in profonde o meno profonde trasformazioni, la conclusione andrà sempre a chiudersi nella muta eco di se stessa, nel profondo della propria non ricostruibile unità, nel livello più basso e sottile della disgregazione individuale, dove reciterà per l’ultima volta il gioco della vittoria cercata, per trovare, e questa volta in modo definitivo, la sconfitta.
L’autonomia dell’individuo, fondata sulla forza di trasformazione, ha portato a tante e perturbanti contraddizioni. Se impugno qui questo sacro luogo comune della cosiddetta liberazione, è perché non c’è stata nessuna liberazione, e non ce ne potrà essere in futuro, usando la forza per accrescere il successo, la vittoria assoluta dell’individuo, della coscienza. La vita sta sempre al di sotto, soffocata, anche da queste grottesche deformazioni che si ammantano di forza e di vitalità. La vita non ha niente di questo tipo di vitalità da cimitero o da palestra ginnica. In essa non c’è niente di obbligatorio, niente che una volta rivelato debba per forza di cose, per necessità logica, concludersi sulla medesima linea seriale da cui aveva avuto origine. «Infatti la serie – precisa Emanuele Severino – non diventa inevitabile per il fatto di essere accaduta: ogni elemento della serie sarebbe potuto non sopraggiungere: per il fatto che si constata un certo grado di conferma della prova non si viene a sapere che la prova non era una prova, non era apertura alla possibilità – dell’imprevisto e dell’insuccesso. La serie degli eventi che confermano la prova è cioè un puro fatto, che ha una certa configurazione ma avrebbe potuto averne un’altra, e che sarebbe anche potuto non esistere nel suo insieme. L’esistenza e la configurazione della serie è un puro accadimento e cioè, appunto, caso. Poiché una “regolarità empirica” è appunto la serie di eventi che confermano una prova, ogni regolarità empirica è puramente casuale. La regolarità non è cioè altro che il semplice fatto che tutti gli elementi di una serie sono interpretabili come conferma della prova». (Legge e caso, op. cit., p. 32). Quello che così potremo ottenere, ancora una volta, sarà un aumento del controllo e dell’accumulazione, una rievocazione del prevedibile. Questi aspetti sono stati spesso, e lo saranno ancora, erroneamente visti come momenti di un processo di liberazione, il movimento di un istinto che non muore. Ma non ci sono momenti del genere, non c’è un processo come questo. La realtà non si muove nel senso colorato degli aneddoti che ci vengono indicati dalla storia, questi fatterelli sono piccole faccende che accadono nel recinto del campo che abbiamo riadattato. Dobbiamo avere il coraggio di capire qualcosa di quello che accade fuori di questo campo, perché questo accadere fuori è importante per noi, è il nostro monito oscuro, per noi sudditi di una parte della totalità relazionale nel suo insieme. E ciò può accadere attraverso una ridefinizione dell’individuo nel succedersi delle diversità, non nel vano catalogarsi delle sue omogeneità.
Se neghiamo il centro della coscienza e quindi la coscienza come centro, ne deriva che l’avventura della coscienza diventa una relazione fra le tante, anche quella così traumatizzante, tutta interna al territorio della cosa: nessun gesto eversivo. Ciò significa negare la centralità di qualcosa, di qualunque cosa, e negarla fino in fondo, non procedere a sostituzioni successive, più degne o più accettabili. Nessuno può relegare lontano da sé l’altro, costringendolo ad abitare una periferia di se stesso. Lo stesso porsi di fronte all’intuizione, tutto il lavoro della percezione, mantengono fisso l’obiettivo sulla realtà e sul suo territorio, giusto il tempo di un attimo, l’attimo della proiezione o del gioco della mascheratura del linguaggio, l’attimo della qualità intuita, quell’attimo che è proiezione o dispiegamento, a seconda del lato da cui lo si guarda, ma che non è decorso temporale, essendo qui tutto, assolutamente tutto, negazione del tempo. E ancora lo stesso Severino: «La tecnica sta portandosi al centro e alla guida della nostra civiltà perché le grandi forze di pensiero e di vita della tradizione occidentale vanno ritirandosi ai margini. Si tratta di un evento decisivo e tipico della nostra epoca. E tuttavia, nel più lontano passato dell’Occidente accadde qualcosa che, di tale evento, può essere considerato una sorta di anticipazione, o di premonizione, anche se è stato indicato da una parola ambigua e fuorviante: “sofistica”. Con questo termine, ormai, la nostra cultura non allude più a quell’atteggiamento di apparente sapienza e reale e cavillosa povertà spirituale e concettuale che Platone intendeva smascherare, condannare e bandire. Non è inopportuno richiamare che, originariamente, il “sofista” significava “sapiente”, “dotto”, “perito”. I sofisti percepiscono – sia pure in modi molto diversi e perfino opposti – che la realtà non può avere un significato unitario e immutabile, ma è un continuo fluire dove si scontrano forze inconciliabili e dove dunque prevale la forza che è più potente perché è più intelligente, la forza della tecnica». (Il destino della tecnica, op. cit., pp. 69-70). C’è il guaio che la negazione di tutto può essere inghiottita dalla malattia del relativo. La coerenza è una qualità che una volta strappata alla realtà rende impossibile qualsiasi risistemazione, qualsiasi riammodernamento o raffazzonamento della coscienza. Non esistono ideologie in grado di riparare a questo primato della coerenza.
Coerenza nella diversità, prima di tutto, ovviamente, perché quell’altra coerenza non può essere che un modo di catalogare le cose senza commettere errori di ordine quantitativo. Ma la libertà della differenza non può essere bloccata che dalla paura che provoca ogni cosa eccessiva, ogni cosa incredibile, impensabile, indecente, paura cioè di non riuscire a garantire il controllo. Tutti i sacrifici, perduti. Tutte le speranze, perdute. Tutte le utopie, perfettissime e santissime nella loro ingenuità, perdute anche loro. L’umanità, la fratellanza, la solidarietà, la stessa santa rivoluzione, perdute per sempre. Una coerente libertà della differenza, distruggerebbe tutto. Questo suggerisce la coscienza pietosa dell’ammutolito rivoluzionario, la patetica figura di chi si è imbrogliato con i suoi sofismi, con la sua capacità di manomettere l’ideologia corrente.
Non il rispetto dei delatori o degli sbirri. Diomio, questo no! Nemmeno il rispetto per gli altri, anche questo no. Gli altri debbono meritarsi il mio rispetto, mostrando il loro coraggio. I vigliacchi non posso fare altro che disprezzarli. La paura non merita tolleranza, né giustificazione. I Romani non giustificavano la schiavitù nemmeno in linea di principio, o perché tornava loro comoda economicamente, ma facevano di più, consideravano inferiori gli schiavi, eppure sapevano, come l’avevano saputo i Greci, che la sorte di cadere in schiavitù poteva capitare a chiunque di loro, essendo molto facile essere fatti prigionieri e diventare cosa nelle mani di un padrone. Eppure consideravano gli schiavi come inferiori, e il motivo c’era, a mio giudizio valido, e consisteva nel fatto che lo schiavo era degno di disprezzo perché accettava la schiavitù, si adattava ad essere nutrito, alloggiato, curato da un padrone, e a questa situazione, tutto sommato di comodo, non si ribellava, fuggendo, attaccando il padrone o, più semplicemente, suicidandosi. Ecco perché gli schiavi erano considerati inferiori, semplicemente perché non si ribellavano, non perché tali erano per nascita o per razza. È la coerenza nella diversità che bisogna cogliere e rispettare, per prima la propria, naturalmente, e ciò perché non è facile che essa si mantenga e che non cada invece vittima del recupero della coscienza.
E qui si pone il limite valicabile, anzi necessariamente valicabile, dell’assurdo. Se la diversità è audacia, contrasto, opposizione, differenza, la coerenza ad essa significa abbandono definitivo di ogni sogno di composizione, di cordialità, di conforto, di pace. Io penso che questa sia una domanda cui bisogna dare una risposta affermativa. «Non è l’intelligenza, ma la volontà, quella che crea il mondo. Tutto è verità in quanto alimenta generosi slanci e partorisce opere feconde; tutto è menzogna in quanto soffoca gli impulsi nobili e abortisce sterili mostri. Dai loro frutti conoscerete gli uomini e le cose, ogni credenza che conduca ad opere di vita è credenza di verità, mentre è credenza di menzogna quella che conduce ad opere di morte. Il criterio della verità è la vita e non la coerenza logica, che è solo il criterio della ragione. Se la fede mi conduce a creare o ad aumentare la vita, perché chiedere altre prove della mia fede? Quando le matematiche uccidono, le matematiche sono menzogne». (M. de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, in Obras completas, vol. III, op. cit., p. 130). Non ci può essere unità nel contrasto perenne della parzialità, dove siamo costretti a vivere, in un’atmosfera priva di fascino e di mistero. Possiamo conoscere i limiti di questa parzialità e farne strumenti per l’azione, cioè per la trasformazione, ma una volta proiettati nella totalità siamo obbligati a tornare indietro, arricchiti certamente dell’esperienza della qualità, ma sempre abitanti di questa parzialità del reale, partecipi sostanziali ma lontani di quell’universalità della vita che è totalità e basta. In questa universalità è ben povera cosa la nostra impressionabile sollecitazione a sconvolgere il mondo, essa quasi passa inosservata. Ma per noi, che lottiamo in primo luogo contro le tendenze di controllo e accumulazione della nostra stessa coscienza, è un patrimonio inestimabile che bisogna non solo custodire ma allargare e difendere.
La qualità ha le caratteristiche dell’assurdo, allo stesso modo in cui il senso, con i suoi contenuti, ha molti aspetti della normalità. Ma ciò è sempre considerazione che risponde a valutazioni della coscienza, cioè alle sue strategie riguardanti i meccanismi di ripetitibilità o alle sue preoccupazioni riguardanti l’inquietudine della diversità.
C’è un fascino profondamente fidente nella sicurezza in se stessi che non sia però superba messa in scena, meschina manifestazione di un vuoto di sé, piuttosto che della pienezza di sé. Questa pienezza è essenzialmente semplicità, quindi certezza nella verità del reale, coraggio nel coinvolgimento, sprezzante mancanza di nervosismo e di incertezza. L’originale inquietudine, che ha aperto la coscienza, adesso è cresciuta sempre come differenza, ma non come dubbio.
Quale che sia la sorte che ci aspetta nel territorio della scontro, il ragionamento della logica dell’“a poco a poco”, circospetto e prudente, non può fermarci. Al di là di un certo punto, ed è proprio qui il momento in cui emergono i limiti dell’analisi, si va avanti, oltre ogni considerazione consolatoria, senza chiedersi il perché della stessa diversità, questa esiste e produce effetti. Forse per il momento sono soltanto interpretazioni che sembrano girare intorno a territori non bene conosciuti, ma c’è in loro una forza nuova, che la coscienza da per se stessa, nel chiuso della sua fittizia perfezione, non sapeva mettere fuori, ed è la forza del coinvolgimento. Al fondo di questa straordinaria esperienza, mentre ognuno cerca di risistemare gli aspetti esterni degli equilibri, c’è l’attesa che si trasforma in ricerca, l’assenza che aggredisce come presenza, l’azione che travalica nella trasformazione.
La vita non può aspettare, c’è in essa un’aggressività che aspetta di calmarsi nella concretezza del reale, c’è un desiderio di qualità che va oltre i limiti della sofferenza e del dolore, della condizione ambigua della coscienza, da cui la diversità è uscita come necessità, ma anche come sfida. Di quella condizione di prigionia nulla è rimasto, adesso non c’è più la pazienza dell’attesa, solo la certezza che comunque vadano le cose non si indietreggerà mai.