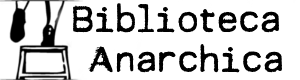Anonimo
Violenza di genere in ambienti antiautoritari e in spazi liberati
Spazi liberati e ambienti antiautoritari
Che cosa intendiamo per violenze di genere o sessiste?
L’Orco e il Compagno (o il principe azzurro)
Che cosa determina la gravità di un’aggressione?
Che cosa condiziona la nostra capacità di autodifesa?
Come reagire o difenderci da una violenza?
Come prendere posizione davanti a una violenza avvenuta?
Come dare appoggio a chi ha vissuto una violenza?
Come comportarsi con chi ha perpetrato la violenza?
Introduzione
Negli ultimi anni ne abbiamo sentite di ogni tipo: da Roma e Parma, da Milano a chissàdove, ci sono giunte alle orecchie narrazioni che ci sfondano i timpani, ci fanno salire il sangue al cervello e tremare le mani, per lo schifo e il disgusto che ci provocano.
Spesso, quando veniamo a conoscenza di episodi così rivoltanti, si riaprono in noi ferite millenarie e ci ritroviamo spiazzate, annusando l’aria per vedere se il vento ci suggerisce il comportamento da tenere, i passi da seguire, la maniera di intervenire.
E qualcun* si ritrova poi a valutare la possibilità che tali ignobili comportamenti dipendano in parte anche da noi, da come ci gestiamo, o non ci gestiamo, piccole e grandi sfide quotidiane nella lotta al patriarcato, al machismo, all’oppressione e alla violenza di genere. Forse troppo spesso, quando vediamo arcaiche relazioni di sopraffazione nei nostri collettivi, tra le persone che frequentiamo ogni giorno, non abbiamo la voglia o la forza di dedicare energia e tempo al portare alla luce ciò che si infila strisciante anche negli ambienti anarchici, anche nelle vite che tendono a un mondo migliore. Magari troppo spesso nello scorrere delle piccole incombenze e delle grandi discussioni, lasciamo che insinuazioni o umiliazioni evaporino nell’aria che poi vorremmo ancora riuscire a respirare. Oppure potrebbe darsi che troppo spesso, quando ci rendiamo finalmente conto di concrete relazioni di dominio e feroci giochi di potere tra persone a noi vicine, invece che cercare di reagire di nuovo puntiamo il naso per aria, a rincorrere i se e i ma che ci si avvitano in testa.
È ben possibile che insistere nel criticizzare atteggiamenti sessisti e autoritari contribuisca a renderci più consapevoli delle dinamiche di oppressione che ancora ci portiamo dentro. Continuare ad avere ben chiaro che non possiamo dare per scontata la liberazione dalla cultura patriarcale e metterci in frenetica attività per dotarci di strumenti per ragionare e agire in maniera conseguente è forse l’unico modo per non ritrovarsi di nuovo con il naso all’insù, per poi di nuovo chinare la testa davanti all’orrore.
Occorre un distinguo sul concetto stesso di Violenza. Questa stessa parola può essere utilizzata per indicare atteggiamenti opposti, uno con una spinta liberatoria, e l’altro con una spinta oppressiva. Vogliamo riappropiarci della violenza per distruggere l’esistente oppressore, per ribaltare le strutture di potere e le autorità che le riperpetuano e proteggono. Attaccare con aggressività chi vorrebbe sottometterci e assimilarci fa parte delle pratiche che rivendichiamo come nostre e di cui vorremmo una moltiplicazione.
Più spesso di quanto non ci piacerebbe ammettere, però, tra i nostri compagni e tra le nostre compagne la violenza cessa di essere strumento liberatorio comune, riprende il percorso verticale e diventa di nuovo oppressione, torna a essere strumento di mantenimento dell’ordine gerarchico. Allora il più vecchio esercita il potere sul più giovane, chi ha più esperienza impone a chi ne ha meno, chi è più forte a chi lo è meno, ricreando come in uno specchio le relazioni dell’esistente che si dice di voler sovvertire. Si ricalca la violenza di stato, l’imposizione normativa, l’imposizione del proprio volere sulle libere scelte di altre persone. Questo genere di violenza è quella che vogliamo combattere per sradicarla e liberarcene.
Nel testo che segue, proviamo a porci degli interrogativi e a ragionare sulle risposte. Le domande da porsi e le maniere in cui rispondere potrebbero essere infinite, non pretendiamo che quelle proposte siano esaustive o universalmente valide, ma suggeriamo alcune possibilità, e soprattutto un atteggiamento che porti a parlare e a ragionare continuamente sul tema della violenza.
Il testo è liberamente tradotto dalla fanzine “Antifeminismo y agresiones de género en entornos antiautoritarios y espacios liberados”. Alcune parti sono state modificate, altre aggiunte, altre eliminate.
Il testo completo è disponibile sul blog rechazodistro.wordpress.com
Spazi liberati e ambienti antiautoritari
Facendo una radiografia dei nostri spazi ci ritroviamo con un antifemminismo latente e contemporaneamente con la diffusa credenza che il ghetto si salvi dai comportamenti di merda che si danno al di fuori.
Si crede ingenuamente, o stupidamente, che rifiutare l’oppressione patriarcale e i ruoli di genere imposti basti perché questi spariscano. Non si riconoscono i diversi femminismi che operano negli spazi, li si sottomette a una critica severa, o li si ridicolizza e tratta come questioni di scarsissima importanza. È uno dei successi del sistema patriarcale all’interno dei movimenti sociali: ha ottenuto di isolare e rendere macchiette folcloristiche le compagne femministe e chi porta avanti discorsi e pratiche queer. Non succede con altri fronti del discorso politico, se non forse in maniera assimilabile con il veganesimo, che chi presenta questioni problematiche venga attaccato molto prima di essere ascoltato. La persona che invece pone delle questioni come la divisione dei compiti per genere nell’organizzazione di un collettivo o di una iniziativa, oppure osa commentare un volantino che ritiene sessista o offensivo, può essere denigrata, ci si permette di urlarle contro, la si deride ancor prima di aver sentito cosa la spinge a parlare. L’antisessismo è facilmente volto in battuta o zittito con una urlata. Battute che poi proseguono nei giorni successivi, che appiccicano etichette addosso alle persone che non si vogliono prendere sul serio, per timore di doverle poi stare ad ascoltare, e magari anche mettersi in discussione.
Tutte le lotte si possono criticare, o per distruggerle oppure per trasformarle attraverso l’autocritica, che in questo caso significa o per proteggere i privilegi del patriarcato oppure per cercare di opporvi resistenza. La competitività, la gelosia, il viscidume, la divisione del lavoro, l’autoritarismo, l’omofobia, la transfobia sono atteggiamenti presenti anche in ambiti politicizzati, e sono patriarcali.
Riconoscere una violenza
Che cosa intendiamo per violenze di genere o sessiste?
Le violenze di genere sono attacchi contro l’autonomia e l’integrità morale, emozionale, fisica e/o sessuale di una persona sferrati grazie alla superbia che deriva dalla supremazia del ruolo maschile. Sono più frequentemente aggressioni da parte di persone socializzate come uomini verso persone socializzate come donne o che si sono sottratte a tale socializzazione di genere binaria, che siano persone trans o non eterosessuali. Tali aggressioni si radicano nell’ordine normativo patriarcale in quanto strutturato su un chiaro sistema piramidale di autorità e privilegi. Vertice di tale piramide, la figura del maschio adulto eterosessuale (bianco, di classe media, abile).
Sono atti relazionali di prevaricazione ed imposizione di una volontà su un’altra che utilizzano il “sistema genere” come strumento di dominazione primario rispetto ad altre relazioni di potere come “razza” o classe sociale. E che muovono da una specifica idea del sé mutuata durante la socializzazione primaria che configura un sistema binario: uomo/donna, forte/debole, sicuro/insicura. Attraverso queste dicotomie si strutturano personalità e identità di genere normative che comportano atteggiamenti, modi di comportamento, forme di pensiero che rispondono alle aspettative dell’ambiente.
Possono darsi attraverso diverse modalità, con diverse forme, cioè possono agire su un piano solo, sia fisico, sessuale, morale o psicologico, o più spesso abbordare tutte queste sfere. La violenza psicologica o emotiva è alle volte più difficile da riconoscere chiaramente. Insultare, sminuire, offendere, criticare non costruttivamente, umiliare, ricattare, controllare, colpevolizzare l’altra persona sono esempi di soprusi. Possono essere violenze puntuali o perpetrate nel tempo, azioni singole o conformazioni di relazioni durature.
Possono anche avere diversi fini, non sempre coscienti. Possono rispondere al desiderio di riportare alla norma, all’obbedienza, o essere mezzi per appagare la volontà istintuale di godimento attraverso l’utilizzo strumentale di un’altra persona per trarne piacere fisico o rinforzi positivi rispetto al proprio potere o al proprio modo di essere.
Le violenze di genere possono darsi tra estranei, con insulti o commenti non richiesti per strada, con stupri o molestie da completi sconosciuti, ma più spesso si compiono all’interno di confini relazionali noti, nell’intimità di una casa, di una coppia, o di un gruppo di affini. È all’interno di mura protettive, siano esse reali pareti domestiche o astratti confini gruppali, che si sviluppano la maggior parte dei ripugnanti abusi che conosciamo e che vogliamo affontare in questo testo.
Ci soffermiamo sulla violenza più diretta tra le persone per rispondere all’esigenza del momento, ben consapevoli che c’è moltissimo altro da affrontare, perché è oppressione di genere anche la terribile violenza strutturale più normalizzata, per la quale non si può mettere una persona in particolare davanti alle proprie responsabilità, ma della quale ci dobbiamo responsabilizzare collettivamente per volgere al cambiamento. Quella dell’educazione, che differisce a seconda del corpo con cui si nasce, quella del riconoscimento e conseguente atteggiamento di chi dà per scontato il benessere nel proprio corpo e l’intrinseca accettazione delle relazioni di potere e delle norme vigenti. È la violenza che affida i compiti di cura a qualcuna e i ruoli di protezione a qualcun altro, che distingue il mondo in due metà senza pensare che alcune persone non vogliano definirsi. È la violenza che vuole principesse e intrepidi cavalieri e non si interessa dei desideri dell’individuo, e che discredita, schernisce, attacca, aggredisce chi non è come ci si aspetta.
Per le causanti strutturali della violenza di genere, per le direzioni in cui si sviluppa, ed anche per una questione numerica o di proporzione, utilizzeremo il maschile per parlare di aggressore e il femminile per parlare di chi viene aggredita.
L’Orco e il Compagno (o il principe azzurro)
I mezzi di comunicazione di massa costruiscono un immaginario collettivo rispetto a chi potrebbe aggredirci che invece di favorirci nella presa di coscienza delle reali minacce, ostacola il nostro lavoro per arrivare a capire quando potremmo davvero essere in pericolo ed invisibilizza le aggressioni più frequenti. Giornali e televisioni sono strumenti nelle mani dei gruppi dominanti che configurano una realtà sociale attraverso una determinata narrazione finalizzata all’influenzare le credenze ed i comportamenti del grande pubblico. In questo caso, l’immaginario creato vorrebbe mantenerci costantemente in uno stato di paura. La paura è uno degli strumenti del patriarcato per limitare la libertà delle donne e di chi non si conforma agli standard cis[1] ed eterosessuali: ci insegnano a temere tutto, e ad aver bisogno di un principe azzurro che ci protegga e ci accompagni per mano nella foresta stregata. Se la volontà è quella di mantenere uno status quo in cui le donne sono continuamente sotto il controllo di un collettivo oppressore, allora riuscire a farci avere paura è estremamente funzionale. Se riescono a farci introiettare i loro spauracchi, a farci temere la metropolitana di notte o il parcheggio sotto casa, a farci dubitare di poter affrontare lunghi viaggi o di essere in grado di guidare in autostrada sarà più facile che riescano a tenerci a casa, a tenerci vicine, a non dover dividerci con nessun*, a non doverci affrontare in gruppo.
Purtroppo, alle volte anche le narrazioni degli ambienti antagonisti o anarchici si sviluppano sulla falsa linea del discorso mainstream. Ed allora anche il garantire la sicurezza in certi momenti, o lo scendere in strada preparat* a scontrarsi in modo violento o addirittura compiere lavori elettrici o idraulici o di muratura, diventano compiti prevalentemente maschili, senza che ci si interroghi abbastanza sul perché ci si dia tali divisioni dei compiti.
Per alimentare la tensione a creare relazioni “altre” nei nostri spazi scegliamo cosa vogliamo fare e quando farlo, attente a non seguire necessariamente divisioni di genere prestabilite. Le aggressioni, contrariamente a quanto sostenuto dal discorso pubblico, non avvengono quasi mai per mano di sconosciuti in parcheggi deserti o in treni notturni. Più spesso invece si danno tra i nostri amici e le nostre amiche, in coppia, in famiglia, in quartiere, in spazi della nostra quotidianità, in casa, al lavoro, in squat. Tra persone conosciute, insomma.
Nel discorso mainstream la figura dell’aggressore è spesso impersonificata da uomini che si credono legittimati ad esercitare la violenza su altre persone e a imporre le proprie decisioni con l’uso della forza. Ma non è necessariamente così: questa forma distorta di concepire il corpo, la volontà e la vita delle altre persone può non essere del tutto cosciente. La violenza può essere molto sottile, celata dietro comportamenti, battute e modi di approcciarsi che non vengono immediatamente letti come problematici o pericolosi, ma che contribuiscono al mantenersi di ruoli di potere e gerarchie. Poche persone ammetterebbero che sono d’accordo con chi tratta le donne in maniera diversa dagli uomini, e ancor meno riterrebbero di giustificare una aggressione, ma molte di queste riproducono dinamiche di machismo giorno dopo giorno senza necessariamente arrivare a essere riconosciute come clamorose ma che hanno comunque un impatto sul vissuto delle persone su cui le si commette.
Dunque, non parliamo necessariamente di persone che maltrattano, violentano o molestano in maniera volontaria, ma, “semplicemente”, di persone che lo fanno, per qualsiasi motivo, che lo riconoscano oppure no. Le persone che aggrediscono alle volte non mettono in conto la possibilità di agire violenze o microviolenze, non credono di aver commesso errori nella propria condotta, non colgono gli elementi relazionali problematici, ma inseriscono le violenze nella continuità del loro modo di fare, nella loro prospettiva di genere intrinsecamente oppressiva. Né l’instabilità emozionale, né il cattivo momento, né il consumo di alcol o altre sostanze sono la causa delle aggressioni di genere, ma possono esserne i meri detonatori.
Dunque, colui che commette una violenza o una serie di violenze perpetrate nel tempo non è necessariamente il macho alfa, lo stupratore seriale, il mostro che sceglie coscientemente la sopraffazione come forma di relazione. Può anche darsi che non abbia piena consapevolezza degli atteggiamenti che assume, per non aver mai ragionato sul significato della parola dominio, della parola oppressione, in ambiti di genere. L’aver scelto nella propria vita di lottare contro lo Stato o contro il capitale non garantisce per estensione la volontà di lottare anche contro il patriarcato e il sessismo, talmente radicati in noi da necessitare una chiara e definitiva esplicitazione per essere superati. Il definirsi un compagno o una compagna non è mai una garanzia, e di certo non lo è rispetto al sessismo, bisogna che si tenga ben chiaro che ogni singolo rapporto umano basato sulla sopraffazione o sulla degradazione dell’altr* è una merda, e come tale va ripulita. Vanno stanati i meccanismi più subdoli di cui non siamo riuscit* a liberarci, per affrontarli ed eliminarli dalle nostre condotte.
Che cosa determina la gravità di un’aggressione?
Le aggressioni sono influenzate e determinate da molteplici fattori ed è praticamente impossibile classificarle per gravità.
In primo luogo, ogni persona è diversa, ha storie diverse, non tutt* abbiamo le stesse reazioni al contatto fisico non voluto, agli insulti o alla pressione psicologica-emotiva.
Non è neanche la forma della violenza (sessuale,fisica, o emotiva) a definirne il grado, anche perché spesso i diversi piani si sviluppano simultaneamente, e bisogna tener conto anche dell’intensità, dei tempi, degli obiettivi degli attacchi.
Ad esempio, se qualcuno tocca il culo o le tette senza consenso è una aggressione sessuale, però può darsi che succeda in un momento concreto e non abbia particolari conseguenze sul vissuto della persona; d’altra parte, si può vivere immersi nel massacro emozionale in una relazione di coppia per anni, ossia vivendo in una costante violenza psicologica. O puoi essere ricattata e forzata ad avere relazioni sessuali anche se non ne hai voglia, ed anche questa è una violenza sessuale anche se meno visibile, e non è neanche la stessa cosa che un tuo amante o il tuo compagno ti dia una sberla o che ti scassi di botte mandandoti in ospedale, anche se entrambe le cose sono violenze fisiche.
Se non esistono criteri oggettivi di classificazione delle violenze, e non ne esistono se non in un campo giuridico che non può interessarci né competerci se non vogliamo scadere in un tribunale militante, allora la soggettività diventa il criterio.
La percezione diventa dunque strumento di analisi, ed accogliere il vissuto di ogni persona in maniera attenta è il primo passo per valorizzare la sua esperienza e porsi nella condizione di affrontarla insieme. Non sempre i nostri vissuti sono simili, e i limiti della sopportazione sono estremamente mobili tra i soggetti: ciò che è poco rilevante per qualcuna può essere massacrante per qualcun’altro, in un continuum in cui l’unica persona a conoscenza dei propri limiti è quella che sta ponendo il problema.
Se la nostra ambizione è quella di costruire tra di noi relazioni non determinate soltanto dalle norme sociali prescritte ma centrate sul rapporto contingente, costituite di onestà, confronto, consenso, allora il saper comunicare i propri desideri e il saper cogliere i limiti, le volontà, le possibilità delle altre persone coinvolte diventa imprescindibile. In un esercizio costante di curiosità e propensione a chi hai davanti, ma anche di critica al sé e di messa in discussione, che ci permetta di riconoscere quando anche involontariamente esercitiamo una violenza, per rimetterci sul nostro cammino e puntare ad arrivare sempre più lontano.
Rispondere a una violenza
Che cosa condiziona la nostra capacità di autodifesa?
Come abbiamo detto prima, ci sono diversi tipi di violenze di genere e molte di queste sono normalizzate, incrostate nei nostri ruoli e nella nostra quotidianità. Questo implica, da una parte, che sia quasi impossibile rispondere ad ogni micropratica machista o ad ogni microviolenza, vuoi perché non si riconoscono nell’immediato, vuoi perché le si giustifica o le si sopporta, o perché temiamo che le risposte che diamo possano essere messe a giudizio ancor più che le violenze.
Ogni persona ha le proprie forme di resistenza, ma ci sono molti fattori che possono influenzare la maniera di articolare una difesa. Possiamo provare a sviscerarne alcuni, ma l’elenco sarebbe infinito e altamente variabile tra ognuna di noi. Ma secondo le esperienze ci sono alcune variabili altamente ricorrenti.
Una è il grado di coscienza rispetto a quello che stiamo vivendo. Soprattutto nel caso di abusi prolungati nel tempo e di microviolenze continue, non sempre riusciamo a cogliere i vissuti traumatici delle nostre relazioni. Alle volte guardando al passato con occhio critico riusciamo a capire quello che nel momento non riuscivamo a cogliere, ma di cui portiamo i segni addosso. Relazioni distruttive possono dipendere, ma anche portare, a una disfunzionale immagine di se stesse, che influenza anche la nostra capacità di autodeterminazione e di reazione.
Se arriviamo a sentirci costantemente insicure, deboli, dipendenti, avremo maggiore difficoltà a credere alle nostre sensazioni di malessere e a porvi rimedio. Se riusciamo invece a darci più fiducia possiamo utilizzare tutta la nostra forza a rompere vincoli insoddisfacenti o dannosi per non lasciare che nessuno, nel nostro ambiente, ci tratti in una maniera che non ci piace. Potremo allora cercare di comunicare quello che non ci va bene e che pretendiamo che cambi, oppure rompere di netto la relazione. Infatti una variabile importante è la possibilità di comunicazione con chi sta usando violenza. Se non veniamo ascoltate, se non viene prestata alcuna attenzione ai nostri atteggiamenti, se urlare o scuotere la testa non serve a niente, significa che non riesce a darsi un utile canale di comunicazione, e diventa allora molto difficile che i nostri limiti vengano rispettati e le nostre richieste comprese. Se siamo convinte che quella che stiamo vivendo o abbiamo vissuto è una violenza o un abuso, allora riusciremo a dare anche meno peso a un’altra questione che spesso influisce sulla capacità di reazione, sia alla violenza puntuale che alle relazioni dannose, cioè la paura del giudizio delle persone che ci sono intorno. Questo dipende anche dal vincolo che ci unisce a chi ci esercita violenza. In generale può non importarci molto avere atteggiamenti distruttivi verso uno sconosciuto, ma crediamo che il nostro atteggiamento verso i compagni debba essere riparativo, accogliente, comprensivo.
Per le violenze più puntuali, oltre alle dinamiche appena descritte che rimangono sempre valide, intervengono altre variabili legate al momento e allo spazio in cui avviene la violenza. Una importante determinante è il luogo dove ci troviamo e la sicurezza che ci conferisce. Se siamo in luoghi poco accoglienti o in cui sentiamo di avere scarso controllo, è difficile che riusciremo a reagire in maniera determinata. A volte, trovarsi in uno spazio ostile o invece in uno spazio sicuro può far sì che la medesima risposta ottenga risultati totalmente differenti. Anche lo stato d’animo ha una grande importanza. A seconda di come ci sentiamo, avremo più o meno voglia, forza, determinazione, rabbia, fiducia in noi stesse, per riuscire a reagire. Ma la possibilità di reazione non dipende solo da noi, la paura della risposta, del dolore fisico, dell’andare a peggiorare la violenza o il ricatto morale a cui ci sottopongono è rilevante, così come lo è la nostra percezione della forza fisica ed emozionale delle persone intorno a noi e la possibilità di gestione individuale o collettiva di quel che sta accadendo, l’idea che ci possano essere o meno altre persone pronte a mettersi in gioco con noi nel momento stesso, o nel processo successivo, o nel rendere visibile la violenza.
Nelle esperienze risulta molto importante anche lo stato di coscienza in cui ci troviamo. Se siamo addormentate, se abbiamo assunto sostanze che alterano le nostre percezioni, se stiamo passando attraverso momenti di scompenso, non sempre riusciamo a rispondere in maniera decisa alle molestie o alle violenze.
Ragioniamo anche sul fatto che il ruolo di vittima e quello di aggressore spesso sono complementari. Se ci si pone, o ci si fa porre dalla percezione altrui, nel ruolo di vittima si conferma il ruolo dell’aggressore e gli si conferisce ulteriore potere[2].
In ogni caso, lo sviluppo della forza e dell’abilità fisica, attraverso sport o corsi di autodifesa femminista o di altro tipo, e lo sviluppo della fiducia in se stesse e della consapevolezza di poter reagire in differenti forme e modi a seconda di chi siamo, in che momento ci troviamo e che possibilità abbiamo può lasciarci più serene e pronte a rispondere.
Utilizzare tecniche di difesa, o contrattacco, fisiche richiede esperienza e allenamento. Se si vuole procedere per questa strada, sono molti i corsi che si possono seguire e le arti che si possono apprendere. Anche conoscere come rendere un oggetto di uso comune, come un mazzo di chiavi o un casco, un oggetto atto a difenderci può esserci utile in situazioni difficili. Ci si può anche concentrare invece sull’utilizzo di strategie verbali o sulla ricerca di vie di fuga, sul conoscere i luoghi e i modi di colpire per poi scappare, su come gridare aiuto per avere più possibilità di essere sentite. In ogni caso può essere interessante cercare di trovare la forma di risposta che più ci si addice e allenarsi in modo che diventi una risposta automatica, che anche in caso di dolore o paura possa facilmente essere messa in atto. Controllare il panico e reagire sarà più facile se abbiamo in mente metodi efficaci per porre fine a situazioni in cui non vogliamo restare.
Come reagire o difenderci da una violenza?
Se niente ci può mettere totalmente al sicuro dal subire violenze durante una intera vita all’interno di una società patriarcale che ci riconosce come donne o persone trans, dobbiamo essere coscienti che quanto più riusciremo a ragionare e a riconoscere le forme di violenza, e quanto più disporremo di strumenti per reagire, più staremo al sicuro e potremo avere fiducia in noi stesse e nelle altre persone.
Confidare in noi stesse, nelle nostre compagne e nei nostri compagni, nelle amiche e negli amici con cui ci accompagniamo nella vita, può farci sentire più consapevoli e più sicure. Avere chiare le nostre volontà e le nostre possibilità può permetterci di porre immediatamente fine a situazioni che non ci fanno stare bene, e di confrontarci anche aspramente sia con chi intende violare i nostri limiti sia con chi intende giustificare o negare queste violazioni. I limiti non sono inamovibili, possiamo aver voglia di metterci alla prova e di sfidare quelli che mal sopportiamo. Deve però essere una nostra scelta e dobbiamo poterla attuare con i nostri tempi, nessun* deve imporci i propri modi o spingerci avanti più in fretta di quanto non siamo disposte a fare. Se in un dato momento non ci sentiamo abbastanza forti per far fronte alla situazione, non succede nulla, non lasciamoci distruggere da questo, l’importante è sentirsi al sicuro. Quindi, se necessario, possiamo allontanarci dalla zona di pericolo e cercare spazi o persone con le quali ci sentiamo a nostro agio e alle quali possiamo comunicare la situazione in cui siamo. La cosa importante è che davanti a una violenza che mette in pericolo la nostra integrità fisica dobbiamo reagire o scappare, non restare paralizzate.
Facciamo caso al nostro istinto senza sottostimarci. Se un uomo dimostra la volontà di metterci a disagio o non ci trasmette buone sensazioni, reagiamo. Possiamo assicurarci delle sue intenzioni o allontanarci, a seconda di cosa consideriamo migliore. Non dobbiamo sentirci egoiste perché ci preoccupiamo di più per la nostra integrità che per l’altra persona che potrebbe sentirsi cacciata o offesa. Abbiamo tutto il diritto a metterci in guardia. Se persevera nell’idea di darci fastidio e non vogliamo essere noi ad andarcene, comunichiamo il nostro fastidio e la nostra rabbia nel modo che consideriamo più opportuno. Dopo averlo avvisato uno volta, non avrà più scuse. Se riteniamo che debba abbandonare lo spazio che stiamo condividendo per il suo atteggiamento molesto, possiamo assumerci di cacciarlo noi stesse o chiedere aiuto per farlo. Se ancora non ci lascia in pace, possiamo rispondergli in una maniera più contundente.
Perché dovremmo essere di nuovo noi ad abbandonare uno spazio pubblico, ad allontanarci da situazioni in cui abbiamo scelto di essere, perché uno stronzo considera che il posto che occupa nel mondo non è mai abbastanza, ed ha voglia di prendersi pure il nostro? Riprendiamoci le strade, le stazioni, gli spazi, le vie. Riprendiamoci tutto.
Non abbiamo niente da perdere a decidere di difenderci violentemente se ne siamo capaci e siamo nelle condizioni di poterlo fare. Articoliamo una difesa, prima di tutto, per salvaguardare la nostra integrità con dignità. Questo implica non solo il nostro fisico, ma anche come ci si concepisce nell’immaginario, cioè cosa ci si aspetta da noi. Spesso veniamo criticate per le nostre risposte violente, per il nostro modo di fare che rompe con il ruolo di sottomissione, di cura e di dialogo. Spesso chi ci è vicino nutre l’errata presunzione, magari non cosciente, che per quanta violenza viviamo (che non deve essere per forza fisica o sessuale) non risponderemo con violenza. Qualora lo facessimo, dunque, potremmo avere un dito puntato addosso. È possibile che la nostra rabbia e il nostro sfogo, se espresso in forma violenta, possa venir additato e giudicato. Tali reazioni stupiscono chi abbiamo intorno, lasciano frastornati coloro che non ci hanno mai viste così alterate, che arrivano a dar per scontato che siamo noi quelle andate fuori di testa, quelle isteriche. Ci possiamo trovare messe sotto processo senza pensare al percorso che ci ha portato a un dato punto, dando per scontato che siamo state noi quelle eccessive, quelle ingiustificabili, quelle da contenere.
Con questo tipo di ragionamento, si invisibilizza l’oppressione che abbiamo sentito sulla nostra pelle con un colpo di mano, come le spugnette sui muri di Milano. Diventa più importante l’impressione che si da in quel momento, rispetto al percorso che a quella esplosione di rabbia ci ha condotto.
Il monopolio della violenza da parte degli uomini è un meccanismo di subordinazione che serve a riprodurre e mantenere la dominazione maschile, per questo le donne sono sempre state tenute lontane dall’apprendimento e dall’uso della violenza fisica. Ma possiamo osare rompere il monopolio e imparare tecniche per affrontare i nostri aggressori. Fargli male fisicamente è una alternativa valida per lo sfogo della rabbia, per il riscatto personale, per togliersi una soddisfazione, per creare dinamiche di gruppo che possano tornare utili in altre situazioni. Ma forse soprattutto è vendetta, e ne offre tutto il gusto. E se difficilmente sarà utile ad inaugurare ragionamenti sul sé profondi, può però ben darsi che serva alla lotta contro il patriarcato, ad abbattere stereotipi, e a rendere gli spazi più sicuri, perché se anche un solo macho violento non verrà più in uno spazio per paura della “nostra violenza”, avremo comunque una minaccia in meno. Non sarà la soluzione alla millenaria cultura dello stupro, ma magari servirà all’appagamento immediato, al vedere la possibilità di ripresa del controllo sul proprio corpo, sulle proprie scelte. Nello scegliere questa strada bisogna però fare attenzione a mettersi in sicurezza, creando condizioni per cui la violenza nuoccia a lui e non a noi, magari muovendosi in gruppo, condividendo le proprie intenzioni, perché non ci si rivoltino contro.
Nel caso di violenze sessuali o fisiche per le quali abbiamo bisogno di un medico, è meglio non cambiarci né lavarci, ma dobbiamo sapere che è possibile che il medico denunci. Se non vogliamo che la violenza passi per vie legali, dobbiamo evitare di andare dal medico o inventare delle scuse. O possiamo provare a costruire le strutture che ci permettano assistenza fisica o psicologica senza passare necessariamente per sbirri e giudici, affidandoci a amiche con conoscenze mediche o a strutture a cui possiamo chiedere di non procedere per vie legali.
Nel caso che le violenze siano continuate nel tempo dobbiamo cercare un’altra maniera di affrontarle. È importante far uscire dalla sola sfera privata le relazioni, in particolare le relazioni di abuso. Se alcuni dei commenti o degli atteggiamenti di altre persone che abbiamo intorno non ci sembrano appropriati, facciamo caso alle nostre intuizioni. Uno strumento per verificare le nostre idee è parlarne con altre persone esterne alla relazione, per chiarire se la vedono allo stesso modo. Troppo spesso manteniamo l’idea della coppia come sacro vincolo, e rispondiamo diligentemente al famoso detto: tra moglie e marito, eccetera eccetera. Ma la cura e l’attenzione verso le nostre compagne e compagni passa anche attraverso la distruzione del senso comune, che vorrebbe le relazioni, quantomeno quelle che rispondono a un immaginario di amore romantico, come isole a sé, come sono cazzi loro e stanne fuori. Se non siamo sicure che ci piaccia quello che vediamo, parliamone con persone di fiducia, cerchiamo di capire se le nostre impressioni sono viziate dalle nostre esperienze, o se è invece importante anche secondo altri e altre non lasciare che il massacro si perpetui in nome dell’inviolabilità del legame di coppia. Ognun* ha il proprio modo di gestire le proprie storie, ma ad ognun* può anche succedere di perdere l’occhio critico su quello che sta vivendo. Se crediamo di essere invischiate in relazioni abusive o violente e ce ne rendiamo conto, non vergogniamoci di chiedere appoggio al nostro ambiente per affrontare la situazione, tanto quando siamo ancora immerse nella relazione quanto durante il percorso successivo di presa di coscienza di quello che abbiamo vissuto. Sentire che abbiamo l’aiuto e gli strumenti può aiutarci a vivere il cambiamento con più sicurezza e a non soccombere facilmente ai ricatti e alle minacce dell’altra parte. Se crediamo realmente che la nostra integrità sia in pericolo e non ci sembra che il collettivo ci apporti sicurezza sufficiente, possiamo cercare altri metodi. Se il collettivo non riesce a darci uno spazio di sicurezza, non lasciamo che ci giudichi per la nostra decisione di utilizzare altri mezzi che ci possano salvaguardare.
Ogni persona ha le proprie forme di resistenza alle violenze e la propria maniera di reagire, ma il sistema morale patriarcale molto spesso fa sì che i percorsi di riflessione successivi al riconoscere e affrontare una violenza abbiano un portato di vergogna e senso di colpa per aver sopportato o peggio provocato una situazione del genere: “Era ubriaca, aveva la minigonna, scopa con tutti, se stava così male se ne andava”. Non lasciamo che nessuno aumenti questo sentimento con rimproveri o lezioncine. Impariamo a liberarci delle attitudini che ci hanno portato alla paralisi e alla sottomissione e smettiamola di attribuirci la responsabilità del danno che ci hanno causato. Questo non vuol dire non riconoscere che avremmo potuto far le cose in altra maniera, che avremmo potuto riconoscere prima la forma di relazione che si stava dando in un dato momento, che avremmo potuto vedere l’atteggiamento distruttivo della persona che avevamo davanti anche con i nostri occhi accecati – accecati dalla dipendenza, o dalla paura, o dalla abitudine, non certo dall’amore. Vuol dire non massacrarci per aver permesso a qualcuno di usare violenza: i nostri stessi atteggiamenti non sarebbero stati sbagliati, se la persona non avesse voluto usarli per farci del male. Non è sbagliato andare a ballare da sole, è una merda che qualcuno ci tocchi senza il nostro consenso. Non è un errore parlare in assemblea, è una merda chi usa la nostra voce contro di noi. Non è da stupide mostrarci affezionate o scoprire punti deboli, è da stronzi risputarceli addosso per farci passare come insicure o paranoiche.
Non voglio questi “compagni”
“S’è inventata tutto”
“Ma chi la conosce? È solo una pazza isterica”
“Non creiamo divisioni davanti alla repressione”
Altre battutine suggerite dai nostri cari “compagni”... come queste frasi di merda che realmente ci è toccato sentire:
“Sì ma scopava con tutti e poi si lamenta che la chiamano puttana– sì ma stava fattissima”
“ Ma cosa vuoi, adolescenti ubriachi possono sbagliare, no? Era sbronzo e in speed, non si sarà accorto...”
“Non siamo in parrocchia, voi non avete mai passato una serata in cui un buco è un buco e un cazzo è un cazzo?”
“Cosa parli tu, che ti sei scopata tutti i miei amici”
Come prendere posizione davanti a una violenza avvenuta?
Così come ci sono differenti maniere di reagire a una violenza nel momento stesso in cui viene perpetrata, così ci sono diverse maniere di prendere posizione rispetto alle violenze di cui veniamo a conoscenza a posteriori, e diversi fattori che influenzano le scelte rispetto a se schierarsi o meno, e come.
Anche in questi casi, alle volte chi si schiera chiaramente e pubblicamente contro le violenze corre il rischio di essere definita violenta a sua volta, di non essere considerata o peggio di essere giudicata da chi preferisce non proferire parola per non offendere nessun*. Concedere troppo spazio alla paura di parlare, però, può portare a giustificare atteggiamenti che non riteniamo “idonei” e a difendere i privilegi quando vengono attaccati, invece di esigere che vi si rinunci.
Altre volte si sceglie di non prendere una chiara posizione per evitare attriti o conflitti, senza preoccuparsi del fatto che non intervenire vuol dire lasciare che la violenza si riproponga davanti ai nostri occhi e la persona attaccata si senta mancare un qualsiasi appoggio, portando probabilmente alla perdita di fiducia nei nostri confronti e alla rottura di vincoli.
Altre ancora evitiamo di prendere posizione perché pensiamo che le relazioni formano parte di un terreno privato nel quale non ci dobbiamo intromettere. Questa eterna divisione tra pubblico e privato da spazio alle persone violente per continuare a fare quello che più gli piace senza dare spiegazioni ed evita che la persona che soffre le violenze possa parlare di quello che sta vivendo.
Un’altra barriera deriva dal non saper riconoscere quando si sta parlando di una violenza o di una serie di violenze. Una violenza di genere è un qualsiasi atto contro la volontà di un’altra persona, che non tiene conto del consenso, all’interno di una relazione di potere basata su ruoli di genere: significa che non è necessario essere un mostro, per essere un uomo violento. Questo però può generare confusione, possiamo non essere sicure di quello che percepiamo come distruttivo o aggressivo, e preferiamo non parlare piuttosto che creare fraintendimenti.
Esiste un eufemismo per definire la mancanza di decisione nel momento in cui è necessario prendere posizione, e si chiama “assumere un atteggiamento neutro”. Ma è più probabilmente confusione, o peggio vigliaccheria. Assumere un atteggiamento neutro non è possibile. Può essere che le circostanze non permettano di vedere quello che è successo con chiarezza, anche se molte volte quello che succede è che non vogliamo vederlo per le conseguenze che può scatenare, ma anche in questi casi dobbiamo almeno schierarci rispetto alle violenze in modo generale.
Non possiamo relativizzare tutte le aggressioni rifiutando di chiamarle con il loro nome, perché non sono state sufficientemente violente, o durature, o sanguinose. Le ambiguità nel nostro prendere posizione riflettono il fatto che non affrontiamo nella maniera migliore il tema della repressione e della gestione dei conflitti all’interno dei nostri spazi. Tutto ci sembra sproporzionato perché non sappiamo qual è la misura. Le punizioni, gli esili, i gulag e le prigioni sono cose abominevoli, ma non riusciamo a trovare altri strumenti che possano porre un freno a degli atteggiamenti che non riteniamo possano trovare spazio nel nostro ambiente.
Un capannone nella periferia di Milano, tecno a palla, luci che vanno e vengono, un muro di casse, un sacco di persone che ballano. Suoni rimbombanti, l’effetto delle droghe che sale, la voglia di far serata e di divertirmi, con le mie amiche e i miei amici. Cazzo, uno stronzo mi si attacca al culo. Levati. E si struscia di nuovo, Che vuoi, vattene. Mollami. Rimane lì, guarda, aspetta un nuovo momento per ributtarsi. Possibile che mi debba stare così addosso, diocan, dirlo una volta doveva essere sufficiente, due sono già tante. Ma non c’è bisogno di ripeterlo una terza. Come ci riprova, ho due compagne dietro. Senza bisogno di chiedere, la sua insistenza ha già esaurito la nostra pazienza. Non c’è storia, non ti strusci ancora. Fatti una sega e lasciaci ballare, stronzo.
Come dare appoggio a chi ha vissuto una violenza?
La prima cosa che possiamo fare per dare il nostro appoggio a una persona che è stata aggredita è entrare in contatto con lei o con il suo ambiente ed offrirle il nostro sostegno e il nostro aiuto. È molto importante considerare i tempi di ognuna. Se una persona decide di comunicarti come si sente, che cosa desidera, o in termini generali renderti partecipe del proprio percorso, te lo farà sapere. Non la soffocare di domande che possono essere dolorose, lei deciderà i tempi per comunicare all’esterno quello che desidera, la cosa fondamentale è essere presenti e che sappia che può chiederci quello di cui ha bisogno. È molto importante concentrarsi sull’autonomia della persona che è stata aggredita. La violenza è cancellazione della possibilità di
scelta: riprendere a decidere per sé stesse vuol dire reagire alla violenza. Incoraggiare e supportare nel processo di identificazione dei propri bisogni e delle proprie volontà è fondamentale nel sostegno di una persona aggredita. Ognun* ha le proprie forme e i propri modi per reintegrare in un percorso di vita gli eventi traumatici, ma è possibile che questi modi non siano immediatamente comprensibili. Esplorare le possibilità di reazione e valutare attentamente le possibili implicazioni di ogni decisione vuol dire riprendere la coscienza del sé e del valore dell’autodeterminazione. Aiutare una persona lasciandola parlare e cercando di seguire i suoi processi decisionali appoggiandola ma esprimendo anche i propri dubbi o suggerimenti, soffermarsi sulla validità e sulle conseguenze di ogni possibile risposta, può aiutare a dipanare il loop di pensieri su quello che si potrebbe fare, e riuscire a prendere decisioni ponderate che restituiscano fiducia in se stesse e nell’ambiente che ci sta supportando. Dobbiamo saper tener conto della differenza tra la nostra opinione e l’opinione della persona aggredita: non porre ostacoli alla sua risposta, né cercare di migliorarla. Non dobbiamo rubarle la sua capacità di difendersi e di decidere liberamente come desidera gestire la questione.
La persona che ha vissuto una violenza non ha bisogno di consigli di gente illuminata, né di moderatori o salvatori, ma ha una propria opinione e può difendersi da sola, con o senza l’appoggio del gruppo. Per quanto si possa pensare di rappresentare la sua volontà, la sua volontà la conosce solo lei. Dare le cose per scontate o giudicare le situazioni da fuori è pericoloso, quindi attenzione a quello che si dice. Questi limiti non dovrebbero impedire di stabilire un contatto con lei o di offrirle appoggio e darle la nostra opinione, semplicemente significa che non dobbiamo decidere né parlare per lei – a meno che non ce lo chieda, ed allora valuteremo come comportarci.
Se pensi che una persona stia soffrendo una violenza, prima avvicinati e chiedile se ha bisogno di aiuto. Se vuoi esprimere una opinione fallo su ciò che conosci o hai vissuto in prima persona, non giocare a fare l’interprete di relazioni altrui. Puoi però sempre comunicare all’aggressore che non ti piace quello che sta facendo, rendere visibile e non tollerare certe attitudini nel tuo ambiente. Possiamo certamente evitare di parlare o agire per altre persone che sono libere di farlo – o non farlo – da sole, ma non per questo dobbiamo accettare dei comportamenti che ci fanno schifo. Non è in nome della persona che hai molestato che ti sto sputando in faccia, è per me stessa, sono io che non voglio dare spazio a degli atteggiamenti che trovo ripugnanti. Di fianco a me, nello spazio in cui mi muovo, certe cose non le voglio tollerare, né su di me né su chi ho intorno.
Nel caso in cui la persona aggredita decida di spiegare quello che le è successo, che sia ad una sola persona o a livello collettivo, bisogna riuscire a rispettare il momento, mettersi in un atteggiamento di ascolto attivo e accertarsi di come si sente (per esempio considerando l’espressione corporea). Se hai la confidenza o la necessità di mostrarle appoggio fisicamente (toccandola, accarezzandola, abbracciandola) sarebbe meglio farlo in maniera progressiva, e sempre con la massima attenzione alla sua risposta corporea. Se vedi che il racconto dell’aggressione scatena emozioni difficili, comunicale che non è necessario che ti racconti se non vuole farlo, che la conversazione è un modo per farla stare meglio, non per soddisfare la nostra curiosità. Non parlare mai con altre persone della violenza, dei suoi sentimenti o delle possibili risposte senza il suo consenso. Se non ci riesci, o se hai bisogno di parlare, scegli una persona di fiducia e sfogati. Non è necessario fare nomi o fornire dettagli, si può trattare la questione in un modo astratto che però permetta di sviscerare con altri le proprie emozioni rispetto a ciò che è accaduto a un’altra donna, evitando anche di riversarle sull’aggredita in quanto unica a conoscenza dei fatti.
Nel mettere in dubbio ciò che una persona dice quando riesce a tirare fuori una violenza, chiedendo prove o negando validità alla sua parola o relativizzando la questione di genere, potresti fare il gioco dell’aggressore. Spesso si espongono le persone aggredite a un giudizio non necessario e dannoso.
Con questo tipo di atteggiamenti l’ambiente smette di concentrarsi su di lei per concentrarsi invece sull’aggressore e si utilizzano le reazioni alle violenze come punti a favore dell’aggressore: per esempio “l’atteggiamento di lei era sproporzionato”, “il suo comunicato non mi piace”, “non sembra stare molto male”. Giudizi formulati alle volte alla svelta, senza fermarsi troppo a capire il cammino verso tali atteggiamenti, o tale comunicato. Alle volte, si pensa erroneamente di conoscere già i motivi soggiacenti agli scoppi d’ira di una persona: è stata tradita, è stata lasciata, è gelosa, vuole attirare attenzione... dare per scontate queste motivazioni permette di tapparsi gli occhi rispetto a problemi più difficili da sviscerare e affrontare. Bisogna interessarsi a conoscere le versioni di entrambe le parti, anche se non necessariamente di prima mano, e sforzarsi anche di riconoscere che privilegi difendiamo con le nostre prese di posizione.
Ogni violenza deve essere trattata singolarmente, dato che, al di là della forma che ha assunto, è molto importante tenere in mente il vissuto e la reazione della persona che è stata aggredita. Due persone possono vivere in maniera molto distinta la stessa situazione, per esempio la molestia sessuale da parte di un compagno può darti fastidio, farti incazzare o portare a un attacco di panico. Modalità di comunicazione violente possono far più presa su chi non è abituata a farsi urlare addosso, o essere totalmente normalizzate per altre persone. È possibile che qualcun* concepisca con consapevolezza l’arrivare a picchiarsi con i/le partner per sfogare la rabbia, mentre per altre persone uno spintone può essere un gesto molto forte. Questo non vuol dire che una scarica di botte o un insulto devono essere trattate nello stesso modo, ma che è necessario tenere da conto le personalità delle persone coinvolte, e quanto i limiti erano stati esplicitati durante la relazione. Oltrepassare volontariamente i limiti di una persona con lo scopo di ferirla, con lo scopo di cambiarla, con l’obiettivo di “insegnarle a stare al mondo” o cosa è veramente importante, è una forma di violenza diffusa e normalizzata che ha però le sue conseguenze. “Una violenza è una violenza quando la persona che la subisce la sente come tale”, “se si è sentita aggredita, allora è una aggressione”, ognuna in ogni momento stabilisce i limiti che è disposta o no a oltrepassare. La nostra opinione può contribuire a rendere visibili gli abusi, ma l’ultima parola è sempre della persona sulla quale è stata agita violenza.
Bisogna però che tutte le persone coinvolte siano ben consapevoli del potere che detengono in ogni momento, e che cosa significa e che conseguenze potrebbe avere definire una persona come un aggressore. Un potere, in quanto tale, può essere mal utilizzato: bisogna dunque che ognuna ne sia consapevole. D’altra parte, è un errore non esporsi quando si nota una relazione di abuso perché si pensa che la compagna sia già “sufficientemente autonoma” o “sufficientemente femminista” da riuscire a riconoscerla da sola. Non dimentichiamo che tutte possiamo diventare cieche o sbagliarci rispetto alle nostre relazioni e che, alla fine, tutte siamo state educate con certi standard e viviamo immerse nel patriarcato.
Bisognerà rispettare il fatto che la persona che si è sentita aggredita possa non volere condividere lo stesso spazio del suo aggressore. È una decisione che va a discapito della libertà di movimento del soggetto in questione, ma se non rispettata andrebbe a discapito dell’integrità di colei che deve convivere con lui. Troppo spesso si criticano le persone che hanno vissuto violenze per non essere abbastanza assertive con i ragazzi, con i loro “problemi emozionali”. Quando si vivono certe situazioni è francamente difficile essere dialoganti e non sentirsi violate o mettersi sulla difensiva in presenza di qualcuno che ha usato violenza contro di noi. La priorità dovrebbe essere che le persone aggredite abbiano i loro spazi e si occupino di prendersi cura di se stesse e si sentano sicure. Quello che sono disposte a sopportare è qualcosa che solo loro possono decidere e che nessuno può imporre. Se vorranno accompagnare colui che ha usato violenza in un percorso, lo faranno, ma nel caso non ne avessero nessuna intenzione, non lo faranno né dovranno farlo. Si può anche non considerare questa richiesta di non frequentare gli spazi come qualcosa di permanente e insuperabile, per poter dare a chi ha aggredito la possibilità di tornare nel caso prendesse coscienza e lavorasse sui suoi atteggiamenti.
Come comportarsi con chi ha perpetrato la violenza?
Se sai che una persona ha commesso una violenza, o si dice in giro che ha aggredito qualcuna, è importante, se abbiamo voglia, conoscere la sua versione di prima mano, essendo però consapevoli del fatto che l’aggressore potrebbe riproporre la violenza con le sue parole. Questo non vuol dire che dobbiamo andare da lui già predisposte al conflitto o al perdono. Quello che succede di solito è che evitiamo di incontrare queste persone se le conosciamo, ma è importante che affrontiamo la situazione.
Non dobbiamo difendere una persona che ha comportamenti disprezzabili solo perché è vicina o si definisce anarchica, il fatto che professi una idea non deve rendere più flessibile la nostra posizione rispetto alle violenze di genere.
E soprattutto, è necessario riuscire a rompere i vincoli di solidarietà maschile rispetto a chi usa violenza. Alle volte però ci sono anche donne che difendono più strenuamente gli aggressori degli stessi uomini, a dimostrazione di quanto profondamente ci è entrato dentro il sistema di pensiero patriarcale.
Quando decidiamo di parlare con lui, sia in un momento collettivo sia privatamente, non dobbiamo partire con l’idea che abbia commesso una violenza, ma cominciare chiedendogli spiegazioni rispetto alla situazione. Nello sviluppo della risposta magari possono cominciare a intravedersi giustificazioni, idee su come è stato gestito il tema del consenso, sullo stato di coscienza. Le volte in cui loro stessi non sono coscienti di aver usato violenza, la ammetteranno senza dargli questo nome. In ogni caso, non aver capito la maniera in cui ci si è comportati, cioè non tenere in conto il consenso nella giusta forma, non esime da responsabilità. In alcuni casi, può essere che il miscuglio tra le due versioni rimanga ambiguo e non si giunga a un quadro sensato. In questo caso è importante essere coscienti che i ruoli di dominazione sono intrinseci e non si danno solamente nel momento della violenza. Inoltre è necessario avere ben presente il contesto che condiziona entrambe le persone per poter comprendere meglio la situazione.
Se abbiamo la possibilità può essere molto utile confrontare le versioni con terze persone per cercare di comprendere quello che non ci suona, o chiedere ad altre eventualmente presenti quando è accaduta la violenza, o che l’abbiano vissuta a loro volta, o che ne siano in qualche maniera coinvolte. C’è anche la possibilità che l’aggressore in realtà non sia tale, e qui sarebbe necessario capire da quale conflitto nasce la bugia. Segnalare qualcuno come aggressore pubblicamente è una accusa molto grave, quindi non deve mai essere fatta alla leggera. Le persone che la usano per provocare una situazione di potere su un’altra dovrebbero essere espulse dai nostri spazi, cercando anche però di approfondire le determinanti di tale comportamento odioso, e di responsabilizzare la persona in questione rispetto alle conseguenze delle proprie parole.
Da una prospettiva riparativa, che è solo una delle opzioni, è importante lasciare spazio a chi ha usato violenza perché ammetta i suoi atteggiamenti e per sviluppare un lavoro politico di riconoscimento e superamento di questi. Bisogna essere consapevoli che quello che è stato alimentato per vent’anni non sparisce di punto in bianco e che bisognerà stare attente che le aggressioni non si ripetano. Nel caso in cui l’aggressore non riconosca il proprio ruolo evitiamo di cadere in paternalismi. Solo quando loro lo decideranno, non noi, potremo superare certi atteggiamenti.
Con questo arriviamo allo spinoso tema di che fare con il violento quando non intende smettere di esserlo. Perché in teoria è molto facile, ma in pratica i vincoli affettivi perdonano molte cose. Alle volte alcune persone dimostrano di non aver alcun interesse rispetto alle oppressioni che esercitano, hanno un atteggiamento scocciato verso di noi e ci chiamano “nazi”, sono persone che semplicemente e pacificamente smettono di guardarsi dentro perché si trovano in una posizione comoda. Dal punto di vista che il personale è politico e il politico è personale, pensiamo che chi non è disposto a cambiare i suoi atteggiamenti non può avere spazio nei nostri ambienti e nelle nostre vite. L’espulsione da un ambiente affettivo è un processo di apprendimento drastico ma, molte volte, anche efficace. Non dobbiamo continuare a permette gli abusi verso di noi. Un uomo che non ha nessuna intenzione di liberarsi dal patriarcato è nostro nemico. Questo si può urlare ben chiaro: chi non è disposto a mettersi in gioco e a mettere in piazza i privilegi di cui dispone, chi non ha intenzione di rivedere atteggiamenti dannosi o dolorosi ma preferisce giocare con il fatto che da secoli le cose funzionano così, è un nemico più pericoloso di chi non è mai stato messo davanti a discussioni e pratiche di liberazione dal sessismo del sistema patriarcale.
Strategia
Come rendere pubblica una violenza?
Un altro punto delicato da affrontare è quello della “socializzazione” della violenza: il se e il come rendere pubblico un vissuto di violenza. Alcune volte la volontà di portare a comune conoscenza la propria storia muove da un basilare istinto di protezione: evitare che qualsiasi altra persona viva nuovamente gli abusi di un uomo violento. Non sempre è così, ed ancora una volta la decisione rispetto a se rendere pubblico o meno un comportamento di merda dipenderà da chi se lo è vissuto.
Raccontare e spiegare la situazione alle persone che si conoscono, e che spesso conoscono tutt* i soggetti coinvolti,può non essere facile: può diventare estenuante dover ripetere un vissuto più o meno traumatico fino alla sazietà, doversi continuamente esporre al giudizio degli altri, incassare risposte non sempre gradite, vivere scetticismo o pietà, non sapere mai se la persona alla quale ti stai esponendo comprenderà, o sarà anche solo interessata a sentire la tua versione della storia. E non diventa più facile quando per esempio si ha a che fare con un circolo più ampio, come un’area politica concreta.
Uno degli strumenti più comuni per rendere pubblica una violenza su ampia scala è quello del comunicato. Un comunicato è uno scritto che può includere una narrazione completa di quello che è successo o anche solo quello che le persone aggredite ritengono opportuno spiegare per evitare altre violenze e, in alcuni casi, chiedere appoggio e prese di posizione collettive.
Potrebbe essere un utile strumento per spiegare le dinamiche che si ritiene abbiano portato all’esercizio di violenze prolungate o a situazioni puntuali di aggressione. Ma potrebbe soprattutto essere interessante se aiutasse a collettivizzare strumenti per rispondere alle violenze, che attraverso un accumulo di ragionamenti, esperienze, approfondimenti, ci permetta di affrontare e superare queste situazioni ogni volta in maniera più consapevole.
Di solito si affrontano molti aspetti prima di scrivere un comunicato: rispondere alla violenza, far presente all’aggressore i suoi atteggiamenti, conoscere la sua posizione rispetto a quello che è successo, cercare i possibili metodi di soluzione, valutare la questione e vedere come dare supporto a chi ha vissuto la violenza; scrivere un comunicato è uno degli ultimi passi, all’interno del lavoro psicologico dell’aggredita e/o dell’aggressore. Il fatto che sia lo strumento più utilizzato non vuol dire che sia l’unico, quindi possiamo cercare quello che si adatta meglio ai nostri bisogni.
Astraendosi dalla situazione particolare e riportare su un piano di dibattito pubblico i temi del sessismo e della violenza significa intraprendere percorsi di rivoluzione del sé e delle relazioni che si intrecciano. Tenere primariamente nel quotidiano atteggiamenti attenti e rispettosi e introiettarli, scrivere fanzine o contributi, fomentare progetti antisessisti e di lotta al patriarcato sono strategie per superare comportamenti di merda e liberarsi progressivamente da strutture autoritarie che influenzano i nostri modi di vivere.
Il silenzio ci trasforma in complici, e non è un opzione.
Se non riteniamo di poter parlare coerentemente e correttamente di una situazione, rompere la cappa di neutralità e scetticismo che circonda le questioni di violenza in generale è comunque utile a tutte.
Aria di festa a Milano, la primavera appena arrivata, il parco della Martesana già pieno di gente che accenna a bere le prime birrette sull’erba, di ragazzini e ragazzine che lanciano via la giacca accaldati dai giri in bicicletta, di signore che corrono e ragazze che giocano a pallone. I colori di via Padova si mischiano sotto il sole, c’è un concerto all’anfiteatro, un sacco di gente per una delle giornate di avvicinamento alla festa del 25 aprile in quartiere. Gruppetti sparsi, cambio alla gente che suona, relax. Ma comincia a spargersi una voce tra le compagne, Ragazze venite, ma solo noi. Uno stronzo urla addosso a una donna che piange, attaccata alla balaustra che la separa dal fiumiciattolo regno delle nutrie. Le va sempre più vicino, la insulta, la provoca. Noi ci schieriamo dietro, in silenzio, guardiamo. Occupiamo una panchina, poi delle compagne si siedono anche sullo schienale, guarda già ne regge almeno sei, questo legno verde marcio per le piogge milanesi. Altre di fianco, appoggiate agli alberi, ci stiamo innervosendo, ma non interveniamo. Lei ci ha viste, questo è l’importante, non ci conosce, ma capisce che non è sola. In uno scatto di rabbia lui si gira, ci vede, ma non si rende conto. Un secondo solo, prima che si giri di nuovo e capisca che siamo lì per lei, per contenere lui. Provaci a toccarla, dai. Che con la rabbia accumulata da generazioni, odiamo come solo una donna può odiare un uomo che si impone, imputando a lui la miseria e la sofferenza di migliaia di donne per migliaia di anni. Ma è meno scemo di quanto sembra, il tipo. Ha compreso molto bene cosa facciamo lì, e se ne va. La ragazza timidamente si avvicina, le guance rigate da pianto di rabbia e di paura. Qualcuna di noi muove verso di lei, tranquilla, è andato. Un paio di compagne le fanno scudo sulla via di casa, chissà mai che la merda torni per sentirsi forte da solo. Ci si scambiano i numeri, si semina un dubbio: si può non essere sole, si può non aver bisogno di altri uomini a difenderci. Noi ci bastiamo.
La costanza dà i suoi frutti
Che non ci sia un lavoro costante, strutturato o spontaneo, sull’oppressione di genere nei nostri spazi rende molto difficile rispondere adeguatamente alle violenze. I problemi sono molteplici, cominciando dal definire che cosa è una violenza e finendo con il rischio di relativizzare sempre tutto in modo sproporzionato.
Per prevenire le violenze è necessario un lavoro politico di formazione e risoluzione dei conflitti costante. Tale lavoro può assumere diverse forme e occupare differenti momenti, può darsi all’interno di gruppi di persone socializzate nello stesso genere o essere misto, assumere insomma la forma migliore a seconda delle necessità di ogni gruppo o persona. Bisognerebbe anche imparare a comunicare i nostri limiti, sia verbalmente che con il linguaggio corporale, ed ancor più ad ascoltare e dare retta a quelli degli altri: questo è consenso. Creare uno spazio per la comunicazione è imprescindibile per evitare fraintendimenti, per evitare di oltrepassare i limiti delle altre e degli altri, per non sentirsi costrett* a comportarci come non vorremmo, etc. Prestare la giusta attenzione a come ci sentiamo in ogni momento può rendere più facile rispondere chiaramente alle situazioni di abuso patriarcale che viviamo e soprattutto può contribuire a cessare di normalizzare tali abusi. I cambiamenti non si ottengono solo con le buone intenzioni, ma hanno bisogno di un lavoro di riconoscimento e eventualmente superamento dei propri atteggiamenti e della propria maniera di intendere le relazioni.
Il fatto che nei nostri spazi riconosciamo prima, e più spesso, le violenze di genere, è dovuto al discreto lavoro che stiamo facendo per renderle visibili. La risoluzione del conflitto generato da una violenza non è a esclusivo vantaggio di chi l’ha subita, ma è necessaria per il benessere collettivo. La coesione e la forza del gruppo non è data dal nascondere i nostri punti deboli ma dal lavorarci sopra tutt* insieme. Le dimostrazione di vicinanza con altre persone che hanno vissuto violenze di genere e le prese di posizione ci aiutano a creare degli spazi più sicuri. È una chiamata a riprenderci cura di noi tra di noi.
Non sempre i momenti più caldi sono i migliori per pensare a quello che è successo, perché tutte ci sentiamo coinvolte e manteniamo un atteggiamento difensivo e una posizione di chiusura. Dovremmo ragionarci prima che si creino certe situazioni invece che affrontarle solo quando ci tocca, perché prima non erano ritenute una questione “prioritaria”. E sopratutto perchè quei gruppi o quegli individui che portano avanti un lavoro politico sulla questione delle violenze di genere vengono troppo spesso disprezzati, definiti come “femministe che si devono riprendere” o “che devono scopare di più”, mentre si grida a gran voce che il femminismo è morto e non c’è n’è più bisogno perché la parità di genere è stata raggiunta “e siete voi che non siete veramente libere”. Spesso vengono assunti nei loro riguardi atteggiamenti distruttivi che alimentano l’”antifemminismo” dei gruppi, che definiscono le critiche come “pezze tirate da compagne maliziose”, o “pipponi”[3].
Bisogna rompere questo tipo di dinamiche politicizzando le relazioni e affrontando il tema di genere con il dovuto impegno. Coprire le violenze di genere non fa sì che chi ne è stata coinvolta si senta più sicura o a suo agio nei nostri spazi, anzi moltiplica le possibilità che queste vengano perpetrate. Additare e criticare il femminismo è facile quando ti permette di non prendere mai posizione, dicendo che queste cose capitano, che il mondo è una merda e la violenza serve a ottenere rispetto. Ma no, noi non vogliamo vivere nella merda: siamo compagni e compagne in percorsi politici, ci riempiamo la bocca con l’idea di un mondo migliore e poi facciamo fatica a rispettare chi ci è di fianco.
Già, gli spazi sicuri in assoluto non esistono. Per questo dobbiamo cominciare a costruire spazi con strumenti, dove possiamo sapere che gli atteggiamenti machisti non avranno spazio, dove possiamo credere di godere di un appoggio collettivo che ci faccia sentire forti rispetto a quello che ci può succedere e ci permetta eventualmente di reagire con determinazione e tranquillità.
“Conclusioni o nuovi inizi”
Se le violenze di genere in ambiti che si definiscono antiautoritari continuano a emergere come una realtà a cui rispondere, può darsi che gli strumenti messi in atto perché questo genere di merda non accada siano poco efficaci, o insufficienti. Possiamo lasciare che ogni individuo combatta contro i propri fantasmi o organizzarci per assumerci la parte di responsabilità che deriva dal contesto. Ad esempio, come si è detto, pensare a una serie di pratiche che permettano non solo di rispondere in maniera decisa, ma anche di sviluppare progetti teorici e pratici perché non ci sommergano.
Organizzarsi per l’autodifesa e per l’azione diretta contro chi ci attacca, produrre e distribuire materiale che decostruisca la cultura dello stupro e promuova quella del consenso, preparare workshop o iniziative dedicate possono essere validi modi di sfidare il patriarcato e avere la meglio sui comportamenti abusivi. Lavorare sulla comunicazione, condividere esperienze e ragionamenti, possono portare a cambiamenti radicali e duraturi nella percezione dei propri comportamenti, e nei comportamenti stessi.
Bibliografia
-
Antifeminismos y violencia de género en entornos antiautoritarios y espacios liberados: rechazodistro.wordpress.com
-
Violenza sessuale negli ambienti anarchici – critiche e suggerimenti sui modi di affrontarla: anarcoqueer.wordpress.com
-
Accounting for Ourselves: Breaking the Impasse Around Assault and Abuse in Anarchist Scenes: www.sproutdistro.com /zines/accountability-consent/accounting-for-ourselves/
-
Betrayal – a critical analysis of rape culture in anarchist subcultures: libcom.org
-
Thoughts About Community Support Around Intimate Violence: www.activist-trauma.net
-
Circa i fatti di Parma nella sede della RAF: come riparare 4 crepe prima che qualcosa si rompa per sempre
-
Via Testi. Le crepe portano ossigeno
-
Anarchia e femminismo – Scagliare una pietra al patriarcato: anarcoqueer.wordpress.com
-
LAVOMATIC, Laviamo i panni sporchi in pubblico – Spunti di riflessione sulle violenze di genere nel movimento antiautoritario: transumanze.noblogs.org
-
Manual de autodefenza para “mujeres” y otras expresiones de género nohegemonicas: anonimxslibertarixs.files.wordpress.com
-
Forbici per tutte! Testi sulla violenza machista nei movimenti sociali: anarcoqueer.wordpress.com
-
Raccolta di esperienze e riflessioni sulla cultura dello stupro: anarcoqueer.wordpress.com
-
Micromachismos: la violencia invisible en la pareja
-
Spazi pericolosi. Resistenza violenta, autodifesa e lotta insurrezionale contro il genere: anarcoqueer.wordpress.com
[1] Cis, oppure cisgenere, è una persona per la quale il genere che percepisce come proprio coincide con quello che le altre persone le hanno assegnato alla nascita.
[2] Manual de autodefensa para “mujeres” y otras expresiones de genero no hegemonicas, pag. 4
[3] Tra le virgolette, commenti realmente avvenuti in diverse circostanze.