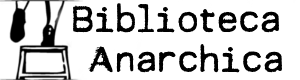Edizioni cooperativa Apache – maggio 1983
Angelo Monaco, Bruno Peirolo, Cesare Maino, Claudio Waccher, Dario Corbella, Ermanno Colleda, Graziano Esposito, Juan Soto Paillacar, Luca Frassineti, Massimo Domenichini, Riccardo D’Este
Ogni uomo deve avere delle buone ragioni per alzarsi al mattino
Ogni uomo deve avere delle buone ragioni per alzarsi al mattino
“A chi ha cercato la maniera e non l’ha trovata mai”
Da alcuni mesi a questa parte stanno circolando dentro alla carceri, nei luoghi ad esse contigui e, più in generale, nell’ambito “sociale”, documenti, bozze, prese di posizione varie sul problema della prigionia politica in Italia, della fine o della ridefinizione della cosiddetta “lotta armata” e, infine, pur alludendovi, del conflitto sociale tuttora in corso. Noi intendiamo intervenire in merito con l’autorevolezza dataci dalla passione e non certo da qualsivoglia etichetta. Perciò ci preme subito dire come, da chi, da dove e perchè nascono queste parole che sono solo un passo distanziate dalle idee!
Siamo un gruppo di soggetti incasellati in varie inchieste giudiziarie attualmente detenuti nel carcere speciale di Fossombrone, un gruppo che, a partire da livelli di aggregazione vissuta, si è sedimentato negli ultimi tempi e va verificandosi sul dibattito riguardante la proiezione reale e possibile del nostro essere ed esistere interno alle dinamiche sociali, tendenzialmente controsocietarie. Non intendiamo certo riproporre caratteri da “vecchia organizzazione”, ne riassumerne le caratteristiche, nè infine, pretendiamo o desideriamo presentarci come un blocco monolitico che, oltre a non essere reale, non avrebbe neppure quella “forza espressiva” alla quale ambiziosamente tendiamo.
Siamo consci delle disomogeneità presenti tra noi, sia di percorsi, sia di pensiero attuale, ma di questo dato di apparente debolezza vogliamo far leva di forza caratteriale, ben certi che la nostra ricchezza derivi anche, seppur non solo, dal confronto-scontro tra soggettività vive. Ciò che senz’altro rifiutiamo, immediatamente e metodologicamente, è l’agire da “bravi politici” i quali oggi vestono tutti i possibili abiti ideologici, nessuno realmente adeguato al loro pratico esistere, come vecchie puttane che più o meno abilmente si rifanno il trucco. E, si sa, una laida meretrice davanti allo specchio ha molti, troppi sogni che la conducono ad indossare i panni più mistificanti, più dentro la moda del momento, pur di celare la realtà vera che la trova distesa sulla brandina da campo a praticare tariffe sempre più basse per sopravvivere.
Non si pensi però che vogliamo liquidare apoditticamente le posizioni miserabili oggi prodotte dal “ceto politico” che, comunque, si ripropone. Affronteremo più avanti le questioni partitamente, dando e dicendo a ciascuno il suo. Ci preme ora sottolineare che non ci unisce soltanto una critica verso altre posizioni, nè alcun “rocchetto di filo rosso” ipotetico e pregresso, ma una concreta determinazione ad agire, un riconoscersi, un amore sovversivo che é di se per sè eloquente presa di posizione, distinguo materiale e vissuto. Le molle che ci spingono ad uscire pubblicamente con questo testo sono esattamente quelle sopraindicate. Non ci importa certo rispondere ai vari mercanti di storia, ma porre e proporre le basi per una nostra-di noi tutti-proletari assoluti, ripresa di azione e di forza, lasciando finalmente da parte caratterizzazioni apofantiche del tipo: “siamo quelli che non...”. L’unica ed indiscutibile discriminante che poniamo, tanto a noi stessi quanto ad altri, é l’appartenenza ad un’area libertaria (come forza dell’agire liberazione umana e non certo come surrogato del “libertarismo” ideologico da più parti ridicolmente conclamato) contro ogni riferimento teorico-pratico a posizioni m-l, a qualsiasi ipotesi di partito, a qualsivoglia ipostatizzazione di masse e avanguardie, comunque rivisitate e ridefinite.
Gli spazi di dibattito, e anche di azione, che si sono aperti o che si stanno aprendo nell’ultimo periodo, sono astrattamente larghi, vanno però concretamente riempiti pena un odioso parlarci addosso. Se non possiamo che rilevare positivamente il fatto che taluni settori prigionieri finalmente parlino, e forse pensino, dopo tanti leaderismi e gregariati ignobili, non possiamo che constatare con disappunto quanto spazio sia stato inopinatamente e immotivatamente occupato da coloro che, veicoli di vuoto e confusione, attraverso tali spazi vedono la possibilità di dialettizzarsi con lo stato presente delle cose nonché di trattare con lo Stato, vendendo la propria “pubblicità” precedente, ovvero, per tirar via il culo dalla galera, creandosene di nuova su pratiche fondanti quelle forme differenziatrici tra soggetti, prigionieri e non, che l’assetto societario e le sue istituzioni richiedono. E’ importante sottolineare come tutti gli interventi, dovunque provengano, cerchino di affrontare e di sciogliere il nodo della liberazione – per alcuni ridotta a mera scarcerazione, quasi la libertà socialmente concessa fosse libertà reale – dei cosiddetti prigionieri politici. Già questo seppur limitativo punto di vista, ci trova dissenzienti per metodo e per merito: la questione reale é – e deve essere – l’abolizione del carcere e della società che lo fonda e costituisce. Altrimenti ogni ipotesi, più o meno sensata e più o meno praticabile, di “soluzione politica” assume dignità discorsiva mentre, senza mettere in discussione l’esistente, cerca solo le forme più adeguate per la sua rappresentazione e conclusione. Né é un caso che nei discorsi di taluno venga compiuto il surrettizio confronto con l’estinzione” dei manicomi, quasi si fosse introiettata la logica “sovietica” che rende equivalenti antagonismo e follia, o il ricorso alle amnistie “politiche” dello Stato, quale, p. es., quella adottata nel dopoguerra nei confronti dei fascisti; in realtà, se noi siamo “matti”, vogliono estinguere noi e non dissolverci, portatori di potenziali virus, nel tessuto della società; in realtà, i fascisti andavano scarcerati perché il fascismo, forma di ridefinizione del capitale, veniva sussunto e inverato dalla forma-democrazia, mentre la sovversione sociale non può essere scarcerata senza, per l’appunto, una forza sociale che lo imponga!
Precisiamo da subito che noi non siamo indifferenti al problema della liberazione dei cosiddetti detenuti politici di questo paese, né vogliamo rimandarla ad un tempo senza fine, quando un improbabile sole rosso splenderà su un altrettanto incredibile presa di un Palazzo d’Inverno, oggi socialmente diffuso e quindi non identificabile in sè e per sè come entità separata, “cuore del potere”. Ma d’altronde non riusciamo a vedere slegato il problema dei detenuti politici da quello delle forme di controllo e di comando societario cosicché, se soluzione può esservi, e ha da esservi, fin d’ora diciamo che potrà essere solo di natura sociale. Questo impone una scelta di campo ed una presa di coscienza da parte di molti ed in primo luogo dei detenuti sociali (politici e non) che devono saper impiantare una battaglia di libertà complessiva, sola possibilità autentica di relazionarsi ad altri segmenti di proletari spossessati e tendenzialmente in lotta di liberazione. Quindi nessuna passività e, nel contempo, nessuna delega alle “istanze politiche” vere o presunte che siano.
Non ha del tutto torto, almeno su questo punto, un Oreste Scalzone quando sostiene che la liberazione “manu militari” non può oggettivamente rappresentare la soluzione immediatamente praticabile per tutti. Ma non coglie nel segno. Infatti, se ribadiamo il concetto di “soluzione sociale” su cui ci diffonderemo più avanti, vogliamo anche sottolineare l’importanza della critica pratica alla pretesa impermeabilità della struttura carcere che, per essere forata, sembra necessitare sempre di soluzioni “altrove”, cioè laddove i prigionieri nulla contano di per sé soli. Lo strumento dell’evasione (e i casi di Frosinone e Rovigo ci sembrano esemplari) ci pare importante non perché “ideologicamente” prediletto, non in quanto tale, ma perché dimostra nei fatti il carattere utopistico del progetto totalitario di controllo. A questo proposito e a scanso di equivoci, ci piace precisare che anche tutte le scarcerazioni ottenute facendo leva nelle crepe della cosiddetta “giustizia” vanno favorite ed anzi è compito dell’intelligenza saper sfruttare, quando possibile, soluzioni processuali vantaggiose, “difendendosi”, senza peraltro alcuna svendita o cedevolezza. È evidente perciò che per noi non è questione di privilegiare il “militare” o il “tecnico-giuridico”; ci preme invece affermare la necessità di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per sottrarre soggetti e gruppi di soggetti alla carcerazione e, nel contempo, per riaffermare la possibilità concreta di uscire dalle carceri, al di là e “contro” le imputazioni formulate da una magistratura che sempre più si connota come forma particolare, specifica dell’esercizio del comando codificato.
Nessuna illusione, perciò, ma l’obbligo concreto di battere ogni forma di rassegnazione, verso la costituzione materiale di quella “soluzione speciale” a cui tendiamo e che, pur con allusioni e contraddizioni, é stata un idea-forza della sovversione sociale in questo paese lungo l’arco di un quindicennio. Nessuna etica del sacrificio quindi, ma la capacità forzante di unire il bisogno del “qui ed ora” alla prospettiva più ampia del “per tutti e comunque”. Perché, lo si dica chiaramente, il nostro percorso di “comunismo” è si affermazione di materialità immediate e concrete, ma nel contempo contiene un progetto ambiziosissimo e ne siamo orgogliosi che appare per la prima volta nella storia dell’umanità: l’abolizione di ogni forma di società, comunque autoriproduttiva di alienazione, per la liberazione delle energie complessamente umane e di nuova comunità. Tutti coloro che si illudono riguardo a “nuove società” venture, parlano il linguaggio dell’unica società possibile, l’attuale, e dunque sono costretti a riempirsi la testa di “soluzioni politiche” o di fantasie guerriere, senza mai centrare il nocciolo del problema: l’abolizione della società e, durante questo percorso, l’applicazione di nessi controsocietari.
Noi partiamo da una critica puntuale e rigorosa della società dominatrice così come si sta informaticamente delineando lungo tracce di controllo e differenziazione, mutuate proprio, per paradosso, dal regime penitenziario. Galera sociale dunque, come più volte venne detto e colto; peccato che ora, nell’ansia di togliersi di dosso il carcere materiale, molti, troppi se ne dimentichino! Sembra che si confondano, più o meno volutamente, le cause con gli effetti, sembra insomma che la catastrofe immanente di cui la società é portatrice sia stata determinata, almeno in Italia, dalla cosiddetta lotta armata. È vero esattamente il contrario. La lotta armata nel nostro paese non ha certo determinato per sé solo le condizioni repressive che oggi viviamo; esse infatti erano, e sono, già contenute nel progetto totalitario del capitale. Naturalmente vi è stato uso di parte capitalista di tutti i possibili errori della lotta armata, ma questo non ci può impedire di scorgere la forma e la sostanza del disegno autoritativo e autoriproduttivo “sociale” così come si manifesta planetariamente. Né é un caso che in altre nazioni dove la lotta armata si è sviluppata poco e niente, il progetto totalitario-carcerario della società sia proceduto a grandi passi; ci basti citare l’esempio degli USA dove, nonostante i tagli della spesa pubblica e del Welfare voluti dalla politica reaganiana, gli incrementi di spese per nuove carceri, e dunque per nuovi prigionieri; sono altamente previsti e messi in bilancio come dimostrano recenti rapporti ufficiali. Perciò a chi giova una critica riduttiva della lotta armata o, al contrario, una sua riproposizione acritica seppur rinnovata di panni? Non certo ai rivoluzionari che da tempo hanno criticato – o lo stanno facendo ora, se in ritardo – le strettoie formalistiche del politico e quindi anche della lotta armata come entità autoriproducentesi, autonoma e separata dai percorsi liberatori e controsocietari in atto. Su ciò torneremo con visione d’assieme, ma già fin d’ora va detto che la critica dei rivoluzionari ai fenomeni pregressi, e ai gravi errori colà contenuti, non parte certo da una riautentificazione dei rapporti sociali dati, né tanto meno là vuole giungere. Al contrario, essa si applica alle forme inadeguate, alle loro riproposizioni, ai ritardi del movimento di emancipazione dalla società, alle secche in cui si è trovata e si trova la forza che, mentre vuole praticare la dissoluzione dei vincoli societari attuali, deve saper far emergere i nuovi liberi legami di comunità umana.
Altri invece, pur partendo da una critica o autocritica inevitabile, giungono, chi per un verso chi per un altro, alla riproposizione, seppur sotto nuove forme rappresentative, dei rapporti esistenti nel mondo e delle loro forme istituzionali. Noi che non abbiamo nessuna spiaggia da difendere, se non quella che c’é sotto il pavé (come si diceva un tempo), riscontriamo la miseria di tutti questi signori che, incapaci di critica radicale all’esistente, ora “accollano” alle effettive responsabilità del lottarmatismo anche tutte quelle che competono ad un ceto politico gaglioffo e vile, capace solo di autoriprodursi e di candidarsi eternamente a ruoli dirigenti-amministrativi. Questi poveri ricchi politici cercano di liquidare addirittura il “sogno di una cosa” e, come i “pentiti” non sono veritieri riguardo a nessun movimento che hanno guardato soltanto da voyeurs, cioè dal buco della serratura della loro squallida esistenza, così, altrimenti ma similmente, questo ceto politico non è credibile quando sviluppa una critica che tale in realtà non è, mentre risulta solo un coacervo di banalità indotte e di “excusationes non petitae”. Il caso del professor A. Negri e dei suoi “allievi”, in queste gelide nozze di sangue freddo con le istituzioni e la società-Stato che le coagula, è senz’altro esemplare. Sicuramente vittime dell‘“ingiustizia che incarcera” (parafrasando le. parole del defunto ma non compianto generalissimo Dalla Chiesa, alla fine anch’egli massacrato dai giochi di potere che aveva contribuito notevolmente ad alimentare) come risulta dall’affaire giudiziario che va sotto l’etichetta di “7 Aprile”, impotenti ad essere veramente autonomi – e non Autonomi! – e quindi di realizzare autentica battaglia di libertà, sottoposti alla proterva autorità dello Stato, costoro si lagnano pecorescamente o si fanno addirittura complici e veicoli di un arrogante progetto di smemorizzazione e annichilamento di ampli settori antagonisti e trasgressivi, divenendo dunque voce dei loro stessi aguzzini e scaricando su un “colpevole” immaginario (gli “irriducibili”, cioè coloro che conservano dentro di sé delle buone ragioni per alzarsi dal letto ogni mattino) i “peccati” di cui sono vittime partecipi, proponendo infine la propria candidatura come futuri dirigenti di un possibile movimento, purché esso si delinei dentro le gabbie istituzionali! Né a molto servono i recenti tentativi di rileggere la storia, recuperandosi “a sinistra”, che vengono compiuti (testo:“Do you remember Revolution?”) poiché non solo si vuole spiegare “politicamente” una vicenda che è stata essenzialmente sociale, ma soprattutto perché, quando sono costretti ad immergersi nel sociale, usano categorie economiche interpretative tramandate dal capitale stesso. Forse sarà utile in altra occasione sforzarci verso una nuova scrittura della storia, ma senza ambiguità o riduttivismi concettuali.
Tornando a questi signori, sinceramente non c’è bisogno di molti discorsi per liquidarli, poiché sono essi stessi, con le loro parole, a liquidarsi da sé soli: propongono infatti “patti di percorso” che praticamente significano una modernizzazione delle stesse istituzioni che li incarcerano! Avendo compreso che la società del capitale esiste solo per differenziazioni, si fanno agenti promotori delle stesse, nell’illusione che questa soluzione sia accettabile “colà ove si puote ciò che si vuole”.
Una grande battaglia di libertà, così come poteva essere costruita su questo caso e altri consimili, è stata preventivamente svenduta dai protagonisti stessi che preferiscono le briciole pubblicitarie televisive alla forma di affrontamento sociale che il contenzioso stesso richiederebbe. Costoro reclamano per se quei diritti che negano ad altri, al punto di formulare richieste di cogestione penitenziaria che in prospettiva premino i soggetti (“patto di percorso”) in qualche modo compatibili col sistema carcerario e istituzionale, nonché dunque ad esso dialettizzantisi, mentre giocoforza presuppongono, senza peraltro il coraggio di affermarlo con voce chiara, che per gli irrecuperabili, i disutili, i non dialogici, infine gli “irriducibili”, sia necessario si spalanchino le infernali porte di quel pozzo nero che sono le carceri speciali ove ciascuno che vi entra dovrebbe lasciar fuori ogni speranza!
Persino altri, pur intrigati in ipotesi di “soluzione politica”, sono costretti a dichiarare che “tutto ciò è indecente”. Non varrebbe, come si é detto, la pena di occuparsi troppo di simili posizioni se esse non fossero in qualche misura, più o meno inconsapevolmente, introiettate come chance da altri settori di prigionieri e di compagni e, soprattutto, se queste ipotesi non rientrassero nel quadro che le ali più “avanzate” degli amministratori sociali si propongono per risolvere il complicatissimo caso-Italia. Per esempio, è facile vedere come l’autodeterminazione carceraria – in sé e per sé concetto di qualche interesse – che viene, proposta, in realtà altro non sia se non una forma di cogestione, di pratica collaborazionista; la pretesa autonomia dei soggetti risulta solo “possibilità di scelta” dentro un sistema binario, all’interno delle forme dell’asservimento.
Al proposito sarebbe assai interessante, per meglio comprendere i modelli di organizzazione concentrazionaria e delle forme collaborazionistee che si manifestano al loro interno e che vanno addirittura oltre la famosa Sindrome di Stoccolma, ristudiare la storia e nella fattispecie le forme in cui si é espresso e materializzato il comando più “audacemente” totalitario che, a sua volta, ha indotto specifiche forme di collaborazione-partecipazione: i lager nazisti. Vi sono vari documenti e libri, tra i quali è d’obbligo segnalare quelli di Rousset e di Rassinier, pur tra loro differenti, in cui viene delineata e spiegata la figura del Kapò. Sia chiaro da subito: il Kapò non era un SS o comunque un nazista; poteva essere o un ebreo privilegiato o un “comunista” che intendeva privilegiarsi; insomma, per lo più il ruolo veniva assolto da gruppi di prigionieri che, per ottenere speciali vantaggi, svolgevano tali maensioni di controllo, di contenimento e dunque di amministrazione. II Rassinier, tra l’altro, parla esplicitamente, e con dovizia di particolari, del posto di rilievo occupato da taluni “comunisti” (in specie i francesi del PCF) che, in nome di una pretesa funzione di avanguardia, cioè di ceto politico, si accaparravano il controllo di tutte le forniture, cibarie comprese, sacrificando così di fatto altri prigionieri ritenuti meno “utili”. La politica si sposava al comando con mutuo vantaggio!
Non sembri casuale questo riferimento storico: infatti riteniamo che il modello di politica reclusionaria, concentrazionaria e infine annientatrice, abbia evidenziato il passaggio dal dominio formale al dominio reale del capitale il quale, spurgandosi degli aspetti più deleteri delle forme politiche precedenti, le assume valorizzandole nell’amministrazione totalitaria del pianeta. Oggi le condizioni di prigionia subite, seppur tragiche, non sono realisticamente paragonabili a quel livello, soprattutto come forma; ma la logica è la stessa. Quale può essere, quindi una possibile “autodeterminazione” dentro il ghetto imposto, la miseria obbligata, lo spossessamento diffuso? In una società-carcere si può sfuggire al ruolo scomodo di prigionieri (o di ribelli che arrischiano quotidianamente di divenirlo in virtù della propria ribellione) soprattutto diventando Kapò, anche senza indossare la divisa e lordarsi le mani di sangue, poiché un esercito di Killers statali è pur sempre pronto in pianta stabile, e disponibile. Negri ed amici, dopo il brivido del passamontagna, vogliono vivere il più squallido brivido della repressione cogestita: comunque sempre in replay, mai del tutto in diretta, illudendosi di cantare mentre scorre il nastro del play-back.
Si ricostruisce la storia a proprio uso e consumo, riducendola a cronaca, si stravolge la realtà dei fatti e i ricordi del passato – nonché le coscienze del presente – confondendo il tutto in un groviglio inestricabile da cui sembra emergere un’unica “ragione”: la storia del capitale e della società.
Gli eccessi rivoluzionari che, dopo severa autocritica, andrebbero ripresi per il loro contenuto “utopico” ma reale, vengono così del tutto stravolti in una squallida cronaca di terrorismo in cui non solo nessuno può riconoscersi veramente, ma che soprattutto non rende giustizia di ciò che é stato vissuto da donne e uomini in questa convulsa congiuntura storica. Perciò si arriva a figurare il movimento del ‘68 come spinto da una forte concettualità di tipo leninista – che era perlomeno intrecciata a tutte le consistenti tensioni antiautoritarie le quali, oltre che in Italia, si esprimevano nel “mouvement” internazionale e soprattutto in Francia, nella RFT e negli USA- ed a negare una precisa volontà antistatale della cosiddetta “illegalità diffusa” che, invece, manifestava proprio un altro grado di insofferenza verso le forme di controllo e di dominio esercitate dallo Stato: Sui perché della “sconfitta” e dei ritardi sarebbero necessari ben altri lavori di ricostruzione storica. Ci preme qui, per concludere, sottolineare l’aspetto riformistico e neo-istituzionale con cui i signori del 7 Aprile e di “Do you remember Revolution?” rileggono i fatti, ben attenti alla soluzione politico-giudiziaria, ma incapaci di capire una nuova ondata possibile controsocietaria che, in effetti, spazzerebbe via anche le loro vagheggiate “mediazioni”.
Siamo chiari: la proposta del professor Negri e dei suoi amici non é poi così irrealistica come altri più “ingenui” hanno detto. E’ dentro lo sviluppo delle cose. Vende qualcosa per ottenere dell’altro. Vende, in particolare, gruppi di individui e una memoria complessiva in cambio di una maggiore elasticità istituzionale che sappia diluire nel sociale quello che il carcere oggi manifesta come concentrato.Né a caso si parla di “generazione politica”; si taglia così di fatto ogni legame con le generazioni in senso proprio, in senso storico, in senso sociale. Rimane una questione tra “politici” la cui soluzione deve passare sulla testa dei moderni proletari assoluti. Anche sotto il fascismo-regime un uomo come Pertini era prigioniero; ora è presidente di una repubblica sicuramente “antifascista” ma che, altrettanto sicuramente, farebbe impallidire con le sue costumanze e regole i truci fascisti stessi! Sono sempre ceti politici che si affrontano, volta a volta vincenti o perdenti, mentre lo sviluppo sociale rimane solo quello del capitale.
Noi non crediamo che in linea di massima siano impossibili “soluzioni politiche”, invece che, se esse non saranno frutto maturo di un’ampia volontà sociale, comunque ci passeranno sopra la testa.
L’art. 90 è un caso emblematico. Si tratta in effetti di una forzatura voluta dallo Stato italiano per contenere e comprimere la trasgressione sociale e soggettiva, per separare radicalmente i detenuti dalle loro esperienze e dal loro “habitat”. Ben pochi, oltre ai prigionieri ed ai loro famigliari ed amici, hanno affrontato questo problema; sopra vi è stata distesa una coltre di silenzio ovvero su di esso si è innervata una serie di proposte “democratiche”, che mai hanno messo in discussione i termini concreti della carcerazione in Italia negli anni ’80. Quest’errore non viene compiuto solo dai Rodotà e da altri illusionisti stipendiati, ma pure da taluni compagni. Sembra che non ci si renda conto della natura sostanziale e formale dello Stato Moderno, vera espressione della società presente.
Compagni come le donne e gli uomini di Rebibbia, che recentemente si sono espressi con più testi, compiono anch’essi un errore fondamentale; si rendono conto della necessità di superare esperienze passate ed oggi non interessanti (come la fissazione del lottarmatismo); si rendono conto dell’importanza di ricostruire un movimento che, nelle sue caratteristiche, contenga forza sociale liberatoria; ma, nel contempo, sfuggono l’analisi di ciò che é la società attuale e quindi chiudono gli occhi di fronte alla forza totalitaria che essa esprime; ancora una volta scambiando cause per effetti si illudono di poter trattare tra “rappresentazioni”: essi stessi come rappresentazione del movimento già dato ed il governo ed i suoi uomini come rappresentazione del movimento sociale capitalistico. Questi sforzi, seppur talvolta onesti, sono destinati al fallimento perché prescindono dalla qualità della “libertà civile” oggi possibile in Italia, non solo per i prigionieri in senso stretto ma per tutti i cittadini-prigionieri sociali. Il governo non é un guscio vuoto che basta aprire per vederne le manchevolezze, né soltanto una cosca politica con cui in qualche modo si può cercare di trattare: la strettoia della politica non é casuale, é la forma fenomenica del dominio sociale così come va determinandosi. È dunque illusorio ritenere che lo “sforzo di volontà” di certi soggetti per oltrepassare la forma lottarmata e i suoi avvitamenti terroristici possa essere un buono da poter riscuotere presso il Banco della Società-Stato, poiché é essa stessa ad essere realmente terroristica e ad aver dichiarato guerra, senza dichiarazioni formali, contro tutti gli individui, come le misure restrittive della “libertà”, spossessative dei salari-redditi e come l’esautoramento decisionale dalle questioni sociali generali hanno dimostrato. Si vuol dire semplicemente questo: una società che si modernizza in senso autoritativo e totalitario, cercando di introdurre il sistema dei codici addirittura sotto la pelle degli individui, affronta il problema del carcere esattamente come affronta tutti gli altri problemi. Laddove la carcerazione diffusa é bastevole, la socializza il carcere; dove ciò non é immediatamente realizzabile si fa carico della più dura repressione poiché il soggetto cittadino o é compatibile con l’assetto societario o non é, nel senso che ne viene annichilita l’originalità propositiva e, se del caso, la fisicità stessa. (vedi nota)
Non siamo sciocchi però, e quindi sappiamo che le bande-racket del capitale non sono sempre in sintonia, omogenee. E sensato dunque giocare arditamente su queste contraddizioni e su questi ritardi, ma, come nel gioco del calcio, bisogna farlo di rimessa, in contropiede, utilizzando gli spazi che volta a volta si aprono, senza soprattutto fornire il nostro materiale umano come materia di sperimentazione, senza fornire noi stessi come nuovi filosofi-propositori di progetti ristrutturativi, senza, infine, sposare l’una o l’altra delle bande politiche che si contendono la questione del comando.
La critica principale che vogliamo muovere alle campagne e ai compagni di Rebibbia dei documenti di “oltrepassamento” é proprio questa: di non essersi oltrepassati abbastanza, di aver ipotizzato ancora una volta soluzioni politiche difficilmente proponibili mantenendo fermi i propri caratteri di originalità, dunque di essersi posti, con rottura parziale del passato, ancora come ceto politico che, per sua necessità di sopravvivenza e autoriproduzione, si ripropone nell’ambito politico.
L’autocritica dei percorsi sinora compiuti non viene però solo da coloro che, rendendosi conto dell’impossibilità dell’andare oltre con simili criteri, stanno tentando una ridefinizione del loro passato-presente-futuro, ma anche da chi, comunque, ripropone una pregnanza centrale della lottarmata o della “guerriglia”.
Vi é infatti una tendenza che possiamo definire “continuista”, cioè la posizione di coloro che, a fronte delle profonde e radicali trasformazioni societarie, dell’assetto di comando e quindi anche del pensiero analitico-sintetico, non sanno dis°ilrsi di categorie quali quella di classe, organizzazione, avanguardia, partito. Di coloro, insomma, che, incapaci di vivere concretamente gli spunti positivi della dialettica, la fissano come canone assoluto, nuovo codice, linea-discrimine per potenziali rivoluzionari. In realtà oggi abbiamo di fronte un complesso sistema di codici in cui ciascuno di essi, purché mantenga la natura protocollare, può essere accettabile; in parole povere tutte le opinioni sono concesse, anzi stimolate, purché si riducano ad essere opinioni, nuovi comportamenti, ulteriori codici interpretativi del reale.
Questo “continuismo”, tanto generoso quanto miserabile, non ha colto né sa cogliere il grandioso progetto totalitario della società né, di converso, l’altrettanto ambizioso “sogno” di decodificazione e di liberazione assoluta. La politica, intesa come tecnica di maneggio e di governo, uscita dalla porta rientra dalla finestra, e i comunisti, nuovi e impropabili catari, dovrebbero essere di per sé portatori di nuova società. L’abbiamo detto e lo ripetiamo: il fine nostro e reale é l’abolizione della società stessa, la distruzione della politica come arte del management, per un’imposizione forte di un tempo e di uno spazio “astorici” e “disorientati”. Non c’é una rimembranza da esaltare, é la memoria del futuro che va concretamente affermata giorno dopo giorno. Altri compagni, reduci da pesanti e penose condizioni organizzativistiche, in cui tutti i miti staliniani e terzinternazionalisti venivano riprodotti, stanno cercando di adeguarsi al passo delle cose, alla discronia tra il progettato e il vissuto, alla sincronia, invece, tra le tensioni liberatorie. Onestamente dobbiamo dare atto a questi compagni di un grosso sforzo per adeguarsi ad un movimento effettivamente reale. I testi che escono da Palmi, ad esempio, non possono che suscitare attenzione e curiosità intellettuale in coloro che non sono del tutto pregni del pregiudizio imposto, dello spettacolo della società che riafferma se stessa. Non di meno, possiamo dire che non tutti i testi sono analoghi e che, nel contempo, non tutte le proposizioni ci piacciono, curiosità ed interesse a parte. Laddove ci sembra di cogliere un rimpannucciarsi delle ideologie sotto nuove vesti, lì esprimiamo il dissenso; laddove invece troviamo spunti di critica alla realtà concretamente vissuta, lì troviamo punti di possibile interazione e di futura dialogicità. Prima di una sintetica rassegna dei testi, vogliamo apporre una doverosa premessa. La maggior dimostrazione della inutilità ed impraticabilità, rispetto ad un percorso realmente rivoluzionario, della forma-partito viene proprio dal tipo di autocritica compiuta dai suoi stessi militanti, purtroppo solo in seguito alla sconfitta subita dalla loro forza organizzata. Sembra che, di fronte all’attacco statuale che ha determinato l’arresto di centinaia e migliaia di compagni, si sia prodotto un fenomeno bizzarro: finalmente “liberi”, proprio perché imprigionati, i militanti si svelano nelle loro ricchezze e nelle loro miserie, nelle contraddizioni fino ad ora assorbite ed azzerate dalla ragion politica e dalla matrice organizzativa, dando vita ad un dibattito assai variegato e spesso addirittura ricco. È questo paradosso che ci colpisce, e cioè che, per rompere l’ideologia e lo schema della “avanguardia armata” più o meno monolitica e compatta, si sia dovuta attendere là sconfitta o là disfatta politico-militare!
Se è vero, come scrisse Marx, che le forze controrivoluzionarie accelerano il rinsaldamento dell’energia rivoluzionaria, è comunque ben singolare che molti abbiano dovuto attendere l’imprigionamento per sprigionare quell’intelligenza che precedentemente rinserravano nella solita routine. Purtroppo però è ben vero, per dirla con Hegel, che le abitudini si conformano come seconda natura dell’uomo; così talora le abitudini sembrano essersi plasmate direttamente sul cervello dei soggetti onde impedirne un’autentica liberazione.
Ci si riferisce qui soprattutto à quei tentativi che, pur proponendo “polifonie” e “complessificazioni”, in realtà ci sembrano poco procedere sul terreno della critica radicale. più che altro ci pare – e i fatti hanno là testa dura, come dovette riconoscere pubblicamente lo stesso Lenin – che alcuni ai fatti si siano adeguati senza tuttavia superarne il senso e il segno. Esemplare in questa direzione è l’autointervista compiuta dal collettivo che ha prodotto il testo “non é che l’inizio”. Questo gioco di domande e risposte secondo noi svela puntualmente il vero pensiero degli estensori, al di là degli equilibrismi innovativi. Ci sembra, insomma, che essi sviluppino un’autocritica solo perché i fatti là impongono, onde impedire di esser travolti dà una reale critica radicale. Infatti, cosa significa agitare là “rottura” operata al loro interno e che ha dato vita al partito-guerriglia come il tentativo più amplio di complessificazione di schemi guerriglieri? Ci sono alcuni punti, impliciti ed espliciti, di simile ragionamento che ci trovano assolutamente discordi. Non vogliamo entrare nel merito delle miserie espresse dal sedicente P-g poiché sono sotto gli occhi di tutti. Ci interessa invece scalzare dà subito un mito che pare scontato: l’esistenza di una guerriglia italiana. Diciamo le cose come stanno: là lotta armata è stata il prodotto contemporaneo sia di fredda volontà politica che di passionale risposta alle condizioni del presente. La prima è stata causa dei ritardi teorici-pratici dell’intero movimento rivoluzionario; là seconda, invece, ha creato “stranamente” dei soggetti migliori delle loro opinioni, delle donne e degli uomini vitalmente insofferenti al sistema capitalistico di relazioni. In effetti quasi tutti sono costretti à riconoscere che non si è andati oltre là forma della “propaganda armata”, senza che avvenisse un reale salto o innovamento alla e della guerriglia sociale e metropolitana. Ma nessuno sembra veramente chiedersi su cosa vertesse tale “propaganda”. Era là propaganda di tesi politiche precostituite, reduci dagli schemi ideologici del movimento operaio passato, incapaci di entrare nel vivo del magma sociale e delle tensioni controsocietarie che, al contrario, si volevano ridurre dentro sistemi politici e dunque amministrativi.
Noi non neghiamo affatto là natura sociale della ribellione che ha portato ad impugnare le armi, affermiamo però che là forma è stata rappresentativa, perciò inadeguata, in taluni casi riduttiva, in talaltri mitologica. Non ha quindi per noi alcun senso logico parlare di guerriglia – che ci pare una sorta di oscuro oggetto del desiderio – né tantomeno dei motivi del suo scollamento o della sua “perdita progressiva di internità strategica al proletariato metropolitano”. Ci sembra infatti che debbano essere rifocalizzate, rivisualizzate, ripercorse le pulsioni che hanno determinato e determinano condotte dure e violente all’interno del proletariato assoluto, immiserito qualitativamente dallo strapotere di un’organizzazione statuale sempre più dispotica, che modella su di sé intere relazioni sociali. Là guerra non è certo tra due o più classi, ma va determinandosi come nuova forma di “guerra coloniale” dà parte dello Stato e dei suoi centri di potere-comando contro tutti gli individui, sempre più sminuzzati, parcellizzati, resi soli ed impotenti di fronte ad uno Stato-Padrone, ad una Società-Maestra. L’operazione concettuale che porta à costituire in classe rivoluzionaria il proletariato metropolitano è perciò quanto mai erronea, e allude à successive forme di rappresentazione e quindi di delega della classe artificialmente ricomposta. Oggi abbiamo sotto il naso l’uso social-amministrativo della politica, là tendenza alla riduzione dei conflitti a guerre tra bande-racket, perciò dobbiamo assolutamente evitare simili trabocchetti della storia e della ragione. Il proletariato urbano é scomposto, né alcuna operazione ideologica può ricomporlo categorialmente, ma, per paradosso, questa è proprio là sua forza, là nostra forza. Infatti nasce proprio dallo scompaginamento dei ruoli e dalla proletarizzazione dell’uomo in quanto tale là possibilità della sovversione moderna-contemporanea. Che non si fonda su interesse particolari quali sono quelli di classe, ma su esigenze assolute, che alludono prepotentemente ad un nuovo assetto di rapporti tra uomini. È la specie femino-umana ad essere in gioco e, seppure incoerentemente e disordinatamente, é appunto di questo che testimoniano le condotte dei singoli proletari urbani o di gruppi di essi. Non si può teorizzare un polimorfismo cercando poi di intubarlo nel canovaccio predeterminato. Il polimorfismo è reale e sta aprendo un ventaglio di lotte tra loro apparentemente incongrue; il filo che lega non è il filo rosso del progetto rivoluzionario né quello logico dell’astuzia della ragione; più semplicemente è espressione di intolleranza verso l’ordine delle cose costituitosi in comunità materiale. Perciò è assai ideologico vedere in questo movimento, più che mai magmatico un’affermazione della forma-guerriglia. Le bande che attraversano le metropoli sono più frutto della miseria sociale che non prodotto della sua critica. Non di meno sono importanti perché evidenziano là ripulsa ad essere soggetti dell’universo macchinico, l’impossibilità per molti di essere “normali”, laddove là norma sta diventando addirittura codice genetico.
Cogliere là polifonia significa assumersi fin d’ora intelligenza e capacità atte ad amplificarla “eccessivamente”, significa insomma usare come unico parametro là soggettività-altra, che dà più parti si esprime e che cuoce nel fuoco lento delle storie individuali e della storia complessiva. I compagni di Palmi dell’intervista e di “Non è che l’inizio” sembrano precipitare in queste contraddizioni senza uscirne. I vecchi miti vengono sostituiti con nuovi feticci: questo è il timore che nutriamo, e motivatamente. Là critica delle OCC si é avvitata in un’immagine del proletariato metropolitano ancor tutta ideologizzata; dall’operaio-massa, all’operaio-sociale, al proletariato-generico metropolitano, pare esserci continuità e contiguità cosicché le forme di espressione organizzativa hanno solo bisogno di rimodellazione e non di critiche essenziali! E falso che l’iniziativa rivoluzionaria sia in qualche “altrove” rispetto ai rivoluzionari; invece è vero che le strategie sono insufficienti a spiegare un’iniziativa che solo astrattamente è rivoluzionaria, mentre concretamente é ribelle non solo nei confronti dell’esserci societario ma anche delle ipotesi strette di “organizzazione rivoluzionaria”. Là transizione di cui si parla o è un’invenzione o é già avvenuta: é un’invenzione se ci si riferisce ad un passaggio guerrigliero da forme di dominazione a quelle di concreta libertà; è già avvenuta se ci si riferisce al “socialismo” determinato dal capitale stesso con l’accentramento autocratico di alcuni livelli decisionali e, nel contempo, con il decentramento di altri che possiamo definire partecipativi. Se é la fine di forme politiche è anche la fine della figura del militante. Solo per negativo oggi si può intravedere la capacità soggettiva di ribaltare le condizioni date; se di classe universale ormai dobbiamo parlare, i suoi compiti sono immensi, oltre la politica, l’economia , la cultura, la militanza, la guerriglia stessa, tutte forme di un passato recente ma pur tuttavia passato.
Non vogliamo certo sostenere il tramonto della violenza soggettiva come “levatrice della storia” come arma essenziale dell’antagonismo controsocietario, al contrario. La società, come imposizione di regole, richiede forza in chi le applica e forza di segno contrario in coloro che le vogliono negare, abolire. Non esistono passaggi storici in cui sia assente la forzatura, sotto forma di violenza. Tanto più ciò é vero oggi, mentre si determina una violenza sociale di proporzioni sconosciute nel passato. Ogni attimo di vita vissuta dagli uomini o é giocoforza violento o viceversa soggiace alla violenza altrui. Il dominio reale del capitale si afferma come violenza “ragionevole” sull’esistenza di tutti; la
sua fine non può apparire se non come contro-violenza, esercizio di una soggettività in rivolta che dovrà assumere forme e caratteri idonei alle necessità stesse.
Ma la violenza é un’arma a doppio taglio, come tutto nell’insieme sistemico capitalista. Vi é una violenza che è diretta germinazione dei rapporti sociali e che, pur con tutte le sue convulsioni, non sa scrollarseli di dosso; e vi è una violenza tendenzialmente liberatrice, come affermazione di una comunità in divenire. Tutte le chiacchiere attuali intorno alla lottarmata eludono il problema. Nessuno sembra voler riconsiderare criticamente la freddezza politica della violenza esercitata; nessuno, del pari, si fa carico del bagaglio di passionalità soggettiva in essa incorporata. La lottarmata ha avuto, per l’appunto, questo carattere duplice: essere stata violenza fredda e politica, e perciò quasi istituzionalizzabile e dunque “naturale” per la società-Stato, ancorché per esorcizzare la reale violenza sotterranea; si è snodata anche come storia di soggetti tutt’altro che freddi, ma caldi invece di un’umanità a stento compressa. Così non si é mai addivenuti ad una fase di guerriglia effettiva e la politica, comunque amministrata, ha potuto incapsulare e negare le tensioni più radicalmente stravolgenti. Nel contempo si é creata una ben singolare “avanguardia”, la quale non ha più riferimenti storici o sociologici nei ceti esistenti. Parla per se stessa, solo per se stessa, ma, contemporaneamente, avendo nella testa e nel cuore l’umanità generalmente intesa. Questi sono gli embrioni aggregativi del proletariato moderno ed assoluto, altro che ricostituzione “in classe”, altro che forma-partito o forma-guerriglia! La guerriglia va completamente re-identificata; il primato delle armi è illusorio, mentre si afferma il primato della alterità, dell’insofferenza, della trasgressività. Le sue armi sono molteplici, non escluse quelle tradizionalmente intese. Ma è ben strano davvero che, mentre la “gente” ha stravolto la musica, ha imparato l’arte di cavar profitto dalle contraddizioni, si’è addestrata in truffe colossali o in saccheggi a forza di lance termiche, le forme politiche pseudo-rivoluzionarie siano rimaste immutate ed
anzi abbiano trasferito su di sé le modificazioni avvenute nel ceto politico statuale! Se vogliamo correttamente parlare di nuove forme espressive di un proletariato urbano, metropolitano ed assoluto, dobbiamo giocoforza fare i conti con queste modificazioni intervenute.
Che diremo noi, infatti, delle torme di tossicomani o tossicofili, delle bande di skinners, di punks e affini? È sin troppo facile liquidare come miserabili e indotte tutte queste tendenze e esigenze. D’altronde, nel black-out metropolitano, la gente si arricchiva quasi soltanto di merci povere: televisori, macchinette ed altri oggetti umanamente disutili se non dannosi. Era niente più e niente meno che la manifestazione selvaggia di bisogni indotti. Ma in questa sfera dell‘eccesso” noi non leggiamo soltanto miseria, ma anche voglia scomposta di passarvi oltre; noi non riconosciamo una nuova classe, un nuovo soggetto storicamente e sociologicamente inteso, ma una tensione verso la ricomposizione dei soggetti frantumati in comunità indipendenti e tendenzialmente libere; noi non avvertiamo ancora il segno del positivo (come può essere ipotizzato nella forma-guerriglia) ma soprattutto l’emersione brutale del negativo: stiamo alfine giungendo a chi per affermarsi deve totalmente negarsi; il potere dispotico dello Stato crea dunque quegli “eccessi” che ne vietano la lunga riproduzione e quindi la vitalità.
I compagni di Palmi hanno senza dubbio compiuto degli sforzi, ma ancora molti sono necessari per sapersi davvero orientare nel disorientamento quotidiano, per buttare a mare le formulette antiche e riscoprire nella vita carne del vissuto le potenzialità inventive di cui oggi abbiamo bisogno. I “percorsi originali” devono essere originali davvero e non possono venir costretti in una “guerriglia sociale per la transizione al consumismo”, mentre si sta totalmente riformulando il concetto di guerriglia e ridiscutendo visceralmente l’ipotesi concreta di comunismo. La fine delle OCC è anche la fine di taluni “scenari”.
L’impetuosa irruzione del desiderio assoluto, nelle esistenze assolutamente soggiogate al capitale, richiede un grosso salto di qualità. Non è più soltanto questione di lasciar “liberi” i singoli militanti nell’esprimere le loro dissonanze; è questione invece di cogliere il ritmo sotteso a tali dissonanze, allargandone la portata e le scansioni.
A questo proposito, ben più interessante ci pare la posizione espressa dall’intervento “Ad occhi aperti”. Benché si ipotizzi una dominazione troppo assoluta del capitale, mentre si vagheggia un sociale originariamente “buono” e quasi “naif”, tuttavia si giunge ad una positiva liquidazione della sfera politica in quanto sistema di appiattimento delle tensioni controsocietarie agite da disparati settori sociali. Finalmente l”‘avanguardia” non è più ritenuta traguardo superiore che, una volta “conquistato”, permane come dato caratteriale dell’individuo. Si riconosce invece che essa si può definire solo di volta in volta, di situazione in situazione, di luogo in luogo. Si tratta di una riflessione profonda che tende a rompere con il percorso precedente, soprattutto laddove questo allisciava tutto in schemi, in codici predeterminati, la cui obsolescenza è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo difficoltà a recepire immediatamente la mancanza di salto al quotidiano sovversivo; non di meno il ribaltamento del problema – da una presunta “costituzione in classe del soggetto della transizione” al suo opposto – è forse un segno tangibile di rifondazione di tematiche incentrate sul senso della specie, su una rivoluzione “umana, troppo umana” (parafrasando), sulla distruzione di tutte le classi e di tutti i ceti. Può essere nuova attenzione rivolta ai movimenti, ancora deboli, che si indirizzano verso una comunicazione non alienata, verso rapporti intersoggettivi nuovi, verso una “personalità” che non sia mera maschera dell’uomo ma concreta specificità femino-umana. A ciò noi siamo interessati e non ci importa molto dei ritardi teorici altrui, come non ci interessano troppo le ancor pesanti nostre manchevolezze soggettive. È una grande scommessa quella intrapresa ed é anche un rimettere sui piedi valori umani ora capovolti sulla testa. Ci importa invece il vettore propulsivo che talvolta emerge e che, si può condensare in una banale formula: energia trasgressiva rivolta ad un “work in progress”, metamorfosi in divenire, comunità in tensione ad essere. Questo, ripetiamo, importa e non solo perché il nostro cuore è balzato oltre le false opinioni del presente ma, soprattutto, perché é un processo dentro cui ci si sta oppure no, che si afferma e realizza agendo la “catastrofe” del capitale oppure si determinerà come squallida e quotidiana catastrofe delle donne-uomini. Quindi ciò che apprezziamo in alcuni sforzi è questo “salto” che può permettere l’interazione tra reali comunità di senso, tra prigionieri sociali incarcerati e figure sociali in ribellione.
Perciò ci lasciano freddi e ironici i tentativi di ridefinizione di obsoleti concetti da parte dei membri della cosiddetta colonna Walter Alasia (nonostante il riutilizzo, da altri mutuato, del sarcasmo riguardo ai testi Mogol-Battisti), nonché i generosi ma inutili sforzi della “coppia” (Forastieri-Segio) che, nonostante tutto, non soltanto non si liberano dalle panie del combattentismo e dell’avanguardismo ma che, viceversa, si riducono ad un ammodernamento di concetti inadeguati e perdenti – non a causa soltanto dei “pentiti” ma proprio della loro stessa inattitudine ed impraticabilità presso settori tendenzialmente sovversivi e già comunque refrattari all’esistente.
Nel testo “Culo di sacco” gli autori liquidano soltanto la concezione leninista del partito che, diciamo la verità, è stata già liquidata dalla storia, mentre mantengono un atteggiamento stranamento asettico ed esterno all’insieme delle questioni quasi che il groviglio di idee, di reazioni, di necessità che si é prodotto nel recente periodo li riguardasse da lontano, insomma quasi che gli “insuccessi” fossero colpa della pochezza dei singoli militanti o addirittura di una testardaggine dispettosa della storia stessa. Naturalmente non é così; non é possibile modernizzare la funzione-avanguardia o la forma-partito; esse sono state nei fatti incapaci di determinare un’aggregazione sovversiva che sapesse essere radicale e dunque oggi, se vogliamo essere onesti e soprattutto radicali, se vogliamo essere onesti e soprattutto contemporanei a noi stessi, si deve discutere di questioni ben più profonde, di sperimentazione di nuove forze aggregative che volta a volta dovranno determinare le loro proprie forme. Noi, al pari di tutti, non abbiamo ricette da proporre proprio perché, nella complessità sociale presente, solo un’audace sperimentazione può “pagare”; ci facciamo pero’ carico della critica negativa, di liquidare tutte le concezioni ritardatarie, discroniche o comunque inidonee; non sembri piccolo questo compito poiché le miserie del movimento rivoluzionario non sono state prodotte solo dalla forza autoriproduttiva del capitale, ma anche dai vuoti di teoria e di prassi coerente che illusoriamente si é cercato di riempire con un attivismo più o meno “professionalizzato” e “militante”, con un attaccamento patetico a presunte verità antiche del movimento operaio, probabilmente false già allora, sicuramente inutili e dannose oggi.
Da più parti si sostiene, in termini diversi, che non si deve buttare via insieme alla classifica acqua sporca il tradizionale bambino. Noi dubitiamo fortemente che tale “bambino” sia mai esistito, almeno nei termini a cui ci riferiamo; questo “bambino”, se va inteso come pratica-esperienza di liberazione, é ancora tutto da generare, senza tuttavia perdite di quella memoria di cui i fatti ci hanno disordinatamente fornito. Noi non siamo certo per l’elogio dell’assenza di memoria, che in realtà é solo sua esorcistica rimozione, ma pretendiamo esercitare il dovere di critica anche sulla memoria stessa e sui fatti che essa evoca. Così, se passionalmente siamo sempre dalla parte di Spartaco, degli indiani d’America, dei comunardi, della banda Bonnot, dei rivoluzionari tedeschi insorti intorno al ’20, degli IWW americani, insomma di tutti coloro che nel loro tempo si sono battuti coraggiosamente per la liberazione propria e generale, nondimeno non possiamo esimerci dalla critica radicale di tutto il passato rispetto ai compiti che oggi noi stessi – e non certo una malintesa Storia – ci imponiamo. La memoria é forza, se si accoppia alla capacità reale di essere autenticamente contemporanei al proprio tempo, addirittura alla volontà di praticare embrionalmente il futuro. Quindi, per concludere, nessun “liquidazionismo” da parte nostra, ma la serena consapevolezza che la più parte dei moduli pregressi, organizzativi o anche analitici, oggi ci serve a ben poco e che soprattutto la sua riproduzione é di danno allo sviluppo delle nuove potenzialità rivoluzionarie; liquidare la forma-partito, comunque intesa, non significa certo rinunciare a forme aggregative oggi concretamente possibili, così come rifiutare il concetto di “presa del potere” non significa certo l’accettazione dell’insieme dei poteri attuali ma, al contrario, vuol essere sforzo verso la loro individuazione concreta e capacità effettiva di abbatterli. Che il capitale si sia inserito dentro ciascuno di noi é dato d’analisi imprescindibile, perciò il bisogno di liberazione deve sapersi confrontare con questi materiali ostacoli, riuscendo infine a rendere possibile una liquidazione del “gregariato”, dei ruoli, di tutte quelle forme insomma con cui il singolo soggetto riproduce valori di capitale e nessi di società.
Ci siamo obbligati, seppur un po’ controvoglia, a questa lunga carrellata critica sulle posizioni espresse recentemente da diverse parti (e tutto quello che non abbiamo trattato, fatta salva una possibile non conoscenza, é perché non era neppure interessante per l’analisi o perché comunque poteva rientrare nella critica di altre posizioni manifestate) per un dovere di correttezza di raffronto, ed anche perché, secondo metodo saggio, pensiamo che attraverso la disamina critica dell’affermato da altri sia emersa la filigrana di quanto noi stessi pensiamo ed affermiamo.
Ma almeno su un punto ci é d’obbligo diffonderici ancora, per evitare malintesi o confusioni: ed é quello che definiamo come la “soluzione sociale” del problema dei prigionieri politici e, più in generale, della prigionia sociale.
Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco; la soluzione che cerchiamo e vogliamo non é, sotto mentite spoglie, lo stesso della futura possibile o meno Grande Rivoluzione. È evidente da quanto detto che noi tendiamo effettivamente ad una rivoluzione che rovesci la storia e le relazioni umane presenti come un guanto; va da sé, pero’, che sarebbe quanto meno sciocco ed illusorio aspettare quel lontano momento per affrontare concretamente problemi già oggi in campo, primo tra tutti questo della prigionia.
Abbiamo già detto che la liberazione é per noi un percorso, un processo che va tentato e praticato da subito. Aggiungiamo che non può trattarsi di un percorso lineare, ma di una serie di salti, di rotture, anche di forzature: di più che la possibile realizzazione futura di legami liberi di comunità passa necessariamente attraverso la forza di sperimentazione attuale, l’intelligenza di sapersi situare “fuori e contro” i valori dominanti, addirittura oltre ad essi; nessun utopismo però, nessuna idea di falansterio (tanto meno nelle miserabili versioni moderne di volontari ghetti che mai depassano la ragione codificata e l’accettazione supina dell’esistente) e quindi nessuna “isola felice”: se di isola si tratta, cerchiamo l’isola non trovata, anzi pretendiamo di inventarla! Quello che si intende per sperimentazione concreta di libertà e di comunità é tutto dentro la dinamica dell’opposizione ostinata all’esistente societario. La libertà, infatti, può essere sperimentata solo attraverso le forme di negazione materiale dell’illibertà sociale o comunque introiettata individualmente; la comunità reale può essere pre-vissuta come comunità di intenti, di tensioni, di agire. Ciò non é permesso. Per questo la trasgressione assume valenza positiva, seppur degna di smitizzazione e soprattutto di non fissazione. La trasgressione in sé non porta valori comunque umani, ma ne nega altri codificati; se essa, però, si trasforma in riaffermazione differente di ciò che prima ha rifiutato non é altro che forma recuperata, produttiva di comportamento sociale controllabile. La trasgressione cui noi ci riferiamo é quella che contiene tanto la negazione del presente quanto l’allusione al futuro. Non ci interessano certo i ladri che si fanno banchieri né i banchieri che diventano ladri! La trasgressività é quanto, pur prodotto dalla società, tende ad affermare caratteri diversi, antagonici, di comunità. Quando si contrappone il concetto di “comunità reale” a quello di società – come che si sia storicamente manifestata – non é certo per riprodurre una sorta di guerra di tutti contro tutti, l’“homo homini lupus” di lontana memoria, né tanto meno per ricordare nostalgicamente le società-comunità primitive (poiché allora effettivamente i due termini si confondevano tra di loro). L’appartenenza reciproca, il riconoscimento delle differenze e la loro corretta valutazione, il superamento di appiattimenti “egualitarizzanti”, la riscoperta dell’originalità singola e collettiva contro il processo di identificazione: ecco i caratteri dell’essere-vivere comunità, ecco quanto é stato sottomesso e soggiogato dalla forma-società. Perché, siamo chiari, la “società umana”, se può apparire concetto fascinoso, é d’altronde storicamente e concettualmente falso. Società é patto, regolamentazione, insieme di diritti-doveri, accettazione sì delle possibili diversità ma, nel contempo, loro codificazione, sicché solo alienando parte di sé e del proprio interesse l’uomo può addivenire alla convenzione societaria.
L’anticipazione dei caratteri di comunità non è utopistica seppur, letteralmente, appare utopica, nel senso che oggi non esiste in alcun luogo. Ma anche questo é solo parzialmente vero; non esiste in nessun luogo in modo codificato o istituzionalizzato, proprio perché la sua natura é ribelle al codice e alle istituzioni; é esistita invece sul filo del tempo, nei tentativi rivoluzionari della storia, ed esiste, ancorché sommersa, nelle esperienze di ri-aggregazione liberatoria che contengono grossi elementi di disgregazione del già-costituito, del già formalizzato.
L’anticipazione di cui parliamo è di natura duplice: da un lato si evidenzia come “eccesso”, come negazione di ciò che esiste e disaffezione originale ad esso; dall’altro si esprime come innovazione della qualità dei rapporti tra i soggetti implicati in questa forma di ostilità all’esistente. Le relazioni umane che si determinano nella terra di nessuno sottratta al controllo possono divenire effettiva anticipazione dei caratteri sopra detti. Attenzione però, questo é possibile solo quando la trasgressione, l’affermazione di sé nuova e la capacità di comunicare il vissuto si intrecciano strettamente tra loro. Noi conosciamo e viviamo molti episodi, molte relazioni autenticamente complesse ed originali, vive, ma d’altronde abbiamo sotto gli occhi il tracollo che si é determinato quando questa innovazione veniva postulata ma non vissuta, quando le formalità – e quelle politiche in primo luogo – si sostituivano alle ricchezze di sostanza (il fenomeno‘ ‘pentiti” va letto soprattutto in questa chiave e, per dirla tutta, non possiamo solo limitarci nei loro confronti all’odio e al disprezzo, peraltro tanto umanamente inevitabili quanto logicamente necessari, ma dobbiamo sottoporre a critica radicale le strettoie formali in cui ci si è impegolati, e che (...) estranei quando il vento delle cose li ha spinti su spiagge solitarie, dove ciascuno é quel che è, e lo spettacolo è monopolizzato dall’insieme dei poteri-istituzioni).
L’anticipazione di cui parliamo é presto definita: è la pratica di agire libertà dentro le chiusure imposte. Ciò avviene in modi volta a volta singolari dentro i territori del capitale – e tutti lo sono – e soprattutto quel potente veicolo di controllo sociale, ma nel contempo di sua possibile negazione, che è la metropoli, la città che invade con i suoi nessi ed i suoi rapporti tutti gli spazi circostanti.
Ben poco infatti rimane fuori dalla metropolitanizzazione ed anche quel poco si confronta sempre con gli Stati-metropoli, con le città-metropoli, con le condizioni-metropoli: é un universo tendenzialmente metropolitano, intersecato da segmenti diversi ma segnati tutti dalla corsa all’urbanesimo, quello con cui dobbiamo fare i conti: é questa l’intima essenza del rapporto-società, questo il pianeta del capitale, creato – come il mondo da dio – a sua immagine e somiglianza.
La soluzione sociale che vogliamo proporre è tutta dentro questa pratica dell’anticipazione, questo prodursi di tensioni tra vari segmenti sociali e, soprattutto, riguardo la vettorialità rivoluzionaria che in molte lotte, ancorché limitate o scomposte, é visibile da lettori attenti. Non ce n’é, la “seconda società”, la “società-altra”, che molti hanno delineato in questi anni – vuoi per esorcizzarla, vuoi per recuperarla, vuoi per esaltarla – é un indiscutibile dato di fatto . Vi é un nuovo modo di vivere velocificato e radicalizzato dalla formazione stessa riproduttiva di capitale, che rimane un dato emergente e forte. E questa “seconda società” che ha prodotto i soggetti attualmente incarcerati (e non solo i politici) ed è per l’appunto questa che va attivata per la liberazione degli stessi, cioé, per parlar chiaro, di noi. I passaggi sono difficili da ipotizzare e sarebbe comunque sciocco non calcolare la possibile formalizzazione statuale di eventuali e nuovi rapporti sociali.Non é per spocchia che siamo contrari a soluzioni del tipo amnistia o sanatoria. Ci dispiace molto di dover togliere le paranoie, anch’esse consolatorie e autovalorizzatrici, ad Oreste Scalzone e al suo “Cahier de doléances” poiché le sue doglianze sono non vere e quanto meno non appropriate. Nessuno di noi respinge per principio l’ipotesi di amnistia o di sanatoria né, crediamo, qualcuno si rifiuterebbe di uscir fuori dal carcere in seguito ad una scarcerazione. Ancora una volta Scalzone prende lucciole per lanterne, tipico fenomeno degli esiliati volontari o involontari, giacché crede che vi sia una forma di “irriducibilismo” sciocco che ben pochi hanno, poiché ritiene che qualcuno si rifiuterebbe di tollerare mediazioni realistiche o addirittura fuoriuscite dal carcere. Così, fingendosi uno scenario del tutto fantasioso, lo Scalzone onestamente può proporre la cosiddetta “soluzione politica” persino come forzante, come “sogno”. In realtà le soluzioni politiche appartengono a chi nella politica può. Non a noi. Crediamo infatti che le soluzioni politiche contengano dentro di loro un segno triplice, e triplicemente interpretabile: possono avvenire dopo una palese vittoria di una delle due-o più parti interessate al contenzioso, cioè come magnanimità dei vincitori del conflitto; (“Parcere victis, debellare superbos”, cioè risparmiare i vinti, gli assoggettati e infatti talora si trova “subiectis” al posto di “victis” e colpire gli ostinati é vecchia massima latina, é oggi il principio stesso del trattamento differenziato, della legge pro “pentiti”, della benevolenza statuale verso chi ad essa non si dimostra incompatibile); oppure come trattativa specifica tra parti separate, nella fattispecie tra due ceti politici che si riconoscono e si definiscono reciprocamente, riversando il loro comune livore su di un terzo-assente-presente, cioè verso coloro che non aderiscono a questi schemi o da essi fuoriescono; infine come mutato rapporto complessivo dentro la società tutta, come espressione di debolezza delle forze di governo ed amministrazione, come loro tentativo di placare una possibile ed eventuale tempesta.
Se guardiamo con lucidità e disincanto le amnistie promosse dallo stato repubblicano d’Italia, possiamo facilmente scorgere questa trivalenza. L’amnistia verso i fascisti, come già detto, fu forma di “clemenza” e, soprattutto, di recupero nei confronti del pregresso, del vinto, forma di autentificazione dello Stato stesso; molte amnistie “comuni” sono state il frutto di una impossibilità statuale di gestire le sue stesse contraddizioni, un tacito patto, sempre sul bilico della rottura, con i ceti delinquenziali a cui, di fatto, veniva riconosciuta validità riproduttiva; l’amnistia per i cosiddetti reati politici e sociali avvenuta nel ‘69 fu la palese dimostrazione della volontà dello Stato-regime di tollerare, se non di cooptare, i comportamenti trasgressivi, volontà non certo “naturale” quanto obbligata dalla pressione sociale allora difficilmente governabile. In questo quadro storico-metodologico noi dobbiamo situarci ora. Ma non solo con gli occhi rivolti ad una possibile vertenza complessiva con lo Stato. Mille vertenze, se così vogliamo definirle, si possono aprire in ogni sede processuale, in ogni condizione carceraria. La questione è relativamente semplice, se non si vuole vendere o svendere checchessia. E’ un problema di ripresa di forza sociale, é divaricamento delle contraddizioni esistenti, é infine forma di anticipazione dei modi e dei tempi della “società-altra”, cioè di quella parte di individui che, seppur “sociali”, rivendicano una propria tensione radicalmente controsocietaria. Significa, per noi, radicare le battaglie di libertà su un terreno concreto, significa quindi legare la critica del carcere alla critica dello Stato, ed entrambe alla lotta contro la società che li genera. Si manifesteranno, se sapremo procedere con il giusto passo, dei legami di senso tra coloro che sono inchiodati ad un carcere territoriale diffuso e coloro (noi) che sono materialmente imprigionati.
Chi oggi, ed é la stragrande maggioranza dei proletarizzati – funzionariato parassitario escluso -, viene spossessato con tasse ed altre vessazioni di una parte sempre più consistente del proprio reddito non si trova, nei fatti, in condizioni assai diverse, verso l’autorità dello Stato, da chi ne è completamente vittima, cioè i prigionieri. Ciò che lega noi agli altri proletarizzati è proprio la forma oppressiva dello Stato. A ciò, con segno opposto, dobbiamo riferirci e su ciò dobbiamo fare leva. La liberazione dei prigionieri non può essere vissuta solo come problema degli stessi, ma é una linea di discrimine e dunque di lotta e di libertà per tutti coloro che oggi non solo si sentono estranei alle forme delle istituzioni, ma che addirittura rivendicano la propria inimicizia rispetto ai poteri di esse.
Nel concreto noi proponiamo che ogni “processo politico” sia un terreno di confronto tra soggetti viventi nella metropoli e, nel contempo, di leva sulle contraddizioni del ceto amministrativo-politico.
Noi chiediamo ampie battaglie oltre-politiche, e cioè sul terreno effettivo della lotta allo Stato, a tutti i compagni che in qualche misura si rapportano al carcere e ai prigionieri. Più specificatamente chiediamo che vengano condensati i problemi che, a loro volta, possono irradiarsi sul tessuto sociale. Non è una battaglia di principio che desideriamo, né tanto meno un’agitazione per la semplice scarcerazione delle “avanguardie” comuniste. È ben di più. E’ coinvolgersi e coinvolgere ampi settori di antagonisti sul terreno dell’impossibilità di tollerare la forma-carcere come forma inevitabile e necessaria. E’ la richiesta di coerenza sufficiente per esplicitare temi che ciascuno dentro di sé sente come vivi e che di fatto collegano realmente i prigionieri ai “liberi”, e viceversa. Sono, in sintesi, la questione della sessualità dispiegabile che, negata materialmente ai prigionieri, é in realtà compressa in tutti, ridotta a mere funzioni riproduttive, a ruoli sociali e spettacolari; é la questione della salute degli uomini che viene attaccata pesantemente, non solo dal carcere materiale, ma da un’intera società volontariamente nociva e demenzialmente cancerogena; é la questione della pace che, sicuramente, agitata in astratto non può esistere, ma che oggi si sviluppa solo come accettazione della guerra interna imposta e come equilibrio tra forze imperiali nemiche; la pace che vuole il prigioniero, e più in generale l’uomo, non è assimilabile al concetto di accettazione della guerra ma, al contrario, vuole essere suo ribaltamento: la distruzione del ceto autoriproduttivo e guerrafondaio è l’impostazione di una pace non ideologica, ma realmente e concretamente vissuta da tutti, insieme; la questione della libertà come possibilità di movimento dentro gli spazi e, sconvolgendone i ritmi, sopra il tempo: il prigioniero è massimamente espropriato di tempo e completamente ridotto in spazi angusti che negano sin dall’inizio la possibilità di percorrere sentieri che non siano predeterminati, ma questa è davvero la condizione dell’uomo contemporaneo, l’abbrutimento della specie femino-umana di cui i prigionieri sono solo l’esemplificazione macroscopica; infatti che tempo ha l’uomo “comune” costretto a ritmi di “lavoro inutile” e di “tempo libero” altrettanto dissennato, meramente riproduttivi di una glaciazione storica, che spazio ha la “gente” costretta a percorsi sempre uguali, a territori compressi, ed espropriati di ogni valenza innovativa, che spazio tempo è concesso a chiunque dentro la sfera fissa della temporalità orològiaia e della spazialità urbanistica?
Su tutti questi temi vogliamo lucidamente produrre un collegamento tra noi medesimi e tutti coloro che oggi apparentemente ci sono separati, da mura e da cancelli. La soluzione sociale é si rifiuto della politica, ma non é assurdo rifiuto delle formalizzazioni politiche che altri – lo Stato – può dare. È soltanto inversione di tendenza, ribaltamento del piano relazionale, imposizione di trasgressività concretamente prescelta.
Allora nei singoli processi è possibile dimostrare la miseria dell’accusa, forzare il quadro concettuale e interpretativo che ha fondato gli stessi capi di imputazione, ottenere concrete, seppur parziali, “vittorie” su casi singoli e particolari senza però scollarli e differenziarli dal resto. Allora é possibile che la “vertenza” sulla liberazione non sia più tra differenti ceti politici, ma divenga asse portante di una battaglia ben più ampia, in cui l’assunzione di ogni caso specifico sia forma dell’insofferenza all’assetto socio-istituzionale. Allora possiamo seriamente pensare a “debolezze” statuali che consentano margini di liberazione, essendo ben chiaro comunque che sul terreno della libertà solo altri potranno mercanteggiare, in tentativo di recupero, e non certo chi questa libertà vorrà imporla e praticarla.
Abbiamo delineato delle grandi questioni (sessualità, salute, libertà stessa, etc.) ed é su questo piano che la soluzione sociale può attuarsi, pur nella sua momentanea parzialità.
Non chiediamo forme di autodeterminazione, non perché essa sia esclusa dai nostri desideri, ma soltanto perché, slegata da una corsa alla libertà reale, diventa miserabile cogestione.
Pretendiamo di conseguenza interventi significativi in merito da parte di tutti coloro che ritengono – a ragion veduta – di avere qualcosa da dire. Sui processi, certo, ma soprattutto sull’imprigionamento di cui tutti siamo vittime, talora purtroppo consenzienti.
Questa é la nostra prima presa di parola; faremo seguire “lavori” che pensiamo immensi e magnifici. Vedremo. E certo comunque che nessuno ci toglierà il gusto per una vita “esagerata”!
Nota
Una nota va infine aggiunta, non per pignoleria ma per sottolineare e rendere esplicito a tutti i possibili lettori quanto é stato già immediatamente vissuto dagli estensori del presente scritto. Una nota unica e doppia. L’unicità è data dal senso complessivo, la duplicità delle due questioni che vanno chiarite: scelta dell’occasione per presentare pubblicamente queste riflessioni a voce alta, e scelta della firma, cioè delle firme, insomma del modo di presentarci. L’occasione è, se ci si concede il pleonasma, occasionale – ma nel contempo liberamente prescelta: il processo milanese a “Rosso” e a tutta la cosiddetta “area dell’Autonomia”. Da tempo, invero, i discorsi tra di noi si espandevano e si raggrumavano in concetti, in piccole convinzioni vissute e viventi, in rapporti amicali e, forse, già di comunità, in parole scritte seppur scompostamente e disordinatamente. Il processo milanese all’area dell’Autonomia ed a vari spezzoni organizzati ci ha semplicemente fatto accelerare i tempi. Perché? Perché si inserisce in una prossima e lunga stagione di processi penali non riguardanti solo organizzazioni particolari e determinate, ma aventi anzitutto la pretesa di ricostruire fasi complesse di storia sotto la fattispecie giudiziaria. Allora ci è parso assai stimolante, ed anzi necessario, intervenirvi con tutta la nostra alterità, il nostro disincanto, la convinzione di essere, noi, sempre da un’altra parte rispetto a quella in cui ci cercano, ci descrivono, ci vogliono catalogare. E, lo si riconosca, è davvero singolare ma significativa la pretesa di partecipare, a nostro modo, ad un processo che vede imputato direttamente solo qualcuno di noi! Insomma, é la riaffermazione del nostro diritto – vero perché assunto unilateralmente e del tutto soggettivamente – di parlare dovunque ci piaccia, non accettando più, se mai le abbiamo accettate, le regole comportamentali dell’agire politico” che, in fondo, è pur sempre agire amministrativo. Ci interessa, al contrario, dislocarci solo sui terreni da noi stessi volta a volta prescelti. Parlare “a sproposito”, dunque, e sempre a proposito perché infine è comunque di noi stessi e su noi stessi che ragioniamo. Solo così ci possiamo correttamente rapportare ad altri, senza più sovradeterminazioni ma, sia chiaro, anche senza “umiltà” sottodeterminate.
La firma poi, anzi le firme. Questo è un periodo in cui tutti stanno firmando nominativamente, sancendo così anche formalmente la fine delle certezze organizzative. È un nuovo costume a dire il vero non meno fastidioso di quello precedente, secondo il quale invece si procedeva per sigle ed etichette. Perciò, per sfuggire questo attuale gioco delle parti che sembra trovare consenzienti svariati attori, avevamo pensato di andare ancora una volta controcorrente, e dunque di trovarci una firma collettiva. Tra un bicchiere e l’altro, ne avevamo trovate anche di buone. Da un irridente e sorridente “club degli incorreggibili” – incorreggibili nel tentare innovazioni e sperimentare intelligenza, a dispetto di tutto, art. 90 compreso – ad un più enigmatico ma, svelato il mistero, simpaticissimo “gli amici del ‘solitone” (chiamasi “solitone” un’onda che, a differenza delle consorelle, non si infrange né si spezza o interrompe, continuando a riprodursi a lungo, quasi inesauribilmente, pur modificandosi. Il fenomeno fu rilevato per la prima volta da un gentiluomo inglese dell’800 che, cavalcando lungo un canale, si accorse di questa onda curiosa, desueta ed ostinata; oggi, per la miseria utilitaristica della scienza, le leggi del “solitone” sono studiate da molti matematici e fisici e trovano implicazioni nelle onde elettromagnetiche nonché applicazioni nel campo delle fibre ottiche e del laser). Diciamo la verità: queste ed altre possibili “sigle” ci divertivano parecchio, e divertirci per noi è molto!
Tuttavia dopo chiacchiere, ragionamenti ed analisi, e nonostante la voga presente, ci siamo resi conto che nel nostro caso era ancor più bizzarro ma esplicativo firmarci con nome e cognome, individualmente. Per l’estrema varietà dei soggetti. Infatti si va da chi da molto tempo ha espresso forti critiche (da “sinistra”) alle mitologie lottarmatiste, a chi ha vissuto soprattutto le cosiddette “pratiche di movimento”, da chi è stato vitalmente e passionalmente nella lotta armata di questi anni, a chi è più un “comune” che un “politico”. Da chi si è “rivendicato”, a chi si è motivamente “difeso”, senza però alcuna cedevolezza o compromissione. Da chi ha posizione giuridica pesantissima, a chi potrebbe, dovrebbe uscire di galera tra poco. Da chi, infine, è direttamente coinvolto nel “processo-Rosso”, a chi invece non c’entra per nulla! Questa bizzarria è per noi esemplare. Perché è la dimostrazione concreta che il nostro pensare ed agire non è la somma dei percorsi già compiuti da ciascuno, non è solo memoria del passato, ma è invece rottura e superamento di quella continuità che sfocia nel continuismo. E dunque coscienza del presente, ragnatela di vite e di ragioni, segno dell’impossibile da rendere possibile nel più prossimo futuro. Mica poco!
Noi ci “dichiariamo”: alcuni di noi hanno pensato e scritto; altri però co-firmano e condividono; le diversità non vengono azzerate e, invece, le originalità sviluppate; né i disagi reciproci tra certi soggetti possono essere cancellati con un colpo di spugna: è un percorso difficile ma bello quello su cui ci azzardiamo. Su questo terreno vogliamo “parlarci”, con tutti coloro che hanno qualcosa da significare: altri processati, altri prigionieri sparsi, molti “liberi” vicini e lontani. Come diveva Bruce Springsteen in un’intervista: “Sai, promettere a qualcuno che tutto andrà bene, non ti è mai possibile. Dovresti essere un politicante. Tutto quello che puoi fare è dire che esistono delle possibilità, che alcune di esse si concretizzeranno ed altre no, che cercate e lottare sono cose che confermano il valore della vita. Le illusioni ti indeboliscono, i sogni e le possibilità invece ti rendono forte”.
E così sia.
Fossombrone, febbraio-marzo 1983
ANGELO MONACO, BRUNO PEIROLO, CESARE MAINO, CLAUDIO WACCHER, DARIO CORBELLA, ERMANNO COLLEDA, GRAZIANO ESPOSITO, JUAN SOTO PAILLACAR, LUCA FRASSINETI, MASSIMO DOMENICHINI, RICCARDO D’ESTE.