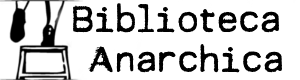Prima edizione: aprile 1986
Seconda edizione: maggio 2015
Anarchismo (rivista)
Anarchismo e progetto insurrezionale
Atti del convegno
Nota introduttiva alla seconda edizione
Nota introduttiva alla prima edizione
Circolare di convocazione del convegno
Relazione introduttiva della Redazione di Milano
La cultura del bordo. Antagonismo e forme di comunicazione differenti
Nota introduttiva alla seconda edizione
Poco meno di trent’anni non sono pochi e la rivista che dette il nome a quel Convegno milanese del 13 ottobre 1985 non esiste più. Esistono invece i compagni presenti quel giorno a Milano, a discutere e a scambiarsi, forse per la prima volta, i fondamenti di un’analisi che ancora oggi rimane incognita o, se non proprio incognita, ricca di aspetti non chiariti e di equivoci più o meno volontari.
I miei nuovi lettori, e ve ne sono di talmente “nuovi” da imbarazzare la mia presunzione di prefattore, sono pregati di notare che la parola “insurrezionalista” si trova, in queste pagine, citata tre volte. Due volte per riferirsi a una presunta scelta teorica malatestiana di alcuni anarchici che al di là della soglia della propria biblioteca non hanno che vani ricordi di antiche scaramucce più o meno goliardiche, e una sola volta per parlare propriamente delle tesi relative al progetto insurrezionale. Non è una questione terminologica, ma al contrario si tratta di un problema importante.
Tutti oggi, in tutto il mondo (non è una iperbole) parlano di “insurrezionalisti” e di “insurrezionalismo”, quasi mai di “progetto insurrezionale”, e questa etichetta è di origine prettamente giornalistica. Alla fine io stesso mi sono dovuto arrendere e ho pubblicato un libro che porta precisamente il titolo: Anarchismo insurrezionalista.
Mi permetto di suggerire la lettura di un passo di Kropotkin (cito a memoria) contenuto nel libro Parole di un ribelle, riguardante il problema dei nichilisti russi dei suoi tempi (seconda metà dell’Ottocento). Costoro erano tutt’altro che contenti dell’etichetta ricevuta, non ne condividevano l’estremismo verbale e non erano d’accordo con il concetto sottaciuto di “nulla”, che non apparteneva alla loro filosofia di vita. Ma non potevano fare niente, la potenza (di già all’epoca) del meccanismo giornalistico era tale che ogni tentativo di critica, o di correzione, era e restò vano. Pensate ai giorni nostri, se decidessimo di rispondere al concetto universalmente accettato di “insurrezionalismo”, per quanto riguarda le nostre posizioni teoriche. Fare una distinzione, per altro necessaria, tra “progetto insurrezionale” e “insurrezionalismo”, con tutto quel che segue, resterebbe lettera morta.
Lasciamo perdere.
Pensiamo che la lettura di questo libretto possa ancora essere utile. Si tratta dei primi passi teorici (e pratici, ma questo è un altro problema). Il discorso che oggi facciamo non è molto diverso.
Gutta cavat lapidem. O, almeno, così ci sembra.
Trieste, 23 aprile 2014
Alfredo M. Bonanno
Nota editoriale
Si è scelta la soluzione di non riportare i nomi dei relatori ma di indicare solo le iniziali. A distanza di tanto tempo pensiamo sia la cosa migliore. Se qualcuno volesse togliersi la curiosità, si procuri la prima edizione del presente libro (Catania 1986).
Il nome dell’estensore della Nota introduttiva alla seconda edizione, lo stesso della Nota introduttiva alla prima edizione è invece lasciato per esteso. Mancano di Alfredo M. Bonanno: “Per un’analisi di un periodo di superamento. Dalle illusioni post-industriali alle illusioni post-rivoluzionarie” che si trova pubblicato in Anarchismo insurrezionalista, seconda ed., Trieste 2009, pp. 42-75, ad esclusione dei paragrafi: “Le chiacchiere della rivoluzione”, “Niente da fare con l’insurrezione”, “La delegittimazione” che si trovano pubblicati in Chi ha paura della rivoluzione, terza edizione, Trieste 2015, pp. 103-112).
Nota introduttiva alla prima edizione
A distanza di alcuni mesi può essere interessante tracciare alcune riflessioni riguardo il Convegno di “Anarchismo”, tenutosi a Milano il 13 ottobre 1985 sul tema “Anarchismo e progetto insurrezionale”, di cui pubblichiamo gli Atti.
Per molti aspetti le relazioni e gli interventi qui pubblicati parlano da soli. Con tutti i loro limiti, di analisi, di forma, di estemporaneità. Ma per molti altri aspetti occorre andare oltre il momento letterale: anche i silenzi hanno il loro spessore.
Per prima cosa, la presenza del movimento. In una città come Milano, dove i fermenti anarchici sono ancora oggi vivi e compositi, nessuna partecipazione si è notata se non quella scontata dei compagni più vicini al modo di pensare della rivista “Anarchismo” o, comunque, più interessati a verificare quel minimo di progetto che i gruppi redazionali vanno elaborando. Le altre componenti del movimento milanese, pur dovendo fare appena pochi passi, erano assenti. Nessun confronto, nessun dibattito, nessuna partecipazione.
Alla base di questa chiusura c’è da cogliere la decisione precisa di non dare spazio a posizioni (le nostre) che vengono riconosciute potenzialmente “pericolose” perché mettono in discussione il diffuso perbenismo del movimento anarchico e perché vogliono spingere alla ribellione e all’azione rivoluzionaria. Chi preferisce continuare a dormire s’inquieta anche del più piccolo bisbiglio (che non di alti strilli qui si tratta) e fa di tutto per non essere disturbato. Anche l’allargamento del dibattito, in fondo, può essere visto come un indiretto avallo, se non altro come una presa di coscienza dell’altra faccia della luna, con tutte le conseguenze del caso. Conseguenze nei confronti di quella fascia di movimento che si vuole continuare a gestire – spesso nel più squallido dei modi – facendo persistere la mancanza d’informazione, la critica da cortile se non la demonizzazione vera e propria.
E poi c’è la vecchia credenza nella nostra “oggettiva” pericolosità, del rischio che il movimento tutto, nel suo insieme, corre dandoci corda, consentendoci di portare alle estreme conseguenze le nostre analisi. Non sono pochi i compagni che ritengono che noi, approfondendo le nostre analisi rivoluzionarie, forniamo elementi alla repressione, sia dal punto di vista dei contenuti dell’analisi stessa (facendo capire cose che altrimenti il repressore non capirebbe mai da solo), sia dal punto di vista dell’alibi che potremmo fornire ad un eventuale intensificarsi della repressione.
Non c’è oggi chi non convenga sull’idiozia di queste posizioni. Il potere non ha certo bisogno, per arrivare alle sue conclusioni, delle nostre analisi (è finita l’epoca del carabiniere che sapeva solo leggere e dell’altro carabiniere che sapeva solo scrivere). Oggi alti livelli di ricerca scientifica sono attingibili dalle forze repressive con notevole facilità, sia per la diffusione a macchia d’olio delle informazioni di comando, sia per il nuovo ruolo che l’elemento repressivo viene a giocare all’interno dello Stato post-industriale.
Allo stesso modo, non è possibile usare il luogo comune, tipicamente “stalinista”, dell’“oggettivamente” pericoloso, ogni volta che si propone un’analisi che scopre i punti deboli dell’avversario e propone interventi di azione diretta. In caso contrario si finirebbe per stabilire una censura preventiva diretta ad impedire ai compagni l’esercizio del più ampio diritto all’approfondimento della realtà, e si finirebbe per indicare rigidamente i limiti di ciò che si può dire.
Non era infatti raro, in passato, sentire compagni affermare con serietà che certe analisi si possono fare ma non si possono né pubblicare né discutere in pubblico, perché il potere ne trae elementi per criminalizzarci. Ecco, tutto ciò non è roba del passato, è ancora presente all’interno del movimento anarchico, ed è, almeno mi sembra, uno dei motivi della mancata partecipazione al Convegno di buona parte del movimento anarchico milanese.
Questo classico modo di mettere la testa sotto la sabbia contraddistingue non solo gli struzzi ma tutti gli altri rappresentanti della paurosa categoria degli accomodanti e dei perbenisti.
Ci sono molti modi di avere paura della rivoluzione.
Un secondo elemento che ci pare utile sottolineare è quello dell’apparente adesione alle nostre idee insurrezionaliste. Ci sono difatti alcuni gruppi anarchici che si rifanno all’insurrezionalismo, particolarmente malatestiano, e hanno spesso colto l’occasione per sottolineare questa loro scelta. Ebbene, in alcuni casi questi gruppi hanno fatto scelte di natura puramente nominale, senza alcuna penetrazione nei fatti e nei progetti di azione. Basta ricordare l’insurrezionalismo di questi compagni che si rifanno a Malatesta ma che, nello stesso tempo, sostengono l’impossibilità e la conseguente inutilità di ogni azione che si ponga come metodologia l’attacco minoritario e clandestino, in quanto il livello di perfezione tecnologica raggiunto dal potere oggi rende assolutamente impossibile un lavoro che si basi sul segreto e sull’azione minoritaria e clandestina.
Anche questi compagni, con tutto il loro insurrezionalismo da biblioteca, erano altrove, a festeggiare uno dei tanti anniversari di cui il nostro movimento è ricco e che siamo tanto bravi a ricordarci e a opportunamente mettere in risalto. Evidentemente ci sono cose talmente importanti – come è appunto il tagliare una torta insieme – che fanno passare in secondo piano un’occasione di approfondimento di tematiche – guarda caso, insurrezionali – che, da per se stesse, dovrebbero focalizzare l’attenzione di tutti i compagni.
Ma non occorre molto per capire come non ci sia nulla di veramente concreto in alcune scelte politiche – ripeto puramente nominali – che frastagliano e sembrano far diventare interessante il nostro movimento. Scendendo in fondo, ben al di sotto della superficie smossa dai frastuoni dei tanti re Travicello, non resta altro che la mota più spessa e uniforme.
Un terzo elemento che si respirava nell’aria del Convegno era quello della non comprensione delle possibilità dello strumento che si stava per fornire ai compagni. Molti (e la cosa appare chiara leggendo gli interventi) si sono mossi in modo del tutto inadeguato, colti spesso in contropiede dalla situazione, ed hanno reagito in maniera classica, raccontando le loro esperienze, le lotte più recenti in cui erano stati protagonisti, le repressioni di cui erano stati vittime. Il resto, l’elemento più significativo dell’incontro, cioè l’approfondimento analitico veniva messo da parte, spesso gli si dedicava qualche parola, talmente superficiale e infantile da far subito capire che non si erano ascoltati nemmeno gli interventi introduttivi o che se li si era ascoltati, non erano stati capiti.
Da ciò, spesso, il ricorso all’alibi della difficoltà, dell’intellettualismo, dell’analisi difficile, di cui veniva immancabilmente fatta colpa ai compagni. Si tratta di un vecchio luogo comune che non manca di venire fuori sistematicamente tutte le volte che compagni di scarsa volontà e di nessuna preparazione si incontrano con compagni che qualcosa fanno e che un minimo di preparazione se la sono data. I primi rimproverano ai secondi proprio l’impegno di questi ultimi. Non vogliono, in alcun modo, lavorare ad un approfondimento analitico, vogliono (anzi pretendono, sotto pena dell’accusa di intellettualismo) che i secondi si avvicinino alla loro superficialità e al loro trastullarsi con stati d’animo e beghe di periferia.
Certo, l’accusa è fatta in modo da sembrare vera. Viene infatti affermata l’esistenza di una intenzione preconcetta di chi sviluppa un’analisi approfondita, di rendere oscure le cose, di usare termini poco comprensibili, di esacerbare il proprio intellettualismo; e ciò in modo che gli altri non possano capire e, non capendo, si trovino obbligati a non sapere ribattere. Spesso questa posizione nasconde una profonda impotenza individuale, una non idonea educazione della propria volontà all’impegno e al lavoro intellettuale, elementi, questi, indispensabili per qualsiasi azione rivoluzionaria da intraprendere, se non si vuole cadere in balia del dato immediato e dell’occasione spontanea. Ora, l’impotenza intellettuale, se non opportunamente frenata – ripeto con lo studio e l’impegno – finisce per generare il sospetto preconcetto, l’ottusità mentale di chi è sempre contrario per metodo e non per discernimento, la chiusura genericamente populista contro ciò che è analisi in quanto parto della fantasia pericolosa degli intellettuali.
Tutto questo si respirava nell’atmosfera del Convegno e si può, adesso, cogliere in alcuni interventi, cristallizzato in una paranoica persistenza del dato immediato, del fatto spicciolo, della lotta singola ma certa, della modestia del senso comune. Come si può cogliere nella tracotanza tutta verbale nei riguardi dell’analisi, nel rifiuto massimalista di ogni approfondimento, nella supervalutazione del sentimento della lotta e nella svalutazione delle cause e degli scopi dello scontro di classe.
Un quarto elemento mi sembra interessante coglierlo in alcune assenze che si sono verificate, assenze non fisiche ma di contributi, anche da parte di compagni che – almeno in linea di principio – si dichiarano abbastanza vicini alle posizioni della rivista “Anarchismo”. Non è senza importanza chiedersi il perché di questa latitanza. Mancanza di tempo? Incapacità tecnica della redazione? Motivi marginali. Altri aspetti, più sostanziali, mi sembrano al centro di tutto ciò. Per prima cosa la preminenza data ad alcune scelte di intervento. Il lavoro generico nel sociale, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di adesioni, non ad una linea analitica precisa, ma ad una possibile operatività comune. Il dialogo con componenti non specifiche del movimento nel suo insieme, anche con quelle parti che manifestano una generica potenzialità sovvervisa, immersa, spesso, nell’annacquante desiderio di sopravvivere nei rapporti col potere. Da qui discussioni interlocutorie con organismi responsabili della cosa pubblica, scelte intermedie e non di netta contrapposizione, accettazione di soluzioni proposte dalla controparte che mal si accostano alle condizioni essenziali dell’azione rivoluzionaria che debbono per forza partire da una chiara posizione di scontro. Lo stesso discorso degli spazi, per quanto interessante per gli elementi autogestionari che sottende, se non correttamente impostato in termini di autonomia dell’intervento e di conflittualità permanente, e quindi in termini insurrezionali, minaccia di scadere in un processo di accomodamento, in una riverniciatura dei guai strutturali del processo di recupero.
In questa direzione le chiarezze sono poche e queste mancanze potrebbero essere, a mio avviso, l’elemento determinante del mancato contributo al Convegno. In fondo, non è che non si sapeva “come” dire, ma, forse, si era occupati a dire “altro” e questo altro, a conti fatti, non risultava facilmente riavvicinabile alle posizioni teoriche di “Anarchismo”, posizioni che magari su di un piano di assoluta indeterminazione si possono anche condividere.
Infine un quinto elemento, la valutazione complessiva. È strano ma la mia è una valutazione positiva. Ed è questa valutazione positiva – a caldo – che ha sbalordito molti compagni, i quali concludevano per una valutazione fallimentare.
Perché positiva? Semplice. Positiva perché si sono viste alcune cose con chiarezza. I limiti del movimento nel suo insieme, le riottosità di parte che non accennano a diminuire e che nascondono male le paure e la psicosi perbenista. I primi risultati negativi di un dilagante possibilismo che intende fare andare meglio le cose nei rapporti con la repressione, magari confinando al margine e contribuendo a criminalizzare quella parte del movimento che – come noi – non accetta accomodamenti di nessun genere. Basta pensare al problema dell’amnistia per vedere in che modo ha reagito il movimento. Alle analisi socialdemocratiche dei sostenitori dell’amnistia, persi nelle loro fanfaluche, il movimento, anziché rispondere con un no deciso e preciso, ha preferito tergiversare, considerare la posizione favorevole e quella contraria (la nostra) come due posizioni degne di eguale credito, come se qui si stesse discutendo di faccende accademiche e ognuno avesse diritto alla propria credibilità in linea di principio.
Nel Convegno di Milano è parso chiaro il progetto di smantellamento della lotta che dilaga nel movimento anarchico, progetto che fa capo all’accettazione del dialogo col potere, alla lotta favorevole all’amnistia, alla giustificazione del dissociazionismo, alla confusione tra desistenti e compagni che continuano la lotta (a qualsiasi costo e in qualsiasi condizione si trovano). È parso chiaro il progetto socialdemocratico di arretramento che una grossa parte del movimento anarchico sta perseguendo con la tesi della delegittimazione, un’altra accozzaglia incredibile di fanfaluche che si ricollegano alle tesi dei “radical” americani, sprazzi di un movimento d’opinione di tante brave persone – intellettuali di grido e mezze calzette di casa nostra – che cerca di riportare la calma dopo un periodo di tempesta.
La trama dei silenzi, alcuni molto pesanti, si è sviluppata appieno nel Convegno di Milano, e in essa abbiamo potuto rintracciare, in controluce, le pietose ammissioni di coloro che non chiedono altro che un posto dove andare a finire i loro giorni, una pensione per passati servizi, una considerazione per i sacrifici sopportati. Solo che tutto ciò non si può chiedere se alcuni rompiscatole continuano a sollevare il problema della lotta, dell’irriducibile violenza rivoluzionaria, dello scontro di classe che non può accomodarsi, della repressione e del potere che non possono essere “delegittimati”. Fin quando questi rompiscatole resteranno in piedi, fin quando i loro strumenti di informazione e di analisi continueranno ad uscire, non sarà possibile nessun serio accomodamento e si correrà sempre il rischio di essere smascherati per collaborazionisti.
Ecco perché si tace. Perché non si vogliono, almeno fino a questo momento, impiegare gli strumenti del passato: la censura e la calunnia. Forse verrà il tempo anche per questi strumenti, riprendendo dalle mani dei compagni del passato il metodo dell’imbroglio e della mistificazione. Forse un piccolo cenno appare all’orizzonte se dovesse continuare e farsi costume il caso di una critica che ci riguarda, pubblicata da un giornale anarchico, e della mancata pubblicazione, sullo stesso giornale, della nostra risposta. Ancora non siamo alle calunnie del passato, ma c’è sempre tempo. I compagni in buona fede sono avvertiti.
Ecco perché, almeno per un primo motivo, ho ritenuto subito positivo il Convegno di Milano, ma ci sono altri motivi. E il più importante è che per la prima volta si è potuto sviluppare, dentro i limiti di un Convegno e di un dibattito, l’analisi insurrezionalista e la si è potuta collegare alle mutate condizioni del capitale nell’attuale situazione post-industriale.
Su questo argomento, che poi costituisce la proposta teorico-pratica che rivolgiamo a tutto il movimento, il lavoro da fare è ancora moltissimo.
Catania, 31 marzo 1986
Alfredo M. Bonanno
Circolare di convocazione del convegno
In un momento di particolare difficoltà per il nostro movimento, pensiamo sia indispensabile rompere l’attuale empasse che sembra aver coinvolto la maggior parte dei compagni portandoli a non intervenire, o quando qualche timido tentativo viene operato, più spesso avviene sul ripiego di prospettive rivoluzionarie.
Esiste dunque il bisogno di riconsiderare una progettualità insurrezionale che si riallacci ai numerosi frammenti antagonisti emergenti, indicando obiettivi che rispecchino un agire anarchico diretto ad attaccare le strutture del dominio. È in questa prospettiva che stiamo preparando, come avrete certo letto su “Anarchismo” n. 47, un Convegno aperto a tutte le tendenze del movimento anarchico e libertario.
I temi che intendiamo trattare sono tre, ma offrono diverse possibilità per lo sviluppo degli interventi, e precisamente:
-
Il ruolo attivo degli strumenti di informazione e comunicazione nel movimento.
-
Quale antagonismo, quale trasgressione nella metropoli.
-
Il ruolo che vanno assumendo le nuove tecnologie di base, soprattutto in rapporto all’azione dei rivoluzionari.
Abbiamo scelto questi argomenti perché ci sembrano abbastanza centrali e dibattuti attualmente fra i compagni; in particolare il secondo punto può essere trattato e visto da diverse angolazioni, a seconda dello specifico campo d’intervento dei compagni (antimilitarismo, ecologia, nuovi movimenti, ecc.).
Avremmo potuto inserire molti altri punti di discussione all’ordine del giorno (come giustamente ci hanno fatto notare alcuni compagni), ma con una sola giornata a disposizione, mettendo troppa carne al fuoco, si sarebbe rischiato di rendere dispersivo ed inconcludente il dibattito. Tuttavia, se alcuni compagni intendessero trattare argomenti diversi da quelli elencati, che siano comunque in sintonia col filo conduttore del Convegno (Anarchismo e progetto insurrezionale), possono farlo liberamente.
Ci sembra altresì importante ed estremamente urgente ricominciare a ricucire alcuni fili spezzati di comunicazione e di confronto fra di noi, attraverso un dibattito che non rimanga fine a se stesso, ma contribuisca a rilanciare quei contenuti di sovversione e di conflittualità permanente che sono sempre stati patrimonio degli anarchici, nonostante alcuni compagni, per i più svariati motivi, tendano via via a perderli per strada.
In conclusione, questo vuole essere un momento di incontro attivo e dinamico per provare a turbare la tranquillità di quegli iper-realisti che hanno da tempo disertato il campo dell’antagonismo ed accantonato le pratiche dei tentativi.
Per la riuscita degli scopi che ci proponiamo, riteniamo sia indispensabile la partecipazione attiva di tutti i gruppi e le individualità con propri interventi scritti, oltre naturalmente a quelli che scaturiranno nel corso del dibattito.
Redazione di Milano
Relazione introduttiva della Redazione di Milano
Con questo convegno intendiamo lanciare un sasso che smuova le acque dell’apparente tranquillità e della sicurezza in cui siamo immersi un po’ tutti. Questa iniziativa vuol essere un invito, uno stimolo per provare a scrollarci l’apatia e la rassegnazione con cui oggi subiamo certe situazioni. Pensiamo sia molto importante reagire, uscendo dal caldo delle proprie sedi, consapevoli della necessità di ricominciare ad agire nella realtà sociale in maniera incisiva.
Basta guardarsi attorno: da tutte le parti piovono inviti alla prudenza, che raccomandano, per ragioni di ovvia opportunità, di non entrare nel merito di discussioni che potrebbero compromettere, tenendo in debito conto i tempi in cui viviamo e soppesando le parole per non fare una fine prematura. Insomma, pare che di questi tempi occorra essere tatticamente pacifisti ad oltranza, iper-realisti che sappiano rifiutare la provocazione di chi spinge verso una radicalizzazione dello scontro sociale. I critici del nostro movimento tuonano contro i cosiddetti avventuristi che non hanno i piedi per terra e che hanno il torto di considerare suicida la loro strategia.
La realtà è che siamo sommersi, al nostro interno come all’esterno, dalle ragioni del quieto vivere e del buon senso, che non solo ci bloccano nell’intraprendere ogni sia pure timido tentativo rivoluzionario, ma passo passo ci sospingono, senza accorgercene, verso la palude istituzionale. In questo modo il gioco dell’accomodamento e della possibile mediazione ricerca le proprie motivazioni nella logica partecipativa che insegue la pacificazione. Così, chi più chi meno, concorriamo al mantenimento dello status quo, dato che le regole a cui tutti devono assoggettarsi sono: sopravvivenza e convenzioni. Se continueremo ad abbandonarci a questa mentalità, finiremo col trasformarci da rivoluzionari in illibati gesuiti.
Nel promuovere questo dibattito è nostra intenzione cercare di reagire a questa situazione di sfascio, noi per primi, e stimolare i compagni in tal senso, augurandoci che non rimanga fine a se stesso e che da esso possano scaturire indicazioni concrete.
Non si può vivere tacendo, mimetizzandosi, giocando al “si salvi chi può”, nell’attesa che accada qualcosa di diverso, altrimenti nella convenienza ci costruiremo alibi per giustificare la nostra condotta di persone che cercano di sopravvivere lontane dal cambiamento. Chi sente, come noi, l’esigenza precisa di scrollarsi queste cose, non può che manifestare in modo concreto la volontà di attaccare su tutti i fronti quella tendenza quietista che fa della prudenza e del ripiego le sue armi preferite, e costituisce l’attuale camicia di forza cucitaci addosso. L’argomento che trattiamo è indubbiamente divenuto materia scottante, suscettibile, per le sue implicazioni, di conseguenze talvolta spiacevoli, dato che attira su di sé (e di per sé) le attenzioni repressive dell’autorità giudiziaria. Ma noi abbiamo scelto e valutato attentamente che vale la pena correre questo rischio, se siamo consapevoli dell’importanza che riveste per tutto il movimento la causa che sosteniamo. Non vogliamo certo nasconderci le grosse difficoltà che esistono per la ripresa di un minimo di movimento rivoluzionario e i problemi che presenta l’attuazione di un intervento sociale sovversivo. Naturalmente queste sono cose che espongono i rivoluzionari a correre rischi che vanno, per loro natura, seriamente valutati. Qui dentro più o meno conosciamo tutti i vari processi di censura e di repressione che i compagni si sono autoimposti. E questi, oltre a condizionarci, aggravano la situazione perché portano in un certo senso ad autoclandestinizzare quei contenuti rivoluzionari che vanno viceversa propagati adeguatamente.
Oggi sui nostri giornali e nelle discussioni che facciamo in genere non si valutano più la sostanza, la qualità e la validità dei discorsi che si sostengono o delle cose che si possono praticare, ma si valuta innanzitutto il fatto di una possibile sanzione penale. A quanto sembra le cose che si possono fare non sono più legate all’esigenza che lo scontro di classe in atto richiede, ma al codice di procedura penale. Così, più che far emergere comportamenti antagonisti e conflittuali, questa forma di autoterrorismo psicologico ci condiziona a tal punto che assumiamo atteggiamenti da avvocato, forse giustificabili in un’aula di tribunale, ma del tutto fuori luogo nella realtà che intendiamo affrontare. Molto spesso, invece di provare ad attaccare le strutture del dominio accentuandone le contraddizioni, cerchiamo di salvaguardare la difesa di quei ristretti e mortificanti spazi sociali rimastici. Per difenderli si finisce coll’arretrare passo passo, così il potere può facilmente gestirli ed ingoiarli.
Qualcuno ha già detto che le cose, se non possono migliorare, possono però peggiorare. A dimostrare questa affermazione bastano alcuni recenti fatti, come le accuse contro elementi di DP da parte dell’apparato giudiziario milanese. Il drago istituzionale, avendo ormai divorato tutto, con la sua insaziabile fame repressiva, si morde la coda e cinicamente ripaga con l’ingratitudine questi suoi diletti figli che tanti buoni servizi gli hanno reso. La storia della miseria sembra non si sia arrestata ai pentimenti spettacolarizzati e alle dissociazioni, giacché il potere – per suoi bisogni politici – esige la cancellazione totale dell’esperienza antifascista maturata nelle piazze dal movimento della passata contestazione sociale. Che beffa! Oggi il perverso ed abominevole meccanismo generato dalla cultura del sospetto e della delazione anonima si è riversato proprio su coloro che ne sono stati, per tante ragioni, i primi fautori.
Noi comunque, al di là di queste considerazioni, ribadiamo che anche la pratica dell’antifascismo militante è parte della nostra storia. E mai come oggi avvertiamo la necessità di liberarci dell’eccessivo pessimismo che troppo spesso ci porta a frenare l’entusiasmo che anima molti giovani compagni che vorrebbero fare qualcosa. Scrollare le spalle, guardarli con quell’aria di sufficienza da fratelli maggiori, è un atteggiamento sbagliato che dimostra la nostra vanità personale nel considerarci come quelli che sanno tutto, tutto hanno provato e tutto hanno capito. In fondo sono pochi coloro che si accorgono che il pessimismo portato all’eccesso come senso critico nel valutare le cose, in ultima analisi, fa della rassegnazione il suo puntello. La troppa ragionevolezza porta ad autoconvincersi dell’inevitabilità e dell’immutabilità delle cose. Il ritornello ricorrente recita in questo caso che non serve granché cercare di cambiarle.
Tutto sommato i pessimisti negano le potenzialità di un possibile cambiamento sociale solo per una questione di personale risentimento, essendosi in altri tempi sentiti traditi nei tentativi da loro stessi operati in tal senso.
Coloro che si ritirano dalla lotta attiva non devono tanto convincere gli altri, ma autoconvincersi. Essi non si rapportano più alla condivisione di un progetto teso a modificare la realtà, ma all’accettazione della realtà stessa, considerata inevitabile. Il loro scopo diventa così quello di dare una qualche spiegazione che umanamente fornisca una giustificazione ai propri alibi. Chi sostiene di aver tutto compreso e tutto vissuto è incapace di una critica costruttiva, è incapace di sorridere. La grigia perfezione è una misura assolutamente statica e priva di contraddizioni, ma la nostra profonda imperfezione è, per fortuna, incapace di immaginarla, perché solo i credenti impiegano tali pretesti per definire ciò che non sono in grado di spiegare e di modificare.
Apriamo quindi una lotta contro il pessimismo eccessivo, per combattere nelle sue diverse manifestazioni l’attuale empasse che ci coinvolge, soprattutto quando traiamo certe conclusioni in anticipo, dando un esito scontato ancor prima di cominciare.
L’esigenza di intervenire è divenuta per noi impellente, ma questa voglia deve essere in grado di sostenere una pratica sovversiva fatta di tentativi continui, capaci di incidere sul vivere sociale con una più desiderante radicalità. Si tratta cioè di una esigenza in netto contrasto con il ripiego dalle prospettive rivoluzionarie e contro la riproduzione di modelli presi in blocco dal passato.
Esiste dunque per noi il bisogno di riconsiderare una progettualità insurrezionalista, capace di ricucire i mille spezzettati frammenti antagonisti emergenti, sia nelle grandi metropoli del Nord, come al Sud, sia nei piccoli centri e dovunque, tenendo conto delle diverse e autonome esigenze dirette a insinuare la lotta. La validità di queste lotte sta nella multiformità e selettività degli obiettivi scelti, che devono sapersi indirizzare all’attacco delle strutture piccole e grandi del dominio. Solo così si potrà rispecchiare un agire anarchico sovversivo che sia contemporaneo e che non soffra della mancanza di un modello delineato e formalizzato. Anche la ricerca di autorganizzazione specifica e proletaria è indispensabile, ma va misurata secondo i nostri desideri e bisogni, e non studiata a tavolino; la riterremo proficua se viaggerà sul terreno della informalità, per mostrarci quanto di affine oppure di diverso possediamo, contro quindi le proiezioni idealizzate che pretendono descrivere a priori e nel dettaglio il processo rivoluzionario. Queste proiezioni sarebbero in realtà il frutto, più di nostre paure interne che di esigenze di autocontrollo, evidenziando al più i nostri peggiori freni inibitori di fronte all’ignoto, non certo una voglia totale di liberazione.
Quel che qui ci interessa rilevare, al di là delle chiacchiere faziose e delle polemiche isterilite, sono le reali differenze di vedute che esistono fra noi, ed in questo senso è necessario un confronto diretto che ponga tutti nella condizione di esporre le proprie tesi, compresi naturalmente coloro che si trovano in aperto disaccordo con l’insurrezionalismo. Ciò che conta è che finalmente ciascuno di noi abbia l’opportunità di dirsi le cose fuori dalle mediazioni e dalle voci filtrate da questa o da quella parte.
Sentiamo la necessità di stabilire, o meglio di ristabilire, in concreto quel che vogliamo e con quali mezzi sia possibile ottenerlo. Le nostre scelte sono legate intimamente a questo rapportarsi reciproco, che denota il superamento delle troppe incertezze finora emerse al riguardo. Ecco perché intendiamo provare a tracciare, per grandi linee, un progetto insurrezionale che abbia fatto del qualitativo la sua forza d’urto.
Quanto più riterremo validi gli obiettivi da raggiungere, tanto più dovremo convincerci della necessità di non disperdere forze ed energie preziose in direzioni opposte.
Abbiamo sempre affermato che l’analisi deve stare in rapporto continuo con l’intervento che si vuole operare, per poter con l’esperienza apprendere i propri limiti. La pura teoria non può prevedere in anticipo gli errori, né quindi li può adeguatamente correggere. La realtà ha sempre dimostrato alla pura teoria quanto quest’ultima sia assai circoscritta nel pretendere di ridurla nei limiti del suo sapere. La nostra teoria è di larghe vedute, ma la vita lo è ancora di più e coprirne con la propria pratica la distanza non è poco.
In fondo la rivoluzione appare come qualcosa che ha reso possibile l’inimmaginabile incontro tra le nostre fantasie e quella realtà che oggi si presenta come tutt’altra cosa. Perché la rivoluzione possa essere qualcosa di più di una semplice fantasia e qualcosa di più della realtà odierna, occorre che diventi il fatto centrale che coinvolge tutta la nostra vita.
Oggi non vogliamo mettere nessuna camicia di forza alla nostra immaginazione, né vogliamo congelare il senso di un progetto insurrezionale dentro gli angusti ambiti della nostra così imperfetta conoscenza, perché ci stanno stretti gli schemi mentali di chi cerca di ridurre tutto a semplice fatto di razionalità. D’altra parte abbiamo orrore dei danni provocati da quelle fantasie che cercano di delineare nel particolare la futura società liberata. L’esperienza ci ha insegnato che chi mira a realizzare certi scopi, deve mantenere la propria pratica in costante relazione con questi; laddove ciò non dovesse avvenire non vi sarebbe alcun cambiamento in atto e non avrebbe neppure senso parlarne.
Tutte le ideologie rivelano sempre la schizofrenica separazione tra il dichiarato ed il vissuto di un soggetto. L’ideologia è finzione, l’illusione di liberarsi di qualcosa che al contrario viene con essa maggiormente rafforzata; l’autore-attore diviene così schiavo della propria involontaria vocazione ad alienarsi l’esistenza. Le comode scorciatoie scelte per evitare di correre rischi e il pensare machiavellico, non reggono ad un attento esame dei fatti. Non a caso la democrazia, nel suo divenire sistema totalitario, si trova nella necessità di modificare il proprio apparato centralizzato attraverso i decreti emanati dal suo esecutivo (governo), per riformare alcune regole al proprio interno e sveltire la burocrazia dei processi decisionali. Lo stesso a livello periferico, dove si ha bisogno di produrre una catena di piccole strutture diffuse territorialmente che hanno il compito di far partecipare la gente, dandogli l’illusione di gestire direttamente i propri problemi. Questo processo di controllo e pianificazione dal basso, esteso a tutti gli ambiti societari, è necessario per sottrarre ogni spazio di agibilità all’opposizione antiistituzionale.
L’introduzione delle sofisticate tecnologie di base: elettronica, informatica, nucleare, e così via, favorisce ulteriormente l’attuazione di questo progetto. Abbiamo infatti di fronte le profonde modificazioni economiche, politiche e sociali apportate al processo di razionalizzazione burocratica attuato dallo Stato e dal capitale e ciò si riflette anche nel modo di vivere, di pensare e di comunicare di tutti, compresi i rivoluzionari. L’accentuazione di nuove procedure repressive e di anonimo controllo sociale sul territorio (comitati di quartiere, comunità terapeutiche, ecc.), rende infatti di gran lunga più difficile l’intervento dei rivoluzionari, costretti a ripensare radicalmente su quali moventi e con quali lotte sia oggi possibile insinuare il germe della sovversione sociale, dato che tale accentuazione ha portato alla frammentazione dello scontro di classe, facendogli perdere i suoi caratteri di massa finora evidenziatisi nella lotta e trasformandolo in una miriade di opposizioni individualizzate e non comunicanti.
Questo è dunque un altro dei problemi che qui dovremo trattare, per comprendere come l’opposizione non sia scomparsa. Bisogna cioè capire che ad ogni modificazione del dominio corrisponde sempre la nascita di nuove forme d’opposizione che possono essere rafforzate dalla nostra capacità di intravedere i possibili sviluppi. Come sostenitori di una teoria e pratica insurrezionaliste anarchiche, non diamo nulla per scontato di quello che accade all’interno dello scontro di classe. Basandoci su un rapporto continuo tra l’analisi e l’intervento, bisognerebbe –per quanto possibile – evidenziare le forme autorganizzative più valide.
Coloro che pensassero a un progetto insurrezionalista come a qualcosa di definitivamente tracciato, sostenitore di postulati sacri ed inviolabili, sbaglierebbero di grosso. Il nostro è un modo di pensare ed agire basato essenzialmente sulla costante messa in discussione, perché soggetto a modifiche sia parziali che radicali, secondo le esigenze della lotta. La sintesi mezzi-fini bisogna ricercarla sul piano di una concretezza operativa, più che su dichiarazioni di principio sanzionate da statuti o programmi dettagliati. Quel che vogliamo non è qualcosa che si scrive su un pezzo di carta, cosa che per altro già facciamo, ma da inscriversi nella realtà.
La teoria e la pratica di cui siamo assertori, ieri come oggi, non possiedono certo in anticipo alcuna certezza di riuscita, ma le loro probabilità di successo partono dal vantaggio che possiedono su tante altre che si fondano invece sulla progressiva evoluzione della società, e quindi, in quanto tali, sono state già assorbite dall’attuale sistema di dominio. L’essere gradualisti e riformisti è, in ultima analisi, una maniera di concorrere alla continuità del processo di modificazione di quelle forme interne al dominio considerate ormai superate dal potere stesso.
Ecco perché non condividiamo l’opinione di chi – per esigenze di massa – sostiene un’ipotesi di intervento diluito, dove alla ricerca del qualitativo si è anteposto il mito del quantitativo. Viceversa, nella nostra prospettiva pensiamo occorra scegliere gli obiettivi, mirando soprattutto alla loro sostanza, senza cadere nella trappola di lavorare ad ingrossare l’organizzazione, per non trascurare quelli che si presentano come problemi reali ed immediati, anche se non c’è dubbio che quel modo di intervenire il più delle volte fornisca immediate soddisfazioni e gratificazioni personali. Allo stesso modo ci sembra improponibile il mito dell’organizzazione, intesa come futuro centro di propulsione di grandi masse proletarie, che un giorno o l’altro dovranno fare la rivoluzione, mito che, d’altra parte, ha già perso parecchi dei suoi sostenitori.
Tuttavia ciò non significa che siamo contro il fatto organizzativo, che anzi consideriamo indispensabile. La nostra critica è diretta verso un dato modo di organizzarsi che, risultando scarsamente aderente ai bisogni effettivi dei proletari nella lotta, sostanzialmente ostacola la lotta stessa. Questo avviene quando tutto è stabilito in anticipo ed è chiaro e prevedibile anche nel dettaglio, portando come conseguenza a storicizzare certe forme di antagonismo, divenute man mano incapaci di apportare qualche cambiamento.
Questi sono alcuni dei motivi per cui riteniamo che anche l’organizzazione specifica di sintesi risulti, nelle sue varie forme, superata dall’attuale contesto sociale, riferendoci con ciò anche a forme di organizzazione di massa quali l’anarcosindacalismo e il consiliarismo.
Una possibile soluzione a tale problema la vediamo nella ricerca di strutture autorganizzative scaturite da un rapporto informale che i gruppi anarchici di affinità stabiliscono di volta in volta in base alle esigenze della lotta. Ecco perché riteniamo sia importante discutere degli strumenti da impiegare nella nostra azione.
Vale la pena soffermarci sulla necessità, all’interno dello scontro, del sabotaggio sociale, dell’antimilitarismo, come componenti essenziali ed inseparabili della lotta insurrezionale che intendiamo sostenere. E quando parliamo di insurrezione deve essere ben chiaro che non pensiamo si possa giungere di botto alla sua realizzazione, perché è necessario un lavoro di preparazione e organizzazione nelle lotte intermedie che si portano avanti, ed è attraverso la ricerca di parziali rotture continue che si potrà arrivare ad una situazione insurrezionale. Se poi questa dovesse scoppiare imprevedibilmente, saremmo sempre pronti a sostenerla adeguatamente, muovendoci già in tale direzione. La pratica dei tentativi si sviluppa con piccole lotte che apparentemente potrebbero sembrare cosa di poco conto, l’importanza è la loro qualità, cioè il modo con cui vengono condotte dai compagni, che non dovranno cullarsi nella soddisfazione di eventuali parziali successi ottenuti. Vorremmo perciò che dal dibattito finisse per emergere l’indispensabilità di una ripresa di tale pratica, da cui bruscamente ci si è allontanati da tempo per svariati motivi.
Qui non presentiamo ai compagni risposte preconfezionate. Susciteremo forse più interrogativi ed apriremo più problemi di quello che qualcuno aveva supposto, e speriamo in qualche modo di riuscire a contrastare l’assimilazione passiva e la separazione tra chi parla e chi ascolta, ricercando, possibilmente insieme, delle proposte d’intervento rivoluzionario.
Ciò che in tutta confidenza ci auguriamo è che finalmente riemergano quei contenuti di conflittualità e di antagonismo che fino a qualche anno fa erano considerati scontati e che caratterizzavano l’azione degli anarchici. In sostanza, vorremmo che emergesse tutta la nostra buona volontà e la nostra capacità di essere rivoluzionari di oggi, non fossili del passato.
Se questa non è solo una nostra esigenza, non ci resta che un modo per dimostrarlo, come compagni che fuori di qui hanno qualcosa di concreto da portare avanti: insieme, da soli, come più si preferisce, abbandonando però la psicosi negativa di essere in pochi e di pensare di non avere sufficiente forza per contrastare ed affrontare quotidianamente la realtà che ci opprime.
La discussione è aperta.
Intervento di A.
Vorrei iniziare questo mio breve intervento sull’informatica (che non vuole essere altro che un invito alla discussione), dicendo che non ho affatto intenzione di esaltare alcuna di quelle utopie tecno-scientifiche racchiuse in certe visioni ottimistiche sul progresso, che sono l’avanzamento informatico e robotico, come un qualcosa di positivo.
Certo, in una ipotetica società del futuro, libera dal peso del capitale, i computer potrebbero alleviare il lavoro dell’uomo e lasciarlo libero di autogestire la propria vita. Ma la cosa, in questo momento, non mi interessa più di tanto.
Voglio invece guardare quanto sta accadendo nella realtà, dove con lo sviluppo di queste ed altre tecnologie di base si tende ad accentuare il sapere di pochi per la dominazione di molti.
C’è anche da considerare l’applicazione delle suddette tecnologie nel campo del controllo sociale e della repressione.
Insomma, compagni, grazie alla scienza di Stato gli spazi si stanno chiudendo intorno a noi, e sta proprio a noi rompere quel raggio invisibile che il potere ci sta stringendo intorno, e che va sotto il nome di “Progresso Tecnologico”.
Ma andiamo ad esaminare i diversi campi di applicazione dell’informatica e i relativi compiti che potrebbe assolvere il rivoluzionario.
Dalla fabbrica alla scuola il capitale si sta evolvendo nel suo impero; alcune aziende hanno ormai rinunciato da tempo alla forza lavoro degli operai. Ciò che prima veniva costruito da dieci persone ora lo fa un robot.
La produttività aumenta, i costi diminuiscono, i conflitti sociali si annullano dato che ad un robot non interessa particolarmente che il costo della vita sia raddoppiato, e nemmeno reclama mezz’ora di pausa per pisciare.
Oltre all’annullamento dei conflitti sociali si ottiene un vertiginoso aumento della disoccupazione, che smentisce il teorema che vuole l’informatica al primo posto nella creazione di posti di lavoro.
La scuola, dal canto suo, si prefigge di creare i nuovi automi in carne ed ossa che entreranno a far parte dei quadri dirigenti aziendali, e operai specializzati atti ad automatizzare i processi produttivi. Essi diventano consulenti dell’azienda per l’acquisto e la progettazione delle tecnologie dell’informazione. In questo modo si fanno garanti di una pacificazione all’interno dell’azienda stessa in particolare, e su tutto il territorio in generale. Quei compagni che vedono l’avanzamento tecnologico come qualcosa di positivo, non fanno che avallare i progetti padronali, che si ampliano nei campi che gli sono più congeniali.
Dal nucleare al militare le ricerche per nuove armi più potenti si fanno grazie all’ausilio di computer sempre più efficienti, e programmati da personale specializzato e controllato in ogni suo movimento da centralini digitali presenti con telecamere in ogni settore dell’azienda.
Ma il controllo del lavoratore, che ormai avviene in qualsiasi industria automatizzata, è solo un piccolo aspetto dell’informatica applicata al controllo sociale. Ogni microstruttura di base, dal Comitato di zona al centro recupero tossicodipendenti, è dotata di terminali collegati direttamente con la Questura (e chi non lo ha ancora fatto lo farà presto).
Il loro compito è quello di schedare i nuovi ribelli sociali, e di controllare quei soggetti considerati pericolosi o dannosi alla società. La Questura di Milano, invece, ha da poco inaugurato un mega-computer che permette di tenere sotto controllo contemporaneamente una dozzina di zone della città. Il cittadino continuamente violentato nella sua privacy non reagisce, i compagni neppure, anzi ve ne sono alcuni che contribuiscono direttamente alla divulgazione di questi strumenti.
C’è chi lavora all’interno di case costruttrici di videoterminali, chi scrolla le spalle, chi, ancora, è addetto alla diffusione e propaganda dell’informatica.
Ma c’è anche chi non si adegua a tutto ciò. È necessario demistificare i falsi benefici o le agevolazioni che porterebbe l’informatica in quanto ci si ritorcono contro. Ci alienano sul lavoro con la monotonia delle loro fasi produttive, ci condizionano la vita con il loro silenzioso intrufolarsi nella nostra privacy, controllare e reprimere.
Dobbiamo continuare una lotta iniziata già da alcuni compagni (poco pubblicizzata), i quali rifiutando l’inquadramento e lo sfruttamento a cui sono soggetti, hanno individuato nell’informatica il pericolo dell’annullamento della personalità dell’individuo.
Ma il rifiuto concreto dei computer non può limitarsi all’interno di una azienda e con mezzi di fortuna. Voglio dire, se una tazzina di caffé è sufficiente per far sballare un videoterminale, non basta certo per una banca dati. Ed è proprio verso quest’ultime che si deve indirizzare il lavoro del rivoluzionario.
La “banca dati” costituisce il punto cardine delle tre costanti irrinunciabili del Potere: repressione – controllo sociale – dominazione.
L’ausilio delle tecnologie di base contribuisce a costruire attorno al Potere un muro apparentemente invalicabile. Dimostriamo che questo muro può essere abbattuto, mattone dopo mattone, dimostriamo che noi siamo sempre qui, incazzati più che mai, e che non basteranno un milione di fottutissimi “software” a mantenerci sotto controllo. Così come si organizzarono i luddisti durante la Rivoluzione industriale, i sabotatori informatici stanno già lavorando (dall’America all’Inghilterra), cercando di rendere generalizzata questa rivolta.
E a chi, ipocritamente, ci dirà che non è più il momento (e quando lo era, allora?) noi risponderemo che l’insurrezione anarchica non conosce orario, e l’Inghilterra ne è un chiaro esempio.
Quando il proletariato si ribella contro il terrorismo del progresso, non conosce mediazioni.
Primo intervento di M.
“Milano città europea” è oggi divenuta un simbolo, un modello di pulita razionalità per le altre città italiane, il cui sviluppo vuole assomigliare assai di più all’immagine che abbiamo di alcune metropoli europee. Il suo battesimo ufficiale in questo senso è stato fatto in occasione del vertice europeo tenutosi alcuni mesi orsono da tutti i capi di governo degli Stati aderenti al MEC.
Poi, nei primi giorni di settembre, gli specialisti della repressione e del controllo sociale di tutto il mondo, vi si sono dati appuntamento, col VII congresso dell’ONU sulla criminalità, per discutere le diverse terapie anticrimine da adottare riunendo il bagaglio di esperienze dei vari criminologi, psicologi, sociologi e personaggi politici di fama mondiale.
Così, per la seconda volta in pochi mesi, la città è stata posta in stato di assedio dalle forze di polizia che, con questa scusa, hanno intensificato nel periodo estivo la propria azione preventiva, riscuotendo un largo plauso grazie anche all’appoggio dato alla campagna anticrimine dalla stampa locale e nazionale. Quest’ultima ha inoltre reso noto che il coronamento dei lavori del Congresso dell’ONU sarà costituito – tra le altre cose – dal cosiddetto “Piano di Milano”.
Tutto ciò costituisce l’aspetto più spettacolare ed eclatante della faccenda, ma vediamo un po’ come sta avvenendo la trasformazione programmata di questa città che, per restare fedele allo slogan pubblicitario, è costretta ad epurarsi alla svelta dei fastidiosi e smaglianti colori della contestazione sociale, a prevenire e controllare con largo anticipo i possibili movimenti antagonisti nascenti.
All’inizio del mese di luglio 1985 si è svolto così a Milano un altro summit, a cui hanno dedicato qualche attenzione i giornalisti locali: si tratta dell’incontro avvenuto tra il questore della città Antonio Fanello e i presidenti di tutti i consigli di zona, incontro che ha segnato l’avvio di una proficua e stretta collaborazione tra le forze di polizia e la cosiddetta “città reale” e che comporterà ben più gravi implicazioni sociali.
Lo scopo di tale collaborazione infatti è quello di fare, con l’aiuto dei consigli di circoscrizione, una specie di radiografia di Milano per focalizzare i cosiddetti “punti caldi” della criminalità e della devianza e operarvi di conseguenza, sia in modo preventivo che repressivo, istruendo in tal senso le varie strutture del quartiere e fornendo direttamente anche ai cittadini l’opportunità di avviare una stretta collaborazione. A tale scopo è già entrato in funzione dal mese di giugno, presso la questura, un “ufficio relazioni” per il pubblico destinato a costituire, al di là delle tradizionali funzioni di ordine pubblico, un centro di riferimento preciso per chi ha esigenze di sicurezza, sia individuale che collettiva, e per chi intende segnalare alla polizia persone sospette del quartiere.
È infatti ferma convinzione del democratico dott. Fanello che la delinquenza vada combattuta anche e soprattutto con la collaborazione dei cittadini. Ma il suo fine ultimo, oltre a quello palese di capillarizzare gli strumenti del controllo e della repressione, è quello di arrivare – sul modello anglosassone – all’istituzione del poliziotto di quartiere, il cosiddetto “bobby”.
Tutte le informazioni relative al quartiere, fornite per ora dai consigli di circoscrizione e in seguito dal poliziotto di zona, saranno fatte confluire ai vari commissariati di polizia, che potranno così sveltire le procedure amministrative e gestionarie della città ed averne un controllo effettivo con l’ulteriore ausilio delle nuove tecnologie di base.
Milano è infatti diventato il primo Comune telematico già dalla fine del 1984. Naturalmente di questo progetto se ne è parlato a suo tempo molto poco a dire il vero e solo nei termini di un “sistema informativo telematico” messo a disposizione dei cittadini per ottenere subito, in modo completo e dettagliato, notizie relative all’organizzazione e alle attività del Comune e dei consigli di zona, alle istituzioni e ai servizi della città. Ma poco o per nulla si è posto l’accento sull’ovvia conseguenza che, se un sistema di terminali è in grado di fornire una serie di informazioni, altrettante ne deve immagazzinare sulla città, sui quartieri, con la schedatura diretta di ogni cittadino fatta poco tempo prima. Nonostante questa operazione fosse stata presentata come qualcosa di formale e non vincolante, utile più che altro per un migliore funzionamento dei comuni e dei servizi sociali, non si capisce come mai si sia verificato da parte dei vari addetti alla raccolta dei questionari un vero e proprio tallonamento di tutti coloro che non avevano ancora provveduto a compilarli e presentarli per tempo.
A queste considerazioni bisogna aggiungerne altre che riguardano le modificazioni che sta subendo questa città in senso più strettamente fisico. Per poter meglio ripulirla abbellendone l’immagine, gli amministratori comunali stanno man mano espellendo dal centro cittadino i proletari, colpiti da migliaia e migliaia di sfratti e costretti ad essere relegati nei grandi casermoni periferici.
Anche gli sgomberi di alcune case e centri sociali occupati rientrano perfettamente in questo piano di repulisti, e abbiamo visto come in genere tali operazioni vengano precedute da vaste campagne di stampa che tendono a criminalizzare le realtà esistenti al loro interno, mettendo l’accento sugli aspetti più trasgressivi e provocatori e sulla potenzialità di violenza contestataria che attribuiscono in particolare ad alcuni gruppi di giovani. Gruppi che amano definire appunto “bande giovanili”.
Ma i nostri amministratori si sono fatti furbi. Per portare a termine il loro progetto di disciplinamento sociale hanno messo in atto una duplice terapia nei confronti dei cosiddetti potenziali criminali e devianti. Da un lato utilizzano le forze della repressione per manganellare il dissenso sgomberando i “covi”, facendo retate notturne in tutti i punti di ritrovo giovanile, restringendone progressivamente gli spazi, con la scusa di colpire traffici di droga e violenze di teppisti. Contemporaneamente utilizzano anche tutte le piccole strutture di controllo sociale e di prevenzione: le comunità terapeutiche per il recupero dei tossici, i consultori comunali per un migliore rapporto con le famiglie, una serie di strumenti quali i giornalini locali finanziati dai partiti e distribuiti gratuitamente alla popolazione, i piccoli questionari funzionali alla crescita di una partecipazione più diretta dei cittadini alla vita istituzionalizzata del quartiere.
In questo caso entrano in scena i vari assessori comunali che si dimostrano apparentemente più disponibili del passato ad assecondare anche le varie richieste dei giovani i quali, dopo i numerosi insuccessi ottenuti che ne hanno fiaccato l’entusiasmo iniziale, si vedono costretti il più delle volte a farsi appoggiare da alcune forze politiche, le più a sinistra degli schieramenti istituzionali che si prestano ben volentieri a fare da tramite nelle contrattazioni per propria convenienza politica.
Accade infatti che anche quei gruppi di compagni che all’origine erano sorti in senso oppositivo ai progetti di pacificazione, lottando in modo autonomo e autogestionario contro l’adeguamento e contro l’entrismo nelle istituzioni, pensando ormai di non avere molte chance a causa dei rapporti di forza perdenti e degli smacchi subiti, hanno acquisito una mentalità più realista ed accomodante, in altre parole più politica, e cercano ora per lo più di ottenere dei risultati conducendo un intervento più prudente e consono alla realtà, che sia in grado cioè di offrire maggiori garanzie di riuscita.
Il grosso problema di questa mentalità dominante è che progressivamente ha finito col considerare astratte ed aleatorie proprio quelle modalità di intervento rivoluzionario che una volta erano comuni fra i compagni, forse perché si era in tanti e forse perché erano parti integranti della storia del movimento di contestazione passata.
Se l’ottenimento degli spazi sociali, fosse anche tramite l’occupazione, significa andare a scapito della qualità dell’intervento nel senso che alla fine si accettano le regole del gioco per sopravvivere, allora quello spazio sociale finisce per perdere ogni significato rivoluzionario diventando un punto di aggregazione quantitativa ormai incapace di ostacolare i progetti del dominio e di incidere nella realtà. Solo uno dei tanti luoghi alternativi controllati indirettamente dalla lunga mano istituzionale.
Non è certo facile operare questo genere di critiche quando tutti più o meno ci troviamo oggi a vivere l’assurdità di questa situazione e in qualche modo a contribuirvi, perché è in genere parecchio difficile sfuggire all’adeguamento generale se non si vuole rischiare di sentirsi esclusi, bestie rare da tenere a distanza per non farsi coinvolgere. Ma proprio per questo motivo è secondo me diventato tremendamente urgente e necessario provarci. Provare ad affrontare la realtà sociale non assecondandola, ma attaccando in svariate maniere quegli organismi periferici di potere che sono installati nel proprio territorio e che contribuiscono a fornire linfa vitale alle istituzioni.
Magari si tratterà di piccoli tentativi non eclatanti, ma continui, quotidiani, che tengano conto di una qualità dell’intervento senza rincorrere l’aggregazione forzata che troppo spesso porta al compromesso e alla mediazione politica. Questo discorso sulla necessità di una pratica dei tentativi non deve apparire semplicistico o irreale, solo perché non offre alcuna certezza e garanzia di successo e perché non può essere spiegato secondo un programma dettagliato di cose da fare. Anzi, la sua forza consiste proprio nel fatto che deve essere pensata e ricercata continuamente senza stabilirne uno schema, ma cercando di attuarla in base alla creatività dei compagni e alle esigenze della lotta, per cui diventa impossibile da gestire dall’esterno.
Abbiamo visto prima come i progetti statali si muovano seguendo uno schema avanzato di ristrutturazione sociale per razionalizzare ed ordinare il territorio col proprio controllo diretto a spingere così le persone a partecipare al proprio disciplinamento. Abbiamo anche visto come Milano costituisca il fiore all’occhiello degli amministratori locali, ma la loro sfera di pianificazione non si è completata. Esistono dunque sempre numerose contraddizioni all’interno di questo pretenzioso progetto, molti punti deboli e d’altra parte c’è tanta potenzialità rivoluzionaria in grado di danneggiare e scombussolare questo schema perfetto e ordinato.
In ogni quartiere esistono strutture di repressione, di militarizzazione, di controllo e recupero sociale che agiscono quasi indisturbate, cercando di fare amicizia con la popolazione per essere meglio accettate e che intanto producono condizioni di invivibilità e di ingiustizia sociale. Si può tentare di ostacolarne il funzionamento anche solo instillando il germe dell’inimicizia e dell’ostilità del quartiere nei loro confronti, propagando le pratiche dell’azione diretta e del sabotaggio sociale, noi per primi, secondo le modalità che ciascuno giudicherà più adatte alla situazione. Si tratterà anche di piccole cose, ma la loro forza sarà nella loro qualità, nella capacità di generalizzazione e nell’abbandono di quella mentalità deleteria che si fonda sulla pacata ragionevolezza e spinge verso la soluzione certo più prudente di adeguarsi al modus vivendi e che, considerando alcune realtà come inevitabili, cerca tutt’al più di migliorarla ma senza apportarvi alcun effettivo cambiamento.
In tutto questo c’è bisogno però di alcuni ingredienti fondamentali: una certa conoscenza della realtà, una chiarezza di intenti, una fondamentale coerenza di vita e, cosa che in genere viene sottovalutata o derisa, una buona dose di entusiasmo e di freschezza che ci impedisca di diventare grigi burocrati della rivoluzione, che ormai hanno superato la fase spontaneista della lotta perché già tante situazioni hanno vissuto e cercano adesso di pianificare, oltre la loro, anche la vita degli altri smorzandone la voglia di lottare.
L’imprevedibilità non ci deve spaventare. Può lasciarci magari disorientati perché siamo in genere troppo abituati ad aggrapparci alla terraferma per affrontare il mare aperto, ma non c’è dubbio che sia tanto più desiderabile e in grado di offrire nuove e sconosciute possibilità, se sapremo rituffarci nella mischia con una diversa mentalità, con l’emozione e la determinazione di un tempo ed anche con una maggiore consapevolezza degli scopi che intendiamo raggiungere.
Intervento di Alfredo
C’è una strana contraddizione nell’organizzazione di un Convegno come questo, tra un aspetto formale – una sala così bella – (ma è anche questione di gusti), il vedersi qua, io qua sopra e tanti compagni laggiù – alcuni li conosco altri meno; e un aspetto sostanziale che vuole parlare di un problema, addirittura di un progetto, che prevede la distruzione di tutto questo. Come chi volesse contemporaneamente due cose.
È la contraddizione della vita. Siamo costretti ad usare strumenti del potere con un progetto sovversivo e distruttivo. Abbiamo quindi una realtà concreta del tutto spaventosa e un progetto di sogno che ci sta nella testa.
Gli anarchici hanno tanti progetti. Sono di regola molto creativi, però al centro di questa loro creatività esiste un progetto distruttivo, che non è soltanto un loro sogno, un sogno da incubo, ma un qualcosa che si fonda e trova riscontro nei processi sociali.
Effettivamente, una società divisa, lacerata, contrapposta e contraddittoria – si deve presumere – è necessariamente diretta se non proprio verso un solo sbocco distruttivo e conclusivo, almeno verso una serie di piccoli sbocchi distruttivi anche se non conclusivi.
Questo l’uomo della strada, nei suoi incubi, crede sia l’insurrezione. Gente armata, macchine in fiamme, palazzi distrutti, bambini che piangono, madri cercanti bambini dispersi. Il guaio grosso è che, su questo punto, anche molti anarchici hanno idee poco chiare.
Da quindici anni almeno parlo con compagni dei problemi della lotta insurrezionale e rivoluzionaria e mi accorgo che nelle loro capacità di immaginare l’evento futuro esiste lo stesso modello. Spesso ci si immaginano le barricate ottocentesche, la Comune di Parigi o le scene della rivoluzione francese.
Certamente l’insurrezione è anche questo, ma non solo questo. Il processo insurrezionale e rivoluzionario è questo e qualcosa di molto di più. Siamo qua proprio per cercare di capire un po’ meglio. Abbandoniamo quindi gli aspetti esteriori del problema, guardiamoci negli occhi e cerchiamo di ragionare dieci minuti su questo problema.
Leviamoci dalla testa l’immagine insurrezionale barricadera e vediamo invece in che modo lo strumento “insurrezione” può essere visto nella realtà di oggi, cioè in una realtà in profonda, veloce trasformazione.
Oggi non siamo nel 1871, né nel ’30, né nel ’48, né alla fine del ’700. Siamo in una situazione produttiva industriale in profonda trasformazione, siamo in quella situazione che comunemente viene definita con una frase che per comodità possiamo utilizzare anche noi, come realtà “post-industriale”.
Alcuni compagni, partendo da questa analisi, cioè considerando le profonde modificazioni della realtà produttiva di oggi, sono arrivati alla conclusione che determinati modelli rivoluzionari del passato oggi non sono più utilizzabili, per cui bisogna trovare strade nuove che non solo si contrappongano ai modelli del passato, ma li neghino nei fatti progettando nuove forme d’intervento.
Messa in questo modo la cosa è più che logica, anzi, entusiasmante. Perché si sarebbe disposti a sottoscrivere un avallo su di una cambiale scaduta da cento anni? Chi potrebbe mai pensare come validi i modelli di intervento rivoluzionario datati da centocinquanta anni o addirittura da duecento anni? Certamente, tutti ci facciamo entusiasmare dalle nuove strade, dai nuovi modi di intervento nella realtà, dalle capacità creative, dai nuovi mezzi che oggi la situazione oggettiva ci mette a disposizione. Ma, un momento.
Qua non facciamo citazioni letterarie, però una volta qualcuno ha detto che la capacità del rivoluzionario è quella di cogliere il massimo del futuro con la realtà ancora permanente del passato. Sposare lo strumento del passato, il coltello dei nostri progenitori della caverna, con il computer del futuro. Come avviene questo fatto?
Non perché siamo nostalgici di un mondo che andava all’attacco della barricata nemica con il coltello tra i denti, tutt’altro, ma perché riteniamo che gli strumenti rivoluzionari del passato restano, ancora oggi, validi. Non tanto validi per la decisione di una minoranza che se ne impadronisce e demagogica-mente stabilisce la loro validità, importandole poco di cosa la gente possa pensare: ma validi perché rappresentano il portato, addirittura ancestrale, di ogni sommovimento popolare, della capacità della gente di trovare mezzi semplici a portata di mano per sostenere opportunamente lo scatenamento di reazioni che sono causate dal fatto repressivo stesso.
Cerchiamo di andare con ordine. Nel progetto capitalista c’era qualcosa che non funzionava. Tutti coloro che si sono occupati di analisi economica e di analisi politica hanno sempre dovuto ammettere ciò. L’utopia del capitale aveva qualcosa di tecnicamente sbagliato, cioè voleva fare tre cose contrastanti tra loro: assicurare il benessere di una minoranza, sfruttare la maggioranza ai limiti della sopravvivenza, impedire l’insorgere di quest’ultima in nome dei suoi diritti.
Nella storia del capitale sono state trovate svariate soluzioni, ma diciamo che ci sono stati momenti critici nei confronti dei quali il capitale è stato chiamato a provvedere per ottenere una soluzione. Ad esempio, per non andare troppo indietro nel tempo, la crisi americana tra le due guerre. Una potente crisi di sovrapproduzione del capitale, un momento tragico, collegato con altre cause marginali, a cui il capitale ha dovuto far fronte. Come riuscì a superare la prova? Facendo entrare all’interno della dimensione dei consumi signorili le grandi masse, proponendo cioè un progetto di integrazione, di partecipazione, conclusosi – dopo l’esperienza della seconda guerra mondiale – con un allargamento dei consumi e quindi ottenendo un aumento della produzione.
Ma perché la crisi determinò un sorgere di problemi gravissimi per il capitale? Perché fino a ieri il capitale era costretto a realizzare la produzione facendo ricorso a grandissimi investimenti. Sottolineamo il concetto: “fino a ieri”, il capitale aveva necessità per realizzare quelle che tecnicamente si chiamano economie di scala di investire notevoli quantitativi di capitale finanziario e ciò allo scopo di apportare le necessarie modifiche alla produzione. Se si doveva costruire un nuovo tipo di elettrodomestico, una nuova automobile, gli investimenti erano nell’ordine di centinaia di miliardi.
Questa situazione poneva il capitale davanti lo spettro della sovrapproduzione e davanti l’obbligo di coinvolgere sempre di più gli strati popolari in acquisti sempre più massicci. Chiunque capisce che tale soluzione non poteva essere definitiva, perché prima o poi il gioco doveva concludersi in modo socialmente violento. In effetti, la miriade di interventi del capitale e dello Stato, i tentativi di recupero, si rivelarono provvisori. Molti ricorderanno le sviolinature fatte dagli economisti, su tutti i giornali, quindici, dieci anni fa, sull’importanza della programmazione e sulla capacità di sistemare tutti con simili tecniche (a esempio, i piani quinquennali). Ciò si è rivelato tutto fumo. La realtà è che si andava – badate bene, sto parlando al passato – incontro a situazioni sempre di tensione. Ulteriore soluzione proposta dal capitale: fare intervenire le strutture dello Stato all’interno della gestione capitalista, cioè trasformare lo Stato da semplice custode armato degli interessi del capitale, da semplice cassiere della gestione economica del capitale, in elemento produttivo interno al capitale stesso, cioè da cassiere a banchiere. Si è avuta così una notevole trasformazione, perché si è potuto superare la contraddizione della concorrenza economica che stava per rivelarsi fatale proprio a seguito dell’introduzione del proletariato all’interno delle fasce dei consumi signorili.
Adesso siamo davanti ad una situazione un poco diversa e vi prego, compagni, di riflettere sull’importanza di questa situazione perché è proprio questa nuova prospettiva che si apre davanti alla repressione e alle tecniche di reperimento del consenso del capitale, che rende possibile l’inserimento di un nuovo progetto rivoluzionario.
Nel momento in cui si verificano le condizioni del massimo “diverso”, si possono usare le armi del massimo “conosciuto”. Il passato, in questo modo, nel suo aspetto rivoluzionario e insurrezionale, si lega con la prospettiva del futuro.
Cosa è cambiato, cosa caratterizza la realtà post-industriale? Cosa la differenzia dalla realtà industriale?
Quanto dirò adesso deve essere inteso come una “linea di sviluppo”. Non si tratta di un fenomeno del tipo che ad un certo momento, il capitale, nelle sedi decisionali del processo produttivo, decida di operare una trasformazione e la realizzi in brevissimo tempo. Tale progetto sarebbe qualcosa di fantastico, di fuori della realtà. Nei fatti succede qualcosa come una via di mezzo. Cioè ci sono situazioni molto arretrate, situazioni di miseria, situazioni di disoccupazione, situazioni di differenziazione sul piano internazionale, si può ancora oggi parlare di situazione del “terzo mondo”, e, nello stesso tempo, il capitale procede verso il futuro, verso progetti che non sono assolutamente rapportabili, che non hanno rapporti concreti con le realtà più arretrate del capitale, che sono contraddizioni ma che vengono obbligate a convivere in attesa di un futuro superamento. Ancora oggi ci sono situazioni in cui la lotta contro il razzismo è al centro di situazioni in cui si progettano e si realizzano le grandi modificazioni del futuro.
Parlando di realtà post-industriale dobbiamo quindi tenere conto anche di questo, perché non voglio che succeda – come è accaduto – che qualche compagno dica: un momento, ma io vengo dal posto più arretrato della Sicilia, in cui ancora oggi il reclutamento della mano d’opera avviene la mattina di domenica con il caporale che si presenta in piazza a proporre lavoro a cinquemila lire al giorno. Certo, questo è ovvio, succede, succede anche di peggio. Il rivoluzionario deve tenere conto di queste realtà, ma deve anche tenere conto del punto di riferimento più avanzato del progetto capitalista. Perché, se noi dovessimo tenere conto soltanto della situazione più arretrata non saremmo rivoluzionari, ma saremmo, caso mai, recuperatori e riformisti in grado soltanto di spingere il potere a perfezionare il progetto capitalista.
Ma, per tornare ai fatti nostri, cosa distingue la realtà post-industriale dalla realtà industriale? La realtà industriale, compagni, era basata ovviamente sul capitale, sul concetto che al centro della produzione c’era l’investimento, investimento che doveva essere di notevoli dimensioni. Oggi, con le nuove tecniche di programmazione, un cambiamento di progettualità nella produzione capitalista è semplicissimo, basta cambiare i programmi dei computer.
Esaminate con calma questo problema. Due robot, in una industria, sostituiscono cento operai. Una volta si doveva cambiare la catena di montaggio per modificare la produzione. I cento operai non erano in grado di potere lavorare direttamente nella nuova catena, non erano in grado di impadronirsi subito del nuovo progetto produttivo. Oggi si modifica la catena soltanto come elemento portante, mentre una banale operazione di programmazione dei computer, del costo di qualche decina di milioni, consente di modificare i robot di ieri in quelli di domani. Quindi la capacità del capitale, dal punto di vista produttivo, oggi non è più basata sulla risorsa del capitale finanziario, cioè sugli investimenti, sul denaro, ma è basata essenzialmente, nella sua quasi totalità, sul capitale intellettuale, cioè su questa notevole accumulazione di capacità produttiva che si sta realizzando nel campo dell’informatica, nel campo di questa nuova linea della tecnologia che permette tali modificazioni.
Il capitale non ha più la necessità di ricorrere in assoluto all’elemento operaio classico per realizzare la produzione. Questo elemento finisce per diventare secondario in quanto diventa elemento centrale la capacità di modificazione del capitale intellettuale. Il capitale non ha quindi la necessità di fare grandi investimenti, di accatastare notevoli scorte per recuperare i costi iniziali, non ha la necessità di premere sul mercato, può distribuire sul territorio le zone produttive evitando quelle grandi cattedrali che erano i centri industriali, può evitare l’inquinamento, potremo avere il mare pulito, l’aria pulita, potremo avere meglio distribuite le risorse. Pensate, compagni, riflettete meglio su quanto materiale è stato fornito al capitale proprio dagli ecologisti, materiale che domani verrà usato contro di noi. Quanto lavoro è stato fatto a beneficio delle future modificazioni del capitale. Vivremo domani probabilmente in una realtà sparsa sul territorio, senza i grandi centri industriali come Gela, Siracusa, Genova, Milano, ecc. Non ci sarà più questo. Basterà la programmazione dei computer di un qualsiasi centro in un qualsiasi grattacielo di Milano perché si metta in funzione la produzione a Melbourne, a Detroit o in un altro posto. Questo cosa consentirà? Consentirà al capitale di potere realizzare un mondo migliore, qualitativamente migliore, una vita migliore, una qualità della vita migliore. Ma per chi? Ecco il problema. Certamente non per tutti. Se il capitale fosse veramente in grado di realizzare questo mondo qualitativamente migliore per tutti, qua potremmo sbaraccare veramente, saremmo tutti sostenitori dell’ideologia capitalista. Il fatto è che lo può realizzare soltanto per alcuni e questa fascia di privilegiati sarà nel futuro notevolmente più ristretta di quella del passato. Questi privilegiati del futuro si troveranno, grosso modo, nella condizione in cui si trovarono nel medioevo i cavalieri teutonici, i quali erano sostenitori di una ideologia diretta a fondare una minoranza di “eguali” e di “egualmente” privilegiati, rinchiusi dentro il castello irto di mura, circondato dai miserabili, ovviamente pronti a cercare di entrare nel castello.
Ora, questo gruppo di privilegiati non saranno tanto i grandi capitalisti, ma una fascia che scende giù fino ai quadri intermedi superiori. Una fascia notevole, seppure sempre ristretta nei confronti della grande quantità di sfruttati. Non dimentichiamo, comunque, che stiamo parlando di un progetto di tendenza.
Questa fascia quindi che potremmo definire di “inclusi”, costituita da coloro che in futuro si rinchiuderanno all’interno di questo castello, pensate che si circonderanno di un muro, di filo spinato, di eserciti, di guardie, di polizia? Io penso di no.
Perché le mura del carcere, di qualsiasi ghetto, di qualsiasi dormitorio, quartiere periferico; la repressione nel suo insieme, la polizia, la tortura; tutte cose che sono ben visibili in quanto oggi i compagni e i proletari continuano a morire in tutto il mondo sotto la tortura, ebbene, tutto ciò potrebbe subire modificazioni notevoli nei prossimi anni. Teniamo conto che cinque, dieci anni di adesso corrispondono a cento anni di ieri. Il progetto capitalista viaggia a velocità tale da aversi una progressione geometrica senza paragoni con quello che accadeva prima. Il passo che c’era tra l’inizio degli anni Sessanta e il ’68, oggi si gioca in pochi mesi.
Cosa cercheranno di fare i privilegiati? Cercheranno di staccare gli esclusi, quelli che saranno fuori, dagli inclusi. Staccare come? Tagliando la comunicazione.
Questo è il concetto centrale della repressione del futuro, concetto di cui, secondo me, si dovrebbe avere il massimo approfondimento. Tagliare la comunicazione significa due cose. Costruire un linguaggio ridotto, modesto, con un codice assolutamente elementare, da fornire all’escluso perché possa utilizzare gli strumenti terminali, estremamente facili e quindi perché possa tacere. Fornire, dall’altro lato, agli inclusi un linguaggio “degli inclusi”, per fare andare avanti il loro mondo, verso quell’utopia del privilegio e del capitale che si prospetta un poco dappertutto. Questo sarà un vero muro: la mancanza del linguaggio comune. Questo sarà il vero muro del carcere, non facilmente superabile.
Esistono diversi aspetti interessanti riguardo questo problema. Innanzitutto c’è la situazione degli inclusi stessi. Non dimentichiamo che di questo mondo di privilegiati faranno parte persone che in passato hanno avuto un’ampia esperienza di tipo ideologico-rivoluzionario e che potrebbero domani non gradire la loro stessa situazione di privilegio, sentirsi asfissiati all’interno del castello teutonico. Prima spina nel fianco del progetto capitalista. I ritornanti di classe, cioè coloro che abbandonano la classe. Compagni, riflettete su questo problema. Chi erano i “ritornanti” di classe di ieri? Io sono un ex appartenente alla classe del privilegio. L’ho abbandonata per diventare quello che comunemente si definisce “un compagno fra i compagni”, per diventare da privilegiato di ieri il rivoluzionario di oggi. Ma cosa mi sono portato dietro? Mi sono portato la mia cultura umanistica, la mia cultura ideologica. Vi posso dare soltanto parole. Ma il ritornante di domani, il rivoluzionario che abbandonerà la classe del privilegio di domani si porterà dietro la tecnologia, perché una delle caratteristiche del progetto capitalista di domani, e una delle sue condizioni essenziali per potersi reggere, non sarà più la piramidalità della distribuzione delle conoscenze, ma l’orizzontalità. Il capitale avrà necessità di dovere distribuire – sempre all’interno di questa classe degli inclusi – in modo più ragionevole e più equanime la conoscenza. Quindi il transfuga di domani si porterà dietro elementi notevoli che potranno essere utilizzati da un punto di vista rivoluzionario.
E gli inclusi? Continueranno a tacere? Potrebbe dire qualcuno. In effetti, cosa potranno mai chiedere una volta che si comincerà a tagliare la comunicazione? Per chiedere qualcosa bisogna “sapere” cosa chiedere. Non posso avere un’idea basata sulla sofferenza e sulla mancanza di qualcosa di cui non so nemmeno l’esistenza, di cui non conosco il significato, che non mi dice assolutamente niente, che non stimola i miei desideri. Il taglio del linguaggio comune renderà assolutamente superato il riformismo, il riformismo di ieri, la richiesta parziale di migliori condizioni, di riduzione della pressione repressiva e di sfruttamento. Il riformismo era basato sul comune linguaggio esistente tra sfruttato e sfruttatore. Se il linguaggio è differente nulla può più essere chiesto. A me nulla interessa di una cosa che non capisco, che non conosco, di cui so nulla. Quindi, la realizzazione di questo progetto capitalista del futuro – per come viene comunemente immaginato –, di questo progetto post-industriale, sarà basata essenzialmente sul fatto di mettere a tacere gli esclusi, di consegnare loro un codice di comportamento basato su elementi molto semplici per mettere in funzione il telefono, la televisione, i terminali computerizzati e tutti gli altri oggetti che renderanno possibile, da un lato, la soddisfazione dei bisogni primari essenziali ed anche secondari, terziari, quaternari, quello che volete, dell’escluso, e, nello stesso tempo, per rendere possibile il controllo di quest’ultimo da parte dell’incluso attraverso un procedimento indolore, non sanguinoso. Finiranno quindi le torture, le macchie di sangue sui muri. Finiranno, sempre fino ad un certo punto, è naturale. Ci saranno le situazioni in cui tutto ciò accadrà ancora. Ma, in generale, una coltre di silenzio calerà sull’escluso.
Però, c’è una cosa che non funziona in tutto ciò. Non è vero che il moto di ribellione, nell’uomo, sia soltanto legato allo stimolo del bisogno, al ragionamento e alla constatazione della mancanza. Se riflettete questo è un concetto di origine esclusivamente illuminista, sviluppato poi dall’ideologia filosofica inglese – Bentham e compagni – che parlavano sulla base dell’utilitarismo. Su queste basi razionali si è basata la nostra propaganda ideologica degli ultimi centocinquanta anni. Chiedere perché manchiamo di qualcosa, perché è giusto che questo qualcosa ci venga dato, perché siamo tutti uguali. Ma quello che taglieranno, compagni, insieme al linguaggio, sarà anche il concetto di uguaglianza, il concetto di solidarietà, il concetto di umanità, di fraternità. L’incluso di domani non si sentirà umanamente e fraternamente simile all’escluso, lo vedrà come altro. L’escluso di domani sarà fuori del castello teutonico, non vedrà l’incluso come un suo possibile fratello post-rivoluzionario di domani. Saranno due cose diverse. Allo stesso modo in cui io oggi considero “diverso” il mio cane, il quale non “parla” con me, al massimo abbaia. Certamente, voglio bene al mio cane, mi piace, mi è utile perché mi fornisce servizi, fa la guardia, è simpatico, muove la coda; ma non posso immaginare di condurre una lotta per l’uguaglianza tra la razza umana e la razza canina. Tutto ciò è fuori della mia immaginazione, è altro. E, tragicamente, questo potrebbe anche essere possibile in futuro, tagliando il linguaggio. Infatti, cosa si fornirà agli esclusi, cosa farà parte di quel codice dimezzato se non quello che già è visibile: suoni, immagini, colori. Nulla di quel codice tradizionale che era basato sulla parola, l’analisi, il linguaggio comune. Tenete presente che questo codice tradizionale era la base su cui si fondava l’analisi illuminista e progressista della trasformazione della realtà, analisi che ancora oggi costituisce il fondamento dell’ideologia rivoluzionaria, sia autoritaria che anarchica (per quanto riguarda questo punto di partenza la cosa non fa differenza). Noi anarchici siamo ancora legati al concetto progressista di potere modificare il mondo con la parola. Ma se il capitale dovesse tagliare la parola, le cose andrebbero diversamente. Tutti abbiamo esperienza del fatto che oggi ci sono giovani che non leggono, completamente. Possono essere raggiunti attraverso la musica e le immagini (televisione, cinema, fumetti). Ma queste tecniche, come probabilmente chi ha più competenza di me potrebbe spiegarci, hanno una notevole possibilità – nelle mani del potere – per arrivare ad attingere quei sentimenti irrazionali che sono dentro ognuno di noi. Cioè, il valore della razionalità come elemento di convincimento e di costruzione di quell’autocoscienza che ci potrebbe poi portare all’attacco del nemico di classe, finirà per scadere, non dico totalmente, ma notevolmente.
Ed allora, gli esclusi su che cosa si muoveranno? (Perché, certo, si continueranno a muovere). Si muoveranno su pulsioni fortemente irrazionali.
Compagni, vi prego di riflettere su alcuni fenomeni che stanno accadendo, già a partire da oggi, ad esempio in Gran Bretagna, paese che dal punto di vista dello sviluppo capitalista è stato sempre all’avanguardia ed è anche oggi all’avanguardia. Si tratta di fenomeni di sommosse spontanee e irrazionali.
A questo punto occorre capire bene la differenza tra sommossa e insurrezione, cosa che molti compagni non fanno. La sommossa è un moto di popolo che ha forti caratteristiche irrazionali. Scatta per un motivo qualsiasi: perché a un tizio per strada gli pigliano una multa, oppure perché la polizia ammazza qualcuno nel corso di una perquisizione, oppure ancora perché in uno stadio i tifosi si scontrano fra loro. Spaventarsi davanti a questi fenomeni non porta in nessun posto. Sapete perché ci spaventiamo? Perché siamo portatori dell’ideologia del progresso e dell’illuminismo, perché pensiamo che la certezza che crediamo di avere in pugno e la sua assoluta padronanza, siano tali da poterci garantire che solo noi abbiamo ragione e che questa gente sono soltanto fascisti, provocatori, irrazionali, gente nei confronti della quale occorre fare di tutto per metterla a tacere.
La cosa è diversa. In futuro si produrranno sempre di più queste situazioni di sommossa sovversiva, irrazionale e immotivata. Sento dilagare in molti compagni la paura nei confronti di questo tipo di realtà, il desiderio di ritornare all’indietro, all’impiego di metodologie basate realmente sui valori del passato, cioè sul convincimento dell’attesa, della razionale e preveggente capacità di chiarire. Ma non credo che sarà possibile impiegare ancora metodologie del genere per lungo tempo. Continueremo certamente a produrre i nostri giornali, i nostri libri, le nostre analisi scritte, ma saranno sempre di meno coloro che le leggeranno perché saranno sempre di meno coloro che avranno in mano il mezzo linguistico per poterle leggere e quindi cercare di capire quello che c’è scritto.
In linea di tendenza tutto ciò cosa determinerà? Una serie di situazioni potenzialmente insurrezionali e oggettivamente tutt’altro che insurrezionali. E il nostro compito quale dovrebbe essere? Quello di continuare ad insistere ancora con le motivazioni del passato? Oppure quello di cercare di spostare queste realtà spontaneamente di sommossa, in una dimensione insurrezionale effettiva, capace di attaccare non soltanto l’oggetto dell’incluso, l’oggetto che sta dentro il castello teutonico, ma principalmente il meccanismo di esclusione, il meccanismo di taglio del linguaggio? Noi dovremmo in futuro lavorare a fornire strumenti leggibili per gli esclusi in chiave rivoluzionaria e insurrezionale.
Parliamoci chiaramente. Non potremo fare un lavoro talmente grosso da riuscire a costruire una scuola alternativa capace di continuare a fornire gli strumenti razionalisti a chi non avrà più la possibilità di poterli utilizzare. Non potremo cioè sostituirci a quel lavoro che una volta faceva la controparte, quando aveva necessità di un linguaggio comune. Una volta che la controparte, detentrice e dispensatrice delle capacità razionalizzanti, ha tagliato il cavo, non possiamo costruirne uno alternativo. Sarebbe una delle tante illusioni del passato. Noi potremo semplicemente impiegare gli stessi strumenti (immagini, suoni, ecc.) in un modo capace di veicolare concetti in grado di contribuire allo spostamento delle realtà di sommossa in realtà insurrezionali. Questo è un lavoro che possiamo fare, che dobbiamo cominciare a fare fin da oggi. In questo senso intendiamo parlare di insurrezione.
Contrariamente a quello che molti compagni si immaginano in merito al fatto che siamo ottocenteschi, obsoleti sotto ogni riguardo, credo che, al contrario, siamo realmente in grado di costruire questo esile ponte aereo tra gli strumenti del passato e le dimensioni del futuro. Costruirlo certo non sarà facile. Il primo nemico da sconfiggere si annida dentro noi stessi, ed è dato dalla repulsione verso situazioni che ci fanno paura, atteggiamenti che non capiamo, discorsi incomprensibili per un vecchio razionalista come me.
Eppure uno sforzo bisogna farlo. Attaccare – molti compagni dicevano – sulle tracce dei luddisti, come si faceva centocinquanta anni fa. Certo, attaccare è sempre una bella cosa, però il luddismo è tramontato. I luddisti avevano un linguaggio comune con i possessori delle macchine. Tra i costruttori delle prime fabbriche e il proletariato che si rifiutava e resisteva ad entrare dentro gli opifici inglesi, c’era un linguaggio comune, c’erano gli stessi interessi. Solo che uno mangiava e l’altro non mangiava, ma a parte questo aspetto, sicuramente non marginale, avevano un linguaggio comune. Oggi la realtà è tragicamente diversa. E in futuro lo sarà sempre di più. Occorrerà quindi costruire le condizioni perché queste sommosse non ci trovino impreparati. Perché, compagni, intendiamoci, non è vero che possiamo prepararci solo psicologicamente; fare esercizi spirituali, per poi presentarci nella realtà con le nostre bandiere. Non è possibile. Il proletariato, o come volete chiamarlo, gli esclusi in sommossa ci respingeranno come ospiti estranei e sospetti. Sospetti. Cosa diavolo potremmo avere in comune con chi reagisce all’anonimato, alla assoluta inutilità della propria vita e non, badate bene, al bisogno e alla mancanza? Con chi reagisce pur avendo a casa la televisione a colori, il video-telefono e tanti altri oggetti di consumo; pur avendo la possibilità di mangiare; con chi mangia eppure reagisce? Quale discorso possiamo fare? Forse il discorso che facevano le organizzazioni di sintesi anarchiche del secolo scorso? Il discorso insurrezionalista che faceva Malatesta? È questo che è obsoleto, questo tipo di discorso insurrezionale è obsoleto. Dobbiamo pertanto trovare presto, prestissimo, una strada diversa.
E una strada diversa la si trova prima di tutto dentro di noi, con una scalata per superare il vecchio che è dentro di noi, l’incapacità di capire il nuovo. Il potere – statene pur certi – lo capisce perfettamente e sta bene educando le nuove generazioni, con una serie di messaggi subliminali, ad accettare il messaggio di rassegnazione. Ma si tratta di una illusione.
Quando queste sommosse scoppiano non dobbiamo essere là come ospiti di un avvenimento spettacolare perché, tanto, siamo anarchici e non possiamo essere altrove e perché la cosa ci riempie di soddisfazione. Dobbiamo essere là come realizzatori di un progetto esaminato ed approfondito in dettaglio prima.
Quale può essere questo progetto? Quello di organizzare gli esclusi non più su basi ideologiche, non più attraverso un ragionamento esclusivamente fondato sui vecchi concetti della lotta di classe, ma su di qualcosa di immediato, capace di calarsi nella realtà, nelle differenti realtà. Certo, nelle vostre situazioni e nelle vostre analisi ci saranno zone in cui si stanno creando tensioni. Il contatto con queste realtà, se si dovesse continuare a realizzare su basi ideologiche finirebbe per farvi espellere fuori. Il contatto deve essere stabilito su una base diversa, organizzativa ma diversa. Questo non può farlo un’organizzazione ampia che ha la pretesa tradizionale, illuministica e romantica, di servire da punto di riferimento e di sintesi per una miriade di realtà, quale potrebbe essere l’organizzazione anarchica di sintesi, ma lo può fare soltanto un’organizzazione agile, duttile, capace di adeguarsi, cioè una organizzazione informale di compagni anarchici, un’organizzazione specifica costituita da compagni che hanno una coscienza di classe anarchica che però riconoscono i limiti del vecchio modello e si propongono invece modelli diversi, più agili, che si calano nella realtà, l’analizzano, ne sviluppano una sintesi analitica molto semplice, la fanno conoscere, utilizzando gli strumenti del futuro possibilmente, non soltanto gli strumenti del passato. Teniamo presente che la differenza tra strumenti del futuro e strumenti del passato non è solo quella di mettere una fotografia in più o in meno nei nostri giornali, non è soltanto quella di dare un taglio diverso, più umoristico o meno saccente ai nostri scritti, ma è veramente capire quali sono gli strumenti del futuro, di studiarli, approfondirli, perché sono quelli che rendono possibile la costruzione dello strumento insurrezionale del futuro, quelli da porre accanto al vecchio coltello che i nostri progenitori portavano tra i denti, non dimentichiamolo. Così si può realizzare il ponte aereo di cui dicevamo prima.
Organizzazione informale quindi, che faccia un discorso semplice che si presenti senza grandi obiettivi, senza pretendere (come molti di noi fanno) che da ogni intervento debba per forza scaturire la rivoluzione sociale, perché allora che anarchici saremmo? State pur certi, compagni, che dietro l’angolo non c’è la rivoluzione sociale, che la strada angoli ne ha tanti, che è molto lungo il percorso. Quindi intervento agile, con obiettivi anche limitati, capace di colpire preventivamente lo stesso obiettivo che l’escluso si prefigge. Organizzazione quindi che sia in grado di essere “nella” realtà di sommossa sovversiva nel momento in cui questa si verifica per poterla trasformare in realtà oggettivamente insurrezionale, indicando obiettivi, mezzi e conclusioni costruttive. Questo è il compito insurrezionale. Altre strade oggi non sono percorribili.
Certo, badiamo bene, la strada dell’organizzazione di sintesi, della propaganda, dell’educazionismo anarchico, del dibattito – come questo che stiamo facendo qua – è ancora percorribile, certamente, perché, come dicevamo, si tratta di un progetto di tendenza che cerca di far capire cosa c’è nel progetto capitalista come sviluppo. Ma, come rivoluzionari anarchici, siamo obbligati a tenere conto di questa linea di sviluppo e quindi prepararci, fin da oggi, a trasformare le situazioni irrazionali di sommossa nelle realtà insurrezionali e rivoluzionarie.
Relazione di “Tracce”
“Come d’incanto, un movimento di lotte tanto vaste e prolungate, dimenticò se stesso e si arrestò”.
Censor
“Le colombe non possono né vincere né convincere i falchi se, in un primo tempo, non attaccano i falchi con la violenza dei falchi stessi”.
Yvon Bourdet
“La sovversione detesta il disordine. È essa stessa ordine virtuoso opposto ad un ordine reazionario”.
Edmond Jabès
La cultura del bordo. Antagonismo e forme di comunicazione differenti
La funzione dell’“editoria marginale” / sotterranea è quella di produrre conoscenze sommerse e momenti di aggregazione nei quali muoversi, agire, riconoscersi come portatori di possibilità culturali-politiche differenti ma tutte volte all’antagonismo e al disvelamento del nemico comune: che qui non dirò per pudore ma che tutti conoscono!
Cinema, fumetti, fotografia, letteratura, musica, computer sono contenitori, scritture, linguaggi di modellamento, di assoggettamento dell’immaginario sociale. Si tratta di andare a smontare i congegni (le strutture) di fascinazione di queste scritture per allargare i fini delle loro menzogne ed indicare segnali diversi e scritture impostate per l’approfondimento della realtà.
Non è facile. Le difficoltà sono molte. Pochi si occupano di tutto e spesso l’insieme è soffocato di problemi economici che intaccano la qualità del “prodotto” e quindi la possibilità di una sua maggiore circolazione.
I ciclostilati, i fogli fatti a mano, le fotografie sfocate o i film tremolanti hanno fatto il loro tempo. Le idee o si trasmettono in modo fruibile o restano ghettizzate nelle teste di pochi.
Sotto il martello della politica proletaria sono state nascoste tante schifezze e perdute tante speranze. O siamo all’altezza del gioco giocato dei “mass-media” o è meglio innaffiare altri territori del “sapere” dove la nostra incompetenza è meno splendente.
La cultura del bordo è un modo di porsi di fronte e contro l’immagine mercantile del “sapere” ufficiale. La memoria offesa degli oppressi di tutta la terra non è stata mai studiata (né repressa) abbastanza: ovunque i “soggetti del margine” infiammano il quotidiano di flussi di desiderio di mutamento sociale e i genocidi, gli assassinii, le galere di Stato non potranno mai raggelare, fermare l’onda lunga di intere generazioni che lottano con forza (e con ogni mezzo) per decretare la fine della società dell’opulenza.
La critica politica dei mezzi di comunicazione di massa (cinema, fotografia, fumetti, musica, carta stampata, linguaggi “software”) occorre che sia crogiuolo d’interessi e luogo dove la “conoscenza” si umanizza. Non è tanto lavorare per affermare la ragione di nessuno quanto per incrinare le certezze e gli oracoli della s-ragione dominante.
È attraverso il coagulo delle nostre differenze che possiamo addentrarci e disvelare, rompere le contraddizioni dello Stato moderno. “Chi lavora solo per l’odio, lavora solo per il caos”. (Matthew Arnold).
Abolire le sette ideologiche significa scoprire nuovi percorsi di combattimento: il bersaglio è sempre quello! Si tratta di renderlo inattuale o almeno tentare di fare di ogni “trono” legna da ardere sul fuoco di una esistenza liberata.
Le inconclusioni teorico-pratiche di “rifiuto del lavoro” o/e “consumo permesso” ed altre corbellerie ampiamente macinate dall’abatino Toni Negri possono affascinare solo chi vive nell’euforismo “rivoluzionario” del “boudoir” e scorge nella classe operaia quella coscienza di ribellione che non c’è. È l’abbaglio tipico di quanti parlano, scrivono o agiscono in nome della Classe senza avere mai visto i cessi di una fabbrica.
Quello che a noi pare praticabile è lavorare per l’insinuamento d’una cultura delegittimante. Entrare nel presente e rifiutare di interiorizzare miti e rituali di domesticazione sociale, tracciare altri valori, interpretare i disagi esistenziali della collettività, rendere consapevole chi lo vuole che togliere il consenso è una forma di sovversione: “La verità conosce ogni forma di sovversione”. (Edmond Jabès).
Il deserto delle ideologie è un fatto. Il destino degli oppressi ha origine nella bocca famelica d’una minoranza borghese che non ha ancora avuto la lezione che si merita. Siamo ancora alle conclusioni politiche contenute nel Leviatano di Hobbes; l’autoritarismo segna le condizioni oggettive in cui la maggioranza degli assoggettati scopre e anela le proprie garanzie di sfruttati in perpetuo.
Ricordiamolo: “Ideologicamente il nostro tempo sarà stato quello della stupidità dei buoni sentimenti e, praticamente, quello della tutela terroristica dell’economia, della politica e dell’ideologia su tutta l’esistenza”. (Pseudo Marcel Duchamp). Si tratta di dare a questo tempo dell’effimero e del guinzaglio le interpretazioni tendenziose della propria nullità.
La critica radicale di tutte le forme di comunicazione è un mezzo per affermare quello che si cela: il Che fare di Lenin è una chiacchiera dispotica e infantile alla quale si sono abbeverate intere generazioni di “rivoluzionari di professione” e “commissari del popolo”. Il rischio non è più nello “stile” (cioè nell’azione), i “fatti” non sono più propaganda (cioè espressione estrema di un atto individuale inteso a vendicare i torti secondo i precetti della propria coscienza atea), gli atteggiamenti crepuscolari più variopinti di molti soggetti della scena nonparlamentare sovente rimescolano antiche problematiche sull’acquisizione del divenire. Lotta armata e rivoluzione si confermano ancora come confessori dove tutto può essere detto e tutto può essere assolto nel santo nome del proletariato inerme.
La mediocrità non sta mai da una sola parte. È la più baldracca di tutte le “intelligenze” perché riesce a nascondersi nelle teste più raffinate.
La critica della separazione nasce dal distornamento-riorientamento della serialità del ruolo. La messa a morte delle ideologie correnti si coglie nella capacità allargata di liquidare i santini del passato ed inchiodare l’inumanità della società democratico-comunista al centro delle loro responsabilità.
Distruzione ambientale, armamenti, cultura asservita, corruzioni d’alto bordo, terrorismo economico, delinquenza di Palazzo, ecc., sono temi da sviluppare, facciate da demolire. Il sabotaggio del discorso dominante deve liberare isole di espressione collettiva, autenticare momenti di controffensiva: sottrarsi all’immediato rompere le catene della soggezione.
Simulazione e rappresentazione sono gli schemi pedagogici sui quali si fonda la strategia vincente della macchina-Capitale. Il “vero” è ciò che appare, se non appare, non è. E quanto appare è mimesi di un eccesso di senso che non ha senso alcuno! Rivendicare la propria soggettività è dichiararsi fuori dalla congestione sociale-elettorale; giocare ai bordi delle differenze e sull’orlo dell’ambiguità per saccheggiare i contenitori linguistici-ideologici dei loro fini, smascherare la menzogna culturale, situare in avanti il tempo del “rovesciamento di prospettiva” nella conquista di quell’Utopia concreta che è nella testa di molti.
Ricordiamolo: “Il controllo statuale si accompagna ad una presa di possesso della cultura e del sapere, che giunge sino al loro assorbimento. Questo progetto politico punta anche a fornire sicurezza al popolo, nel senso che cambia le forze popolari in popolazione di assistiti: e questo se da un lato riconosce il loro pensiero politico, dall’altro lo neutralizza”. (Henri Lefebvre).
Occorre operare negli anfratti della “crisi” per sovra-produzione delle democrazie statuali. Il pensiero mercantile-totalizzante delle logiche tecnocratiche di produzione-distribuzione della macchina-Capitale passa, si manifesta nelle mitologie della politica, della religione, della cultura. Ovunque è sempre la stessa chiacchiera di pontificazione del divenire.
Milioni di affamati, senza lavoro, sfruttati e terrorizzati di ogni razza, sono sistematicamente aggregati nella falsità efficiente d’una minoranza dominante. Gli strumenti-mezzi sono sempre quelli: scritture audiovisuali.
Si tratta di lavorare contro queste scritture. Rompere la retorica del terrore che è sistema di norme, di comportamenti, di assuefazioni della pratica sociale che fanno dell’individuo l’appendice schizofrenica di un insieme di segni-relazioni-riferimenti conviviali contrabbandati come “verità”. O la sola realtà possibile.
A partire dalla messa in distruzione della società delle certezze e dei luoghi comuni, si affermano i percorsi tortuosi di una liberazione collettiva. Il luogo e il sogno di un quotidiano senza capi e preti si conquista nella rivoluzione sociale. La Bastiglia del sapere e la fine della proprietà privata delle idee è un primo passo verso l’incendio del Palazzo d’Inverno. Lo straordinario possibile (l’utopia concreta) (Yvon Bourdet) è la lama di luce che taglia la notte e la gogna delle ideologie correnti. La storia da fare è nelle nostre teste: si tratta di portarla nelle strade. Tutti i mezzi sono buoni per espropriare ai gendarmi della ragione la nostra vita.
Il ruolo della “cultura del bordo” deve essere quello di muoversi in una controproduzione dell’informazione. Occorre appropriarsi di tutte le scritture di massa, esautorandole del loro potere, sconvolgendole nelle loro funzioni omogeneizzanti, dirottandole contro i propri centri di erogazione di senso. Cinema, fotografia, musica, video, carta stampata, comunicazione postale, ecc., debbono essere detonatori desacralizzanti, momenti di riflessione e incontri associativi dove dare inizio alla scalata del cielo. Importante è allargare le reti di produzione-distribuzione della cultura alternativa, tracciare attraverso centri di documentazione, radio-TV libere, luoghi di ricerca audiovisuale, empori per l’acquisto di strumenti espressivi, ecc., una ramificazione non asservita dell’informazione che vada dalla periferia al centro.
Importante è intensificare convegni, studi, mostre, tavole quadrate monotematiche che tengono vive le memorie degli oppressi. Biblioteche pubbliche, sale dei quartieri, teatri tenda, palazzetti dello sport, ecc., possono essere strutture da usare a seconda del momento culturale da proporre o della situazione politica da costruire.
Il nostro compito è preparare il terreno alle nuove generazioni o a quanti non vogliono essere ammaestrati dalla ragione di Stato.
La delegittimazione dei valori-bisogni della società statuale è nel riappropriamento sovversivo dell’identità. Simulacri, riti e cerimonie sono la cementazione di una prassi burocratica dove si utilizza l’individuo come plauso o preghiera. La realtà rovesciata segna la fine di ogni illusione sullo Stato moderno: lo scatenamento delle passioni e dei desideri è il raggiungimento di nuovi flussi culturali nei quali (e per i quali) dobbiamo lavorare superando schieramenti ideologici e barriere d’avanguardia sociale.
È nella devalorizzazione del ruolo il franamento della società del vuoto. Ogni teoria è colta nel momento che si supera come epifenomeno e diviene rischio e avventura quotidiana.
Critica radicale della società mercantile è distornare i suoi percorsi-linguaggi nel gioco senza regole delle soggettività in processo: andare alla radice di ogni logica statale significa sabotare lo spettacolo della sua organizzazione.
Qui ogni interpretazione è tendenziosa, ogni tensione anticipa l’inizio del ballo senza maschera: che la festa cominci.
Primo intervento di P. L.
Non si deve considerare il Convegno come qualcosa di precostituito per cui è necessario che i compagni vincano il senso di passività che si nota nella sala come che chi parla deve concludere e gli altri aspettano che poi parli qualcun altro. Vorrei così invitare i compagni a dire le cose su cui sono d’accordo, non d’accordo e sviluppare un minimo di dibattito a braccio, per evitare che tutto diventi una lettura senza pubblico, ognuno che parla per se stesso. Pensiamo di fare un discorso fra compagni, quindi vinciamo un poco queste resistenze interne che ci bloccano, senza paura di dire cazzate o non cazzate, dicendo quello che uno sente e vuole dire rispetto ai problemi.
Ecco, finita questa premessa, vorrei cominciare con un discorso che va affrontato tra i compagni soprattutto partendo da questo dato. Finora si è fatta secondo me una critica essenzialmente al modello marxista, su che cosa non siamo d’accordo, sulla questione della rivoluzione, ecc., ma nessuno di noi ha riflettuto, e gli anarchici anche, sull’idea di rivoluzione che ha, qual è questa idea, qual è questo punto fermo, se punti fermi ci sono. Ecco, in questo ragionamento emerge il primo dato. La nostra idea è vecchia di cinquant’anni, quarant’anni, appartiene a situazioni che non esistono più. Come mai un compagno oggi è sostenitore di una pratica anarcosindacalista, oppure guarda alla ridistribuzione del potere e quindi è consiliarista, che poi è un’altra versione? Che senso ha? Ecco, questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare. Ci siamo fermati noi o il mondo è andato avanti? Siamo attuali? Che critica possiamo sviluppare possedendo questi modelli?
Il primo punto è che noi siamo vittime di focalizzazioni storiche, cioè la maggior parte dei compagni non ha, secondo me, un grado di riflessione e di ricerca del limite proiettato al proprio interno. Ha sempre proiettato la sua critica verso l’esterno, cioè verso ciò che riguarda gli altri non il se stesso. Quando si parla di rivoluzione non si intendono mai i limiti, le inadeguatezze mostrate al nostro interno, rispetto al perché una rivoluzione è andata in un certo modo anziché in un altro. Si riflette soltanto sul fatto che è colpa di qualcun altro, dell’altro, della proiezione all’esterno. Ecco, così l’idea di una metodologia anarchica e insurrezionalista è rimasta focalizzata, e questa focalizzazione, proiezione e progettualità dei compagni si sono fermate a quello che è il modello anarcosindacalista, l’organizzazione di sintesi, il movimento consiliarista. Quale critica, quale evidenza, quale idea un movimento può produrre se nella sua pratica, nella sua analisi riflette una propositività inesistente nella realtà attuale? Cioè, oggi non si tratta di porre il problema: è giusto o no il sindacalismo, è giusto o no tenere conto del sindacalismo, è giusto o no essere consiliaristi, vedere ancora il motore centrale nella fabbrica? Oggi si tratta di un altro problema, secondo il mio punto di vista, si tratta di riflettere che non è stata fatta alcuna analisi in senso concreto della condizione proletaria globale. Questa, infatti, non dipendeva semplicemente dalla condizione di fabbrica separata da tutte le altre. Su questo campo mancano analisi. Mancano analisi sul fatto di considerare perché nei compagni che hanno analizzato la struttura del dominio, del potere si insegua sempre quello che si chiama “separatezza”, parzialità. Perché si fa una progettazione di separatezze, di superficialità, con l’introduzione del vecchio mondo riproposta in forma più razionalizzata?
Prendiamo un esempio concreto. Che significa autogestione in una fabbrica, se non la ridistribuzione e la continuazione nello stesso luogo dello sfruttamento e dell’oppressione con una nuova distribuzione di potere? Ecco, la fabbrica stessa, l’idea di fabbrica, di separatezza, di quartiere: l’idea di città, l’idea di villaggio, l’idea stessa dell’urbanistica, dell’architettura del sistema capitalista non possono rientrare, secondo il mio punto di vista e di ricerca, nell’architettura rivoluzionaria. Vorrei che i compagni si domandassero questo. Noi riflettiamo che siamo per la distruzione del potere ma ne conserviamo i luoghi, ne conserviamo le stesse divisioni, abbiamo le stesse percezioni.
Poi qualcuno qui ha portato avanti un altro problema. Ha detto: questo andrà via e ci sarà la società degli esclusi, il movimento di estraneazione, altri passaggi. Io vorrei riflettere su questo problema, sulla questione della progettualità. Cosa siamo in grado di produrre? Il compagno che non pensa, non ha un rapporto di analisi sull’intervento nei termini di partire da quella realtà che si trova di fronte, ma il suo problema è capire ciò che pensa, il rapporto tra la sua idea primitiva con quello che gli sta di fronte che è un’altra cosa. Ecco, questa è la scarsità, è una operazione inversa, un’operazione che hanno fatto i credenti, e i marxisti hanno fatto lo stesso. In altra veste l’hanno fatta anche gli anarcosindacalisti, in chiave libertaria. Piegare la realtà dentro la teoria e non la teoria che apprende dalla realtà. Abbiamo ragionato con gli stessi strumenti, ragioniamo con gli stessi strumenti, siamo produttori della sua stessa cultura, in forma rovesciata.
Ecco, io ho posto questo problema perché intendo che i compagni ragionino su questo. Oggi l’insurrezione. Noi vogliamo, in un certo senso, tornare all’origine. L’origine del movimento è sempre sul piano dell’informalità. Cosa è l’informalità?
È l’indistinto, è la non specificazione data in anticipo. È il muoverci su un terreno che non si conosce. Si ha percezione di sé. Bisognerebbe unire l’immediatezza e la riflessione. Ecco, questo terreno ci fa paura. All’origine il movimento insurrezionalista, sia come teoria che come pratica, aveva questo senso. Ma allora come mai sono nate certe progettazioni? Ecco quelle progettazioni sono punti focali, momenti di esplosione e di risposta al problema rivoluzionario rispetto alla situazione di cambiamento. Sono focalizzazioni, ma non è l’origine, la materia che trattiamo, cioè l’insurrezione, la teoria, la pratica. Noi manchiamo. Dobbiamo creare le forme, dobbiamo ricreare le forme, reinventare i luoghi, servirci di strumenti attuali. Ecco, liberarci del passato. Ma ci si libera del passato non quando non si conosce, ma quando si illumina la vecchia prospettiva e si mostra l’altra, quella che ancora manca e che si intravede. Ma l’opera di un rivoluzionario non può essere proiettata troppo in là, perché più le cose stanno in là, più siamo al di qua noi, fermi. Allora ci serve coprire questo spazio. La prima idea qual è che sorge nei compagni? Che l’idea di rivoluzione oggi non è chiara, che l’idea di insurrezione è un qualcosa che delimita, circoscrive nel tempo, rende immediato quello che si intende per rivoluzione, per rottura sociale. Perché la rivoluzione può essere intesa come evoluzione, come qualcosa che accadrà, che è di là sempre da venire.
Ecco, queste motivazioni devono servire ai compagni per ragionare a fondo. Noi siamo rimasti indietro e la realtà è andata avanti, però, nello stesso tempo, non riusciamo a cogliere questo aspetto. Noi non ci organizziamo secondo il bisogno immediato, e quindi non è che facciamo emergere la praticabilità del concetto del perché siamo anarchici e delle tematiche anarchiche. Cioè non basta, non si può dire: noi siamo contro l’autorità. Noi dobbiamo dimostrare l’insufficienza dell’autorità a realizzare ciò che è nella sua stessa premessa. Vale a dire che non si criticano le ideologie marxiste o di qualsiasi altro tipo, in base al fatto che adottano l’autorità, ma perché l’autorità non è in grado di realizzare quello che dice nella sua stessa premessa.
Su questi ragionamenti i compagni riflettano. Agli operai, alla gente comune si pone un problema molto semplice, secondo il mio punto di vista: qual è la soluzione più praticabile? Qual è il modo che possa portare le persone ad uscire dal fatto dell’amministrazione delegata di una vita nata nella delega? Quando noi ci poniamo nella teoria e nella pratica insurrezionaliste riflettiamo su questo contenuto, dobbiamo avere chiaro uno scopo. Se vogliamo portare le persone all’amministrazione diretta, se vogliamo portare a rompere con la natura delegativa a tutti i livelli, con quali metodi, come insinuarli? Ecco, qui sorge il problema. Chi parte sgombro da un’idea preconcetta, ma ha un’idea di sostanzialità del concetto, ne cerca una sua applicazione dentro l’immediatezza, dentro la lotta stessa. Ecco allora che sorge il problema di quello che chiamo, sul territorio, la assunzione di una progettualità diffusa nei compagni. Non l’assimilazione ma la creazione, il rendersi conto che dietro ogni forma di lotta non è tanto la forma stessa autorganizzativa importante, ma la sua concettualità. Quanto riesce a produrre? I compagni non affrontano il problema in questi termini. Sono vittime di un mondo già formalizzato, già preparato. Cos’è che si illumina accendendo una prospettiva sul passato? Si illumina il peggio, si illumina il limite. Ma gli uomini devono andare avanti. Ecco, sul presente noi stiamo illuminando la vecchia strada per mostrare la nuova, o quanto di nuovo ci sia, e lo facciamo in tempi ravvicinati, approssimativi, non del tutto delimitati? Qual è lo scopo del compagno in questi termini? È quello di mostrare la sua ricerca, non attraverso il dare la risposta precisa, ma attraverso il fatto di possedere delle possibili soluzioni nel momento in cui si è dentro la storia, dentro le cose che si debbono fare. Quando si è fuori, nella critica teorica non esistono contraddizioni, perché allora non sarebbe neanche più la pura teoria, sarebbe la realtà. In teoria non esistono contraddizioni. La nostra teoria è priva di contraddizioni. Però nessuno si pone queste domande. Ecco, vorrei che i compagni riflettessero su questo.
L’idea insurrezionalista è un’idea di informalità. Significa restituire il discorso all’origine per ricomporlo nella sua attualità, secondo schemi e forme appartenenti al presente, i cui possessori, ideatori, creatori dovremmo essere proprio noi.
Non siamo inferiori a chi ci ha preceduto. Mi riferisco a qualcuno che dice che il mito del passato è un mito di illusione, una sudditanza psicologica, non pone il compagno sullo stesso piano, è un’operazione autoritaria, in un certo senso. Noi mettiamo tutto sullo stesso piano. Quando si discute facciamo a meno della soggezione che ci anima, perché allora sì che siamo pronti a vederne i limiti, non nella sua accettazione. Ecco molti compagni, anche marxisti, hanno semplicemente dimenticato di applicare questo metodo. Per cui io dico che i discepoli sono sempre i peggiori cultori del maestro. Ecco, noi non siamo discepoli di nessuno, siamo anarchici come lo erano Bakunin, Malatesta, ecc. Ecco, questo è il primo punto che dobbiamo evidenziare in questa ricerca. Partire da questo: i nostri compagni avevano dei limiti, oggi noi possediamo di più, perché possediamo la loro esperienza, possediamo conoscenze successive.
Ecco, vorrei che i compagni con questo discorso così non globale né parziale, ma frammentario, riuscissero a porsi questo problema: che idea abbiamo noi oggi di rivoluzione?
Ponendosi questo problema si devono anche porre quello della loro operatività, della possibilità di trasformazione della realtà. Coprire questa distanza, raggiungere il punto focale del progetto anarchico e insurrezionale. Questo punto non è nel guardare il passato, ma è nell’illuminare il passato per comprendere il presente e superarlo nelle sue ovvietà. Le conoscenze acquisite non sono mai un cambiamento, ma un aggiustamento.
Vorrei che i compagni portassero qui dentro una discussione che non si agisce qua per idea preconcetta contro qualcuno, contro l’idea della sintesi o l’idea anarcosindacalista, ma qui si discute, ed io discuto, sul loro superamento, sui loro limiti, sulla evidenza delle contraddizioni, sulla loro non applicabilità. Quando parliamo anche rispetto all’autorità ritengo si debba discutere anche riguardo l’applicabilità, se quello che dice è reale e vero, dimostrabile. Non ci si libera dall’autorità criticandola nella sua contrapposizione, ma nella sua inutilità. Ecco, vogliamo dimostrare l’inutilità di un certo modo di organizzarsi. Però, cosa cerchiamo? Cerchiamo un’aggregazione, un’organizzazione sul piano informale e sociale, più reale, più aderente. Non il suo contrario.
Ecco, vorrei che i compagni qui dentro apportassero una critica non di contrapposizione, ma di evidenza, di dimostrazione. La realtà è anche oggettiva, mostra le sue evidenze. Come può una progettazione di cinquanta anni fa avere qualcosa di attuale? Questa domanda dobbiamo porcela e dobbiamo dare una risposta.
Ecco perché vorrei che la discussione si aprisse in tutti i sensi e in tutte le maniere e venissero presentate anche tesi contrastanti con questa veduta, per misurarle e vederne la validità.
Intervento di C.
Vorrei riallacciarmi all’intervento di Alfredo che, secondo me, offre molti spunti per poter approfondire tutta una serie di discorsi e, partendo dalla prima parte del suo intervento, vorrei tentare di mettere a fuoco, di porre l’accento su quella realtà che più di ogni altra, almeno nella situazione milanese, è funzionale al progetto di trasformazione e di ristrutturazione del capitale.
Quella realtà che sta attorno a Milano, ai margini dell’impero che ha la metropoli come epicentro, quel territorio in continua trasformazione, dalle connotazioni e dai confini talmente labili che perfino la definizione che va ad assumere nei notiziari radiotelevisivi e sulle pagine dei giornali (locali e non) è diversa, varia da situazione a situazione.
Diventa provincia, a volte addirittura provincia dolce, nei servizi sui giornali o nei documentari teletrasmessi che conducono l’ignaro lettore o spettatore a scoprire oasi di verde a pochi chilometri dal grigio cemento della città, a riscoprire tradizioni ormai considerate perse per sempre e invece ancora conservate fra i casolari in campagna o lungo le rive del Ticino; dimenticandosi naturalmente di riferire o di riportare la deliziosa sensazione avuta, per raggiungere questi magnifici posti, dall’attraversare Pero con i suoi oltre trecento insediamenti industriali, dimenticandosi naturalmente di rammentare i benefici effetti ai polmoni gratuitamente ricevuti dall’annusare l’aria nei pressi della raffineria di Rho, dimenticandosi naturalmente di trascrivere quello strano brivido che corre lungo la schiena alla vista del suggestivo spettacolo offerto dal nuovo supercarcere di Opera.
Ma questo è già hinterland, così infatti si trasforma il nome di questa zona quando la notizia riportata è un fatto di cronaca nera, quando si parla di uno scippo, quando si devono trattare fatti di sangue, quando un carabiniere uccide un tossico, quando un tossico muore per overdose, oppure quando si deve parlare di “fattacci” legati al lavoro o alla mancanza di lavoro; quando un cassintegrato si lascia morire di inedia, quando gli operai di una fabbrica che ha chiuso i battenti occupano il comune, quando si deve parlare di gravi incidenti sul lavoro o quando si ricorda la zona di provenienza di un compagno finito in galera, ecc.
Hinterland o provincia che dir si voglia vi sono molti aspetti che accomunano quella miriade di paesi e paesini che cinge Milano, sia pure nel pieno rispetto delle peculiarità di ognuno di essi; l’apatia che la fa da dominatrice indiscussa; il potere “comarista” che, alle soglie del 2000 ha ancora un peso notevole e che utilizza ancora con successo la sua arma mai spuntata, il pettegolezzo; l’eroina, vero cordone ombelicale e unico mezzo di collegamento veramente funzionante e sempre puntualissimo con Milano.
Ma ciò che più di ogni altra cosa fa sentire il suo peso e diventa aspetto primario di questo territorio è la sua totale dipendenza da Milano, è la sua totale disponibilità a diventare pattumiera di ciò che la città espelle, è la sua capacità di assecondare tutte le esigenze che la metropoli esprime.
E le esigenze che la metropoli che più di ogni altra in Italia è proiettata verso il futuro, le esigenze che la Milano con velleità di divenire Città Europea esprime sono davvero molte.
Innanzi tutto la volontà di dare un’immagine “pulita” del proprio centro storico, e se l’aspetto più eclatante di questa politica sono state indubbiamente le recenti retate di massa che hanno visto centinaia di giovani riempire i blindati della polizia e affollare le stanze della questura, lo sgombero di spazi occupati destinati a centri sociali e l’accanimento sbirresco e della stampa nei confronti dei punx; ciò che coinvolge in modo diretto anche l’hinterland è l’espulsione sistematica delle famiglie operaie e proletarie in genere dalle abitazioni, non certo lussuose, ancora esistenti in parecchie zone centrali, espulsione incentivata dall’assegnazione di appartamenti costruiti dal comune in quei paesi ormai diventati quartieri dormitorio e periferia della città, paesi come Sesto San Giovanni, Cinisello, Baggio che hanno visto sconvolto il loro assetto urbanistico e che hanno adeguato il ritmo stesso di vita a ciò che Milano ha cacciato dal proprio centro.
Può la Milano capitale dell’innovazione tecnologica, centro direzionale far convivere nel proprio cuore il passo veloce del porta-borse, il candore dei camici, il ronzio dei video terminali con lo stridere di tornio e fresa, con il tonfo della pressa e con la tuta sporca di grasso?
Certamente no! Ed ecco pronto l’hinterland a recepire questa volontà di trasformazione e a trasformare il suo assetto produttivo di pari passo con il trasformarsi stesso del modo di produrre; pur essendo stata, si può dire da sempre, una zona con una forte presenza industriale, si è passati da una situazione fatta di pochi ma grandi complessi industriali dove a lavorare erano centinaia di operai, alla situazione praticamente opposta, dove centinaia sono le piccole aziende e pochissimi gli operai che vi lavorano al loro interno.
E questo passaggio non è stato certo indolore, la fabbrica oltre che essere luogo di produzione di merci è principalmente luogo di produzione e riproduzione di modi di essere, di rapportarsi, all’interno della fabbrica, positiva o negativa che sia, si forma e si sviluppa una cultura ed una filosofia di vita, non è un caso che molti compagni abbiano ritenuto, e alcuni lo ritengono ancora oggi, la fabbrica come punto di partenza per la trasformazione della società.
Ma in una situazione come quella esistente all’interno di questi microscopici insediamenti industriali, con l’aria che vi tira, in una realtà fatta di supersfruttamento, di ricatti continui, dell’utilizzo indiscriminato del licenziamento, dell’inosservanza delle più elementari norme di sicurezza che i padroni di queste fabbriche, in genere ex operai, fanno intravedere ben poche possibilità per poter partire da qui nella trasformazione di questo stato di cose.
Dico questo anche alla luce dell’esperienza fatta con altri compagni nel tentare di intervenire rispetto a questa realtà, che tra l’altro conosciamo molto bene per averla vissuta direttamente sulla nostra stessa pelle; e se l’aspetto positivo poteva essere rappresentato dal fatto di confrontarci con della gente non inquinata dalla logica sindacale (è inutile sottolineare il fatto che rispetto a queste situazioni il sindacato latita, dove non c’è la possibilità di recuperare tessere chi l’ha mai visto?), dall’altro abbiamo dovuto scontrarci con una fortissima resistenza a voler persino mettere in discussione la miseria di una vita vissuta per buona parte del tempo in una situazione del genere. Un altro aspetto che non va sottovalutato secondo me è la composizione della gente che lavora all’interno delle piccole aziende, nella maggior parte dei casi si tratta di giovani e giovanissimi che abbandonata la scuola si accontentano di lavorare dove trovano considerando questa fase come transitoria oppure, in molti casi, si tratta di operai che svolgono qui un loro secondo lavoro e solo questo basterebbe a dirla lunga sulla loro volontà di lottare.
E a questo punto a proposito di lottare e di essere compagni in provincia vorrei portare l’esperienza che sto vivendo, consapevole di suscitare alcune perplessità e di non ricevere probabilmente molti consensi.
La dipendenza dalla metropoli non passa solamente attraverso la trasformazione architettonica e non è esclusivamente di carattere economico, ma si manifesta anche a livello “culturale”: buoni film, buoni spettacoli teatrali, buoni libri noi provinciali siamo costretti a venire a trovarli in città e come accadeva un tempo per i prodotti agricoli ciò che abbiamo di buono dentro la testa veniamo a venderlo nel mercato cittadino, pochissimi sono i collettivi (anarchici e non) presenti in provincia, quando vogliamo “fare gli anarchici” veniamo a prendere contatti con i compagni in città, dopo esserci ricercati veramente con il lanternino nei nostri paesi.
Noi nel nostro piccolo in quella fetta di hinterland che sta a nord-ovest di Milano, abbiamo cercato di superare questo ostacolo e in questa direzione siamo andati anche oltre il semplice voler fare qualcosa nel territorio dove viviamo: nel nostro piccolo, all’interno di quel progetto che ha preso il nome di Luna & Metrò, abbiamo cercato di superare il limite grosso dettato dalle differenze ideologiche, di aggirare lo scoglio dell’incomunicabilità fra compagni che in pratica possono fare un sacco di cose insieme, e il primo passo è stato quello di voler superare il concetto di collettivo di paese in un territorio talmente appiattito che fa sì che i problemi di un paese siano in realtà quelli di una zona intera, confrontandoci anche con compagni che anarchici non sono.
E questo vuol dire correre il grosso rischio di limitarsi a divenire e rimanere nota stonata, ma anche correre il rischio di mettere in discussione concetti buonissimi sulla carta una volta tanto con una realtà in movimento.
Relazione di C.
Prima di tutto una disapprovazione che riguarda lo stesso O.d.G. del Convegno, perché mi sembra molto limitativo. Mi riferisco in particolare al secondo punto “Quale antagonismo, quale trasgressione nella metropoli”, che privilegia a-priori e in maniera discriminante solo i possibili antagonismi sociali della “metropoli”, tagliando fuori altri momenti di antagonismo sociale che prendono sempre più consistenza e prospettive rivoluzionarie. Oltre la conflittualità all’interno della metropoli (in senso lato) stanno sviluppandosi sempre più le lotte contro la metropoli. La rivendicazione dell’indipendenza politica e dei diritti di esistenza in quanto popoli nazionali assoggettati alla metropoli del potere, sono momenti di altrettanti antagonismi sociali e politici che sarebbe un grave errore continuare a trascurare, tanto più da quel movimento che trova espressione nella rivista “Anarchismo”, che è sempre stata attenta e propositiva proprio su tali ambiti. Ritengo sia perciò necessario allargare la discussione a tutti gli antagonismi e trasgressioni non solo della metropoli ma di tutto l’ambito sociale in cui agiamo in quanto anarchici. Credo sia opportuna a tale proposito una concreta valutazione da parte di tutto il movimento anarchico italiano e delle colonie, e, di conseguenza una chiara presa di posizione (anche se non necessariamente unitaria) sulla lotta di liberazione nazionale che vede coinvolti oramai parecchi nostri compagni e gruppi. È tempo di farla finita coi silenzi più o meno espliciti di buona parte del movimento (anche se non è sicuramente una mancanza di “Anarchismo”) su un argomento della lotta sociale anarchica che ormai si sta espandendo sempre di più.
Per quanto riguarda il primo punto dell’O.d.G. “Il ruolo attivo degli strumenti di informazione e comunicazione del movimento”, vorrei puntualizzare alcune cose. Attualmente essi riflettono la generale crisi del movimento specifico e tentano un contraddittorio approccio alla realtà, sclerotizzati come sono ognuno nel “proprio anarchismo”. In generale la situazione può dirsi caratterizzata dal fatto che ad ogni periodico (o qualsiasi strumento di informazione-comunicazione) del movimento corrisponde una delle attuali tendenze dell’anarchismo. L’interazione fra le diverse componenti è scarsamente presa in considerazione per cui ognuno sembra andare avanti senza tener conto dell’altro se non addirittura per denigrare il lavoro dello (degli) altro (altri). E non mi si venga a dire che la critica è una costante determinante del nostro movimento. Qua, compagni, non si sta facendo critica (che questa è sempre costruttiva) ma si stanno accusando i compagni di non essere compagni o perlomeno di fare il gioco del padrone. Ed alle rotture di una volta si aggiungono sempre nuove rotture che frantumano il movimento in altri mille rivoli insignificanti, non solo dal punto di vista quantitativo (non sarebbe poi tanto male di per se stesso), ma anche dal punto di vista qualitativo perché ognuno, ripeto, propaganda il suo anarchismo, perciò solo una tendenza di esso, in contrasto, a volte evidente, con gli altri aspetti che storicamente ha elaborato. In definitiva, credo che la carenza dei nostri strumenti di informazione e comunicazione può essere superata solo da un diverso atteggiamento di tutti noi verso noi stessi. Non si tratta di dar vita ad una sola anima del movimento a scapito delle altre. Bisogna rendersi conto che alle componenti tradizionali (individualisti, collettivisti, comunisti, anarcosindacalisti, ecc.) altre se ne sono aggiunte e che tutte rivendicano la propria appartenenza all’anarchismo. È possibile, mi ripeto da anni, che non si trovi un modus vivendi che dia vita ad una attiva collaborazione fra tutti noi? Io credo che quella possibilità non solo vi sia, ma che è addirittura necessaria se vogliamo nuovamente fare storia assieme alle classi subalterne. In ogni caso, sono convinto che solo l’attiva collaborazione ed il reciproco rispetto (pur continuando ad editare i diversi strumenti ora esistenti) sono alla base di un serio discorso sul ruolo attivo che i nostri strumenti informativi e comunicativi devono raggiungere. Non entro nel merito del contenuto e del modo in cui utilizzare tali strumenti perché essi scaturiranno dalle proposte del dibattito. Voglio però ancora una volta ricordare che è necessario scendere dal piedistallo intellettualistico, incomprensibile ai più, su cui molte volte e volentieri ci cimentiamo tutti noi. I nostri interventi, proprio perché rivolti non alla generica massa, ma a determinate sue componenti, spesse volte sprovviste del bagaglio specialistico che pure noi ci siamo dovuti sorbire ed assimilare, devono essere pienamente comprensibili. E non mi si accusi di populismo infantile e simili baggianate. Il discorso è semplice. I nostri strumenti informativi e comunicativi servono ad esprimere agli “altri” la nostra posizione teorica e pratica. Continueremo a non comunicare un bel niente se non ci leveremo i panni intellettuali che finora abbiamo, erroneamente, indossato.
Nella speranza di poter intervenire personalmente ho voluto mettere alla riflessione dei compagni alcuni punti preliminari a qualsiasi discorso sul futuro del movimento, e come tali vorrei venissero presi.
Riguardo il modo corretto di porsi nei confronti delle componenti anarchiche tutte, pur conoscendo perfettamente la posizione “singolare” dei non insurrezionalisti o fautori della “nuova sovversione”, credo sia opportuno non rompere i ponti definitivamente con essi. E, ancora, non si tratta semplicemente di condividere o meno una specifica presa di posizione teorica e di conseguenza anche pratica. Il fatto è che su lotte concrete e “limitate” è possibile, o per lo meno può esserlo, una azione unitaria anche con i “nuovi sovversivi”.
Buon lavoro e fraterni saluti.
Guasila, 16 agosto 1985
Interveto di A.
I mancati interventi sono forse dovuti alla strutturazione che ha avuto il Convegno non tanto ad una nostra mancanza di disponibilità al confronto, quanto una specie di inibizione che sarà nata dal fatto che tutti quanti noi siamo venuti qua sì con delle aspettative, ma anche con una voglia di partecipare in termini anche più concreti rispetto a queste cose che ultimamente ci stanno passando e, io non so se esco fuori dal tema o meno, ma a questo punto non mi interessa perché mi sembra utile che in questo momento si faccia anche un minimo di riflessione su quello che sta succedendo e che stranamente molta parte del movimento anarchico fa finta di non capire per dei motivi così di ordine che non so se sono a questo punto ideologici o per scelte squisitamente politiche.
Mi riferisco alle ultime cose che sono successe, alle perquisizioni che noi abbiamo avuto, giù in Calabria, come in altre città d’Italia e che penso che ormai, vista la controinformazione minima che siamo riusciti a fare, tutti quanti sapete e al tentativo che questo benedetto Coordinamento nazionale contro la repressione che ormai è diventato solo una sigla che non convince più nessuno e non riesce più a fare niente, aveva cercato di portare avanti. Ed era su questo che io volevo cercare di aprire un confronto, anche perché mi sembra che la cosa non solo non si sia risolta, ma sta continuando.
Faccio una brevissima sintesi di quello che è successo che è un pochino questo. Nel mese di luglio ci sono state, dopo una riunione del Coordinamento nazionale anarchico contro la repressione, tenuta a Roma alla fine di giugno, una serie di perquisizioni per una presunta partecipazione a banda armata a otto compagni che partecipano non solo a questo Coordinamento, ma ad un gruppo, il gruppo Faina che si occupava più specificatamente della condizione dei carcerati, dei compagni nostri che stavano dentro. La motivazione non è stata ben chiara. La cosa che è venuta fuori è che adesso, a questo punto, il sistema è diventato sempre più raffinato, perché non si va su indicazioni generiche, non si cercano più documenti indiscriminati, ma stranamente questi signori erano venuti a cercare documenti che dall’’80 ad oggi sono circolati all’interno del nostro movimento e un po’ sulla nostra stampa. La cosa strana è che purtroppo queste perquisizioni sono passate completamente inosservate, e nonostante la nostra controinformazione e una conferenza stampa che abbiamo indetto il 10 di settembre a Roma, a cui devo dire ha partecipato pochissima componente del movimento anarchico, non si sa bene per quale motivo, non ha avuto molto riscontro, perché la nostra controinformazione è stata quella che è stata, la stampa ufficiale ci ha completamente ignorato, e quello che si sta portando avanti è di nuovo il tentativo di criminalizzarci con questa presunta caccia alle streghe. Mi riferisco – e non so se molti compagni hanno letto – all’articolo che c’è stato su “L’Espresso” e sui giornali come “La Repubblica”, il “Corriere della Sera”, “L’Europeo”, sul fatto del SISDE che dichiarava appunto che alcune componenti del movimento anarchico si stavano organizzando a Roma per preparare un attentato di eclatanza nazionale probabilmente e avrebbero preso contatto con alcuni trafficanti di armi per cercare armi ancora più sofisticate. Questa non so come la possiamo inquadrare, quello che so e che mi pare molto importante, è che ancora oggi in Francia stanno succedendo le stesse cose e alcuni nostri compagni sono stati arrestati, non ne sappiamo niente, sappiamo solo però che noi rispetto alla estradizione, a quelli che sono i problemi politici più impellenti che i nostri compagni stanno vivendo nella realtà del carcere che è completamente ormai disgregata, di noi che non riusciamo dall’esterno a fare niente, di loro che si sentono isolati e che non riescono ad avere probabilmente con noi alcun rapporto, perché intanto ci stiamo facendo i discorsi di ordine squisitamente ideologico o di massimi sistemi, io penso che da questo dibattito, da questo Convegno, che ritengo sia una cosa molto importante, perché finalmente stiamo cercando di superare l’intellettualismo che ci ha sempre caratterizzato, questa ricerca sempre più culturale di noi anarchici rispetto alla realtà che credo che oggi come oggi non solo non paga, ma non ha più nessun riscontro concreto.
Per quanto riguarda questo discorso, io volevo riattaccarmi un po’ a quello che diceva Alfredo Bonanno prima, premettendo anche che ho seguito molto male l’intervento perché stanca, perché c’era un po’ di brusio, sulla sua analisi che faceva rispetto alla tecnologia che ci porterebbe ad essere un po’ dentro e un po’ fuori di certe realtà. Io condivido, in linee teoriche il suo intervento, però non riesco, oggi come oggi, per la disperazione che vivo, per la realtà calabrese che è completamente fuori da qualsiasi possibilità o contesto di aggregazione sociale, come riuscire a leggere, all’interno del nostro territorio, quelli che potrebbero essere gli spunti concreti per far sì che questo discorso di rivoluzione sociale, di metodo insurrezionalista, diventasse poi una nostra pratica, un nostro vivere quotidiano e un sentirci parte degli sfruttati fra gli sfruttati. Insomma, io penso che in questo momento non riesco a dare nessun tipo di contributo se non la mia voglia di confrontarmi su di una progettualità concreta, se possibile, sapendo però di avere un grande limite, quello di non riuscire in questo momento, di proporre a tutti quanti noi, che si possa insieme far continuare questo discorso.
Noi stiamo tentando, nei nostri piccolissimi tentativi, un minimo di controinformazione che riguarda chiaramente solo ed esclusivamente la repressione, però non mi sembra una cosa marginale, non mi sembra una cosa da sottovalutare, perché i nostri compagni hanno bisogno anche di sostegno materiale, in questo caso vorrei che qui si aprisse una sottoscrizione intanto per i compagni francesi – italiani e francesi, ormai – che sappiamo praticamente un po’ abbandonati a se stessi, non riusciamo ad avere notizie più precise, ma penso che a questi livelli dovremmo da qui costruire, in tanti, i presupposti perché quelli che stanno dentro non si sentano più abbandonati e quelli che stanno fuori non si sentano privi di un’identità rivoluzionaria, di capacità di intervenire nel sociale, non soltanto proponendo ormai spazi di centri sociali alternativi che onestamente non so quanto significato possano avere, visto il recupero istituzionale che ne è stato fatto, viste le realtà che noi viviamo di disoccupazione, di disgregazione sociale e generale.
In questo momento, scusatemi, l’unica cosa che riesco a proporre è la mia impotenza, la mia incapacità nella realtà che mi vivo e che non ritengo di essere quella che sta lì a guardare ma che ha fatto tantissimi tentativi per far sì che si smuovesse qualcosa nel sociale, io quello che chiedo ai compagni è che oggi insieme cerchiamo un pochino di abbandonare un po’ queste parole che ci separano, cioè questa paura di andarci a confrontare con chi meglio di noi sa parlare e sa scrivere, perché secondo me dobbiamo assolutamente cercare di trovare questo linguaggio comune, e il linguaggio comune non ci può essere se non riusciamo ad esprimere anche la nostra ignoranza.
Secondo intervento di M.
Visto che la compagna [A.] ha tirato in ballo la questione della Francia e degli ultimi arresti che ci sono stati, va bene, allora ricordiamo che sono stati arrestati, questo qualche settimana fa, la compagna G. B. e il compagno S. C. e il compagno O. D..
Noi abbiamo gli indirizzi di G. B. e di S. C. che possiamo dare eventualmente a chi volesse scrivere qualcosa in solidarietà, a chi volesse mettersi in corrispondenza con loro o a chi volesse sottoscrivere per loro. In ogni caso G. si trova a Fleury-Mérogis e C. a Fresnes.
Inoltre, bisognerebbe fare un minimo di sottoscrizione per raccogliere dei fondi sia per partecipare alle spese degli avvocati, sia perché come tutti ricorderanno S. C. aveva subito, dopo essere stato torturato qui in Italia, con percosse e cose varie, ha la vescica ridotta in pessime condizioni, per cui è costretto adesso a tenere, tra l’altro, un sacchettino attaccato per orinare, non è una cosa molto piacevole, ed adesso, tra l’altro dovrebbe fare un’operazione, un’operazione il cui costo dovrebbe aggirarsi sui due milioni, per cui naturalmente questo sta a tutti i compagni cercare di dare una mano per lo meno in modo concreto a questi compagni, oltre che a sostenerli in senso solidaristico e nel senso di controinformazione.
Chi volesse comunque i due indirizzi dei compagni li abbiamo qui.
Non li leggo perché sono complicati.
Intervento di M.
...ho quindici anni di militanza alle spalle, erano loro che erano più avanti di me, perché quando noi eravamo insieme a loro nella strada principale di fronte a un giardino, io che sono un vecchio lupo del mestiere, sapevo che per fare una manifestazione ci vuole l’autorizzazione, sapevo che se facevamo la manifestazione senza autorizzazione andavano incontro a dei problemi, io sapevo che se sceglievo di fare una manifestazione sarei andata incontro a... e l’avrei potuto fare come l’ho fatto tante altre volte. La gente se ne sta fottendo di queste cose, la gente, arrivato ad un certo punto, che erano là con i cartelloni, hanno detto: ma che cazzo facciamo qua, andiamocene ad occupare il Comune. Giustamente, perché loro non si pongono questo problema, hanno un problema, una necessità e la fanno, perché non ne sanno di autorizzazioni, cose, ecc., e quindi, praticamente, va bene, siamo andati, ci sono stati dei blocchi stradali, c’è stata poi una occupazione dell’IACP e compagnia bella.
Ora, questo qua è un piccolo esempio di una lotta che è stata portata avanti, secondo me una lotta fallita. E, credetemi, dire: ma come in questo momento, riuscire, insieme alla gente, i bambini, i vecchi, ad occupare l’IACP, a fare dei blocchi stradali, a fare una manifestazione non autorizzata, e dici che è una lotta fallita? Sì, è una lotta fallita. Con i compagni con cui siamo stati insieme abbiamo riflettuto, per esempio, molto su questo fatto, e abbiamo cercato di capire perché è una lotta fallita. Perché gli obiettivi che cercavamo di portare avanti insieme a queste persone, erano obiettivi parziali. La gente si muove, solo ed esclusivamente, se si sente toccata in prima persona, se ha bisogno di una cosa. Aveva bisogno della casa e per la casa era disposta a tutto, ha fatto tutto. Finita la casa è rientrata nei ranghi. Ecco, questa è anche una riflessione che io vorrei sottoporre ai compagni, per questo io ritengo che questa lotta sia fallita. In ogni caso, sono sempre tentativi da portare avanti, perché già questo ci ha dato una lezione. La lezione è questa, che quando ci sono cose di questo genere non ci si può limitare a lottare per la casa, ma bisogna cercare di allargare il discorso con queste persone, su problematiche che vadano al di là della casa, che vadano al di là della qualità della vita in generale, che vadano al di là, che vadano sulla repressione, sulla disoccupazione, che vadano su tutto quello che c’è attorno ad una “casa” e alla vita di una persona. Ecco, questa è stata la limitazione di questo esempio che io avevo detto, per cui, praticamente, se un’altra volta ci sarà, io mi ripropongo di tentare per lo meno questa strada qua. E quindi una coscienza della parzialità di queste lotte. Però, oggettivamente, io mi rendo conto che oggi non è che ci siano tante altre possibilità. Questa è una possibilità. Da una lotta per la casa domani non sappiamo cosa può venire fuori. In ogni caso, non è stare con le mani in mano, in ogni caso non è dormire, non è strapparsi i capelli, e in ogni caso non è nemmeno buttare la spugna. Ecco, va bene, questo è, in parole povere, quello che volevo dire.
Adesso, non so, io pregherei i compagni di, non so, porco dio, non siamo all’università, non siamo in un posto qualsiasi, ognuno penso che abbia delle cose da dire e viene qua e le dice come le ho dette io, come le hanno dette tutti gli altri compagni, altrimenti stare là, per ore e ore, a guardarci in faccia, con quella atmosfera di gelo, sembra effettivamente come se stessimo tutti talmente bene, se non avessimo tutti completamente problemi, se... non è che qua, chi viene qua deve avere delle soluzioni da apportare. Soluzioni non ne abbiamo nessuno, gente mia. Chi viene qua può fare una proposta, può dire le sue riflessioni su qualche cosa, può cercare di allargare il dibattito, può cercare di captare l’attenzione di un compagno che la pensa un poco come lui e mettersi in contatto con lui, semplicemente questo, e basta.
Secondo intervento di P. L.
Se il dibattito i compagni lo considerano chiuso, se abbiamo intenzione, in un certo modo, mi sono assunto un impegno di dover riassumere, per così dire, tutto quanto si è detto qui dentro brevemente, il senso di quello che è emerso, dei discorsi sostenuti dai compagni. Dall’altro canto sto riflettendo, con una grossa incertezza, che sarebbe questa. Una volta usciti di qua siamo più ricchi di qualcosa o siamo rimasti gli stessi? Stavo riflettendo se le cose che qualcuno avrebbe voluto dire, non le ha dette. Abbiamo comunicato o ci siamo autoascoltati, quelli che hanno parlato? Ecco, credo che oggi sia proprio questo momento reale della comunicazione tra i compagni, il senso che si è persa la voce, si è persa la riflessione, però siamo qua presenti.
Ecco, queste mie incertezze, modi di vedere le cose, mi ricordano il senso che allora una sala era piena, ma era piena anche di discorsi, era piena di persone che avevano qualcosa da dirsi. Noi abbiamo perso questo senso, evidentemente. Dall’altro canto, nessuno di noi, tra coloro che hanno parlato, tiene ad autoparlare per se stesso, forse hanno scelto alcuni compagni vincendo la propria resistenza interna, più di farlo parlato, di farlo scritto, l’intervento. E questo ha condizionato il dialogo del compagno nella sua immediatezza. Ecco credo che non ci rendiamo conto, secondo il mio punto di vista, della gravità che il silenzio, anche il silenzio è una forma di comunicazione, quale però? Quella di cui si è parlato stamattina in rapporto a quella di un movimento di estraneità. Non siamo più in grado di parlare attraverso le parole, attraverso queste riflessioni, ma siamo in grado semplicemente di recepire immagini, recepire suoni e non aver parola per questi suoni, per queste immagini?
Questo è un fatto che mi sconcerta in un certo modo. Ecco, vorrei, prima di trarre delle conclusioni, invitare ancora i compagni su cosa uno si porta fuori di qua, in questo rapporto. Abbiamo sbagliato tutto, siamo in una situazione in cui i compagni stessi sentono che non sia possibile, allo stato dei fatti, sostenere il discorso, non si è più in grado di parlare. Siamo diventati degli intimisti, per cui è molto più facile parlare in un rapporto a uno, a due, a tre, ma non siamo capaci di avere una relazione più ampia. Mi sa che il mondo si è circoscritto ancora ulteriormente, invece di ampliarsi, così come si doveva fare. I compagni se hanno da dire, rapportare, questa essenza di cose, anche l’incomunicabihtà delle cose, importantissima anche questa, vengano qua ad esprimerla, con parole, con suoni, che non siano il brusio, il silenzio, il detto a metà, il detto tra noi o il detto col vicino.
Intervento di G.
Stavo pensando di avere assistito un’altra volta ad una riunione simile, ma numericamente molto più ridotta, e ripensavo allo stesso effetto di allora, che è stato un effetto squallido, in quanto proprio si verificava questa situazione, in cui da una situazione non usciva niente, se non del disgusto, disgusto perché, forse proprio come in questo caso, si capiva che possibilmente ognuno magari aveva dei contenuti da volere esprimere, esigenze da volere raffrontare assieme agli altri, però non si riesce spesso a parlare, anche perché forse questi convegni, questi incontri vengono in un momento che si può definire anche di crisi e spero di non essere troppo pessimista. Quindi, in un momento di crisi ci si aspetta che siano gli altri a parlare e suggerirci qualcosa e non si riesce ad esternare, ad estrinsecare quello, tutti i propositi, tutte le esigenze e gli eventuali progetti che sono all’interno di ognuno di noi.
Ma, naturalmente, aspettarsi che sia un altro a proporci delle vie o a proporci il “che fare”, penso che è magari un brutto segno della situazione. Insomma, se c’è un momento di crisi è facilmente percepibile da parte di tutti, ma da parte di tutti ci si dovrebbe sforzare di capire i motivi della crisi e dello scoramento ed assieme eventualmente cercare di trovare delle soluzioni, magari che non siano di massa, magari non delle soluzioni che siano totalizzanti, che possano interessare tutti, ma delle soluzioni, al limite, che possono cercarsi nei vari gruppi di paese o di città, ma purché qualcosa, qualche soluzione, diciamo anche non soluzione, qualche passo verso una forma di risveglio si abbia. Quindi, a questo punto, o vengono fuori delle proposte risolutive, oppure è meglio chiudere.
Poco fa, in mattinata, mi ero posto un problema, leggendo qua il cartellone che parla di progetto insurrezionalista, anche se la riunione non è stata specifica e non implica che si debba parlare per forza del tema, ma mi chiedevo: parlando di progetto insurrezionale noi ci troviamo di fronte a due termini che sono “progetto” e “insurrezionale” e da questo “italianamente” parlando dovrebbero venire fuori delle proposte che facciano parte di un progetto e una qualità di queste proposte che debba indirizzarle verso gli aspetti insurrezionali, cioè una qualità di queste proposte che debba tentare di portarci all’insurrezione. Perché noi sappiamo che ci troviamo in una situazione che è negativa, in ogni caso, in paese o in città, nel centro o in periferia. Percepiamo negativamente la nostra esistenza, perché è fatta purtroppo di sofferenze, di privazioni, è fatta di emarginazione, è fatta di carcere, è fatta di tutte queste cattive qualità. Cioè, il nostro modo di insorgere nei confronti di questa realtà, qual è? Che cosa dobbiamo fare? Per chi è disoccupato, o è emarginato, il nostro modo di intervenire qual è? E se non sappiamo qual è almeno dovremmo dire, dovremmo studiare quale dovrebbe essere. Cosa che purtroppo non viene fuori. Ripeto forse perché ognuno si aspetta che sia la terza persona a proporre questa strada, o una delle tante strade o a fare in generale una proposta.
Se qualcuno pensa di poter dare non una soluzione, ma di poter venire a proporre qualcosa, se ne può discutere. Può darsi che sia accettata o meno. La sensazione comunque che si ha, che sto avendo massimamente io, è quella di non saper parlare, anche perché in una situazione mortifera come questa è difficile che uno si incoraggi a parlare, però o chiudiamo i battenti, oppure qualcosa dobbiamo riuscire pure a dircela.
Intervento di D.
Io sono comunista e non anarchico. Premetto questa cosa per spiegare perché sono qua. Spiegare perché sono qua significa fare alcuni discorsi che intendo fare.
Mi sono già perso. Va bene. Comunque il problema per cui sono qua è questo: sostanzialmente mi interessano le esperienze di tutti i compagni. Questo non vuol dire acriticità rispetto alle cose, rispetto a quello che succede, non vuol dire non avere un punto di opinione, o considerarci, tutto sommato, tutti fratelli, per cui “vogliamoci bene”. Sicuramente non questo. Però sicuramente il rompere le barriere, i ghetti che ci sono stati, secondo me la crisi che si sente in questa sala è, tutto sommato, la crisi di tutto il movimento che qualcuno fa partire da una data, qualcuno da un’altra, comunque parte un po’ di tempo fa. È una crisi di progettualità grossissima ed è innegabile che ci porta da una parte ad una moria di gente che si integra e dall’altra parte dei compagni che comunque non mollano il loro contributo, anche se non sanno più come farlo uscire da se stessi.
Quindi il problema, secondo me, è solo un discorso di comunicazione, per gran parte. Cioè, il fatto di non riuscire a parlare tra di noi è, tutto sommato, il minore dei limiti. Il problema grosso è che non riusciamo a parlare più al di fuori di noi stessi. Cioè con i compagni che abbiamo vicino. L’esperienza mia personale dei compagni anarchici, è relegata a quella che conosco, e, con alcuni di loro, si è rotto questo ghetto, e quindi c’è stata la possibilità di una comunicazione di esperienze estremamente diverse che come unico denominatore comune aveva forse un senso di liberazione che non è stato perso. Ora, questa cosa qui, secondo me, portata all’esterno da noi, è ritrovare le contraddizioni grossissime che la gente al di fuori di noi vive, che però noi con gli occhi con cui abbiamo imparato a conoscere le contraddizioni sociali, non riusciamo più a capire, nel senso che la mia impressione è questa, che le contraddizioni arrivino oggi non tanto in forma organizzata, ma attraverso le mille rivolte che uno vive, le quali mille rivolte sono persino quella dell’ulcera rispetto al corpo nel momento in cui a uno gli sta sul cazzo lavorare. È chiaro che non l’esprime più, come avevamo imparato, rispetto ad organizzarsi, a far dell’assenteismo organizzato, ma l’esprime in un modo altamente così implosivo, praticamente da uccidere il soggetto anche a livello fisico. E così tantissime altre contraddizioni si esprimono in questo modo.
Il problema a questo punto è non di voler fare l’avanguardia, ma di portare la nostra esperienza, in modo che qualcosa invece di implodere esploda, e quindi andare a trovare tutti i soggetti che esprimono rivolta, ma che l’esprimono talmente in modo diverso, e comunicare con loro. E questo si può fare solo uscendo da molti ghetti in cui siamo, per cui – faccio l’ultimo esempio – io quando ho conosciuto i primi punx non ho avuto una bella impressione, non mi piacevano. Perché erano estremamente diversi da me, da un me che comunque è ’77 e via così, e quindi c’era questa grossa incomunicabilità, questo grosso rifiuto. Nel momento in cui sono riuscito a superare questo rifiuto evidentemente c’è stato qualcosa che si poteva comunicare. È chiaro che ciò non voleva dire appiattire me o loro, voleva dire solo costruire degli orizzonti insieme, che non erano né i miei né i loro, ma il risultato forse di una comunicazione tra soggetti diversi.
Intervento di A.
Vengo da Torino, non sono in mezzo ad una realtà di lotta o di movimento, qualche volta magari mi ci sono anche visto, ma comunque quella odierna la trovo molto diversa da quella che mi sarebbe piaciuto che fosse.
Parlo un po’ di me, nel senso che mi sento autorizzato ad intervenire visto che siamo a ruota libera e in qualche maniera c’è la difficoltà a comunicare. Io la sto esprimendo con i gesti, le parole, con tutto. Ne sono l’espressione in qualche modo.
Questo essere venuto a Milano mi potrebbe servire non foss’altro per avere la possibilità, un domani, dal momento che sono sardo e penso di rientrare in Sardegna, di potere fare qualcosa lì, come dicevo a P. prima e collegarmi alla realtà di là e riuscire almeno lì a combinare qualcosa.
Nelle varie volte che sono rientrato in Sardegna ho avuto modo di avere contatti con giovani di paese e questi qua avrebbero un sacco di iniziative che pensano, presumono di portare avanti. Cose che potranno veramente essere realizzate se si ha un contatto, se si ha un aggancio con altri gruppi, con compagni che bene o male serviranno di sicuro e servono quando si ha una qualsiasi iniziativa. Soprattutto se questa deve prendere certe strade invece di altre. Insomma, se si rischia in qualche modo, come spesso accade, di essere inglobati, inseriti insomma nel sistema. Questo per progetti vari di cooperative, produzione, lavoro, turismo e un sacco di altre cose.
Rientro in Sardegna proprio perché qua c’è difficoltà di comunicazione, che è il mio problema. A Torino, città in cui ho abitato in questi ultimi quattro anni, ho avuto modo di sentirla questa incomunicabilità e forse è la prima volta che riesco anche a uscire anch’io e a parlare. E purtroppo appunto ci si rende conto che si è da soli, non conosco i compagni di Torino che so che sono qua, che so che esistono perché ho letto i manifesti in via Garibaldi e difatti sono potuto venire per quello.
Lì, a Torino, dove abito, si è in lotta, c’è un pensionato di un’opera pia della S. Vincenzo, ed il proprietario è il Comune di Torino. Adesso il sindaco ci ha intimato una lettera di sfratto. Questo pensionato era prima gestito da una cooperativa di compagni del PCI. Per dire, momenti di lotta, realtà minuta, microrealtà, esistono. Qualcosa la si fa, la si potrebbe fare. Mancano gli agganci, io tento di colpevolizzare me stesso dicendo che non ho saputo legarmi a realtà come Torino e magari appunto non conosco i compagni di Torino di “Anarchismo” e mi sono limitato da parte mia a prendere solo nelle edicole “Rivista Anarchica” o leggiucchiare qualcosa di quello che si faceva altrove nel movimento. A Torino mi è sembrato che si facesse sempre poco, o almeno non ne venivano notizie.
Che ne so, possibilità di fare ce ne sarebbero anche a Torino, in queste realtà. Dove abito si tratta di un pensionato di lavoratori e di studenti stranieri, gente con una scarsissima coscienza politica, tant’è che adesso si trovano ad occupare senza saperlo questo stabile di cui è proprietario il Comune e che penso sia la prima volta che l’amministrazione comunale si sta assumendo la responsabilità di sfrattare invece di sistemare come solitamente, almeno in ultimo, facevano, di sistemare gli sfrattati altrove. E ci sono ancora queste venticinque persone che con grandissima paura della polizia sono lì che non hanno la possibilità, non riescono a trovare casa, perché sono disoccupati, oppure anche lavoratori ma con stipendi bassissimi. Insomma le realtà che si conoscono nelle città, è il solito problema della casa, dovunque, in tutte le città, e quindi si trovano ad occupare questo stabile del Comune, e le tre persone – e figuratevi io sono una di queste tre – che cercano di mobilitare questa cosa, di farla crescere. Niente, continuiamo a restare isolati. C’è stato anche un intervento di RAI 3, di Radio Flash, di Radio Torino Popolare, qualche articolo sulla “Stampa Sera”, però non si riesce a immaginare altre possibilità di aggancio. Il PCI è proprio il fautore di questo sfratto, perché dipende dalla vecchia amministrazione Novelli. C’è questa difficoltà di agganciarsi. Lì stesso, per queste venticinque persone che sono appunto proletari, operai, ecc., parlare di politica è difficile, difficilissimo, perché la aborriscono, la rifiutano, perché ne hanno paura. Se si fa una certa cosa, che ne so, una difficoltà era: verrà la polizia e noi rimaniamo nell’atrio, non facciamo niente e verranno a prenderci loro. E questi tre insistevano, no, è meglio salire sul terrazzo, almeno se vengono a prenderci ci prendono di là, forse qualche giornalista verrà e la cosa si potrà sapere in giro. Per dire, c’è difficoltà anche a far prendere una decisione simile. Oppure, quando qualche giornalista amico è venuto si rivolgevano a lui come dire, ma lei scriverà in favore a noi, lei è con noi, con i nostri problemi? e così via, e questo qua diceva, no, noi possiamo parlare solo dei fatti e non parteggiamo per nessuno. Comunque per dirvi che non c’è grande possibilità. C’è questa aspirazione da parte della gente non ad essere aiutati, ma ad espandersi, ad allargarsi un po’, però non sappiamo e non sanno a chi rivolgersi. PCI non di sicuro. DP, loro non ci pensano ma questi tre non intendono rivolgersi neppure a DP. Insomma, si è staccati. I Radicali farebbero un cosaccio che non ci piacerebbe ed io personalmente non ho avuto modo di conoscere la possibilità, che ne so, di una sede anarchica dove portare un problema simile che tra l’altro sembra troppo minuto, troppo insignificante per la problematica che può stare intorno a gruppi anarchici o quanto meno un po’ slegata da quelli che sono gli interessi immediati di un gruppo anarchico di una città come Torino.
Io penso che invece ci sarebbe bisogno anche di questo. Attualmente siamo venticinque, lo stabile ne potrebbe ospitare duecento, sarebbe interessante, che ne so, occuparlo insieme a persone che abitano fuori. Non lo so, sono disarmato in qualche maniera. Sarebbe bene magari partissimo dal piccolo, senza pensare a questo tema che questo Convegno si è dato, di progetto di insurrezione. Il guaio nostro è che non riusciamo neppure a stare con quei pochi che si reputano anarchici e che sono ancora attorno alle problematiche dell’anarchismo. Dovremmo pensare a ricostruire dal piccolo – a mio giudizio – e quindi tenere conto degli sfrattati di Catania che, appunto, si muovono. Dovremmo badarci non a livello singolo ma a livello organizzativo, di gruppi, che seguono certe iniziative. Per esserci non per indirizzare, ma comunque per esserci quanto meno.
L’altra mia esperienza torinese è stata quella di educatore a Collegno in una comunità alloggio con compagni del ’77, così, per abbreviare. In qualche maniera è stata più disastrosa di quest’ultima, nel senso che anche lì comunità gestite da cooperative del PCI. PCI a Collegno, PCI a Torino, PCI alle USL e abbiamo trovato una barriera. Almeno le poche persone che hanno voluto dimostrare qualcosa. Anche lì si era completamente isolati. Non sapevamo a chi rivolgerci. I volantini ce li procuravamo di straforo da una sede del sindacato autonomo di lì, oppure interessandoci presso...
Intervento di J.
Visto che siamo arrivati al punto di dire la nostra sul Convegno, io dico la mia. Il Convegno è molto interessante. Diciamo, non vado spesso ai convegni, però se vado, penso di portare via qualche cosa e penso che questo di oggi sia un momento molto interessante e importante perché, per quanto posso capire, anche il tema del Convegno, tra le altre cose, è anche il tema della diseducazione, cioè del diseducarci nei riguardi di certi preconcetti, di modi di vedere le cose che tutti abbiamo dentro di noi. Prima di tutto l’idea del Convegno stesso, che abbiamo l’abitudine di misurare attraverso una valutazione quantitativa, strutturata, dove si discute di tante cose, dove possiamo risolvere tutti i problemi del futuro, progetti concreti, cose da fare, ecc.
Invece oggi, quello che è stato fatto, è che abbiamo aperto una porta – secondo me – verso il futuro, attraverso un modello, magari schematico, magari che non esiste oggi, però un modello che ci aiuta anche a capire meglio il presente, meglio l’oggi. Chiaramente, il presente, l’oggi non sono un fatto uniforme, non siamo arrivati al futuro, dove ci sarà una totale divisione tra esclusi e inclusi nella società, esistono nelle periferie del capitalismo fatti dove la gente è ancora al livello di dovere lottare per avere una casa, invece nelle metropoli siamo al punto dove c’è la coesistenza dell’assistenzialismo della casa, dove ognuno ha il video, con scoppi improvvisi di sommosse che succedono sia in Inghilterra, dove i protagonisti sono gli West-indiani, in Germania, dove sono giovani più politicizzati diciamo, o negli stadi di calcio dove c’è una situazione di scontro senza nessuna prospettiva. Non divago sul problema della violenza negli stadi, ma il problema è che si tratta di scontri che scoppiano tanto per scoppiare.
La rabbia esce da questo cosiddetto benessere, dall’assistenzialismo, dall’inglobamento, dalla socialdemocrazia. Il problema che abbiamo di fronte ora, secondo me, che adesso vediamo meglio, non è un problema che ha avuto soluzione, ma è una domanda che facciamo a noi stessi, sia nel momento della lotta per la casa, sia nel momento della sommossa: che posizione prendiamo noi come movimento anarchico? Cosa significa la nostra esistenza in queste realtà? Significa che noi, quando c’è la lotta per la casa arriviamo in quattro e ci inseriamo in questa lotta? Oppure quando c’è la sommossa, arriviamo in quattro e buttiamo la nostra pietra? Oppure ancora abbiamo una funzione in quanto movimento che può portare qualche cosa non solo nel momento microscopico di un avvenimento che non si può dire che fallisce o riesce, perché non si può dire che una sommossa fallisce o riesce, o uno sciopero fallisce o riesce, o che una lotta per la casa fallisce o riesce, se noi parliamo da un punto di vista rivoluzionario, perché riesce solo quando siamo arrivati alla rivoluzione. Dunque, noi dobbiamo dire, partendo da un certo livello di chiarificazione che è uscito oggi, di cercare di diseducarci in merito a certi schemi che ci mettono fuori da queste cose che stanno succedendo e ci impediscono di essere legati in queste situazioni, perché siamo bloccati in vecchi schemi di azione e il nostro contributo o è non coglibile perché siamo talmente ghettizzati che loro vanno da un lato mentre noi siamo altrove, o dobbiamo partire oggi da tutte queste domande per dire: noi siamo il movimento anarchico, ma fuori di questa stanza vi sono migliaia e migliaia di giovani ribelli che non si chiamano in alcun modo, ma che non vogliono capi, non vogliono leader, non vogliono neanche la società in cui vivono e dunque non possiamo dire che questo Convegno sia fallito perché non siamo usciti con un progetto preciso e non c’è abbastanza colloquio. La cosa importante è arrivare sulla strada della domanda, della diseducazione che ognuno poi può portare nella sua realtà e cercare di sviluppare anche partendo da questo contributo di oggi.
Lettera dal Campo di Novara
Il 9 settembre 1985, con una fermata all’aria, la maggioranza dei prigionieri della sezione speciale di Novara sono scesi in lotta contro le pratiche di annientamento e differenziazione del Ministero.
Si torna a parlare di carcere, e ancora una volta in occasione di nuove ristrutturazioni, cambiamenti, imposizione di nuovi e sempre più micidiali livelli di controllo e annientamento.
Del resto, a mano a mano che tramonta definitivamente l’epoca dello Stato assistenziale (la cui legittimità era legata alla capacità di assicurare “diritti” e “benessere”), sempre più... Lo Stato, nell’epoca metropolitana, impone una sua legittimità sulle capacità di “regolare” le contraddizioni sociali attraverso una iniziativa calibrata sempre più sulla capacità di “controllo e annientamento”.
Tutto ciò, e la necessità di mascherare lo scontro di classe e le lotte che si sviluppano nel carcere, richiede una “rappresentazione” e una “immagine”. E sul carcere si accendono i riflettori e le voci dello Stato.
L’offensiva propagandistica, che è stata ormai da mesi scatenata dal Ministero, è centrata sulle “grandi e luminose prospettive”... e su qualche “sgradevole necessità”.
Una campagna stampa massiccia e articolata con cui il direttore delle galere Amato ha sparso ai quattro venti le ottime intenzioni del Ministero: “Liberarsi dalla necessità del carcere”. Il culmine di questa campagna si è avuto a Milano al convegno ONU contro la “criminalità” con una vera e propria ufficializzazione di questo idilliaco progetto.
E tutto questo serve unicamente a rifare il trucco allo staff del Ministero perché non risultino troppo laceranti le concrete attuazioni di quelle che vengono presentate come “sgradevoli necessità”. Necessità che si possono condensare cosi:
Per la borghesia l’unico prigioniero buono è quello che diventa affabile, dissociato, pentito...
Per questo, ogni prigioniero deve essere segregato, controllato, isolato, annientato.
Allora, tra quasi tutti i compagni che hanno lottato è maturata la necessità di evidenziare i nodi e le questioni posti dalla situazione attuale e dai movimenti di ristrutturazione del carcerario.
L’annientamento e la cooptazione, la “sicurezza” e la “normalizzazione” sono in realtà un solo movimento, è il prigioniero distrutto e annientato nella sua identità, nelle sue relazioni che può essere “cooptato” e “risocializzato”. E la cooptazione è il “naturale completamento” alle strategie e pratiche di annientamento che sono dimensione costante del carcere metropolitano.
Così non stupisce che il nuovo salto di qualità della ristrutturazione carceraria, le “sgradevoli necessità”, il piano operativo di Amato sia una riorganizzazione del governo del carcere centrata su un ulteriore approfondimento ed estensione del trattamento differenziato e personalizzato e di un ulteriore sviluppo delle misure di “sicurezza” e “controllo” capillari della vita dei prigionieri. E che questo piano abbia come suo cardine la costituzione “per via legislativa” – e quindi permanente e definitiva – di un circuito superspeciale, dove il controllo sulla vita dei prigionieri, sui rapporti tra loro e con l’esterno, sia totale: colloquio coi vetri, controlli auditivi, massimo isolamento per 4.000 “soggetti a rischio” già individuati, stabiliti in base al tipo di reato, e quindi in rapporto all’identità del prigioniero.
E la pubblica enunciazione di questo piano operativo, significa che nei progetti ministeriali tutto è più che maturo, ed è volto unicamente a sollecitare una sanzione legislativa ad un processo già in atto.
Questo non è solo un progetto annunciato, è già in atto!
-
I braccetti con decreto amministrativo sono continuamente prorogati in attesa che la legge richiesta da Amato risistematizzi ed estenda le stesse condizioni di isolamento e annientamento ai 4.000 prigionieri di “massima pericolosità”.
-
Continui blitz di “normalizzazione” e “bonifica” prolungati nel tempo guidati da squadroni mobili di AC. scadenzati da perquisizioni, provocazioni, pestaggi.
-
Mantenimento di livelli di pressione fortissima e micidiale sui prigionieri di alcuni carceri, così da mantenere acceso in tutto il carcerario un generalizzato clima terroristico, da mantenere precisi poli di deterrenza, attraverso l’annientamento dei prigionieri di quelle carceri: Poggioreale, Buoncammino, Pianosa, Livorno, Cuneo...
-
Instaurazione di nuovi livelli di isolamento, con l’apertura di una nuova sezione distaccata nell’isola di Pianosa per sei compagni completamente isolati dal resto dei prigionieri.
-
Tutto ciò che il ministero propaganda come “umanizzazione” delle condizioni di detenzione, “non più unicamente punitiva”, maschera i sempre più diretti caratteri scientifici della individualizzazione del trattamento, della segregazione spinta ai massimi livelli, della imposizione “regolamentata” di un sistema di “premi-punizioni” che dovrebbe scandire e regolare ogni attimo di vita dei prigionieri. Un meccanismo di differenziazione dei prigionieri in buoni/cattivi, che una volta accettato dovrebbe spingere ogni prigioniero all’autodifferenziazione. È un processo che marcia a suon di circolari, l’ultima quella che subordina la concessione di colloqui straordinari e degli spazi di socialità interna alla disponibilità del “detenuto a collaborare attivamente alla osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo attuato nei suoi confronti”.
-
Una intera rete di nuovi carceri sorge come funghi, dotati delle strutture necessarie e funzionali ai contenuti di questo progetto: “complessi-gioiello, in cui la struttura cubicolare, cellularizzata, gli impianti di controllo visivo, l’isolamento dei prigionieri, a gruppi o individuale, permettono il massimo controllo, violente pressioni, l’individualizzazione estrema del trattamento, in una parola, il più scientifico “macello” psico-fisico dei prigionieri. Busto Arsizio, Aosta, Ivrea, Vercelli, Avellino, Como, Spoleto, Sollicciano. Cosenza, Belluno... sono stati costruiti più di 25.000 posti detenuto coi più avanzati livelli di annientamento negli ultimi 5 anni... non c’è davvero male come “abolizione del carcere”!
Contro questa ristrutturazione, contro queste condizioni occorre lottare, e da subito!
Perché la lotta è l’unico terreno che permette la socializzazione (comunicazione, organizzazione, confronto, decisioni) necessaria per opporsi ad un movimento così articolato e accelerato, per non farsi fare a pezzi, per liberarsi.
Perché solo la lotta permette di mettere un freno e fissare i singoli passaggi di questa ristrutturazione.
Perché solo la lotta riporta sul terreno concreto e costruisce la coscienza e la pratica proletaria della distruzione del carcere metropolitano.
Perché rimanere passivi all’incalzare di queste pratiche significa renderle più attive.
Contro il carcere occorre lottare e da subito dentro e fuori le galere.
Per questo ci sentiamo uniti e solidali ai compagni di Cuneo che venerdì 30 agosto sono scesi in lotta contro il blitz, i pestaggi, le perquisizioni, le provocazioni delle squadre speciali degli AC, anche nelle condizioni più dure, anche se solo in otto. Come dicono i compagni:
“Infine, perché in otto? Non ci interessa con questo comunicato esporre le ragioni politiche degli altri prigionieri. Intendiamo invece affermare che il carcere è un terreno di lotta, che non è pacificabile, e quindi la nostra volontà di lottare sempre”.
Lottare dentro, con tutti i proletari che si trovano a doversi misurare con queste condizioni e strategie di annientamento, che vivono la stessa dimensione “sociale”, che sentono le stesse tensioni a resistere all’annientamento, a lottare, a liberarsi, e che si organizzano per questo.
Lottare fuori, con tutti i proletari che nelle metropoli vivono il carcere come nemico diretto. Il carcere metropolitano non si limita a “contenere”, è attivo. Produce modelli di controllo e annientamento di valenza generale (come il “pentitismo” e le “dissociazioni”). Invade materialmente la metropoli organizzandosi e integrandosi nelle sue strutture (rapporto con Enti locali, “misure alternative”, reti di controllo tossicodipendenze, ecc.). Agisce sempre più direttamente come ricatto e pressione verso tutti i proletari che in numero sempre maggiore vivono quotidianamente nella metropoli in condizioni di extralegalità e antagonismo.
Il carcere nella metropoli è una macchina di morte che minaccia non più solo indirettamente (minaccia potenziale), ma direttamente tutto il proletariato metropolitano.
La distruzione delle galere è interesse e obiettivo di lotta di tutti i proletari nella metropoli.
Novara, settembre 1985
Terzo intervento di P. L.
Il dibattito mi pare importante soprattutto se pensiamo concretamente al fatto che fino a poco tempo fa eravamo vittime di analisi, di certezze considerate la base, il punto fermo su cui tutto il nostro lavoro di rivoluzionari era impostato.
Ora, noi, nel promuovere questo Convegno abbiamo cercato innanzi tutto di esporre delle analisi che non sono come quelle che in un certo modo escono su “Anarchismo”, che è uno strumento intermedio di approfondimento teorico (diviso tra analisi e cronaca) ed in quanto tale ha un vizio di fondo, un limite.
Un compagno ha aperto la discussione sulle varie tendenze e le prospettive del capitale e dello Stato, come vanno manifestandosi nei loro progetti di controllo, di repressione, di trasformazione dell’assetto societario. Questo processo è spiegato come un qualcosa che va al di là. Cioè questa tendenza è stata spiegata come qualcosa di oltre il semplice dato immesso nel computer, quindi tenendo conto dello sviluppo del processo. Il centro del discorso è stato quindi la capacità di gestione, la capacità di creare una produzione e un consumo di questa produzione che, a loro volta, creano questo famoso castello e separazione tra esclusi e inclusi.
Ecco, tutta questa chiave di lettura, che è tendenziale rispetto al progetto di controllo, cioè rispetto a quello che finora ha manifestato l’assetto societario che va modificandosi, è una delle poche analisi, in un certo senso, che cerca di riflettere più in là del semplice dato della trasformazione vista come potenzialità infinita del computer, per analizzare soprattutto che cosa? per analizzare quello che realmente è e può interessare il capitale, lo Stato, cioè le procedure della comunicazione, della separazione e l’emergere di un movimento di estraneità, da cui la chiave di lettura del sommovimento e il passaggio necessario dell’impegno del rivoluzionario verso quella che si chiama una strategia insurrezionale, cioè il fatto che il movimento sia in grado di acquistare, logicamente e razionalmente, una forza propria di trasformazione, più che l’effimera rivolta basata sul bruciare, cioè più di una semplice spinta propulsiva alla distruzione.
È chiaro che i compagni essendo disabituati a questo tipo di collocazione, a questo modo di ragionare, anche su problemi che ieri non c’erano, hanno trovato forse delle difficoltà – secondo me – ad esporre anche tanti dubbi che sorgevano rispetto a questo problema specifico, analitico. E quindi l’approfondimento è ancora in atto, secondo me, tutto da farsi. È stato, questo grado di analisi, non un’analisi definitiva, non è stata un’analisi che ha cercato di inglobare determinati dettagli, è stata un’analisi che tendenzialmente per quanto si attiene all’analisi stessa, ha voluto prospettare la sua ricerca, i suoi punti fermi, il suo guardare in avanti, più che riferirsi indietro, ma un guardare in avanti con una rapportabilità nell’immediato, visto che è un’analisi di parte inserita verso una spinta di un progetto insurrezionale, su cui si basa la sua soluzione, le sue motivazioni di ricerca.
Ecco, in noi, essenzialmente anche nei compagni, è sorto credo questo problema grosso: non siamo affatto i ruderi dell’Ottocento, come ci hanno voluto identificare, facendo vedere quel tempo di insurrezione, quel tipo di metodologia immaginata nell’Ottocento, qualcosa di cui noi stessi siamo i primi critici, ma abbiamo voluto sottolineare l’aspetto della rottura, il movente di fondo che lega la prassi trasformativa. Ecco, questo è chiaro che ha condizionato anche i compagni, in una discussione, data l’impreparazione mentale a recepire un discorso che non faceva di sé un modello, non costringeva i compagni dentro una gabbia mentale precisa, dove doversi rapportare e fare i conti, dove tutto è già stato deciso da chi ha organizzato la cosa.
Ecco, io credo, e sono convinto che nei tentativi, e quindi anche in questo tentativo, qualcuno abbia appreso che al di là delle idee che possedeva prima, ora ha appreso anche che esistono in atto, che la trasformazione è diventata molto più complicata e difficilmente raggiungibile secondo quegli antichi modelli che si conoscevano. Quindi, è vero, noi abbiamo attraversato la crisi di noi stessi e del nostro progetto, abbiamo attraversato la crisi del nostro non pensare. Oggi stiamo pagando uno scotto immenso, perché scopriamo all’improvviso che i discorsi fatti non reggono più, quindi non siamo più in grado di comunicare, perché c’è un rapporto anche all’indietro: prima comunicavamo che cosa? di cosa parlavamo? cosa dicevamo nelle nostre discussioni? Oggi invece stiamo prospettando non più di persuadere qualcuno intorno ad una tesi, ma stiamo presentando dei motivi di ricerca perché bisogna superare questo tipo di rapportabilità con la realtà, con cui facciamo i conti nel nostro intervento rivoluzionario.
E questo nei compagni, logicamente, ha creato il vuoto, il silenzio. Ecco. Credo che se c’è una conclusione da dare a questo Convegno è che il suo tentativo ha mostrato il nostro sforzo e anche il grado di possibile ricezione del modo di fare che hanno i compagni stessi. Cioè c’è questa impotenza nei compagni nel comunicare un qualcosa che non sia già datato, già fatto, già stabilito. Se qua avessimo parlato della rivoluzione vista in termini anarcosindacalisti, consiliaristi, probabilmente molti compagni avrebbero parlato. Se avessimo parlato della lotta per la casa vista come qualcosa di utile, che serve ancora a qualcosa... averne parlato come fallimento, come qualcuno ha fatto, o averne parlato come qualcosa che non può stare in piedi in un progetto insurrezionale attuale, come motivazione del semplice bisogno, che ha sottratto il terreno ai compagni, quel terreno usuale, quel terreno abituale su cui incentrano i propri discorsi, la propria prassi, ma anche il proprio limite, il proprio modo di non uscire da questo terreno, dal già seminato, dal già dato, da quello che ormai è un qualcosa di talmente acquisito e scontato che non consente modificazioni, mentre c’è una realtà che va ancora più avanti, che modifica gli stessi compagni che pensano di modificare qualcosa che si sta già modificando. Chi non coglie la realtà in movimento, chi non coglie per approssimazioni successive il movimento stesso della realtà che si trasforma, finisce per essere uno dei tanti meccanismi periferici, arretrati, cioè puntelli che lavorano all’indietro, e questo porta a quel grado di cose che comunemente uno conosce come “testimonianza”, come frammento storico, qualcosa a cui aggrapparsi.
Ecco, noi abbiamo voluto significare, con questa spinta, una ricerca del movimento anarchico, sia verso l’esterno che l’interno, diretta al superamento dei gruppi che non riflettono un’adeguatezza dell’intervento in rapporto alla realtà e da qui la critica all’organizzazione di sintesi, la critica ai vecchi modelli, con una propositività che lasciava e restituiva ai compagni la creatività rivoluzionaria, il senso di costruzione della forma nella concettualità, cioè riduceva alla sostanzialità il contenuto che i compagni hanno di autogestione, di autorganizzazione proletaria, dandogli la libertà, finalmente reale e vera, della loro forma, cioè la forma che assumono in base all’incidenza della lotta, in base alla capacità della lotta stessa di essere reale, di avere modi e forme proprie di manifestarsi.
Ecco noi abbiamo presentato questo piano di ricerca, come compagni di una parte del movimento, non di tutto il movimento ma di una parte precisa. E presentando questa ricerca abbiamo, in un certo senso, voluto coinvolgere i compagni perché questa ricerca non sia un patrimonio, un monopolio di una parte, ma sia un patrimonio di tutti. Ecco perché abbiamo voluto ridiscutere e ridiscutiamo in avanti e non indietro il senso del perché oggi manca nella realtà un progetto anarchico insurrezionale. Ne abbiamo voluto manifestare la reale esigenza, ma abbiamo anche voluto dire che per manifestare una esigenza bisogna avere occhi diversi, non i soliti occhi, bisogna fare degli sforzi immensi, diversi dai soliti, bisogna prendere in considerazione il qualitativo rispetto al mito del quantitativo.
Ecco, noi apparteniamo, in un certo senso, a una fase del lavoro rivoluzionario che è una parte importantissima che è quella della preparazione. Oggi siamo in una fase di preparazione, di aggiustamento teorico, di tentativi, tentativi che si devono operare per conoscere, ma per operarli bisogna possedere tutte le valenze passate perché per superare bisogna conoscere. Ora, noi conosciamo il nostro passato, conosciamo quanto abbiamo fatto, quanto era limitato, ma per andare avanti bisogna possedere quel qualcosa in più, questa ricerca, questa voglia di fare un tentativo nella ricerca, non il tentativo del già dato, non il tentativo del già conosciuto. Ecco perché nei compagni oggi sorgeranno più interrogativi che una certa base di cose. È chiaro che l’operatività nasce dal fatto che i compagni oggi devono assumersi, in questo fatto, la ricostruzione delle forme e quindi la praticabilità e la sostanzialità dei concetti, una progettualità diffusa, per cui diventano essi stessi i progettatori del proprio senso di autorganizzazione, sia specifica, sia riguardo le lotte in cui si trovano dentro. Ecco, in questo senso si acquista un’altra dimensione e si restituisce la dimensione rivoluzionaria al suo lavoro informale, cioè al suo lavoro che non è mai stato quello di focalizzarsi, cioè si focalizza qualcosa in una situazione rivoluzionaria, là dove c’è stata una rivoluzione. Allora la creazione dei soviet è stata una focalizzazione del momento insurrezionale, la soluzione data limitata esclusivamente a quei problemi, la sua validità era allora e non oggi. La validità del sindacalismo era nel momento in cui vi erano le borse in Francia dei lavoratori, erano lotte radicali e vi fu l’entrata degli anarchici per usare quegli strumenti che in quel momento davano e focalizzavano un progetto insurrezionale. Oggi il sindacalismo, il consiliarismo, queste parzialità non sono più ritenute valide. A dimostrarlo non siamo tanto noi quanto la realtà stessa che le estranea, le supera, le cancella.
Tutto questo discorso l’abbiamo fatto qua perché abbiamo voluto avanzare delle tesi, avanzare soprattutto un senso: la ricerca nei compagni è importante, e abbiamo voluto dimostrare ad altri che non siamo noi i reperti archeologici, ma sono coloro che si trovano dentro al vecchio mondo avendone accettato le logiche, sia che queste siano anarcosindacaliste oppure siano altre logiche, quelle ancora più scontate, di adeguamento alla socialdemocrazia e ai suoi diversi movimenti.
Ecco, penso che dietro tutto questo, fuori di qua, i compagni possano e debbano aprirsi al fatto che l’operatività nei compagni stessi nasce da questa ricerca, quella realtà, non quella quantitativa, non quella fatta da migliaia di tentativi, ma quella fatta da piccoli tentativi, fatti in una selezione, in una obiettività di comprensione della realtà della ricerca che consente di smuovere, di rompere.
Ora, se siamo stati in grado di avere recepito questo discorso, di averlo fatto proprio, di elaborarlo, lo dimostreremo fuori di qua col tempo, nell’immediato, in quello che sapremo progettare e mettere in chiaro sul nostro territorio.
Io credo che questa soluzione, o non soluzione, sia quello che ci restituisce, brutalmente, la difficoltà. Noi abbiamo due cose di fronte, sostanzialmente: la scelta di camminare sulle difficoltà, sul filo spinato delle difficoltà: oppure l’acquiescenza di ciò che già conosciamo per cui in fondo siamo anche noi degli integrati.