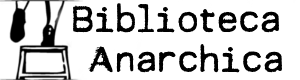Prima edizione: maggio 2015
Alfredo M. Bonanno
Distruggiamo le carceri
Introduzione
Il carcere è la struttura portante dello Stato. Carcere e Stato sono due angolazioni della medesima mostruosità. Gli anarchici sono contro lo Stato, ecco perché sono contro il carcere.
Poiché rifuggiamo, come più volte detto, da affrontare problemi della società del futuro, quella per intenderci fondata sulla bellezza dell’anarchia, e ci interessiamo di questioni terrene e non angeliche, tutto si riduce a discutere sul termine “contro”.
Che vuol dire essere contro il carcere?
È presto detto. Siamo per la distruzione del carcere. Allo stesso esatto modo di come siamo per la distruzione di questa società in cui ci stanno affogando.
Quindi non siamo, solo a chiacchiere, contro il carcere ma anche con i fatti. Fatti e preparazione di fatti. Siamo per i progetti, per la conoscenza dettagliata di rapporti, responsabilità (individuali e strutturali), dislocazioni nel territorio, regolamenti che consentono la gestione di decine di migliaia di persone racchiuse tra quattro mura, private della libertà.
Distruggere lo Stato. Distruggere il carcere.
Trieste, 8 maggio 2014
Alfredo M. Bonanno
Conferenza di Monza
Parlare del carcere è una delle cose più difficili, secondo me.
Anche le interviste che nel filmato che abbiamo visto, in fondo, non dicevano delle cose sbagliate.
È proprio quello che la gente pensa. Cioè, io non voglio parlarvi della possibilità di un mondo senza carceri, in altre parole di una utopia anarchica. Una società libera finalmente, in cui saremmo tutti fratelli perché vivremmo tutti basandoci sulla presa nel mucchio di cui parlava Kropotkin.
A me non interessa questo discorso. Non sono venuto qua stasera per dirvi come si possa costruire una società senza le carceri. Mentre, quello che a me interessa molto di più è capire cosa possiamo fare oggi, nella società in cui viviamo, per lottare contro il carcere.
Prima di tutto dobbiamo renderci conto quindi che è questa società che non ci appartiene e alla quale noi siamo estranei. Siamo un corpo estraneo, questa società ha bisogno del carcere.
Quindi, partiamo da questo concetto: il carcere è funzionale a questa società. Se noi parliamo, o vogliamo parlare di una lotta contro il carcere, non possiamo tagliarla da una lotta contro questa società. E finché non chiariamo questo concetto non ci intendiamo, noi parliamo di due cose diverse.
Ora, per capire che cosa, nella sua specificità, sia il carcere, dobbiamo condurre la lotta contro il carcere all’interno della nostra lotta contro la società, contro lo Stato, contro il potere che ci opprime. È questo lo spostamento che dobbiamo fare. Non possiamo noi parlare, non possiamo parlare di una lotta contro il carcere come di una lotta specifica, quindi documentarci, diventare specialisti del carcere, parlare esclusivamente del carcere. La gente non ci capisce. Chi sono questi marziani che parlano contro il carcere? Come mai la povera vecchietta di cui parlavamo prima, dice: “Io ho paura. Se non ci sono le carceri come faccio a dormire la notte con tanti delinquenti che ci sono in circolazione?”. Come darle torto? Quindi non è che possiamo convincere la gente a fare a meno del carcere. Dobbiamo convincere la gente a fare la rivoluzione per abbattere questa società che ha bisogno del carcere. È questo il programma. È per questo che dobbiamo capire come funziona il carcere. Perché il carcere è il cardine, la base, il fulcro attorno a cui ruota la società. Una società di prevaricazione, di sfruttamento, una società assassina ha bisogno necessariamente di mettere la gente che si ribella contro di essa all’interno di un posto chiuso, da cui questa gente “criminale”, “delinquente” non possa uscire. In caso contrario non si può reggere lo sfruttamento, non si può reggere la repressione. Questo dobbiamo capire.
Quindi quando qualcuno, come qualche “scienziato” specialista del carcere, mi parla della necessità di procedere all’abolizione del carcere, mi viene da ridere, amici e compagni. Mi viene da ridere perché abolire, se capisco la lingua italiana, significa tagliare, “ablare”, togliere una parte. Come si fa a togliere da questa società una parte che le è alla base? Togliere la “parte” carcere dalla società non è possibile. Come si potrebbe togliere? Con una bellissima legge fatta da un governo che dice: “Aboliamo le carceri”? Certamente no. Quindi l’unica soluzione che possiamo ipotizzare, una soluzione pratica, concreta, non utopica, che possiamo ipotizzare parlando di lotta contro il carcere, è la distruzione del carcere.
Io questi concetti non solo li dico qua, li dico da quarant’anni, ma li ho anche detti in carcere, li ho anche detti in dibattiti che si sono svolti in carcere, li ho detti a compagni miei che erano in carcere insieme a me e che vivevano le condizioni di repressione specifiche dei detenuti.
Ora, chi sta fuori, e si propone il problema di portare avanti una lotta che convinca il cittadino medio, chiamiamolo così, la persona che ci sta ad ascoltare, il benpensante che nello stesso tempo è un po’ illuminato perché non è del tutto fascista ma ha delle idee grosso modo pallidamente di sinistra, ora, chi di noi si propone di parlare a questa gente, che costituisce la grande maggioranza, più o meno rumorosa che essa sia, che cosa può dire? “Quanto sono cattivi questi repressori che sono al governo, che si sono mangiati i soldi, che hanno rubato a man bassa, che invece di fare stare in carcere quarantamila poveri detenuti, li hanno portati a sessantaseimila”. Che bei numeri che sono questi qua! Perché non costruiamo altre carceri in modo che la percentuale di distribuzione di questi sessantaseimila, che nei prossimi due anni saranno ottantamila, si riduca e questi poveretti staranno più comodi? Quanto è brutto che in una cella con otto letti, quattro o cinque devono dormire due nello stesso materasso, e come si fa poi che in questo materasso non si possono commettere orrendi crimini di tipo omosessuale, e così via? Chi se ne frega. Chi se ne frega. Che cosa possiamo dire su questi argomenti?
Ebbene, compagni, spesse volte caschiamo nell’equivoco di dire alla gente esattamente quello che la gente si aspetta di sentirsi dire. Perché non vogliamo disturbare, vogliamo che la gente venga con noi, ci aiuti, quantitativamente diventi significativa a fianco a noi, perché noi siamo quelli che sappiamo che cosa è veramente il carcere e sappiamo anche che, in fondo in fondo, le notizie che ci arrivano dal carcere non sono totalmente d’accordo con la tesi, anarchicamente corretta, di una distruzione del carcere.
Certo, per il detenuto che è in carcere, e che sa che deve scontare una pena più o meno lunga, il suo progetto di vita quale può essere? Prima di tutto quello di stare meglio, cioè a dire meglio a breve scadenza, stare meglio il giorno dopo, secondo di avere più ore d’aria possibile, terzo di vedere il più possibile altri detenuti, massimamente la sera in quelle due ore che si chiamano, tra virgolette, socialità, non so per quale diavolo di motivo, così si esce e si va nella cella vicina per scambiare con altri detenuti i dolori reciproci, il fatto di essere tutti tra quattro mura, di non potere respirare, e tutto il resto. Questo pensa il detenuto.
Pensa ad esempio: “perché questi disgraziati che stanno al governo non fanno un’amnistia?”, confondendo poi l’amnistia che ai detenuti non interessa un cazzo con l’indulto che è la sola cosa che interessa loro, perché l’amnistia interessa ovviamente soltanto ai giudici e non ai detenuti. Ma queste sono faccende di tecnica carceraria e a noi, anarchici, che cosa ci interessano questi problemi? A noi interessa che andiamo davanti a un carcere, stendiamo un lenzuolo lungo cinque metri e diciamo: “aboliamo le carceri”. Che cazzo possa poi voler dire “aboliamo le carceri”. Oppure, “noi siamo contro le carceri”, oppure quando si può una volta ogni tanto potere usare – che agli anarchici non succede spesso – usare il cervello, dire: “distruggiamo le carceri”. La gente dice: “questi sono pazzi”, perché che cosa significa distruggiamo le carceri?
Ci siamo mai posti il problema di coordinare la nostra lotta contro le carceri con la nostra lotta, sia pure intermedia, non pretendo una lotta insurrezionale che sbocchi e si concluda nella rivoluzione, nella nostra lotta che facciamo quotidianamente, di portare il carcere all’interno di questa lotta? Ci siamo mai posti questo problema? Non ce lo siamo posti. Nella maggior parte dei casi, tristemente, non ce lo siamo posti. Ci siamo posti il problema di entrare in contatto con i detenuti a prescindere, a prescindere, sottolineo questo verbo, dall’aspetto personale, o sentimentale, con i detenuti che stanno dentro, perché guardate che i detenuti sono delle sanguisughe, perché cercano qualunque occasione per potere avere quel minimo di possibilità di respirare un’aria che viene dall’esterno, un’aria pulita, un’aria libera – per loro, ovviamente –, perché stanno dentro poveracci e sono comprensibili, si possono anche capire – però non bisogna cascare nell’equivoco di fare dell’assistenzialismo, di diventare cioè gli infermieri, o le infermiere, o il sostegno, o la piccola boccata di ossigeno per i detenuti. Anche queste sono delle domande. Ci siamo posti il discorso, serio, di entrare in rapporto con i detenuti? Ci siamo posti il discorso serio di conoscere la composizione carceraria che c’è oggi nelle strutture che ci stanno di fronte? Come è cambiato il clima che si respira oggi nelle carceri? Non ci siamo posti questi problemi. A quel che a me risulta. Io spero che nell’auspicabile dibattito che succederà alle mie poche parole si possa prendere questo argomento.
Perché, se togliamo la discussione che ho detto prima della ipotesi utopica di un mondo senza carceri, di cui a me interessa poco, se togliamo la discussione dell’abolizione delle carceri che ovviamente è una stupidata democratica, se togliamo la funzionalità del concetto di carcere, nel senso che il carcere non serve affatto a un recupero. Il concetto di carcere si basa sulla pena, cioè sul fatto che io ho commesso un fatto che secondo i dominatori è un reato e quindi è giusto che io vada in carcere. Basta, perché questo lo stabilisce la legge e non si discute. Ora, se togliamo tutto questo, cosa ci resta? Nulla, soltanto la distruzione delle carceri.
Siamo in grado di potere essere capiti dalla gente a cui comunque noi pretendiamo di fare un discorso, sulla base esclusivamente di un concetto di distruzione delle carceri? No, non siamo in grado. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di approfondire le contraddizioni che stanno all’interno delle singole interpretazioni, dei singoli sentimenti che costituiscono quello che si chiama il sentire comune, l’opinione che oggi è in circolazione, capire qual è la differenza tra la condizione del passato, di appena venti, trenta, quarant’anni fa, e che cosa è successo nel frattempo? Perché oggi la repressione non si basa più soltanto sul fatto di togliere dalla circolazione le persone pericolose, ma anche di togliere dalla circolazione persone che possono creare un pericolo in futuro, cioè in una situazione appena appena oggi ipotizzabile. Quindi, questo numero di persone che stanno in carcere, che vengono tolte dalla circolazione, non vengono colpite perché costituiscono oggi un pericolo oggettivo, ma perché potenzialmente in futuro possono costituire un pericolo oggettivo.
Basta pensare alla comunanza, all’eguaglianza che c’è oggi tra carceri – poco fa si è sentita la distinzione tra case circondariali e case penali, piuttosto confusa, in effetti non c’è distinzione se non tecnica, sostanzialmente sono la stessa cosa, sono carceri e basta – e campi di concentramento, luoghi dove oggi vengono messe le persone che vengono da fuori, che non hanno quello che non so come diavolo chiamare: cittadinanza o permesso di lavoro, ecc., vengono poste in questi luoghi “limbo”, non so in che modo possano essere definiti se si esclude la parola carcere. Quindi, i detenuti in Italia, non sono circa 66.000 ma sono circa 90.000. Ora, se noi pensiamo che questo numero diventa quasi il due per mille della popolazione italiana, capiamo subito quale potenzialità eversiva, non rivoluzionaria, ma eversiva, abbiamo davanti.
Entrare quindi in contatto con la condizione carceraria significa conoscerla. Non è vero che nelle carceri non ci siano, dall’interno, cioè da parte dei detenuti, dei segnali di movimento, cioè tentativi di ottenere una maggiore capacità d’azione dall’interno delle carceri. Solo che noi, di questa enorme difficoltà che si esprime in piccole iniziative che vengono prese all’interno delle carceri, anche oggi, non abbiamo alcuna cognizione, nel senso che non sappiamo in che modo può accadere una piccola manifestazione di dissenso all’interno delle carceri, per qual motivo questa può svilupparsi, quali sono i suoi limiti e quali sono principalmente le difficoltà.
Ora, io voglio fare un esempio, perché essendo un ex carcerato, so di che cosa sto parlando, questo è un argomento specifico che soltanto chi è stato in carcere può capire. Noi, ad esempio, siccome siamo rivoluzionari, abbiamo una cognizione piuttosto critica del concetto di sciopero. È logico, uno pensa, sciopero, chi se ne frega. Sappiamo cosa è successo dopo le vecchie tesi di due secoli fa sullo sciopero come momento rivoluzionario e così via, dopo l’inquinamento sindacale che tutti conosciamo, sappiamo che quelle tesi non valgono più nulla. In carcere non è così. Il concetto di sciopero in carcere è estremamente delicato, estremamente difficile. Voi pensate a come si può organizzare uno sciopero in un carcere. I detenuti si vedono all’aria. Parlano fra di loro in piccoli gruppi. Normalmente, nel passeggio, dove i detenuti passeggiano due ore al mattino e due ore al pomeriggio, quando non è minore questo spazio di tempo a loro gratuitamente assegnato, qui parlano di organizzare questa piccola manifestazione. Normalmente è una manifestazione graduale, in quanto può essere ad esempio uno sciopero del carrello, cioè un rifiuto del cibo che viene portato cella per cella, può essere lo sciopero di qualcosa di più importante, uno sciopero dei colloqui con i familiari, a esempio, oppure uno sciopero di ricevere i pacchi, oppure uno sciopero della fame.
Ora, se i detenuti vedendosi all’aria fra di loro, parlando, individuano qualcuno – come potrei essere io, come tantissime volte in tante carceri mi sono trovato al centro di questa particolare attenzione da parte dei detenuti – che sa leggere e scrivere e parlare meglio di altri, cercano di spingerlo a dire che cosa fare, a dare indicazioni, a parlare col direttore, non fare questo, non fare quello? Bene. Questa sembrerebbe la strada più semplice, anzi sembrerebbe come se un rivoluzionario – come me – trovasse modo di dire qualcosa in una assemblea numerosa, per dare indicazioni di lotta, ecc., a favore dei propri compagni detenuti. Errore. L’indomani mattina ti trovi trasferito in un altro carcere. Loro hanno immediatamente lo strumento per stroncare tutto. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna suggerire, se si vuole a esempio organizzare lo sciopero della fame, che l’indomani mattina ogni detenuto metta sul blindato cioè sulla porta corazzata della cella un appunto scritto a penna dove sta scritto: “visita medica”, per cui quanti sono? Trecento, quattrocento detenuti, si mettono tutti in fila all’infermeria e bloccano tutto il carcere, senza che si possa individuare un responsabile.
Ora, io non sto facendo un elogio iconografico di quello che accade in un carcere, sto dicendo che quello che fuori sembre una minchiata dentro non lo è, dentro diventa una cosa complicata tecnicamente e produce effetti estremamente dirompenti perché si blocca una organizzazione che invece deve continuare a funzionare, non può essere bloccata. Quindi devono fare intervenire medici da fuori, devono intervenire strutture repressive differenti, devono alla fine valutare se conviene o no concedere quella piccola richiesta che viene avanzata dai detenuti. È questo che noi dobbiamo cercare di capire: cosa accade nelle carceri che diventano oggetto della nostra attenzione rivoluzionaria. Entrare in contatto, cosa possibile, ovviamente nei modi e con le cautele che ognuno studierà, a me non interessa questo aspetto, ma che devono essere studiate, entrare in contatto per sapere quali sono le lotte che vengono realizzate all’interno del carcere. Solo in quel caso la manifestazione davanti al carcere può avere un risultato, un risultato di conforto e di sostegno per quelle che sono le lotte in carcere che sono, come dire, apparentemente semplici ma sostanzialmente molto complicate, e nello stesso tempo può avere un risultato perché fa conoscere la realtà del carcere che, come un bubbone, si trova all’interno del tessuto sociale e la gente non se ne accorge.
Per esempio, a Trieste, dove io vivo, il carcere si trova in pieno centro, attaccato, secondo l’uso austriaco, al tribunale, ed è assolutamente sconosciuto alla gente. La gente passa ogni giorno davanti a questa costruzione dove ci sono le celle, dove uomini e donne soffrono da anni chiusi lì dentro, e non sa nemmeno di cosa si tratta, e non basta certamente un piccolo striscione, o anche un grosso striscione posto là davanti, con quattro o cinque compagni, pieni di buona volontà a cambiare questa condizione sociale.
Occorre pertanto un progetto che abbia un significato più a lunga scadenza e che abbia anche una capacità di coordinare le lotte che si svolgono in altre situazioni, in altre contesti, lotte che riusciamo a realizzare, di coordinazione tra carcere e territorio.
Non credo di essere stato in grado di farvi capire quali sono i miei sentimenti profondi, cioè quello che scatena dentro di me di indignazione, di odio, di ribrezzo, di schifo, quando parlo del carcere. Ma, nello stesso tempo, il carcere costituisce una parte della mia vita, costituisce uno dei miei amori. Quando io penso alle notti in solitudine che ho passato dentro tante celle di tanti carceri, è come se una parte della mia vita fosse rimasta lì dentro quando sono andato via. Quindi io so che in quel posto dove sono stato io altre persone stanno soffrendo e questo non può essere dettagliato nel mio ragionamento freddo che cerca di capire qual è la realtà del carcere.
Io voglio che voi capiate che dovete mettercelo dentro questo sentimento, questo senso di paura che dà il carcere, senso che è anche di amore, perché è un luogo di sofferenza che sta facendo soffrire altre persone. E la distruzione di questo luogo. E la distruzione di questo luogo deve essere assolutamente il primo compito di ogni anarchico e di ogni rivoluzionario.
Scusatemi.
Domanda sulle lotte parziali in carcere.
La questione dei conti correnti non l’ho capita. Io ho lavorato anni ai conti correnti e non ho capito quello che vuoi dire. Bloccare i conti correnti, a parte la questione tecnica che qui interessa poco, io penso forse che tu voglia riferirti al blocco degli acquisti? Il conto corrente non lo puoi bloccare perché resta là. Puoi impedire l’arrivo di nuovi soldi, o non comprare al sopravvitto. Questo è possibile. Ma questo interessa poco il carcere. Quello che invece interessa e danneggia veramente il carcere sono due cose: le pulizie, cioè lo sciopero dei lavoranti, che blocca la cucina e le pulizie, e lo sciopero della fame perché ti devono controllare ogni giorno col medico, e devono avere delle strutture che non è tanto facile per loro avere.
Ma il problema vero è come entrare in contatto con i detenuti. Per prima cosa quando un nuovo aggiunto arriva in un carcere è difficile che riesca a entrare in contatto con gli altri detenuti, deve passare del tempo, chiunque egli sia, anche l’imperatore delle rivoluzioni. Per altro non è possibile, e non è nemmeno giusto, mettersi a dire facciamo questo o facciamo quello, perché uno che arriva non può dire qualcosa a quelli che da anni sono in un posto e conoscono bene i rapporti di forza che ci sono. Occorre quindi un pochino di intelligenza o, per meglio dire, di prudenza, perché sono luoghi un pochino pericolosi, nel senso che se uno sbaglia a parlare corre il rischio, se gli va bene, che si piglia una bella bastonatura, e se gli va male potrebbe anche giocarsi la pelle. Conseguentemente non è consigliabile agire in modo imprudente in carcere, essendo un luogo pericoloso.
Ora, entrare in contatto con i detenuti, per un compagno che entra in carcere, significa avere chiara l’idea della tipologia che ha davanti, perché non tutti i detenuti sono uguali. Le nostre belle chiacchiere ideologiche in carcere non funzionano. Ci sono davanti ai tuoi occhi delle strutture fatte di detenuti, i detenuti sono bestie particolarmente pericolose perché sono uomini e donne costretti a essere privati della libertà. E quando a un uomo e a una donna hai levato la libertà gli hai levato il novanta per cento della propria umanità. Quindi sono persone disumanizzate. Con queste persone non ci si può rapportare come ci rapportiamo qua, fra compagni, fra amici, fra conoscenti, come due che si incontrano per strada ed educatamente si dicono: “scusi, permesso, si accomodi, ecc.”. Cortesie che in carcere non si usano. O se si usano si usano con una sfumatura, con un sottile tono di ironia o di secondo fine, che bisogna calibrare volta per volta, per cui occorre avere una certa pratica o impiegare un minimo di prudenza e di intelligenza.
Certo, è chiaro che in carcere ci sono determinate categorie che hanno un maggiore peso, ed è proprio nei riguardi di queste categorie che bisogna vedere che cosa esse vogliono fare. Perché se uno si mette a dare di coccio con la testa contro il muro, si spacca la testa e non conclude niente. Ora non dico che bisogna mantenere un distanza politicamente corretta, ma non si può nemmeno pretendere di imporre la propria visione del mondo, perché è la propria visione del mondo, a quella degli altri. E il carcere è l’ultimo posto del mondo dove si possono mettere in atto esercizi di autorevolezza gratuita. Non funziona in carcere.
Come entrare in contatto dall’esterno, compagni che in questo momento, come per esempio noialtri, con persone che sono in una condizione come quella, ad esempio, del carcere di Monza? Ci sono dei metodi normali, ne abbiamo parlato prima. Conoscenze personali, rapporti diretti che bisogna cercare di oggettivizzare per quanto è possibile, sottraendoli alle intenzioni sempre assorbenti da parte del detenuto, perché succhia, cerca di succhiare quella vitalità che pensa ci sia nell’altro: parente, amico, conoscente, o supporter esterno. Ecco bisogna tenere conto di questo e collocare il rapporto in modo possibilmente oggettivo. Secondo, ci sono delle strutture ufficiali che possiamo utilizzare. Cioè ci sono delle organizzazioni carcere-territorio. Non entrare a fare parte di queste strutture, ma stare a sentire quello che fanno, perché attraverso di loro, attraverso i loro documenti, le loro iniziative, si può capire qual è il termometro della situazione carceraria in un dato contesto. Io penso che anche in questa città o in altre città vicine ci siano strutture di questo genere, strutture essenziali, strutture di volontariato, strutture di partito come quello radicale, come altri imbecilli di questo tipo che hanno, chiamiamola, questa visione della vita, per non dire una parola che direbbe poco o nulla, questa visione della vita di volere reggere la coda ai detenuti. Ecco nel momento in cui loro reggono la coda dei detenuti, noi possiamo apprendere alcune notizie che possono esserci utili da un punto di vista rivoluzionario.
Dice: questo lavoro somiglia molto al cosiddetto “entrismo” politico. Nossignori. Somiglia molto, invece, alla concretezza del lavoro sul carcere. Qua stiamo parlando di cosa significa mettere le mani a mollo, bagnarsi le mani. Se vogliamo essere puristi, io sono anarchico, mi interessa allora solo il giorno in cui ci sarà la grande esplosione per l’anarchia. Quando faremo l’anarchia svegliatemi dal mio sonno attuale che io sarò sicuramente con voi. Se ragiono in questo modo il discorso finisce là. Se invece voglio fare qualcosa di più concreto, cercare di agire nella realtà, devo cercare di documentarmi riguardo a questa realtà, e nella documentazione oggettiva, di difficile reperimento, può anche darsi che io sia costretto a sporcarmi le mani.
Decidete voi.
Domanda sul lavoro sul carcere. Poco gratificante. Struttura carceraria che si complessifica. Premialità. Differenziazione. Recupero. Campi concentramento emigrati. Alta sicurezza.
Io volevo aggiungere solo una cosa. L’intervento precedente è stato molto esauriente. Io spesse volte, trovandomi in carcere, mi sono chiesto: “È il caso che io entri in rapporto con strutture di sostegno dei carcerati?”. A esempio, nel carcere di Bergamo, dove sono stato due anni e mezzo, c’era una struttura che si chiama “carcere-territorio”, ed era costituita da persone che venivano da fuori, esponenti del mondo della scuola, dei sindacati, che si interessavano, partendo dalla mentalità della gente che è stata intervistata prima, nel filmato che abbiamo visto, dei problemi del carcere, delle condizioni carcerarie, e così via. Essendo in un periodo in cui abbiamo organizzato uno sciopero della fame che è durato sei giorni, e io ho fatto lo sciopero della fame per la prima volta in vita mia, mi sono chiesto: “È il caso che mi metta a parlare con questa gente?”. E ho concluso, cioè, mi sono ricordato che mi avevano insegnato che quando uno si trova ad affrontare una lotta impari non è che deve cercare di mettere prima sul piano della parità lo scontro, ma deve attaccare subito, a fondo, e colpire nei punti più delicati. Cioè se io vengo assalito, non è che prima mi metto a discutere fissando le regole dello scontro, per ottenere che ci si colpisca in modo corretto. Io cerco di mettere due dita negli occhi al mio assalitore, ecco la prima cosa che faccio, per metterlo fuori combattimento. Qualcuno potrebbe dire: “Ma non è moralmente corretto”, no, non lo è, e allora? Devo forse farmi mandare all’ospedale per essere moralmente corretto? No. E allora ho applicato questa mentalità, che mi ero costruita altrove e in altri periodi della mia vita. Ho parlato quindi con loro e, in una riunione nel cinema del carcere (Bergamo, via Gleno, è un carcere modello, moderno e molto grande, ma in fondo è un carcere come tutti gli altri) insieme a tutti gli altri detenuti, il presidente di questo comitato ha tirato fuori un documento che avevano scritto loro, sul nostro sciopero della fame, non si capisce perché io che mangio posso scrivere qualcosa sull’esperienza di qualcun altro che non mangia, ecco, non si capisce. E allora io mi sono alzato e ho detto: “Scusi, no lei non scrive una cosa a nome nostro, siamo noi caso mai che scriviamo a nostro stesso nome, lei può solo prendersi questo foglio di carta, scritto da noi, lo porta fuori di qua e lo fa conoscere”. E così dalla platea abbiamo dettato alla tribuna quello che costoro dovevano scrivere. Cioè non è che non sia possibile utilizzare questa gente, ma solo quando ci si trova in una situazione di forza, quale era quella di noi che in carcere stavamo conducendo una lotta importante come lo sciopero della fame, per cui potevano, come dire, ricattarla, cioè ricorrere a uno strumento eccepibile quanto volete voi, però che nella concretezza funziona. Perché quando mi volevano trasferire, sempre nell’esperienza del carcere di Bergamo, in quanto potevo essere uno di quelli che avevano messo, come dire, il fiammifero sotto la carbonella, ho colto l’occasione della venuta del vescovo di Bergamo – venuto per Natale a dire la messa in carcere –, sono andato alla messa, io vecchio anticlericale e ateo, sono andato a messa, ho ascoltato tutta la messa e alla fine ho detto al vescovo: “Scusi eccellenza, ma lei dov’era quando noi stavamo facendo lo sciopero della fame?”. Questo vecchio sembrava un bambino piccolo, si giustificava davanti a me, dicendo: “Ma io non sapevo, non sono stato avvertito, sono stato dal Papa a presentare le dimissioni perché ho settantasette anni (non so quanti anni avesse esattamente), però da questo momento se non vengo avvertito dai cappellani, li licenzio”. E io non sono stato trasferito per intervento del vescovo. E quando direttore e maresciallo, minacciavano qualche cosa, dicevo subito: “Attenti, altrimenti scrivo una lettera al vescovo”.
Ora, io mi sono chiesto: perché ci facciamo tutte queste preoccupazioni di ordine morale, perché siamo i cavalieri dell’assoluto? Non lo so.
Domanda sui prigionieri politici.
Se c’è una cosa che nell’intervento della compagna mi ha colpito è questa: dopo tanti anni ho sentito parlare di prigionieri politici. Ragazzi, che cosa vi posso dire, io non so chi sono questi prigionieri politici. La compagna ci ha spiegato chi sono i prigionieri politici, ha detto: “Sono quelli che lottano contro la società”. Consentimi, non sono d’accordo. Per me i detenuti sono tutti uguali. Permettimi di dire come la penso io. Oppure forse non ho capito io, quindi spiegaci cosa volevi dire. Io non lo condivido questo concetto di prigionieri politici. Perché sono stato in carcere, sono un compagno anarchico e non mi sono mai definito prigioniero politico. Sono stato in carcere per rapina, per banda armata, per avere scritto delle cose, ma non mi sono mai detto prigioniero politico.
Domanda sull’autorganizzazione, conflittualità permanente, ecc.
Lasciamo stare l’ultima parte del discorso, riguardante i prigionieri politici, perché è troppo complessa per le mie modeste capacità intellettuali. Invece la parte riguardante la conflittualità permanente mi sembra importante in quanto penso che il compagno volesse riferirsi al problema di una organizzazione minimale di base che i compagni possono darsi, organizzazione basata sull’affinità, sulla conoscenza reciproca, sull’approfondimento di questa conoscenza, sulla costituzione di piccoli gruppi informali per decidere le azioni da fare. Noi abbiamo accennato, non parlato ma solo accennato, a un progetto di lotta riguardante la specificità del carcere da condursi all’interno della specificità delle lotte in generale, dove dovremmo essere presenti. Spiegare alla gente, in altre parole, che il carcere fa parte della società, e fare loro conoscere veramente che cosa è l’esistenza di migliaia, decine di migliaia di persone carcerate.
Che cosa significa? Veramente. Ma c’è anche un altro aspetto, quello dell’attacco vero e proprio. Guardate che nella storia nostra, recente e meno recente, le strutture repressive del mondo carcerario, del suo ambiente, sono state attaccate, e questo attacco, come esso si è realizzato, ognuno se lo va a cercare nelle carte che sono state pubblicate e ripubblicate a iosa, che sono disponibili dappertutto. Questi attacchi ognuno se li va a cercare e può scoprire che sono stati attaccati i responsabili, i responsabili di quello che accade nelle carceri e sono state attaccate le strutture sulle quali si basa la possibilità di rinchiudere persone sottraendo loro la libertà.
Questi attacchi possono essere in futuro, sapete, ogni tanto, essendo vecchio, mi viene il desiderio di sognare quello che può accadere in un futuro prossimo, possono, dicevo, essere ripresi in un’altra situazione, in un’altra condizione, da persone diverse da quelle che si trovano qui dentro in questo momento, mentre sto parlando. Per carità, lungi da una responsabilità collettiva. Ma può anche capitare, chissà, che qualcuno, una sera, possa farsi una passeggiata e individuare qualche responsabile di queste belle strutture che ci stanno davanti e che si chiamano carceri. Possa anche individuare qualche bel muro da buttare giù, una parte di queste strutture repressive che si chiamano carceri. Chi lo sa? Lasciatemi sognare ogni tanto, no? Non è impossibile farlo.
Comunque non so se ho risposto bene alla domanda che mi era stata fatta, scusatemi se ho un po’ preso altre strade, cosa volete, capita.
Domanda: detenuti esistenziali, nessuna differenza.
Scusate se capovolgo l’ordine del ragionamento. Mi interessa molto l’ultimo aspetto e di meno il primo. Tu hai posto una serie di argomenti. L’ultimo di questi argomenti riguarda l’analisi da cui sono partiti i compagni che hanno portato avanti la lotta No-Tav, come la chiami tu. E mi pare di capire che tu collochi il suo inizio abbastanza recente nel tempo. Ma guarda che si tratta di qualcosa che è cominciata vent’anni fa. Vent’anni. E vent’anni fa io, per primo, sono stato uno che ha fatto un intervento – a Cuneo, mi ricordo – e in quel documento, pubblicato da me in diverse collocazioni che ora non ricordo, mi pare nel libro che si chiama Dissonanze, parlavo del concetto di “velocità”, collegavo il concetto di velocità con quello di spazio e col concetto di tempo. All’interno del concetto di spazio, sia pure attraverso una chiave di ordine filosofico, si arrivava al concetto di carcere. Cioè la necessità che si ha nel mondo moderno di alimentare l’ideologia, il sogno, l’illusione di arrivare a conquistare lo spazio quanto più velocemente possibile, arrivare da un posto a un altro più velocemente possibile, crea l’illusione che in questo modo si accorci la vita stupida di tutti i giorni e si allunghi la vita significativa, quella che vorremmo veramente vivere, illusione alimentata in maniera formidabile dal capitale negli ultimi vent’anni, attraverso la telematica, ecc., non sto a tediarvi con cose che sapete meglio e più di me, io collegavo questo processo con la riduzione dello spazio, riduzione della libertà, carcere.
Questo concetto non è stato non solo capito, non è stato neanche accettato a livello di discussione, perché intendevano i compagni, a partire da vent’anni fa, collocarsi in una situazione in cui c’era la possibilità di una lotta di natura assommativa, in cui la discussione sul carcere correva il rischio di complicare le cose, ridurre la possibilità di una collaborazione con altre forze rivoluzionarie, politiche, e così via. Questo per mettere a punto le cose per come stanno nella realtà, perché a me interessa personalmente questo problema in quanto sono vent’anni che quella scelta mi brucia. Bene.
Il perché ho accennato a quello sfogo di natura, diciamo, personale, cioè al momento in cui tu esci dal carcere e non c’è cosa più bella di questa, ritrovare la propria libertà, sia pure parziale come è quella che viviamo tutti i giorni. L’ultima volta che sono uscito da un carcere particolarmente infame, come sono le carceri greche, ho avvertito un senso di bellezza, di liberazione, di respirare a pieni polmoni. Ma, nello stesso tempo, c’è stato un senso di paura, perché una parte della tua vita, una parte considerevole della tua vita è rimasta lì dentro. E quei giorni, quegli anni, passati lì dentro non li avrai mai più, non li rivedrai mai più, sono partiti per sempre. La tua vita, in parte, è rimasta lì dentro e tu la stai abbandonando. Ecco, a questo volevo riferirmi, a questo senso di paura che ti prende davanti alla libertà, alla possibilità minima di prendere la strada a destra invece di quella a sinistra senza che ci sia la guardia che ti dica: “No, da quel lato non puoi andare”. Ecco, questa cosa così banale ti fa a un certo punto mancare il respiro, e ti chiedi: “Ma io, che cosa ho fatto della mia vita?”. Noi, pensateci, compagni, abbiamo solo una vita da vivere, non è che dopo qualcuno ci concederà il bis, no. No, c’è solo quella. Ecco perché c’è questo sentimento che io ho vissuto più volte. Tutte le volte che sono uscito dal carcere, mi sono detto: “Cazzo, che cosa ho fatto questi anni?”.
La specificità delle lotte contro il carcere è una questione invece legata alla possibilità di una loro generalizzazione. Non è vero che non è possibile farsi capire dalle persone, nelle lotte che noi concretamente realizziamo nelle minime condizioni che oggi per molti di noi sono accessibili. Perché sono condizioni piccole, di natura ridotta, esperimenti certe volte in vitro, sono lotte di tipo intermedio, non sono certamente lotte che possono determinare la rivoluzione qui e ora. In queste condizioni è possibile parlare del carcere, e abbiamo fatto l’esempio delle lotte No-Tav, ma è possibile parlare del carcere in altre situazioni, anche le più remote fra di loro, soltanto che noi spesse volte non ci pensiamo. Pensiamo soltanto ad essere comprensibili, e non riflettiamo su quanto dobbiamo pagare per essere comprensibili. Agli anarchici guardate che questo accade spessissimo, in quanto pensano che per essere compresi dalla gente bisogna parlare e ragionare come la gente, o comunque essere gradualmente diversi, cercare cioè di presentarsi meno pericolosi possibile. No, non sono d’accordo.
Io non ho una chiave di lettura univoca. Contrariamente a quanto è stato detto stasera stessa, non ho una chiave ideologica della lotta rivoluzionaria. Io sono pronto a parlare di qualunque progetto che abbia come scopo la libertà, e che ce l’abbia fin dal primo momento, non che ce l’abbia nella gradualità dei processi che si potranno sviluppare a seguito di quella forza deterministica che agisce nella storia. Ma stiamo scherzando? Io non credo affatto che nella storia esista una forza deterministica diretta alla realizzazione dell’anarchia. Queste sono le chiacchiere che dicevano nell’Ottocento, quando Bovio affermava che “l’anarchia sarà perché la storia è diretta verso l’anarchia”. Chi cazzo può essere sicuro che la storia sia diretta verso l’anarchia? La storia può essere benissimo diretta verso la costruzione di una società repressiva ancora peggio di quella in cui viviamo oggi, se non facciamo niente. Se noi, fin da oggi, non impegniamo la nostra vita a realizzare le possibilità di trasformazione di questa società che ci ospita. Le cose potrebbero andare ancora ben peggio.
Domanda: progetto insurrezionale.
Aspetta un momento. Io voglio prima cercare di capire la tua domanda. Io mi sono trovato, quasi per un anno e mezzo, un anno e quattro mesi, nel carcere di Koridallos ad Atene e ogni giorno, seduti nei tavolini nel braccio, perché non potevano tenerci tutto il tempo nelle celle da uno dove stavamo in quattro per cui ci chiudevano solo la notte, ogni giorno ho parlato con i compagni delle Cellule di fuoco che erano dentro, ecc., sulla questione dell’organizzazione nel corso degli scontri di piazza. Non esiste una organizzazione possibile, secondo i compagni greci, insurrezionalisti e anarchici, come volete voi, mentre secondo me è possibile. Non è vero che io non sono d’accordo con l’attacco al Parlamento, io non sono d’accordo che l’attacco al Parlamento sia la sola cosa possibile. Questo è il discorso. Cioè la differenziazione di un attacco ha le caratteristiche che ha il progetto insurrezionale. Più il progetto è articolato più l’attacco è possibile. Dopo tutto, questo attacco insurrezionale su che cosa si basa? Sulle regole tradizionali che da centocinquant’anni si trovano alla base del concetto di guerriglia, cioè la parcellizzazione, non la centralizzazione dell’attacco.
Ora questo discorso è stato fatto da me per un anno e qualcosa. Risultati, assolutamente nulla, perché ancora pochi giorni fa, in Grecia, ci sono stati gli stessi scontri sotto il Parlamento.
La questione della legge. Ovviamente la questione della legge viaggia per i fatti suoi. Noi siamo anarchici però, nello stesso tempo, come hai detto tu, riportando le mie parole: “Poi mi svegliate quando arriva l’anarchia”. E, altrettanto, non possiamo incidere, se non indirettamente, sulla questione della legge. Però c’è una cosa. L’acutizzarsi della repressione, ad esempio il fatto che c’è una telecamera dappertutto, il fatto che siamo sicuri che possono controllare i nostri telefoni, il fatto che posso avere sempre dietro un poliziotto, il fatto che dopo un mese che mi sono messo per la prima volta in vita mia gli occhiali da sole è stato scritto sul giornale che io portavo gli occhiali da sole, tutto questo un qualche diavolo di motivo lo deve avere. Perché hanno realizzato questo tipo di repressione preventiva, così capillare. Bene. Cosa ci insegna tutto questo? A non fidarsi dei mezzi di comunicazione, ci insegna a fare attenzione, quell’allegria che ci caratterizzava fino all’altro giorno, non possiamo più permettercela, dobbiamo trovare altri modi, altri processi per comunicare tra di noi, se dovessimo, un bel giorno, come io auspico, nel cuore mio, ovviamente, decidere di fare insieme delle cose. Dovremmo cercare di evitare quegli strumenti che sono di plateale utilizzo da parte degli organi repressivi. Quindi, non è vero che tutte le lame abbiano un taglio solo, in genere ne hanno due, che qualche insegnamento può venire anche dai fatti repressivi che lo Stato realizza contro di noi. Quando vediamo che lo schieramento repressivo si coalizza e apparentemente chiude tutti gli sbocchi, l’unica cosa da fare, compagni miei, è quella di mettersi il coltello tra i denti. Può darsi che un giorno ci impediscano di fare queste stesse quattro chiacchiere in famiglia che stiamo facendo in questo momento, ebbene, allora non faremo più chiacchiere. E che ben venga il momento di non fare più chiacchiere.
[Conferenza di Monza del 24 novembre 2012, tenuta al Centro sociale “Boccaccio”. Trascrizione della registrazione su nastro]
Conferenza di Modena
Fare un discorso all’aperto parlando sul carcere è la prima volta che mi succede. In genere si scelgono dei posti chiusi, così uno si sente un po’ a casa sua.
Certo, spesse volte, pensando ai miei tanti anni di carcere, mi viene in mente che in fondo abbiamo così introiettato il nostro essere sudditi, abitanti di una città, di uno Stato, di una nazione del mondo, che non riflettiamo quanto ci sia di relazione ineliminabile tra carcere e potere, potere e carcere.
A noi sembra che il carcere sia una zona ben precisa delle nostre città, piuttosto delimitata. Anticamente si metteva nel centro della città, così la gente passando lo vedeva e stava tranquilla, ora invece questa istituzione tendono a metterla ai margini. Non conosco il carcere di Modena, ma conosco bene il carcere vecchio di Bologna e il carcere nuovo, perché ci sono stato in tutti e due. S. Giovanni in Monte è al centro della città. I bolognesi sapevano che c’era il carcere, ma per loro era come se fosse una questione di famiglia, insomma come uno che ha un figlio scemo e lo tiene nascosto. Mentre adesso è fuori, alla Dozza, ci vuole un po’ di tempo per arrivarci. È un bel carcere. Sapete a S. Giovanni in Monte c’erano le bocche di lupo, alla Dozza ci sono le sbarre verticali soltanto, e quelle orizzontali non ci sono. Per cui un carcerato, alla Dozza, guarda le sbarre e si sente un po’ meglio. Dice: “Che bel carcere che è la Dozza, quanto era brutto S. Giovanni in Monte”. Come hanno realizzato ciò? Perché le sbarre della Dozza sono speciali, se uno tenta di segarle hanno un’anima all’interno che ruota al contrario del verso della sega per cui impedisce qualunque tipo di utilizzo della sega, quindi le sbarre orizzontali non sono necessarie. Queste piccole invenzioni sono dirette a tenere chiusa la gente lì dentro, per farla stare un po’ meglio, per fare pesare meno il carcere, ma per tenerla sempre in gabbia, sembrano delle faccende prive di senso, o poco importanti, ma in fondo hanno un senso, ed è quello di farci digerire il carcere, di farcelo considerare come una cosa normale, mentre il carcere è una anormalità.
Una persona, un essere umano, chiuso in una gabbia è privato della sua libertà. Ma uno potrebbe dire, si tratta di un’astrattezza, in fondo che cambia, non gli tagliano un braccio, no, non gli tagliano un braccio, anzi, gli danno da mangiare, tre volte al giorno, gli fanno fare la doccia due volte la settimana, minimo, lo fanno andare all’aria. Se non rompe troppo le scatole non lo disturbano molto. Io non ho visto mai torturare espressamente persone in carcere, mentre sono stato più volte torturato fuori del carcere. Però perché resta un’anormalità? Perché un uomo, una donna, un essere umano, senza la libertà non esiste, quindi, nel momento in cui un altro essere umano che indossa la divisa, ha in mano un oggetto che si chiama chiave, e la sera, oltre al piccolo cancelletto, sempre in ferro abbastanza consistente, chiude il blindato girando la chiave nella toppa, si verificano due fenomeni: da un lato la degradazione di un essere umano che raggiunge il più basso livello che è quello di chiudere un altro essere umano a chiave, dall’altro, il subire la degradazione di essere chiuso a chiave, di sentirsi a un determinato momento, esattamente alle dieci di sera, separato dal mondo.
Questi sentimenti fanno parte della vita del carcerato, la deturpano, la modificano, la modellano in una maniera (deforme) adatta a creare una persona adeguata ad accettare in modo passivo le condizioni della convivenza civile richieste dal potere. Quindi si viene a sacrificare un essere umano alle condizioni della convivenza civile.
Certamente molti potrebbero chiedersi: è una cosa importante la convivenza civile, dopo tutto siamo civilizzati, per cui se qualcuno si permette di non accettare le regole del gioco, se qualcuno si permette di allungare la mano sulla proprietà altrui, improvvisamente si mette fuori del gioco, si mette fuorilegge. Ed è giusto che gli strumenti repressivi, all’uopo approvati dalla comunità – ha poca importanza se in base al “contratto” di Rousseau o a qualunque altra stupidaggine del genere hanno tirato fuori i filosofi dalle loro scatole magiche, in base a quale teoria ha poca importanza – se si permette di mettersi fuorigioco, deve essere preso in carico da una struttura repressiva, preso e portato in un posto, un posto particolare che si chiama carcere.
Questo, che sembra un fatto marginale, una persona che si permette di allungare la mano – non tutti lo fanno, su un milione di persone saranno cento che lo fanno – una persona che si permette di allungare la mano sulla proprietà altrui, deve essere presa e portata in un posto “separato”.
Quindi, il concetto qual è: bisogna separarla, separarla dalla comunità. Una volta, pensate, nel Medioevo, molti di voi l’avranno sentito dire, o letto, la peggiore condanna che poteva essere inflitta, a parte le pene corporali e la pena radicale che venivano applicate dalle autorità civili, era la scomunica. La Chiesa metteva fuori un membro della comunità, lo espelleva fuori della comunità dei fedeli. In questa condizione chiunque poteva colpirlo, nella persona e nei beni, senza nessuna conseguenza, nessun pericolo. Che cosa facevano allora? Lo mettevano fuori della comunità. Che cosa si fa oggi? Si prende la persona che ha osato dissentire dalle regole e la si porta in un luogo chiuso, la si separa.
Questa concezione di separatezza è fondamentale per mantenere le virtù repressive dello Stato. L’individuo considerato “colpevole” lo si tiene un certo tempo separato. Però, con l’andare del tempo, ad esempio se consideriamo gli ultimi quarant’anni su cui vi potrei portare una esperienza di tipo diretto, personale, l’istituzione carcere si è evoluta. La separazione non è più così radicale. Una volta ti prendevano, ti chiudevano veramente in un cesso, perché c’era il cesso insieme a te, tu, il cesso e il letto, non c’era altro, ti chiudevano e buttavano la chiave. Non avevi nulla, non avevi nessun diritto, l’unico diritto che avevi era la filodiffusione lanciata ad altissimo volume.
Io mi sono trovato a essere catapultato in uno di questi cessi, esattamente nel settembre del 1972, un pomeriggio, e, all’età di trentacinque anni, mi sono detto: “Io non sono in grado di sopravvivere cinque minuti in un posto come questo”. Perché in un buco di tre metri quadrati c’era una cosa ad altissimo volume, una musica, una canzone, un rumore che faceva impazzire, per cui mi sono tolta una scarpa e ho cercato di raggiungere, cosa impossibile, di raggiungere la protezione di metallo che copriva la cassetta della filodiffusione. A un certo punto, una testa umana è entrata nel buco quadrato del blindato e mi ha detto: “Ma che cazzo sta facendo?”, “sto cercando di rompere…”, “non c’è bisogno”, mi ha risposto la testa umana, “lei chiama me, io sono lo scopino, e…” – tac – ha spento la filodiffusione, e così ho capito come funzionava il carcere. Cioè ho capito che c’è la possibilità anche nell’estrema, assoluta rarefazione dell’isolamento, di trovare lo spazio per sopravvivere. Questo cerca il detenuto. Sopravvivere, cercare di migliorare la situazione di merda in cui si è venuto a trovare.
Quando noi, dall’esterno, noi rivoluzionari, noi anarchici, noi detentori della verità, noi che sappiamo tutto, noi che sappiamo ogni cosa, noi che vogliamo trasformare il mondo, noi che vogliamo capovolgerlo, ci chiediamo: “Come ci rapportiamo con la gente che sta dentro?”. Noi dobbiamo partire dal presupposto che la gente che sta dentro, il suo primo scopo, il suo primo desiderio, è quello di migliorare la propria condizione. Non possiamo, compagni, partire dal presupposto che il nostro modello è invece il ribelle. I detenuti non sono ribelli. I detenuti sono detenuti. Questo non vuol dire che in mezzo a sessantaseimila e cinquecento detenuti che ci sono nelle carceri italiane, non contando i seimila che sono nei manicomi criminali, in mezzo a questo numero eccezionalmente alto in proporzione alle capacità delle strutture carcerarie italiane, non ci siano centinaia di ribelli. Ma non possiamo capovolgere il ragionamento. Se noi vogliamo lottare contro l’istituzione carceraria non possiamo pensare che il nostro referente sia la totalità dei detenuti.
Dobbiamo fare quindi un discorso di approfondimento, dobbiamo cercare di capire che cos’è il carcere, come funziona, quali sono le regole che lo tengono in piedi, qual è il suo scopo, perché è stato strutturato, perché esiste la pena, che vuol dire il concetto di pena. Dal punto di vista, diciamo, filosofico, il concetto di pena è una cosa aberrante. Perché? È essa qualcosa che rimette in equilibrio la bilancia? Cioè, se io ho danneggiato un’altra persona, o la proprietà di un’altra persona, che secondo il diritto è sostanzialmente una emanazione della persona, è giusto? Ora, se io ho danneggiato una persona o la proprietà di una persona, vengo condannato a una pena che è in grado di controbilanciare il danneggiamento che ho causato? Ma come è possibile una cosa del genere? Perché mai, io che ho causato un danneggiamento con un furto, restando chiuso in un posto per, poniamo, un anno e mezzo, ottengo un bilanciamento. Evidentemente è illogica la cosa. Sarebbe più logica se io fossi obbligato a rimborsare il danno causato. E, sul piano puramente commerciale, del do ut des, si potrebbe ragionare, oppure, l’altra spiegazione quale potrebbe essere? Il fatto che io non posso più stare in una situazione che mi potrebbe mettere a contatto con la persona che ho danneggiato, devo essere da questa persona allontanato. Ecco perché vengo chiuso, rinchiuso in un posto, e questo allontanamento è tanto più lungo quanto più considerevole è il danno che ho causato, e qui il ragionamento diventa più plausibile. Ecco perché il carcere è una istituzione chiusa.
Ora, ad esempio, ci sono delle modificazioni. Avete sentito che si è calcolato che per le pene dentro i cinque mesi di condanna si possono pagare 265 euro al giorno. Significa 8.000 euro per ogni mese. Ora, chi può permettersi di pagare 40.000 euro per una condanna a cinque mesi? La quasi totalità di tutti quelli che sono arrestati e condannati a 5 mesi non è un grado di pagare 40.000 euro. Questo è ovvio. Conseguentemente si torna al punto di prima. Tutti questi tentativi cosa stanno a dimostrare se non che il carcere rimane lo strumento portante dello Stato? La base della sua logica di recupero. Ecco. L’individuo viene preso, portato via, messo in carcere, e poi viene studiato. Sottoposto ad una tecnica che prende un nome caratteristico, si chiama “trattamento”. Se voi pensate, la parola viene dal trattamento medicale che si applica nei confronti di un malato, cioè il malato subisce una cura. E così il detenuto subisce un trattamento, subisce una cura, su di lui intervengono: la carcerazione, il personale penitenziario militare, il personale amministrativo, il personale medico. Per il personale medico in primo luogo interviene lo psicologo, il quale fa un lungo discorso con il detenuto, il quale detenuto ne sa più dello psicologo, quindi cerca di imbrogliarlo, cerca cioè, in un certo modo, di sopravvivere. Il discorso è sempre quello.
Lo scopo che dobbiamo quindi potere individuare nella logica carceraria è: la separazione, il trattamento, il reinserimento. L’individuo, superato il periodo della cosiddetta pena, deve tornare nella comunità. All’interno della comunità è ovviamente segnato a dito, indicato come pregiudicato. A determinate condizioni è uguale agli altri, però non è uguale del tutto, perché in qualunque momento quella segnalazione torna sempre a galla, viene ripresa e considerata come elemento aggravante nei suoi confronti, per quel che riguarda qualunque decisione che si dovrà prendere nei suoi riguardi, per un futuro lavoro, per un futuro reinserimento nella società.
Mi si potrebbe obiettare, ma questo signore che, ad un certo punto ha alzato la mano sulla proprietà altrui, e che quindi, arbitrariamente, di sua volontà, si è impadronito di un oggetto che non era suo, non sapeva i problemi a cui andava incontro, i guai che doveva affrontare, il fatto che lo portavano in carcere, ecc.?. Io vi posso rispondere che il cento per cento lo sapevano, il novantanove per cento pensavano, come si dice, ingenuamente, di farla franca.
Questi ragionamenti sono ragionamenti di psicologia spicciola, ma in fondo, se voi ci pensate, sono i ragionamenti che facciamo tutti noi. Ognuno di noi, dentro di sé fa ragionamenti di questo tipo. Perché a ognuno di noi la legge sta stretta. Ma non la legge che proibisce il furto, l’assassinio, i grandi reati, anche la legge che proibisce di passare fuori delle strisce pedonali. Perché ognuno di noi dice a se stesso, va bene, insomma, penso che ce la faccio a passare fuori delle strisce perché così arrivo prima dove devo andare. Anche quello è un atteggiamento fuorilegge, però è un atteggiamento umano. L’uomo è fatto così. Cerca di risparmiare le forze per dedicarle alle cose che gli interessano. Ora, il ragionamento di chi ha alzato la mano sulla proprietà altrui, non mancava della conoscenza dei guai a cui si può andare incontro, ma era anche sollecitato, spinto, dalla necessità.
Quindi, non pensiamo di avere davanti dei ribelli. Il furto non è, di per sé, segno di ribellione, può essere segno di necessità. Quanti invece di rubare avrebbero preferito trovare un lavoro? Qualcuno potrebbe dire: “Ma il lavoro è faticoso”. Ma perché, pensate che il furto non lo sia? Non pensiamo che il furto sia l’effrazione gratuita e violenta, la manifestazione assurda e sconsiderata della prepotenza nei riguardi delle difese innalzate dal proprietario. Non è questo, il furto richiede anche una certa professionalità. E quindi, se voi pensate: fare una rapina, cioè, una rapina in una banca, è un lavoro lungo, stupido, faticoso, seccante, professionalmente impegnativo, è un lavoro. Quindi, non è vero che è profumatamente pagato, non è affatto vero. Anche perché nel cinquanta per cento dei casi può andare male la cosa.
Il ragionamento da cui bisogna partire è che le persone che sono in carcere non sono dei ribelli ma, nella quasi totalità dei casi, sono persone, tranne qualche eccezione, badiamo bene, perché i fuorilegge ci sono, fuorilegge realmente tali, persone che avrebbero preferito fare una vita normale, trovare un lavoro al catasto, insegnare a scuola, essere dirigenti industriali, e non l’hanno potuto fare perché la sorte non è stata favorevole, secondo il loro modo di vedere le cose, non secondo il mio, ma il loro. Non hanno trovato il lavoro, non hanno potuto studiare, non hanno avuto le occasioni, ma sono stati, come dire, condannati a una vita differente, ma non gradiscono l’etichetta di ribelli.
Io vi sto facendo questo discorso, compagni che mi ascoltate, perché sono dell’opinione che non bisogna mitizzare il carcerato. Il carcerato è un uomo come tutti gli altri.
Se noi andiamo in una piazza di mercato e incontriamo cinquecento persone, pensiamo veramente che con quelle cinquecento persone possiamo fare la rivoluzione? Ma stiamo scherzando? Siamo in un mercato, all’aria libera, ci sono cinquecento persone, facciamo un piccolo cartello, piccolo piccolo, lo attacchiamo in un muro, e si fa la rivoluzione? No. E per quale motivo dobbiamo pensare che possiamo farla con i carcerati la rivoluzione? Qual è la differenza? Il fatto che sono chiusi? Che l’animale umano chiuso si esacerba, diventa ancora più feroce? Sì, certo, diventa ancora più feroce, ma perché?, spesso per salvaguardare la sua stessa miserabile esistenza, per quello diventa più feroce. Così cerca di costruire degli spazi di sopravvivenza, cerca di migliorare, di stare un poco meglio, guai se qualcuno gli procura condizioni di peggioramento, perché sono proprio queste le condizioni che vengono a verificarsi nel momento in cui in una struttura carceraria c’è un moto, sia pure minimo, di ribellione. Si determina allora, che cosa?, una condizione di peggioramento.
Quindi, il carcerato sa benissimo che cosa gli può succedere accettando una proposta rivoluzionaria. Nel momento che noi apriamo la bocca per indicare: “si può fare questo”, dobbiamo sapere che ci assumiamo una responsabilità, dobbiamo essere in grado di arrivare fino in fondo insieme alla persona a cui facciamo questa proposta, non possiamo fare la proposta, lanciare il sasso e ritirare la mano, perché le conseguenze ricadono su quelle persone che stanno in carcere. E le conseguenze quali sono? Se individuano delle persone, singolarmente, come nostri referenti, queste persone sono immediatamente trasferite, e un trasferimento in carcere e una cosa di gravità enorme: per la famiglia, per il carcerato, perché si deve ambientare nel carcere dove arriva, perché deve passare un periodo di isolamento, perché deve sopportare un faticoso viaggio, perché finisce per avere problemi finanziari, e tutto il resto.
Con tutto questo, insisto nel dire, non significa che non ci siano elementi naturalmente ribelli, che hanno scelto una vita di combattenti contro una struttura di morte quale è la struttura del carcere, ma sono una piccola minoranza e, singolarmente presi, non sono affatto bene accetti dagli altri detenuti. Comprendiamo questo concetto, compagni. Io mi sono trovato, con la mia storia, ad arrivare in un carcere, immediatamente non ero oggetto soltanto dell’attenzione particolare del personale militare, amministrativo, ecc., del carcere, isolamento e tutto il resto, ma c’era anche l’attenzione dei detenuti, i quali subito pensavano: “Questo che cazzo vuole fare?”, era la prima cosa a cui pensavano, anche se non me la dicevano chiaramente.
Io non voglio affatto disprezzare o mettere in cattiva luce la categoria sindacale dei detenuti, non me ne frega niente, io voglio smitizzare dall’interno un soggetto sociale che non può essere rivoluzionario, non perché è detenuto, non può esserlo perché non esiste un soggetto rivoluzionario. Non i detenuti soltanto non sono rivoluzionari, ma non è mai esistito nella storia un soggetto del genere. Gli equivoci marxisti del soggetto rivoluzionario: l’operaio, il proletariato, il sottoproletariato, sono stati espressamente e sanguinosamente smentiti dalla storia. Oggi lo sappiamo, basta leggere la storia degli ultimi vent’anni, degli ultimi trent’anni. Non è esistito né mai esisterà un soggetto rivoluzionario, quindi perché dovrebbe essere soggetto rivoluzionario il detenuto? Il quale, peraltro, si trova in una condizione talmente difficile e precaria, che la prima cosa che gli viene in mente è quella di sopravvivere. Voi pensate che un individuo che cerca di sopravvivere possa accedere al concetto di libertà rivoluzionaria che equivale alla messa in gioco di se stesso e di qualsiasi miserrimo privilegio possa raggiungere? Può essere mai una cosa del genere? Se accade è un’eccezione. Io posso dire che c’è più probabilità di trovare i compagni con cui fare una lotta fuori del carcere che trovarli nel carcere. Questo non lo dico per sentito dire, lo dico per esperienza quotidiana di quindici anni di carcere. A me dispiace parlare chiamando a testimoniare me stesso, perché sembro il nonno che racconta le favole ai ragazzini, che è una cosa che odio, però è un fatto talmente evidente che deve essere, secondo me, tenuto presente prima di impostare la lotta nei riguardi del carcere. Questo non vuol dire che il carcere deve essere ridipinto dall’esterno con il nostro intervento? Noi dobbiamo riabbellirlo? No. Dobbiamo distruggere il carcere.
Ecco. La prima cosa che rispondevo, quando arrivavo in un carcere (speriamo di non doverlo dire più), alla domanda: “Bonanno, lei che cosa vuole fare?”. “La cosa che voglio fare è distruggere il carcere. Datemene la possibilità e state sicuri che vi distruggo il carcere. Adesso non mi è possibile, il giorno che mi sarà possibile ve lo dirò”.
Non c’è un’altra soluzione. Non possiamo essere complici della orrenda progettualità di miglioramento del carcere, ma dobbiamo cercare di distruggerlo.
Mi si potrebbe dire: “Ma come è possibile distruggere il carcere?”. Distruggere il carcere significa, compagni, distruggere questa società di merda che ci ospita, distruggere questa realtà. Distruggere lo Stato e distruggere il carcere sono la stessa cosa. Quando gli anarchici dicono: “Noi siamo contro lo Stato”, stanno dicendo un sinonimo di essere contro il carcere. E se dicessero: “Noi siamo contro il carcere e poi saremo, dopo avere distrutto il carcere, contro lo Stato”, direbbero una fesseria. Perché carcere e Stato sono la stessa cosa. Non si può immaginare uno Stato senza carcere, non esiste, non è mai esistito né mai esisterà. Quindi noi siamo contro il carcere, lo vogliamo distruggere, allo stesso modo, nello stesso momento, attraverso le stesse procedure, attraverso il medesimo impegno, con cui siamo contro questa società, per cui siamo per una società migliore, non siamo per il caos o per l’assenza di qualunque tipo di relazione umana, ma per una società diversa da quella in cui viviamo, siamo per una società migliore, ma non attraverso le riforme o le modificazioni, ma attraverso la distruzione, attraverso il processo rivoluzionario.
Questo discorso che noi facciamo sempre per quanto riguarda lo Stato è fatto con le medesime parole che dobbiamo impiegare per quanto riguarda il carcere, perché tra carcere e Stato non c’è differenza. Quando noi parliamo criticamente nei riguardi degli uomini politici, del Parlamento, della produzione, dell’economia, di come si mangiano i soldi, di tutte le fesserie e le porcherie che ci sono davanti a noi, sotto il nostro naso, che rendono puzzolente la società in cui viviamo, stiamo parlando del carcere, perché il carcere è questa cosa. Il carcere è la scuola. Il carcere è la fabbrica. Attenzione queste “è” sono con l’accento. Il carcere è la scuola. Il carcere è la fabbrica. Il carcere è la nostra vita.
Solidarietà rivoluzionaria dicevamo, poco fa, fra pochi compagni. Certo, solidarietà rivoluzionaria con chi è in carcere, ma prima di tutto solidarietà rivoluzionaria nei confronti dei miei compagni, di quelli che condividono con me un progetto rivoluzionario e che la cattiva sorte e la non riuscita dell’attacco che stavamo realizzando insieme ha portato in carcere. Quindi io sono obbligato ad avere una solidarietà rivoluzionaria con i miei compagni con i quali condividevo un progetto rivoluzionario, compagni che si trovano in carcere. Questo è un obbligo morale che io ho. In cosa consiste questo obbligo morale? Non nell’aiutarli soltanto, non dico finanziariamente che è una banalità, o col sostegno morale, ma di continuare il progetto rivoluzionario che è stato interrotto perché loro sono stati catturati, di continuarlo io che sono fuori, e così gli altri compagni che lo condividono. Questa è la solidarietà rivoluzionaria. Non una solidarietà vaga, generica, erga omnes, con tutti, perché sono tutti detenuti. Poi, naturalmente, oltre a questa solidarietà rivoluzionaria specifica, c’è una solidarietà generica nei confronti di chi ha perso la libertà.
Bene. Con tutte le critiche fatte prima, che abbiamo visto, che sono abbastanza dettagliate, con tutti i limiti, con l’assenza che abbiamo sottolineato del soggetto rivoluzionario, col fatto che i carcerati sono quello che sono, ecc., però sono sempre esseri umani chiusi in una gabbia. Diceva un compagno poco fa che, a proposito di esseri umani chiusi in una gabbia, ci sono i centri di accoglienza, chiamiamoli così, anche quelli sono carceri, ci sono centri in cui vengono allevati animali per la sperimentazione, sono esseri umani e esseri animali che sono chiusi, catturati, torturati, ebbene come esprimo la mia solidarietà di fronte a queste strutture di repressione e di morte? A chiacchiere o con i fatti? Capisco che qua stiamo facendo quattro chiacchiere fra di noi, ma qua non siamo fra di noi, siamo belli papali papali in una piazza, ma, altro sono le chiacchiere e altro sono i fatti, compagni, parliamoci chiaramente.
Noi usiamo fare dei presidi davanti alle carceri. Io ve l’ho detto subito, non sono d’accordo con il concetto di presidio. Prima di tutto non mi piace la parola. A me la parola “presidio” mi ricorda una cosa militare. Presidio ai tempi miei era dove si andava per la visita militare di leva. Poi, il presidio è di per sé una cosa visibile, no? Tanto è vero che nei presidi davanti alle carceri ci sono dei compagni che mettono dei cartelli contro il carcere. Quindi, io mi reco davanti a un carcere, faccio un presidio, per essere visto. O no? Ho capito bene? Se no qualcuno mi deve correggere. Voglio essere visto, voglio che mi si veda, che io sto manifestando la mia solidarietà. Ora, io metto fatica a capire che questo sia un attacco contro il carcere. A me viene più spontaneo – sarà che sono una malalingua di natura – pensare che questo sia un modo come un altro di tacitare la propria coscienza, perché io mi sento in debito. Quelli, poveracci, sono chiusi, io sono libero, e manifesto la mia solidarietà. Poi me ne vado a casa, ma sempre libero sono io, libero per modo di dire, insomma, non sono certo carcerato, non mi chiudono il blindato alle dieci di sera con la chiave.
Come sposare il concetto di attacco con il concetto di visibilità. Abbiate pazienza. Se io voglio attaccare qualcuno, per esempio c’è quel signore laggiù vicino alla finestra colorata di giallo che mi fa antipatia e gli voglio dare una bastonata, la prima cosa che cerco di fare è di evitare di farmi riconoscere. Oppure gli vado vicino e gli dico: “Buongiorno, mi chiamo Alfredo Bonanno, ora gli do una bastonata”. Quello mi piglia per cretino. Che senso ha una cosa del genere? Se io ho intenzione di bastonare quel signore là, vicino alla finestra dipinta di giallo, cerco di farlo in modo da non farmi vedere. Oppure gli faccio prima un presidio davanti con un cartello, per dargli questa bastonata? Se io gli faccio un presidio con un cartello dicendogli: “Ora ti do una bastonata per questo motivo, ecc.”, io la bastonata a quello non gliela voglio dare. Gliela sto soltanto minacciando. Io sono siciliano e, in siciliano, questo atteggiamento si chiama quaquaraquà. Ed è una delle cose peggiori che ci possono essere.
E, allora, se io non voglio farmi vedere, la cosa non è impossibile. Il carcere non si trova nel deserto del Sahara, oggi specialmente il carcere è una struttura collegata globalmente, ha bisogno di moltissime correlazioni con strutture produttive che lavorano col carcere, per cui basta digitare e si hanno immediatamente queste indicazioni. Quindi se io voglio manifestare contro il carcere, manifestare nel senso concreto, non a chiacchiere, non c’è bisogno che vada davanti al carcere, anzi l’ultimo posto dove io posso pensare di andare è proprio davanti al carcere, ma posso andare davanti a qualcuna di quelle corresponsabilità che circondano tutto il carcere, andare a bussare a quella porta e, se del caso, come con quel signore davanti alla finestra dipinta di giallo, dare una bella bastonata. O vi sembra sbagliata questa teoria?
Più io rifletto su questa cosa e meno sbagliata mi sembra. Non riesco a pensarla diversamente. Ecco, per concludere queste quattro chiacchiere che ci siamo fatte, torna importante conoscere la struttura del carcere, che vuol dire il carcere, come funziona, da che cosa è retto.
A esempio, un carcere che ospita, non so, io vivo a Trieste, e quel carcere ospita trecento detenuti, intorno a questa in fondo piccola struttura ruotano centinaia di milioni di euro di interessi, quindi centinaia di persone, ditte che riforniscono, movimenti di sostegno del carcere, processi di recupero, associazioni, volontariato, vedete quanta gente sta attorno, quante istituzioni, e quanti luoghi fisici esistono che pur chiamandosi in altro modo, ad esempio “comignolo”, sono invece carceri. Si chiamano “finestra” invece sono carceri. Si chiamano “portone” invece sono carceri. Però questa doppia denominazione non è derubricabile direttamente, bisogna andarsela a studiare, andarsela a cercare. Questo lavoro occorre fare, questo significa solidarietà, questo significa attacco concreto.
Quindi: conoscere il carcere e andare a bussare alle porte giuste e, sicuramente, tra queste porte giuste non c’è la porta del carcere. Bussare alla porta del carcere significa non dare una bastonata ma farsela dare.
Teniamo presente che, come dicevamo poco fa con i compagni, il carcere e la società e la lotta rivoluzionaria non sono delle cose separate, sono la medesima cosa. Ad esempio, io mi sono trovato in carcere in Grecia per un anno e mezzo, qualche anno fa, ed ho parlato con decine di compagni anarchici in carcere insieme a me, e chiedevo: “Ma perché nelle manifestazioni in Grecia, con centinaia, migliaia di compagni presenti all’interno della manifestazione con centomila persone, quindi una manifestazione enorme, si va sempre davanti alla porta del Parlamento?”. Ma perché? Che cosa si trova davanti alla porta del Parlamento? Si trova l’esercito schierato. Lo Stato non può permettere che tu assalti il Parlamento, che poi non sarebbe un cazzo espugnare il Parlamento, perché che cazzo ci fa un anarchico dentro il Parlamento se non bruciarlo. Ma tanto non ci vuole molto per rimetterlo di nuovo in piedi. Non vi pare? Oppure noi siamo per la presa del Palazzo d’Inverno? Qua penso bolscevichi non ce ne sono, quindi che cosa ci andiamo a fare dentro il Parlamento? E, la stessa cosa, che ci andiamo a fare davanti alla porta del carcere? Perché si affaccia il detenuto dall’inferriata e ci fa il salutino? Ma questo lo facevo quando avevo cinque anni. Un bambino di cinque anni ti saluta. Ma una persona adulta deve pure capire. Ebbene, un anno e mezzo di discussione: “Perché si va davanti al Parlamento?”. Risposta: perché si manca di una documentazione opportuna su obiettivi diversi da attaccare. Tristemente è questa la realtà.
Migliaia di compagni anarchici all’interno di una grande manifestazione, quindi una forza capace di distruggere e di attaccare non a caso ma specifici obiettivi, da piazza Esarchia al Parlamento, che sono più di due Km, eppure non si riesce a differenziare l’attacco. C’è solo la porta del Parlamento. Il simbolo.
Ora, il carcere, dovete capire che in queste condizioni e nel momento di un presidio è solo un simbolo. Non possiamo essere solidali con chi sta dentro e manifestare simbolicamente davanti a un simbolo. Dobbiamo attaccare
Mi pare di avere finito. Grazie.
Domanda: Propaganda.
Io non penso di avere dato l’impressione di essere contro il concetto di propaganda. Ho passato gli ultimi cinquant’anni della mia vita a scrivere libri, e quindi penso – libri, opuscoli, discorsi come questo – che qualche piccolo contributo l’ho dato alla propaganda anarchica.
Il concetto di “parlare” è fondamentale per un anarchico, di parlare con gli altri, con la gente. Il concetto di “complicità” mi trova piuttosto dissidente, quello di cercare i miei complici, forse io provengo da un altro tipo di mentalità, da un’altra epoca, quindi non lo so. Comunque non ha importanza, non è questione di parole ma questione di sostanza. Il discorso riguarda, mi pare, il luogo fisico: il carcere, la piazza, la strada, il concetto della manifestazione in un luogo preciso, quale la struttura carceraria, l’argomento di cui parlavamo. Evidentemente se io faccio un discorso di presenza fisica davanti a un carcere, di presidio, come si usa dire con questa parola, per me, malaugurata, il mio referente sono i carcerati, quella piccola porzione di carcerati che sono chiusi lì dentro in quel momento. Io ho una discreta conoscenza della media mentale dei carcerati che sono chiusi lì dentro, i quali, tranne qualche ribelle, in numero ristretto, di cui il compagno faceva una distinzione interessante sulla quale vorrei fermarmi un momento, queste manifestazioni non vengono viste in una maniera positiva. Voialtri vi potete pure convincere del contrario, io sono pronto ad ascoltare opinioni diverse, però avendo vissuto dall’interno manifestazioni del genere, vi confermo che tutti coloro che le vivevano insieme a me le vedevano con molta apprensione, avvertivo attorno a me una dilagante considerazione negativa. Non perché le idee veicolate, in un modo necessariamente asfittico e ridotto, come può essere quello di una scritta o di un megafono che urla parole incomprensibili, facessero paura o disturbassero, ma perché all’interno si avvertiva un senso di pericolosità crescente. Le guardie si innervosiscono, ci sono spostamenti repressivi. Questa è l’esperienza che vi comunico avendola vissuta più volte, in diverse carceri e non posso non averla presente. Ed è considerazione diversa dal discorso che facciamo questa sera qua, in questa piazza, delle quattro parole che può cogliere un passante e dell’importanza anche che queste quattro parole possono avere per la sua capacità di inserirle all’interno di un suo discorso. Si tratta di qualcosa di differente. Non è propaganda quella che andiamo a fare davanti alle carceri, difatti non è propaganda anticarceraria. A mio avviso non sono d’accordo, non mi convince.
La questione del ribelle. Non volevo metterla nel senso che il ribelle è una minoranza ben identificabile e separata, o che una parte ben uniformata della popolazione carceraria non sia in grado di ribellarsi. Abbiamo visto rivolte all’interno delle carceri, anche rivolte sanguinose, per esempio alla Dozza di Bologna, vent’anni fa c’è stata una fortissima repressione guidata da un maresciallo nel corso della quale sono state massacrate centinaia di detenuti, e certamente un fatto del genere non era nelle mani di pochi ribelli, ma sono situazioni particolari. Stiamo parlando invece qui della tipologia del ribelle, se volete si tratta forse di una deformazione di tipo sociologico, cioè qualcuno che è riottoso a qualunque regola, a qualunque ragionamento, ecc. Ma si tratta di pochissimi. E, credetemi, non sono ben visti all’interno delle carceri, dagli altri detenuti, non parliamo delle guardia, ma questo non ci riguarda.
Se mi consentite vorrei dire che qualunque cosa avviene in carcere è di estrema difficoltà. Ad esempio, se uno deve percorrere 75 metri, quanto era la distanza in un carcere che ho in mente io adesso, dalla cella dove mi trovavo alla matricola per firmare un pezzo di carta, per fare 75 metri, nella vita normale di un individuo deambulante in modo normale, ci vogliano circa 2 minuti, in un carcere ci può volere dai 5 minuti all’ora e mezza. Ora, una persona che per fare un percorso di 75 metri ci può stare anche un’ora e mezza vede la propria vita del tutto sconvolta, la cognizione dello spazio e del tempo le viene cambiata. Può infatti trovare quattro blindati chiusi con quattro guardie che non gli vogliono aprire, per cui aspetta come un cretino fin quando trova la guardia che gli apre. Questo cambia l’esistenza.
Ora, organizzare una piccola manifestazione di dissenso in carcere è ben altro di farsi 75 metri. Diventa una cosa di portata impressionante, di difficoltà impressionante. Per esempio, ci sono 500 detenuti con cui puoi parlare, ma fino a un certo punto, perché se tu parli all’aria in cento persone, ti vedono, come stiamo noi qua a parlare tutti insieme, arrivano le guardie e ci separano. Quindi si deve parlare in piccoli gruppi, relazionare questi gruppi tra loro, fare circolare un’idea, un concetto organizzativo, una cosa estremamente complicata, passano giorni. Per organizzare un semplice sciopero del carrello, cioè di rifiuto del mangiare della casa, che passa la casa, bisogna considerare che in un braccio le persone che hanno i soldi nel libretto e che quindi possono comprare da mangiare a parte di quello che passa la casa, saranno appena il venti per cento, l’ottanta, il settanta per cento non ha soldi. Quindi, bisogna fare una sorta di sottoscrizione autogestita con tutti gli altri detenuti – e normalmente chi ha i soldi sono i grossi mafiosi, e altre categorie simili, tutta gente con cui non è facile parlare – e convincerli a mettere i soldi per dare da mangiare a quelli che non possono comprarlo e così permettere loro di partecipare al rifiuto del carrello. Ora, organizzare questa solidarietà è una cosa estremamente complessa. Ma vista dall’esterno, molti dicono, che cazzo stanno facendo, un semplice sciopero del carrello. Pare una banalità, ma non è affatto così. Quindi, tutto quello che accade in carcere non può essere valutato con il metro esterno, è una cosa completamente differente. E questi sforzi, le difficoltà, le modulazioni dell’intervento in carcere, devono essere conosciute da coloro che dall’esterno vogliono collaborare con chi è in lotta all’interno.
Ora, la mia tesi, che io sostengo non solo riguardo il carcere ma riguardo a qualunque attività rivoluzionaria anarchica, qualunque cosa che noi facciamo, è questa: anziché limitarsi a una espressione di opinione, di mera opinione, andare al di là di questo. Se noi in carcere facciamo uno sciopero del carrello, e all’esterno arriva questa notizia, evidentemente la fornitura che viene data al carcere, con la quale il carcere prepara la sbobba da dare ai detenuti, viene data da un’azienda. Questa azienda ha vinto un appalto con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria di Roma, e così via. Queste cose bisogna leggerle, ci sono le documentazioni, bisogna trovarle. Ogni zona ha delle aziende che riforniscono alcune carceri.
Vi racconto un piccolo fatto. Sono stato recentemente in America del Sud. C’erano dei compagni, a Buenos Aires, che avevano avuto parenti, chi il padre, chi la madre, fra i desaparecidos, uccisi all’epoca della dittatura, molti di questi compagni avevano trovato, identificato, i torturatori di quell’epoca, e scoperto dove abitavano, e avevano organizzato delle manifestazioni sotto la casa di questi torturatori, i quali sono ormai in pensione, comunque si tratta di persone con grosse responsabilità, e qui, sotto casa, facevano delle megafonate, portavano dei cartelli, insomma creavano tante difficoltà che costoro dovevano cambiare domicilio. Ora, dico io, queste manifestazioni non erano fatte davanti al ministero dell’Interno, a Buenos Aires, ma erano fatte davanti la casa dei torturatori. Ora, portiamo questo ragionamento nella questione del carcere di cui parlavamo prima. In carcere stanno organizzando lo sciopero del carrello. Ma il carrello riguarda il mangiare, ma c’è una ditta che fornisce il mangiare al carcere. E noi che ne sappiamo di questa ditta? Dove si trova questa ditta? Guardate che si tratta di ditte che forniscono due, tre, quattro carceri in una zona e, certe volte, anche in zone lontane tra loro. Sono aziende che magari producono salumi. Ognuno deve cercarsi queste notizie nella sua zona. E se si va davanti a qualcuna di queste aziende, così come a Buenos Aires andavano davanti alla casa dei torturatori, si può fare un bel discorso dicendo: “Voi siete i responsabili che sostenete la struttura carceraria, siete voi il carcere, non sono solo le sbarre, siete voi che avete questa azienda, che mangiate sulla pelle dei detenuti, siete voi che vendete la cocacola in carcere tre volte di quanto costa nei magazzini vicini, siete voi che avete queste responsabilità”. Che cazzo ci stiamo a fare davanti al carcere con i nostri cartelli?
Volevo dire una cosa semplice, non una cosa complessa. Non si tratta di una cosa filosoficamente contorta, è una cosa elementare. Ci sono persone, e aziende, e strutture, e soldi a milioni, che girano attorno al carcere. Se noi sentiamo il cuore battere dentro il nostro petto per la povera umanità che si trova dentro le carceri, benissimo, lasciamo stare l’analisi che dice Alfredo Bonanno, che dice minchiate, che non capisce un cazzo, per quanto riguarda il soggetto rivoluzionario, lasciamo stare tutto questo. Sono poveri disgraziati che stanno in carcere, li vogliamo aiutare? Bene. Aiutiamoli veramente, non con le chiacchiere, questo voglio dire. Che poi io la pensi in maniera diversa, queste sono faccende mie, che possono essere accettate o non accettate, queste sono sfumature.
Domanda: come si è evoluta la situazione delle carceri?
Io penso che, a partire dalla prima metà degli anni Settanta, si è sviluppata un’esperienza autoritaria – sto parlando del cosiddetto “proletariato detenuto” – voluta dalle organizzazioni autoritarie marxiste, Brigate Rosse, Prima Linea e così via, le quali trovavano naturalmente materiale da utilizzare per i loro progetti egemonici diretti alla conquista del potere. Alcune volte, queste organizzazioni, hanno utilizzato bassa manovalanza, all’interno delle carceri, per esempio il nostro compagno, Salvatore Cinieri, è stato ucciso dalle Brigate Rosse, in carcere, semplicemente perché era circolata la notizia, ovviamente non vera, che lui aveva fatto una delazione riguardante un tentativo di evasione organizzato dalle Brigate Rosse. Però è bastata questa impressione perché loro incaricassero un killer delle carceri, uno spagnolo che si chiamava Figueras, che ha ucciso Salvatore, come aveva ucciso anche altri detenuti per motivi che non conosco. Quindi, come vedete, c’era in carcere all’epoca un comportamento di tipo mafioso di certe organizzazioni armate i cui componenti si definivano compagni autoritari e così via, di tipo marxista, ecc., che dava l’impressione che ci fosse una maggiore vitalità rivoluzionaria nelle carceri, cosa che non era vera. In effetti, la struttura della popolazione carceraria resta più o meno simile nel tempo, perché si tratta sempre di individui che la società non può accettare, e quindi li isola, li separa, creando appunto i cosiddetti abitatori abituali delle carceri. Con l’andare del tempo, diminuendo l’importanza delle strutture autoritarie marxiste, gli anarchici in carcere hanno avuto modo di potere organizzare meglio la lotta, con princìpi un poco differenti, è ovvio. Io mi sono trovato, ad esempio, nel carcere di Bergamo, a organizzare uno sciopero della fame, che non è una cosa semplice, altro che sciopero del carrello, una cosa molto più complessa, e sono stato avvicinato da Ferrari Bravo e da altri, coinvolti nell’uccisione del fascista Ramelli, provenienti da Avanguardia Operaia, che all’epoca avevano più di trent’anni, quindi non erano ragazzini, e mi hanno detto: “Alfredo, guarda, noi, data la particolare situazione in cui ci troviamo, non possiamo partecipare allo sciopero”. Quindi, gli organizzatori del proletariato prigioniero si rifiutavano di partecipare ad una lotta, per loro, come dire, recuperativa, diretta a fare stare un po’ meglio la gente in carcere. Quindi, la loro presenza andava diminuendo e la nostra capacità di organizzare qualcosa in carcere, andava crescendo. Come è accaduto a Rebibbia, dove ci sono state delle lotte importanti alla metà degli anni Novanta. La stessa cosa si può fare oggi all’interno delle carceri. Si tratta sempre di organizzare delle lotte dirette, ovviamente, a fare stare meglio i detenuti. Qual è il problema principale che hanno oggi i detenuti? È che davanti a 66.000 prigionieri ci sono circa 55.000 posti letto. E questo fa stare male la gente. Questo tipo di malessere può esplodere in qualunque momento, in maniera impensabili, anche estremamente violente, altro che sciopero della fame o del carrello. Può anche essere che venga distrutto per intero un carcere. Ma questo che vuol dire? Questa eventualità non cambia né le analisi sulla tipologia della popolazione carceraria né i modelli di intervento, di sostegno di queste lotte, Non è che una eventuale accelerazione delle forme di lotta cambia la struttura. No. La struttura è sempre quella. C’è anche da dire che oggi all’interno delle carceri più del cinquanta per cento sono persone non italiane, stranieri con altre esperienze, altre culture, altre religioni e altri modi di rapportarsi, di ragionare, storie diverse. Questo fenomeno, in via di crescita esponenziale, determina una disgregazione nella omogeneità di ribellione che ci potrebbe essere all’interno di un carcere. Per cui succedono due cose: o c’è la piattezza più assoluta qualunque cosa decida la direzione, oppure ci sono esplosioni di violenza che non possono trovare uno sbocco non dico rivoluzionario ma semplicemente rivendicativo, cioè diretto a fare stare meglio i detenuti.
Ciò non vuol dire che le cose oggi siano peggiori o migliori degli anni Settanta, sono semplicemente diverse nella persistenza delle medesime modalità repressive.
Che ne dite se ci alziamo dalle sedie?
[Conferenza di Modena del 13 aprile 2014 presso il laboratorio libertario Ligèra. Tenuta nel piazzale della Pomposa. Trascrizione della registrazione su nastro]
Guida per disincentivare il guadagno sui carcerati
“Il mio sentimento della vita si fonda sulla salda persuasione che la solitudine non è per nulla qualcosa di raro o di singolare, qualcosa di peculiare solo a me e a pochi altri uomini solitari, ma il fatto ineluttabile, centrale dell’esistenza umana”. (Thomas Wolfe).
Ogni detenuto è oggetto di tanti interessi che ruotano attorno alla sua condizione di carcerato, ristretto in pochi metri quadrati per un tempo variabile da pochi giorni a una vita intera.
Senza occuparci, in questa sede, degli interessi giudiziari che si riassumono nel tenere separati dalla società coloro che hanno infranto le regole fissate dalla classe dominante (o sono semplicemente accusati di averle infrante), prendiamo in considerazione il cibo che viene fornito quotidianamente a spese dello Stato, salvo il diritto di quest’ultimo a chiedere un rimborso al detenuto per mantenimento in carcere a fine pena, e quello che ogni detenuto, che abbia a disposizione dei soldi, può comprare. La questione non è di secondaria importanza e causa l’arricchimento di molte aziende specializzate.
Il ministero della Giustizia stabilisce che il cibo da fornire ai detenuti, cucinato ogni giorno all’interno delle singole carceri, sia di ottima qualità. Tabelle dettagliatissime prevedono minuziosamente le quantità e le tipologie, oltre che ai menu e tutto il resto, fino ai grammi di sale e di pepe necessari. Ma l’appalto che la ditta fornitrice riesce a vincere assegna un pagamento per singolo detenuto di pochi euro al giorno, cifra del tutto insufficiente a fornire prodotti di prima qualità, per cui in genere ogni fornitore cerca di utilizzare scarti e merce in parte marcia per guadagnare di più, ciò con la complicità prezzolata del personale di custodia addetto alla cucina e con l’acquiescenza della commissione detenuti che in genere ha paura o semplicemente non è informata. Di certo, uno dei luoghi più pericolosi del carcere è la cucina.
L’altro aspetto, che arricchisce considerevolmente le ditte fornitrici, è dato dal sopravitto, cioè dalla fornitura di quello che i detenuti possono comprare con i propri soldi. La varietà e il numero di questi prodotti, negli ultimi trentacinque anni, è cresciuto da una decina a diverse centinaia. Ciò dimostra non tanto un desiderio ministeriale di fare stare bene i detenuti, ovviamente provvisti di denaro, quanto gli interessi dei fornitori e dello stesso ministero che così pensa di fare guadagnare alla ditta fornitrice in questo settore e risparmiare in quello del vitto vero e proprio pagato dall’amministrazione carceraria.
“La liberté est un mystère”. (Nicolas de Malebranche).
Il contratto alla base dell’appalto vinto dalla ditta fornitrice prevede per i prodotti del sopravitto che i prezzi vengano fissati calcolando la media dei prezzi praticati in tre supermercati prossimi al carcere. Regola questa sistematicamente disattesa senza che i detenuti possano verificare quanto pagano di più.
Molte sono le iniziative di sostegno a coloro che si trovano in carcere. Chi ha frequentato questi luoghi malsani, dico da detenuto non da semplice visitatore, sa bene che esistono miriadi di volontari, più o meno bene intenzionati che fanno di tutto per alleviare la vita dei ristretti: danza, musica, corsi culturali di ogni genere, conferenze contro questo o quel male sociale, iniziative sportive, ecc., affollano le giornate in quasi tutte le carceri. E poi ci sono anche le iniziative di denuncia: di tanto in tanto davanti a qualche muro di cinta si presentano decine di manifestanti contro le carceri. La distinzione è assai semplice: i compagni parlano sempre di abolizione del carcere, i non-compagni di sostegno a questo o quel singolo detenuto. Ognuno fa quello che gli aggrada.
In effetti questi sfoghi sono funzionali a mettere a tacere le coscienze infelici di tanti volontari, in questo caso destra e sinistra sono soltanto parole da dizionario. Se non altro i compagni anarchici, se non altro questi, dovrebbero avere la capacità di aguzzare lo sguardo al di là del proprio naso. Il desiderio di chi sta in carcere non è tanto quello di essere ricordato di tanto in tanto da un suono indistinto di musica quale che sia udito dietro le mura della propria cella, oppure di essere assistito dalla visita e dalle manifestazioni di affetto asettico di qualche volontario, quanto quello di vedere individuate e colpite le fonti dello sfruttamento.
Basta guardare meglio all’orizzonte e si scorge sempre qualcosa o qualcuno che pesa sulle spalle di chi sta in carcere e questo peso non si può alleggerire con qualche nenia cantata o con qualche spettacolo di folclore.
Le coscienze infelici sono destinate a rimanere tali.
Amen.
[Pubblicato su “Senza Titolo”, n. 4, autunno 2009, pp. 18-23 a firma: Non importa chi]
Alcune aziende di forniture alimentari per carceri
SIRIO snc
Via del Gomito
40127 Bologna
Tel. 051.6388446
DOMENICO VENTURA srl
P.zza Francese 2
80133 Napoli
Tel. 081.283927
MORGANTE spa
Via Aquileia 76
34076 Romans d’Isonzo (GO)
Tel. 0481.966511
RAG. PIETRO GUARNIERI & FIGLI
Via Generale Sabato 11/b
70017 Putignano (BA)
Contrada Cavadonna
96100 Siracusa
Tel. 0931.717395
SAEP spa
Zona Industriale
85050 Baragiano (PZ)
Tel. 0971.993100
Contrada Ceppata 1
64100 Teramo
Tel. 0861.411818
Via Camporgnago 40
20141 Milano
Tel. 02.57606469
Via Vigentina 85
27100 Pavia
Tel. 0382.460121
P.zza Filangieri 2
20123 Milano
Tel. 02.4692403
Via S. Quirico 6
20052 Monza (MI)
Tel. 039.835494
Via Belgioioso
20021 Baranzate (MI)
Tel. 02.38201416
Via Gravellona 240
27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381.311491
Contrada S. Luca
85054 Muro Lucano (PZ)
Tel. 0976.2666
Via Pergolesi 144/a
80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081.5261017
MARR spa – CENTRI DISTRIBUTIVI
Via Spagna 20
47921 Rimini
Tel. 0541.746111
Via G. Pascoli sn
80026 Casoria (NA)
Tel. 081.2378111
Via dell’Acero 2
47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel. 0541.746111
Via Emilia Vecchia 75
CAAR Pad. 3
47922 S. Vito di Rimini (RN)
Tel. 0541.746666
Via Coriano 58
47924 Rimini
Tel. 0541.631011
Via Magellano 4
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547.677111
Via Pennabilli 1
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541.699611
Via F. Fantoni 31
40127 Bologna
Tel. 051.6373111
Via Aldo Moro 37
70043 Monopoli (BA)
Tel. 080.4183611
S.P. 19 km 217,400
87019 Spezzano Albanese (CS)
Tel. 0981.958911
Contrada Feudo Orsa
90045 Cinisi (PA)
Tel. 091.8664049
Via G.V. Bona, 3/5
00156 Roma
Tel. 06.410031
Agg. Industr. di Macchiareddu
09010 Uta (CA)
Tel. 070.24601
Via Tiberina Km 17,150
00060 Capena (RM)
Tel. 06.9038831
Via degli Altiforni 29/31
57037 Portoferraio (LI)
Tel. 0565.922411
Via F. Toni 285/297
51100 Bottegone (PT)
Tel. 0573.946611
Località Terrarossa
16042 Carasco (GE)
Tel. 0185.35371
Via Periane 4
18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464511
Strada di Settimo 224/10
10156 Torino
Tel. 011.2237244
Via C. Pavese 10
20090 Opera (MI)
Tel. 02.576931
Via Monte Rite 18
32040 Tai di Cadore (BL)
Tel. 0435.506666
Via Plerote 6
30028 S. Michele al Tagl. (VE)
Tel. 0431.516411
Via della Croseta 51
38062 Arco (TN)
Tel. 0464.516756
Via dei Lanifici 18
36078 Valdagno (VI)
Tel. 0445.416111
SOCIETA’ DEL GRUPPO MARR:
AS.CA. spa
Via Matteotti 33/2
40050 Villanova di Casten. (BO)
Tel. 051.6055011
NEW CATERING srl
Via Kolbe 5/7
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543.476565
EMI.GEL srl
Via Monari Sardè 16
40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051.6055007
ALISEA srl
Via Imprunetana per Tavarnuzze, 231/b
50029 Tavarnuzze (FI)
Tel. 055.2373720
BALDINI ADRIATICA PESCA
Via Pennabilli 6
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541.605657
MARR spa – AGENTI CON DEPOSITO:
ARCIPELAGO PESCA srl
Zona Ind.le Liscia Columba
07020 Palau (SS)
Tel. 0789.708040
ISCHIA SURGEL FOOD 2 srl
Via Michele Mazzella 202
80077 Ischia (NA)
Tel. 081.902731
SPEED srl
Via A. da Messina (area ex Pirelli)
98049 Villafranca Tirrena (ME)
Tel. 090.3301010
ADRIA MARKET srl
Via Nuova 13
61012 Gradara (PU)
Tel. 0541.961820