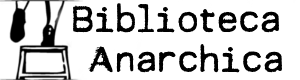Prima edizione: settembre 1977
Seconda edizione: aprile 2007
Terza edizione: novembre 2013
Edizione inglese: Armed Joy, London 1997, 1998
Edizione spagnola: El placer armado, Madrid 2000
Edizione tedesca: Die bewaffnete Freude, New York s.d.
Edizione olandese: Gewapende vreugde, s.l. s.d.
Edizione russa: Riga 2006
Edizione americana: Armed Joy, Baltimore 2003
Edizione turca: Silahli Neşe, Ankara 2009
Edizione croata: Oružana radost, s.l. 2010
Alfredo M. Bonanno
La gioia armata
Nota introduttiva
Quella che esce adesso è la seconda edizione vera e propria di questo libretto. Dal settembre 1977, data della prima edizione, uscita in settemila copie, a causa dei diversi processi conclusi in Corte di Appello a Catania il 30 novembre 1979 con una condanna a un anno e mezzo di carcere per incitamento alla rivolta e propaganda sovversiva, ci sono state soltanto ristampe e riproduzioni clandestine. Le ristampe, esattamente identiche l’originale per non incorrere nei rigori della legge, pubblicate a cura delle Edizioni Anarchismo, sono state dodici per complessive centodiecimila copie, le riproduzioni più o meno clandestine sono state almeno cinque, contando ovviamente solo quelle di cui siamo venuti a conoscenza. A parte vanno indicate, come abbiamo fatto a p. 4, le traduzioni in lingue diverse dall’italiano. Anche di queste edizioni solo alcune sono a nostra conoscenza.
Credo che sia il libretto mio più diffuso e continuamente letto, malgrado i trent’anni dalla sua stesura. Non è poco, considerando l’evolversi della realtà e il mutare delle concezioni teoriche che accompagnano la vita di ogni anarchico e di ogni rivoluzionario. Non è poco che questo testo mantenga ancora la sua freschezza e la sua leggibilità.
Proprio per non modificare le condizioni di lettura non sono state apportate correzioni di alcun genere, nemmeno di formulazione letterale.
Che la civetta continui a volare.
Trieste, 23 febbraio 2007
Alfredo M. Bonanno
Introduzione all’edizione inglese
Scritto nel 1977, sotto la spinta delle lotte rivoluzionarie condotte in Italia in quel momento, questo libro deve essere letto oggi tenendo conto di quella situazione, ormai profondamente modificata.
Il movimento rivoluzionario, e al suo interno anche quello anarchico, era ancora nella fase di sviluppo e tutto appariva possibile, anche una generalizzazione dello scontro armato.
Ma da un pericolo occorreva guardarsi, dalla specializzazione e dalla militarizzazione, che una ristretta minoranza di militanti intendevano imporre alle decine di migliaia di compagni che lottavano con ogni mezzo contro la repressione e contro i tentativi dello Stato – per la verità alquanto deboli – di riorganizzare la gestione del capitale.
Questa era la situazione in Italia, ma qualcosa di simile accadeva in Germania, in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi.
Appariva quindi essenziale evitare che il gran numero di azioni che venivano realizzate giornalmente sul territorio dai compagni, azioni di attacco contro uomini e strutture del dominio e del capitale, non venissero convogliate nella logica dirigista di un partito armato, come le Brigate Rosse in Italia, tanto per fare un esempio.
Lo spirito del libro è tutto qui. Fa vedere come da una pratica quotidiana di liberazione, e di distruzione, possa venire fuori una logica gioiosa di lotta e non un metodo mortale e schematico di irrigidimento dentro i canoni prefissati da un gruppo dirigente.
Oggi alcuni di questi problemi non esistono più. Sono stati risolti dalle dure lezioni della storia. Il crollo del socialismo reale ha ridimensionato, improvvisamente e forse per sempre, le velleità dirigiste dei marxisti di ogni tendenza e di ogni pelo. Ma non ha spento, anzi al contrario forse ha infiammato, il desiderio di libertà e di comunismo anarchico che ormai serpeggia dappertutto, specialmente fra le giovani generazioni, anche se nella maggior parte dei casi non si fa ricorso ai simboli tradizionali dell’anarchismo, alle sue sigle e alle sue teorie, ritenute anch’esse, con un moto dell’animo comprensibile ma non condivisibile, affette di ideologismo.
Ed ecco che oggi la lettura di questo libro riappare attuale, ma di un’attualità differente. Non più critica verso una pesante struttura di accaparramento che non esiste più, ma gioiosamente capace di indicare le potenti capacità dell’individuo, nella sua strada verso la distruzione di tutto quello che opprime e regolamenta.
Prima di chiudere devo ricordare che il libro è stato condannato in Italia alla distruzione. Una sentenza della suprema corte italiana lo ha destinato al rogo. In tutte le biblioteche dove si trovava un suo esemplare è arrivata una circolare del ministero dell’Interno per ordinare l’incenerimento. Non sono stati pochi i bibliotecari che si sono rifiutati di distruggere il libro, ritenendo tale pratica degna dei nazisti e dell’Inquisizione, ma il volume non è consultabile per legge. Allo stesso modo il libro non può circolare in Italia e molti compagni ne hanno avuto sequestrate delle copie nel corso di innumerevoli perquisizioni domiciliari.
Per avere scritto questo libro, sono stato condannato ad un anno e mezzo di prigione.
Catania, 14 luglio 1993
Alfredo M. Bonanno
La gioia armata
I
[A Parigi, nel 1848, la rivoluzione]
fu una vacanza senza principio e senza fine.
Bakunin
Ma perché questi benedetti ragazzi sparano alle gambe di Montanelli? Non sarebbe stato meglio sparargli in bocca?
Certo che sarebbe stato meglio. Ma sarebbe stato anche più pesante. Più vendicativo e più cupo. Azzoppare una bestia come quella può anche avere un lato più profondo e significativo, oltre quello della vendetta, della punizione per le responsabilità di Montanelli, fascista e servo dei padroni.
Azzopparlo significa costringerlo a claudicare, farglielo ricordare. E poi, è un divertimento più gradevole di sparargli in bocca, col cervello che gli schizza fuori dagli occhi.
Il compagno che ogni mattina si alza per andare a lavorare, che s’incammina nella nebbia, che entra nell’atmosfera irrespirabile della fabbrica o dell’ufficio, per ritrovarvi le stesse facce: la faccia del capo reparto, del conta-tempi, della spia di turno, dello stacanovista-con-sette-figli-a-carico; questo compagno sente la necessità della rivoluzione, della lotta e dello scontro fisico, anche mortale, ma sente pure che tutto ciò gli deve apportare un poco di gioia, subito, non dopo. E questa gioia se la coltiva nelle sue fantasie, mentre cammina a testa bassa nella nebbia, mentre passa ore nei treni o nei tram, mentre soffoca sotto le pratiche inutili dell’ufficio o davanti agli inutili bulloni che servono a tenere insieme gli inutili meccanismi del capitale.
La gioia retribuita, quella che il padrone gli paga settimanalmente (vacanza domenicale) o annualmente (ferie), è come fare l’amore a pagamento. Sì, l’aspetto esteriore è uguale, ma qualcosa manca.
Cento discorsi si affastellano nei libri, negli opuscoli, nei giornali rivoluzionari. Bisogna far questo, bisogna far quest’altro, bisogna vedere le cose così, bisogna vederle come dice il tizio, come dice il caio, perché tizio e caio sono i veri interpreti dei tizi e caii del passato, quelli con le lettere maiuscole, che riempiono gli asfissianti volumi dei classici.
Anche questi bisogna tenere a portata di mano. Fa parte della liturgia, il non averli è segno negativo, desta sospetti. Va bene che tenerli sotto mano può essere utile, essendo volumi ponderosi (cioè pesanti) possono essere usati per gettarli in faccia a qualche rompiscatole. Utilizzazione non nuova ma sempre gradevole della validità rivoluzionaria delle tesi del passato (e del presente).
Mai discorsi sulla gioia in quei volumi. L’austerità del chiostro non ha nulla da invidiare all’atmosfera che si respira in quelle pagine. I loro autori, sacerdoti della rivoluzione della vendetta e del castigo, passano le giornate a pesare e contabilizzare colpe e pene.
D’altro canto, queste vestali in bleu jeans, hanno fatto giuramento di castità, quindi pretendono e impongono. Vogliono essere retribuiti per sacrifici che hanno fatto. Per primo hanno abbandonato l’ovattato ambiente della loro classe di origine, poi hanno messo le loro capacità al servizio dei diseredati, poi si sono accostumati a parlare un linguaggio non proprio e a sopportare tovaglie sporche e letti disfatti. Quindi, che li si ascolti, almeno.
Sognano rivoluzioni ordinate, princìpi in bell’ordine, anarchia senza turbolenze. Quando la realtà prende una piega diversa, gridano subito alla provocazione e strillano fino a farsi sentire dalla polizia.
I rivoluzionari sono gente pia. La rivoluzione no.
II
Io chiamo un gatto un gatto.
Boileau
Siamo tutti presi dal problema rivoluzionario di come e di cosa produrre, ma nessuno parla del produrre in quanto problema rivoluzionario.
Se la produzione è la base dello sfruttamento attuato dal capitale, cambiare modo di produzione significa cambiare modo di sfruttamento, non significa eliminare lo sfruttamento.
Un gatto, anche tingendolo di rosso, è sempre un gatto.
Il produttore è sacro. Non si tocca. Che si santifichi, piuttosto, anche il suo sacrificio, in nome della rivoluzione, e il gioco è fatto.
E che cosa mangeremo? si domandano i più preoccupati. Pane e spago, rispondono i realisti semplificatori, con un occhio alla marmitta e l’altro al fucile. Idee, rispondono gli idealisti pasticcioni, con un occhio al libro dei sogni e l’altro al genere umano.
Chi tocca la produttività muore.
Il capitalismo e coloro che lo combattono siedono insieme sul cadavere del produttore, purché il mondo della produzione continui.
La critica dell’economia politica è una razionalizzazione del modo di produrre col minimo sforzo (di coloro che godono dei benefici della produzione). Gli altri, quelli che subiscono lo sfruttamento, devono badare a non far mancare niente. In caso contrario, come si vivrebbe?
Il figlio delle tenebre, uscendo alla luce, non vede nulla come quando brancolava nel buio. La gioia lo acceca. Lo uccide. Allora la chiama allucinazione, e la condanna.
I borghesi, panciuti e frolli, godono nel loro opulento far niente. Godere è, pertanto, peccaminoso. Significa condividere gli stimoli della borghesia, tradire quelli del proletariato produttore.
Non è vero. I borghesi si danno una gran pena per mantenere vivo il processo di sfruttamento. Anche loro sono stressati e non trovano un momento per la gioia. Le loro crociere sono occasioni per nuovi progetti d’investimento. Le loro amanti sono quinte colonne per l’informazione nel campo del concorrente.
Il dio della produttività uccide anche i suoi umili servitori. Stacchiamogli la testa, ne uscirà un diluvio d’immondizie.
Il misero affamato, guardando il ricco circondato dalla sua servitù, cova sentimenti di vendetta. La distruzione del nemico prima di tutto. Ma che si salvi il bottino. La ricchezza non deve essere distrutta, ma utilizzata. Non importa che cosa essa costituisca, che veste assuma, quali prospettive d’impiego consenta. Quello che conta è strapparla all’attuale detentore per disporne liberamente tutti.
Tutti? Certamente, tutti.
E come avverrà il passaggio?
Con la violenza rivoluzionaria.
Bella risposta. Ma, in concreto, che cosa faremo, dopo aver tagliato tante teste fino ad averne noia? Cosa faremo quando non si troverà un proprietario nemmeno a cercarlo con la lanterna?
Allora sarà il regno della rivoluzione. A ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue possibilità.
Attento compagno. Qui c’è odore di contabilità. Si parla di consumo e di produzione. Si resta all’interno della dimensione della produttività. Nell’aritmetica ci si sente sicuri. Due più due fanno quattro. Nessuno potrà mai smentire questa “verità”. I numeri governano il mondo. Se lo hanno fatto da sempre, perché non dovrebbero farlo per sempre?
Abbiamo bisogno tutti di cose solide, dure. Pietre su cui costruire un muro contro gli stimoli preoccupanti che ci salgono alla gola. Abbiamo bisogno tutti di oggettività. Il padrone giura sul suo portafoglio, il contadino sulla sua vanga, il rivoluzionario sul suo fucile. Aprite uno spiraglio critico e tutta l’impalcatura oggettiva crolla.
L’esterno quotidiano, nella sua pesantezza oggettiva, ci condiziona e ci riproduce. Siamo figli della banalità quotidiana. Anche quando parliamo di “cose importanti”, come la rivoluzione, abbiamo sempre gli occhi fissi sul calendario. Il padrone ha paura della rivoluzione perché gli toglierebbe il portafoglio, il contadino farà la rivoluzione per avere la terra, il rivoluzionario per verificare la sua teoria.
Posto in questi termini il problema, tra portafoglio, terra e teoria rivoluzionaria, non c’è differenza. Tutti questi oggetti sono puramente immaginari, sono lo specchio delle illusioni umane.
Solo la lotta è reale.
Discrimina il padrone dal contadino e stabilisce l’alleanza tra contadino e rivoluzionario.
Le forme organizzative della produzione degli oggetti sono i veicoli ideologici che coprono la sostanziale illusione dell’identità del singolo. Questa identità viene proiettata nell’immaginazione economica del valore. Un codice ne stabilisce l’interpretazione. Alcuni elementi di questo codice sono in mano ai padroni. Ce ne siamo accorti con il consumismo. Anche la tecnologia della guerra psicologica e della repressione totale, sono elementi di una interpretazione dell’essere uomini a condizione che si è produttori.
Altri elementi del codice sono disponibili per un uso modificativo. Non rivoluzionario, ma semplicemente modificativo. Pensiamo, ad esempio, al consumismo sociale che si sostituirà al consumismo signorile degli ultimi anni.
Ma ne esistono ancora altri. Più raffinati. Il controllo autogestionario della produzione è un altro elemento del codice dello sfruttamento.
E così via. Se a qualcuno viene in mente di organizzarmi la vita, questo qualcuno non potrà essere mai mio compagno. Se giustifica il suo modo di fare con la scusa che bisogna pure che ci sia qualcuno che “produca”, altrimenti tutti perderemmo la nostra identità di uomini, lasciandoci sopraffare dalla “natura selvaggia e incolta”, risponderemo che il rapporto natura-uomo è un’illusione della borghesia marxista illuminata. Perché mai si è voluto cambiare una spada in un forcone? Perché l’uomo si deve sempre preoccupare di distinguersi dalla natura?
III
Gli uomini, se non giungono a ciò
che è necessario, si affaticano per
ciò che è inutile.
Goethe
L’uomo ha bisogno di molte cose.
Generalmente questa affermazione si interpreta nel senso che l’uomo ha dei bisogni, e che è obbligato a soddisfarli.
Si ha, in questo modo, la trasformazione dell’uomo, da un’unità ben precisa storicamente, in una dualità (mezzo e fine nello stesso tempo). Infatti, egli si realizza nella soddisfazione dei suoi bisogni (cioè nel lavoro) ed è, quindi, lo strumento della propria realizzazione.
Ognuno vede quanta mitologia si nasconde sotto queste affermazioni. Se l’uomo non si differenzia dalla natura senza il lavoro, come può realizzare se stesso nella soddisfazione dei suoi bisogni? Per far ciò dovrebbe essere di già uomo, quindi dovrebbe aver realizzato i suoi bisogni, quindi non dovrebbe aver bisogno di lavorare.
La merce costruisce da se stessa la profonda utilità del simbolo. Diventa, così, punto di riferimento, unità di misura, valore di scambio. Lo spettacolo inizia. I ruoli vengono assegnati. Si riproducono. All’infinito. Senza modificazioni degne di nota, gli attori s’impegnano nella recitazione.
La soddisfazione del bisogno diventa un effetto riflesso, marginale. La cosa più importante è la trasformazione dell’uomo in “cosa”, e con l’uomo tutto il resto. La natura diventa “cosa”. Utilizzata si corrompe e corrompe gli istinti vitali dell’uomo. Tra la natura e l’uomo si aprono larghi spazi, che occorre riempire. A questo provvede la stessa espansione del mercato mercantile. Lo spettacolo si allarga al punto da mangiare se stesso e la propria contraddizione. Platea e palcoscenico entrano in una stessa dimensione e si ripropongono per un livello superiore, più ampio, di riproduzione dello spettacolo stesso, e così all’infinito.
Chi sfugge al codice mercantile non riceve la sua oggettivazione e cade “fuori” della sede reale dello spettacolo. Qui viene segnato a dito. Circondato dal filo spinato. Se non accetta la proposta di inglobamento, se rifiuta un nuovo livello di codificazione, lo si criminalizza. La sua “follia” è evidente. Non è consentito rifiutare l’illusorio in un mondo che ha fondato la realtà sull’illusione e la concretezza sul fittizio.
Il capitale gestisce lo spettacolo sulla base della legge dell’accumulazione. Ma nessuna cosa può essere accumulata indefinitivamente. Nemmeno il capitale. Un processo quantitativo assoluto è un’illusione, un’illusione quantitativa. Ciò è stato compreso perfettamente dai padroni. Lo sfruttamento assume forme e modelli ideologici diversi proprio per garantire, in modo qualitativamente diverso, quell’accumulazione che non poteva continuare all’infinito sotto l’aspetto quantitativo.
Che tutto l’insieme rientri nel paradossale e nell’illusorio, al capitale non importa molto, perché è esso che tiene le redini e fissa le regole. Se deve vendere l’illusione per realtà, e questo gli procura quattrini, tanto vale continuare a venderla e non porsi troppi problemi. Sono gli sfruttati che pagano il conto. È quindi loro compito accorgersi dell’illusione e preoccuparsi di individuare la realtà. Per il capitale le cose vanno bene come vanno, anche se sono fondate sul più grande spettacolo illusionistico del mondo.
Gli sfruttati hanno quasi nostalgia di questa illusione. Hanno fatto il callo alle catene e ci si sono affezionati. Sognano qualche volta affascinanti sollevamenti e bagni di sangue, ma si lasciano abbagliare dalle parole delle nuove guide politiche. Il partito rivoluzionario allarga la prospettiva illusoria del capitale ad orizzonti che quest’ultimo, da solo, non potrebbe mai raggiungere.
È ancora l’illusione quantitativa a far strage.
Gli sfruttati si arruolano, si contano, si assommano, ferocissimi slogan fanno sobbalzare il cuore nel petto dei borghesi. Quanto più alto è il numero di coloro che si contano, tanto più grandi diventano la tracotanza e le pretese delle guide. Quest’ultime fanno programmi di conquista. Il nuovo potere si dispone sulle spoglie del vecchio. L’anima di Bonaparte sorride soddisfatta.
Certo, profonde modificazioni nel codice delle illusioni vengono programmate. Ma tutto deve sottostare al segno dell’accumulazione quantitativa. Crescono le forze militanti, devono crescere le pretese della rivoluzione. Allo stesso modo deve crescere il tasso del profitto sociale, che si viene a sostituire al profitto privato. Il capitale entra, in questo modo, in una nuova fase illusoria e spettacolare. I vecchi bisogni incalzano sotto nuove etichette. Il dio della produttività continua a dominare senza rivali.
Contarsi è bello. Ci fa credere forti. I sindacati si contano. I partiti si contano. I padroni si contano. Contiamoci anche noi. Girotondo.
E quando abbiamo finito di contarci, cerchiamo di far restare le cose come prima. E se la modificazione è proprio necessaria, facciamola senza disturbare nessuno. I fantasmi si lasciano penetrare facilmente.
La politica si riscopre periodicamente. Spesso il capitale trova soluzioni geniali. Allora la pace sociale cade sulle nostre teste. Un silenzio da cimitero. L’illusione si generalizza ad un grado tale che lo spettacolo assorbe quasi tutte le forze disponibili. Tutto tace. Poi si riscoprono i difetti e la monotonia della messa in scena. Il sipario si alza su situazioni impreviste. La macchina capitalistica accusa i colpi. Allora, riscopriamo l’impegno rivoluzionario. È accaduto nel Sessantotto. Tutti con gli occhi fuori dalle orbite. Tutti ferocissimi. Ciclostilate da morirci sopra. Montagne di volantini e opuscoli e giornali e libri. Le vecchie sfumature ideologiche messe in colonna come tanti soldatini. Anche gli anarchici riscoprivano se stessi. E lo facevano storicamente, secondo le esigenze del momento. Ottusi tutti. Ottusi anche gli anarchici. Quando qualcuno si svegliava dal sonno spettacolare e, guardandosi attorno, cercava spazio e aria da respirare, e vedendo gli anarchici diceva a se stesso: finalmente! ecco con chi voglio stare. Subito dopo si accorgeva della stupidaggine. Nemmeno in quella direzione le cose andavano come sarebbero dovute andare. Anche là: ottusità e spettacolo. E questo qualcuno fuggiva. Si richiudeva in se stesso. Si smontava. Accettava il gioco del capitale. E se non lo accettava veniva messo al bando, da tutti, anche dagli anarchici.
La macchina del Sessantotto ha prodotto i migliori funzionari del nuovo Stato tecnoburocratico. Ma ha anche prodotto degli anticorpi. I processi dell’illusione quantitativa sono diventati visibili. Da un lato, hanno ricevuto una nuova linfa, per costruire una nuova visione dello spettacolo mercantile, dall’altro, hanno subito delle incrinature.
L’inutilità dello scontro sul piano della produttività è diventata palese. Impadronitevi delle fabbriche, delle campagne, delle scuole, dei quartieri e autogestiteli, dicevano i vecchi rivoluzionari anarchici. Abbattiamo il potere sotto tutti i suoi aspetti, aggiungevano subito dopo. Ma non penetravano più a fondo, non mostravano la vera realtà della piaga. Pur sapendone la gravità e l’estensione preferivano nasconderla, sperando nella spontaneità creatrice della rivoluzione. Solo che volevano attendere i risultati di questa spontaneità con le mani sui mezzi di produzione. Qualsiasi cosa accade, quale che sia la forma creativa che prenderà la rivoluzione, dobbiamo avere i mezzi di produzione in nostro possesso, essi affermavano. Altrimenti il nemico ci sconfiggerà sul piano della produzione. E per far ciò si adattavano a compromessi di ogni tipo. Per non allontanarsi troppo dalla stanza delle decisioni spettacolari, finivano per costruire un’altra forma di spettacolo alcune volte altrettanto macabro.
L’illusione spettacolare ha le sue regole. Chi vuole gestirla deve sottoporsi a queste regole. Deve conoscerle, imporle e giurarci sopra. La regola prima è che la produzione condiziona tutto. Chi non produce non è un uomo, la rivoluzione non è per lui. Perché dovremmo tollerare i parassiti? Non dovremmo forse lavorare al loro posto? Non dovremmo assicurare anche la loro sopravvivenza? E inoltre: tutta questa gente senza idee chiare e con la pretesa di voler fare di testa loro, non risultano “oggettivamente” funzionali alla controrivoluzione? Quindi, tanto vale attaccarli fin d’ora. Si sappia chi sono i nostri alleati e con chi vogliamo stare. Se dobbiamo far paura facciamola tutti insieme, inquadrati in perfetto ordine, e che nessuno metta i piedi sulla tavola o si cali le brache.
Organizziamo le nostre strutture specifiche. Formiamo militanti che conoscano perfettamente le tecniche della lotta nei settori della produzione. La rivoluzione la faranno soltanto i produttori, e noi saremo là per impedire loro di fare fesserie.
No. Tutto ciò è sbagliato. In che modo potremo impedire loro di fare fesserie? Sul piano dello spettacolo illusorio dell’organizzazione ci sono tromboni molto più grossi di noi. Ed hanno fiato da sprecare. Lotta sul posto di lavoro. Lotta per la difesa del lavoro. Lotta per la produzione.
Quando romperemo il cerchio? Quando finiremo di mangiarci la coda?
IV
L’uomo deforme trova sempre degli
specchi che lo rendono bello.
Sade
Che follia l’amore per il lavoro!
Che grande abilità scenica quella del capitale che ha saputo fare amare lo sfruttamento agli sfruttati, la corda agli impiccati e la catena agli schiavi.
Questa idealizzazione del lavoro ha ucciso, fino ad oggi, la rivoluzione. Il movimento degli sfruttati è stato corrotto tramite l’immissione della morale borghese della produzione, cioè di qualcosa che non è solo estranea al movimento, ma gli è anche contraria. Non è un caso che la parte a corrompersi per prima sia stata quella sindacale, proprio perché più vicina alla gestione dello spettacolo produttivo.
All’etica produttiva bisogna contrapporre l’estetica del non lavoro.
Alla soddisfazione dei bisogni spettacolari, imposti dalla società mercantile, bisogna contrapporre la soddisfazione dei bisogni naturali dell’uomo, rivalutati alla luce del bisogno primario ed essenziale: il bisogno di comunismo.
La valutazione quantitativa della pressione che i bisogni esercitano sull’uomo, risulta, in questo modo, capovolta. Il bisogno di comunismo trasforma gli altri bisogni e la loro pressione sull’uomo.
La miseria dell’uomo, oggetto di sfruttamento, è stata vista come la base del futuro riscatto. Il cristianesimo e i movimenti rivoluzionari si danno la mano attraverso la storia. Bisogna soffrire per conquistare il paradiso o per acquisire la coscienza di classe che porterà alla rivoluzione. Senza l’etica del lavoro, la nozione marxista di “proletariato” non avrebbe senso. Ma l’etica del lavoro è un prodotto del razionalismo borghese, lo stesso prodotto che ha consentito la conquista del potere da parte della borghesia.
Il corporativismo risorge attraverso le maglie dell’internazionalismo proletario. Ognuno lotta all’interno del proprio settore. Al massimo stabilisce contatti (attraverso i sindacati) con i settori similari degli altri paesi. Alla monoliticità delle multinazionali si contrappone la monoliticità delle centrali sindacali internazionali. Facciamo la rivoluzione, ma salviamo la macchina, lo strumento di lavoro, l’oggetto mitico che riproduce la virtù storica della borghesia, diventata adesso patrimonio del proletariato.
L’erede dei destini della rivoluzione è il soggetto destinato a diventare consumatore ed attore principale dello spettacolo futuro del capitale. La classe rivoluzionaria, idealizzata a livello di destinataria delle sorti dello scontro di classe, svanisce nell’idealismo della produzione. Quando gli sfruttati vengono rinchiusi all’interno di una classe, si sono già confermati tutti gli elementi dell’illusione spettacolare, gli stessi della classe borghese.
Per sfuggire al progetto globalizzante del capitale, gli sfruttati hanno solo la strada che passa per il rifiuto del lavoro, della produzione, dell’economia politica.
Ma il rifiuto del lavoro non deve essere confuso con la “mancanza di lavoro” in una società basata sul lavoro. L’emarginato cerca lavoro. Non lo trova. È spinto verso la ghettizzazione. È criminalizzato. Tutto ciò rientra nella gestione complessiva dello spettacolo produttivo. Occorrono al capitale, sia i produttori sia i non garantiti. Solo che l’equilibrio è instabile. Le contraddizioni esplodono e procurano crisi di vario tipo, all’interno delle quali si gestisce l’intervento rivoluzionario.
Quindi, il rifiuto del lavoro, la distruzione del lavoro, è l’affermazione del bisogno del non-lavoro. L’affermazione che l’uomo può autoprodursi e autoggettivarsi attraverso il non-lavoro, attraverso le sollecitazioni di vario genere che il bisogno del non-lavoro gli procura. Vedendo il concetto di distruzione del lavoro dal punto di vista dell’etica del lavoro, si resta interdetti. Ma come? Tanta gente cerca lavoro, è disoccupata, e si parla di “distruzione del lavoro”? Il fantasma luddista emerge a spaventare i rivoluzionari-che-si-sono-letti-tutti-i-classici. Lo schema dell’attacco frontale e quantitativo alle forze del capitale deve restare identico. Non importano i fallimenti e le sofferenze del passato, non importano le vergogne e i tradimenti. Ancora avanti, sostenuti dalla fede in un giorno migliore, ancora avanti!
Per spaventare i proletari, e spingerli nell’atmosfera stagnante delle organizzazioni di classe (partiti, sindacati e movimenti reggicoda), basta far vedere in che cosa annega oggi il concetto di “tempo libero”, di sospensione del lavoro. Lo spettacolo delle organizzazioni burocratiche del tempo libero è fatto apposta per deprimere le immaginazioni più fertili. Ma questo modo d’agire non è altro che copertura ideologica, uno degli strumenti della guerra totale che costituisce la base dello spettacolo complessivo.
È il bisogno di comunismo che trasforma tutto. Attraverso il bisogno di comunismo il bisogno del non-lavoro passa dal momento negativo (contrapposizione al lavoro), al momento positivo: disponibilità completa dell’individuo davanti a se stesso, possibilità totale di esprimersi liberamente, rottura di tutti gli schemi, anche di quelli considerati fondamentali e ineliminabili, come lo schema della produzione.
Ma i rivoluzionari sono uomini ligi ed hanno paura di rompere tutti gli schemi, compreso quello della rivoluzione, se questo – in quanto schema – costituisce un ostacolo alla piena realizzazione di quanto il concetto promette. Hanno paura di trovarsi senz’arte né parte. Avete mai conosciuto un rivoluzionario senza un progetto rivoluzionario? Un progetto ben definito e chiaramente esposto alle masse? Che razza di rivoluzionario è colui il quale pretende di distruggere lo schema, l’involucro, il fondamento della rivoluzione? Colpendo i concetti di quantificazione, di classe, di progetto, di schema, di missione storica, ed altre simili anticaglie, si corre il rischio di non avere nulla da fare, di essere obbligati ad agire, nella realtà, modestamente, come tutti gli altri, come milioni di altri, che la rivoluzione la costruiscono giorno per giorno, senza attendere il segno di una fatale scadenza. E per fare questo ci vuole coraggio.
Con gli schemi e i giochetti quantitativi si è nel fittizio, cioè nel progetto illusorio della rivoluzione, ampliamento dello spettacolo del capitale; con l’abolizione dell’etica produttiva si entra direttamente nella realtà rivoluzionaria.
Lo stesso parlare di queste cose è difficile. Perché non avrebbe senso parlarne attraverso le pagine di un trattato. Mancherebbe l’obiettivo, chi cercasse di ridurre questi problemi ad un’analisi completa e definitiva. La forma migliore sarebbe il discorso simpatico e leggero, capace di realizzare quella sottile magia dei giochi di parole.
Parlare seriamente della gioia è veramente una contraddizione.
V
Le notti di estate sono pesanti. Nelle
piccole camere si dorme male: è la
Vigilia della Ghigliottina.
Zo d’Axa
Anche lo sfruttato trova il tempo per giocare. Ma il suo gioco non è gioia. È una liturgia macabra. Un’attesa della morte. Una sospensione del lavoro usata per scaricare la carica di violenza accumulata nel corso della produzione. Nell’illusorio mondo della merce, anche il gioco è illusorio. Ci si illude di giocare, mentre non si fa altro che ripetere monotonamente i ruoli assegnati dal capitale.
Prendendo coscienza dei processi di sfruttamento, la prima cosa cui si pensa è la vendetta, l’ultima la gioia. La liberazione è vista come ricomposizione di un equilibrio rotto dalla cattiveria del capitale, non come avvento di un mondo del gioco che si sostituirà al mondo del lavoro.
È la prima fase dell’attacco contro i padroni. La fase della coscienza immediata. Quello che ci colpisce sono le catene, la frusta, le mura del carcere, le barriere sessuali e razziali. Tutto ciò deve cadere. Per questo ci armiamo e per questo colpiamo l’avversario, il responsabile.
Nella notte della ghigliottina si gettano le basi di un nuovo spettacolo, il capitale ricostruisce le sue forze: prima cadono le teste dei padroni, poi quelle dei rivoluzionari.
Non è possibile fare la rivoluzione solo con la ghigliottina. La vendetta è l’anticamera della guida. Chi vuole vendicarsi ha bisogno di un capo. Un capo che conduca alla vittoria e ristabilisca la giustizia ferita. E chi vuole vendicarsi è portato a vendicare un possesso di qualcosa che gli è stato tolto. Fino alla suprema astrazione: l’esproprio del plus-valore.
Il mondo del futuro deve essere un mondo dove tutti lavorano. Bene! Avremo, in questo modo, imposto la schiavitù a tutti, escluso quelli che dovranno farla continuare che, proprio per questo, saranno i nuovi padroni.
Vada come vada ma i padroni devono “pagare” per le loro colpe. Bene! Avremo, in questo modo, riportato l’etica cristiana del peccato, della condanna e dell’espiazione, all’interno della rivoluzione. A prescindere dai concetti di “debito” e di “pagare” che sono di chiara derivazione mercantile.
Tutto ciò fa parte dello spettacolo. Quando non è direttamente gestito dal potere, può essere ripreso con facilità. Un capovolgimento dei ruoli recitativi fa parte delle tecniche drammaturgiche.
Ad un certo livello dello scontro di classe, può essere indispensabile attaccare con le armi della vendetta e della punizione. Il movimento può non possederne altre. È, allora, il momento della ghigliottina. Ma i rivoluzionari devono essere coscienti dei limiti di queste armi. Non possono illudersi ed illudere gli altri.
Nel quadro paranoico di una macchina razionalizzante, com’è il capitale, anche il concetto di rivoluzione della vendetta, può entrare a far parte del continuo modificarsi dello spettacolo. Il movimento apparente della produzione si svolge sotto la benedizione della scienza economica, ma si basa in realtà sull’antropologia illusoria della separazione dei compiti.
Non c’è gioia nel lavoro. Nemmeno nel lavoro autogestito. La rivoluzione non può rinchiudersi in una modificazione dell’organizzazione del lavoro. Soltanto in ciò.
Non c’è gioia nel sacrificio, nella morte, nella vendetta. Così come non c’è gioia nel contarsi. L’aritmetica è la negazione della gioia.
Chi vuole vivere non produce la morte. L’accettazione transitoria della ghigliottina conduce alla sua istituzionalizzazione. Ma, nello stesso tempo, chi ama la vita non abbraccia il suo sfruttatore. In caso contrario, odierebbe la vita e amerebbe il sacrificio, la punizione di se stesso, il lavoro, la morte.
All’interno del cimitero del lavoro, secoli di sfruttamento hanno accumulato una montagna della vendetta. Su questa montagna siedono impassibili i capi del movimento rivoluzionario. Studiano il modo migliore di mettere a profitto la montagna. La carica di violenza vendicatrice deve essere indirizzata verso gli interessi della nuova casta di potere. Simboli e bandiere. Parole d’ordine e analisi complicate. L’apparato ideologico si dispone a fare quanto necessario.
L’etica del lavoro rende possibile la strumentalizzazione. Chi ama il lavoro vuole impadronirsi dei mezzi di produzione, non vuole che si vada avanti alla cieca. Sa, per esperienza, che i padroni hanno avuto dalla loro una potente organizzazione per rendere possibile lo sfruttamento. Pensa che solo un’organizzazione altrettanto potente e perfetta, renderà possibile la liberazione. Che si faccia tutto il possibile ma che si salvi la crescita produttiva.
Quale immenso inganno. L’etica del lavoro è l’etica cristiana del sacrificio, l’etica dei padroni, in base alla quale gli eccidi della storia si sono susseguiti con preoccupante metodicità.
Questa gente non riesce a pensare che si può non produrre plus-valore, che pur potendolo produrre ci si può rifiutare di farlo. Che si può affermare, contro il lavoro, una volontà non-produttiva, capace di lottare non solo contro le strutture economiche dei padroni, ma anche contro quelle ideologiche, che attraversano tutto il pensiero occidentale.
È indispensabile capire che l’etica del lavoro costituisce anche la base del progetto rivoluzionario quantitativo. Non avrebbe senso un discorso contro il lavoro fatto dalle organizzazioni rivoluzionarie all’interno della loro logica della crescita quantitativa.
L’estetica della gioia, sostituendosi all’etica del lavoro non impedisce la vita, come tanti preoccupati compagni affermano. Alla domanda: che cosa mangeremo? si può rispondere, con tutta tranquillità: quello che produrremo. Solo che la produzione non sarà più la dimensione in cui l’uomo si autodetermina, trasferendosi questa nella sfera del gioco e della gioia. Si potrà produrre, non come qualcosa di separato dalla natura, che una volta realizzato, si ricongiunge a quest’ultima. Ma come qualcosa che è la natura stessa. Per cui l’arresto della produzione sarà possibile in ogni momento, quando se ne avrà abbastanza. Solo la gioia sarà inarrestabile. Una forza ignota alle larve civilizzate che popolano la nostra epoca. Una forza che moltiplicherà per mille l’impulso creativo della rivoluzione.
La ricchezza sociale del mondo comunista non si misura dall’accumulazione del plus-valore, anche se quest’ultimo risulta gestito da una minoranza che si chiama partito del proletariato. Questa situazione riproduce il potere, negando il fondamento stesso dell’anarchia. La ricchezza sociale comunista è data dalla potenzialità di vita che si realizza dopo la rivoluzione. All’accumulazione capitalista deve sostituirsi non un’accumulazione quantitativa (anche se gestita da un partito) ma un’accumulazione qualitativa. La rivoluzione della vita si sostituisce alla semplice rivoluzione economica. La potenzialità produttiva alla produzione cristallizzata. La gioia allo spettacolo.
La negazione del mercato spettacolare dell’illusione capitalista, imporrà un altro tipo di scambio. Dallo scambio fittizio quantitativo allo scambio reale qualitativo. La circolazione non si baserà sugli oggetti, e quindi sulla loro reificazione illusionistica, ma sul senso che gli oggetti avranno per la vita. E un senso “per la vita” deve essere un senso di vita e non un senso di morte. Questi oggetti saranno, quindi, limitati al momento preciso in cui vengono scambiati ed avranno un significato sempre diverso a seconda delle situazioni che determineranno lo scambio.
Uno stesso oggetto potrà avere “valori” profondamente diversi. Sarà personificato. Estraneo alla produzione così come la conosciamo nella dimensione del capitale. Lo stesso scambio avrà un senso se visto attraverso il rifiuto della produzione illimitata. Non esiste il lavoro liberato.
Non esiste il lavoro integrato (manuale-intellettuale). Quello che esiste è la divisione del lavoro e la vendita della forza lavoro, cioè il mondo capitalista della produzione. La rivoluzione sarà sempre e soltanto negazione del lavoro, affermazione della gioia. Ogni tentativo di imporre l’idea di un lavoro “solo lavoro”, senza sfruttamento, di un lavoro “autogestito”, di un lavoro in cui lo sfruttato si riappropria della totalità del processo produttivo, è una mistificazione.
Il concetto di autogestione della produzione resta valido solo come schema di lotta contro il capitale, difatti non può separarsi dal concetto di autogestione della lotta. Spenta la lotta, l’autogestione non è altro che autogestione del proprio sfruttamento. Realizzata vittoriosamente la lotta, l’autogestione della produzione diventa superflua, perché dopo la rivoluzione, è superflua e controrivoluzionaria l’organizzazione della produzione.
VI
Finché prendi il lanciato da te, tutto
è destrezza e risibile vincita; solo
se tu d’improvviso diventi chi prende
la palla che un’eterna compagna
di giochi lanciò a te, al tuo centro,
con lo slancio propriamente potuto,
in uno di quegli archi di grande,
divina costruzione di ponti: solo allora
saper prendere è forza – non tua,
di un mondo.
Rilke
Tutti noi crediamo di avere esperienza della gioia. Almeno una volta, ognuno di noi, ha creduto di gioire nella propria vita.
Solo che questa esperienza della gioia ha sempre una forma passiva. Ci accade di gioire. Non possiamo “volere” la nostra gioia, come non possiamo obbligare la gioia a ripresentarsi.
Tutto ciò, questa separazione tra noi e la gioia, dipende dal nostro essere “separati” da noi stessi, tagliati in due dal processo di sfruttamento.
Lavoriamo tutto l’anno per avere la “gioia” delle vacanze. Quando queste arrivano ci sentiamo in “obbligo” di “gioire” del fatto di essere in vacanza. È una tortura come un’altra. Lo stesso per la domenica. Un giorno allucinante. La rarefazione dell’illusione del tempo libero ci fa vedere la vacuità dello spettacolo mercantile in cui viviamo.
Lo stesso sguardo assente fissa il bicchiere semivuoto, la televisione, la partita di calcio, la fiala di eroina, lo schermo del cinema, le lunghe fila delle automobili, le luci pubblicitarie, le villette prefabbricate che hanno finito di uccidere il paesaggio.
Cercare la “gioia” nel fondo di una delle diverse “recite” dello spettacolo capitalista è pura follia. È proprio quello che vuole il capitale. L’esperienza del tempo libero, programmato dai nostri sfruttatori, è letale. Fa desiderare il lavoro. Alla vita apparente si finisce per preferire la morte sicura.
Nessuna gioia reale può venirci dal meccanismo razionale dello sfruttamento capitalista. La gioia non ha regole fisse che possano catalogarla. Anche se dobbiamo poter volere la nostra gioia. Altrimenti siamo perduti.
La ricerca della gioia è, quindi, un’azione della volontà. Una ferma negazione delle condizioni fissate dal capitale, cioè dei suoi valori. La prima di queste negazioni è quella del valore del lavoro. La ricerca della gioia può avvenire solo attraverso la ricerca del gioco.
In questo modo il gioco assume un significato diverso da quello che siamo soliti dargli nella dimensione del capitale. Il gioco che si contrappone, come ozio sereno, alle responsabilità della vita, è un immagine falsa e distorta della vera realtà del gioco. Nella realtà di lotta contro il capitale, allo stadio attuale dello scontro e delle relative contraddizioni, il gioco non è un “trastullo”, ma è un’arma di lotta.
Per una strana ironia, la parti si capovolgono. Se la vita è una cosa seria, la morte è un’illusione, in quanto finché viviamo la morte non esiste. Ora, il regno della morte, cioè il regno del capitale, che nega la nostra esistenza di uomini, riducendoci a “cose”, è “apparentemente” serissimo, metodico, disciplinato. Ma il suo parossismo possessivo, il suo continuo rigorismo etico, la sua mania del “fare”, nascondono una grande illusione: la vuotaggine dello spettacolo mercantile, l’inutilità dell’accumulazione indefinita, l’assurdità dello sfruttamento. Quindi, la più grande serietà del mondo del lavoro e della produttività, nasconde la più grande mancanza di serietà.
Al contrario, la negazione di questo mondo ottuso, la ricerca della gioia, del sogno, dell’utopia, nella sua dichiarata “mancanza di serietà”, nasconde la più grande serietà della vita: la negazione della morte.
Anche da questa parte della barriera, nello scontro fisico col capitale, il gioco può assumere forme diverse. Molte cose possono essere fatte “per gioco”. Molte cose che solitamente facciamo con “serietà”, portandoci dietro la nostra maschera di morte, quella prestataci dal capitale.
Il gioco è caratterizzato da un impulso vitale, sempre nuovo, sempre in movimento. Agendo come se giocassimo, inseriamo quest’impulso nelle nostre azioni. Ci liberiamo dalla morte. Il gioco ci fa sentire vivi. Ci dà l’emozione della vita. Nell’altro modello dell’agire, assumiamo tutto come un compito, come qualcosa che “dobbiamo”, come un obbligo.
In quest’emozione sempre nuova, esatto rovescio dell’alienazione e della pazzia del capitale, possiamo identificare la gioia.
Nella gioia risiede la possibilità della frattura col vecchio mondo e l’identificazione di scopi nuovi, di bisogni e valori differenti. Anche se la gioia, in se stessa, non può considerarsi lo scopo dell’uomo, è senz’altro la dimensione privilegiata, volontariamente identificata, che rende diverso lo scontro col capitale.
VII
La vita è così noiosa che non c’è
nient’altro da fare che spendere tutto
il nostro salario sull’ultimo vestito
o sull’ultima camicia.
Fratelli e sorelle, quali sono i vostri
veri desideri? Sedersi in un Drugstore,
con lo sguardo perduto
nel nulla, annoiato, bevendo un caffè senza sapore?
Oppure, forse
farlo saltare o bruciarlo.
The Angry Brigade
Il grande spettacolo del capitale ci ha tutti messi dentro, fino al collo. A turno, attori e spettatori. Invertiamo le parti, ora guardando a bocca aperta, ora facendoci guardare dagli altri. All’interno della carrozza di cristallo ci siamo entrati tutti, pur sapendo che si trattava di una zucca. L’illusione della fata ha ingannato la nostra coscienza critica. Adesso dobbiamo stare al gioco. Almeno fino a mezzanotte.
Miseria e fame sono ancora gli elementi propulsivi della rivoluzione. Ma il capitale sta allargando lo spettacolo. Intende fare entrare in scena nuovi attori. Il più grande spettacolo del mondo ci sbalordirà. Sempre più difficile e sempre meglio organizzato. Nuovi pagliacci si apprestano a salire sulle tribune. Nuove fiere verranno addomesticate.
I sostenitori del quantitativo, gli amanti dell’aritmetica, entreranno per primi e resteranno abbagliati dalle luci delle prime file. Si porteranno dietro le masse del bisogno e le ideologie del riscatto.
Ma quello che non potranno eliminare sarà la loro serietà. Il più grande pericolo cui andranno incontro sarà una risata. La gioia è mortale all’interno dello spettacolo del capitale. Tutto, qui, è tetro e funebre, tutto è serio e composto, tutto è razionale e programmato, proprio perché tutto è falso e illusorio.
Oltre la crisi, oltre le contraddizioni del sottosviluppo, oltre la miseria e la fame, il capitale dovrà sostenere l’ultima battaglia, quella decisiva, con la noia.
Anche il movimento rivoluzionario dovrà sostenere le sue battaglie. Non solo quelle tradizionali contro il capitale. Ma anche di nuove, contro se stesso. La noia lo attacca dal di dentro, lo incrina, lo rende asfissiante, inabitabile.
Lasciamo stare gli amanti degli spettacoli del capitale. Quelli che sono d’accordo fino in fondo a recitare la propria parte. Costoro pensano che le riforme possano realmente modificare le cose. Ma questo pensiero è più una copertura che altro. Sanno troppo bene che il cambiar delle parti è una delle regole del sistema. Aggiustando le cose un poco alla volta, si ottiene il risultato di tornare utili al capitale.
Poi c’è il movimento rivoluzionario dove non mancano quelli che attaccano a parole il potere del capitale. Costoro fanno una grande confusione, ricorrono a grosse frasi ma non impressionano più nessuno, tanto meno il capitale. Quest’ultimo li usa, sornione, per le parti più difficili del suo spettacolo. Nei momenti in cui occorre un solista, fa avanzare sulla scena uno di questi personaggi. Il risultato è accorante.
La verità è che bisogna spaccare il meccanismo spettacolare della merce, entrando nel dominio del capitale, nel centro di coordinamento, nel nucleo stesso della produzione. Pensate che meravigliosa esplosione di gioia, che grande salto creativo in avanti, che straordinario scopo “privo di scopo”.
Solo che entrare gioiosamente, con i simboli della vita, all’interno del meccanismo del capitale, è molto difficile. La lotta armata, spesso, è simbolo di morte. Non perché dona la morte ai padroni e ai loro servitori, ma perché pretende imporre le strutture del dominio della morte. Diversamente concepita, essa sarebbe veramente la gioia in azione, quando fosse capace di spezzare le condizioni strutturali imposte dallo stesso spettacolo mercantile, come, ad esempio, il partito militare, la conquista del potere, l’avanguardia.
Ecco l’altro nemico del movimento rivoluzionario. L’incomprensione. La chiusura davanti alle nuove condizioni del conflitto. La pretesa di imporre i modelli del passato, ormai entrati a far parte della gestione spettacolare della merce.
Il disconoscimento della nuova realtà rivoluzionaria, alimenta un disconoscimento teorico e strategico delle capacità rivoluzionarie del movimento stesso. E non importa affermare che ci sono nemici tanto vicini da rendere necessario un intervento immediato, al di là delle precisazioni interne di carattere teorico. Tutto ciò nasconde l’incapacità di affrontare la realtà nuova del movimento, l’incapacità di superare errori del passato che hanno gravi conseguenze nel presente. E questa chiusura alimenta ogni tipo di illusione politica razionalista.
Le categorie della vendetta, della guida, del partito, dell’avanguardia, della crescita quantitativa, hanno un senso solo nella dimensione della nostra società, ed è un senso che favorisce la perpetuazione del potere. Ponendosi dal punto di vista rivoluzionario, cioè dell’eliminazione totale e definitiva del potere, queste categorie cessano di avere un senso.
Movendoci nel non-luogo dell’utopia, nel capovolgimento dell’etica del lavoro, nel qui e subito della gioia realizzata, ci troviamo all’interno di una struttura del movimento che è ben lontana dalle forme storiche della sua organizzazione.
Questa struttura si modifica continuamente, sfuggendo ad ogni tentativo di cristallizzazione. La sua caratteristica è l’autorganizzazione dei produttori, sul posto di lavoro, e la contemporanea autorganizzazione delle forme di lotta per il rifiuto del lavoro. Non impadronimento dei mezzi di produzione, attraverso le organizzazioni storiche, ma rifiuto della produzione attraverso la spinta di strutture organizzative che si modificano continuamente.
Lo stesso avviene nella realtà non garantita. Le strutture emergono sulla base dell’autorganizzazione, stimolate dalla fuga dalla noia e dall’alienazione. L’inserimento di uno scopo programmato ed imposto da un’organizzazione nata e voluta al di fuori di queste strutture, significa l’uccisione del movimento, il ripristino dello spettacolo mercantile.
La maggior parte di noi è legata a questa visione dell’organizzazione rivoluzionaria. Anche gli anarchici, pur rifiutando la gestione autoritaria dell’organizzazione, non recedono dal riconoscere validità alle loro formazioni storiche. Su queste basi, tutti riconosciamo che la realtà contraddittoria del capitale, può essere attaccata con simili mezzi. Lo facciamo perché siamo convinti che questi mezzi sono legittimi, emergendo dallo stesso terreno dello scontro del capitale. Non ammettiamo che qualcuno non la pensi come noi. La nostra teoria si identifica nella pratica e nella strategia delle nostre organizzazioni.
Molte differenze ci sono tra noi e gli autoritari. Ma queste cadono davanti alla comune fede nell’organizzazione storica. Si arriverà all’anarchia attraverso l’opera di queste organizzazioni (le differenze – sostanziali – sorgono solo sul punto della metodologia di avvicinamento). Ma questa fede sta a indicare una cosa molto importante: la pretesa di tutta la nostra cultura razionalista, di spiegarsi il movimento della realtà, e di spiegarselo in modo progressivo. Questa cultura si basa sul presupposto della irreversibilità della storia e sulla capacità analitica della scienza. Tutto ciò ci consente di considerare il momento presente, come il confluire di tutti gli sforzi del passato, come il punto più alto della lotta contro il potere delle tenebre (lo sfruttamento del capitale). Così, noi saremmo, in modo assoluto, più avanzati dei nostri progenitori, capaci di elaborare e gestire una teoria e una strategia organizzativa che è il risultato della somma di tutte le esperienze passate.
Tutti coloro che rigettano questa interpretazione, si trovano automaticamente fuori della realtà, essendo questa, per definizione, la stessa cosa della storia, del progresso, e della scienza. Chi rifiuta è antistorico, antiprogressista e antiscientifico. Condanne senza appello.
Forti di questa corazza ideologica ci rechiamo nelle piazze. Qui ci scontriamo con una realtà di lotta strutturata in modo diverso. Queste strutture agiscono sulla base di stimoli che non rientrano nel quadro delle nostre analisi. Un bel mattino, nel corso di una manifestazione pacifica, e autorizzata dalla questura, quando i poliziotti cominciano a sparare, la struttura reagisce, anche i compagni sparano, i poliziotti cadono. Anatema! La manifestazione era pacifica. Essendo scaduta nella guerriglia spicciola, deve esserci stata una provocazione. Nulla può uscire dal quadro perfetto della nostra organizzazione ideologica in quanto questa non è “una parte” della realtà, ma è “tutta” la realtà. Al di là: la pazzia e la provocazione.
Si distruggono alcuni supermarket, alcuni negozi, si saccheggiano magazzini di alimentari e armerie, si bruciano vetture di grossa cilindrata. È un attacco allo spettacolo mercantile, nelle sue forme più appariscenti. Le strutture emergenti si dispongono in quella direzione. Prendono forma improvvisamente, con un minimo indispensabile di orientamento strategico preventivo. Senza fronzoli, senza lunghe premesse analitiche, senza complesse teorie di sostegno. Attaccano. I compagni si identificano in queste strutture. Rigettano le organizzazioni dell’equilibrio del potere, dell’attesa, della morte. La loro azione è una critica concreta della posizione attendista e suicida di queste organizzazioni. Anatema! Deve esserci stata una provocazione.
Ci si stacca dai moduli tradizionali del “fare” politica. Si incide fortemente e criticamente sul movimento stesso. Si usano le armi dell’ironia. Non nel chiuso dello studio di uno scrittore. Ma in massa, per le strade. Si coinvolgono nello stesso genere di difficoltà, non solo i servi dei padroni, quelli ormai riconosciuti a livello ufficiale, ma anche le guide rivoluzionarie del lontano e del recente passato. Si mette in crisi la struttura mentale del capetto e del leader del gruppo. Anatema! La critica è legittima solo contro i padroni, e secondo le regole fissate dalla tradizione storica della lotta di classe. Chi esce fuori del seminato è un provocatore.
Ci si nausea delle riunioni, delle letture dei classici, delle inutili manifestazioni, delle discussioni teoriche che spaccano il cappello in quattro, delle distinzioni all’infinito, della monotonia e dello squallore di certe analisi politiche. A tutto ciò si preferisce fare l’amore, fumare, ascoltare la musica, camminare, dormire, ridere, giocare, uccidere i poliziotti, spezzare le gambe ai giornalisti, giustiziare i magistrati, far saltare per aria le caserme dei carabinieri. Anatema! La lotta è legittima solo quando è comprensibile per i capi della rivoluzione. In caso contrario, essendoci il rischio che questi ultimi si lascino scappare di mano la situazione, deve esserci stata una provocazione.
Sbrigati compagno, spara subito sul poliziotto, sul magistrato, sul padrone, prima che una nuova polizia te lo impedisca.
Sbrigati a dire di no, prima che una nuova repressione ti convinca che il dire di no è insensato e pazzesco e che è giusto che accetti l’ospitalità dei manicomi.
Sbrigati ad attaccare il capitale, prima che una nuova ideologia te lo renda sacro.
Sbrigati a rifiutare il lavoro, prima che qualche nuovo sofista ti dica, ancora una volta, che “il lavoro rende liberi”.
Sbrigati a giocare. Sbrigati ad armarti.
VIII
Non ci sarà più Rivoluzione fin quando
i Cosacchi non discenderanno.
Cœurderoy
Il gioco all’interno della logica del capitale è anch’esso enigmatico e contraddittorio. Il capitale lo usa come uno dei componenti dello spettacolo mercantile. Qui, acquista un’ambiguità che di per sé non possiede. Un’ambiguità che gli viene dalla struttura illusoria della produzione capitalista. Il gioco diventa, in questo modo, la sospensione della produzione, la parentesi di “tranquillità” nella vita di tutti i giorni. Esiste, così, una programmazione del gioco e una sua utilizzazione scenica.
Fuori del dominio del capitale, il gioco è armoniosamente strutturato dal proprio stesso slancio creativo. Non è legato a questa o a quella rappresentazione voluta dalle forze della produzione, ma si sviluppa autonomamente. Solo in questa realtà il gioco è lieto, dà gioia. Non “sospende” la tristezza della lacerazione causata dallo sfruttamento, al contrario, la realizza fino in fondo, la rende compartecipe della realtà della vita, che, così, si contrappone a quegli accorgimenti posti in atto dalla realtà della morte – anche attraverso il gioco – per rendere meno triste la tristezza.
I distruttori della realtà della morte, lottano contro il mitico regno dell’illusione capitalista, il regno che aspirando all’eternità si rotola nella polvere del contingente. La gioia della distruzione emerge dal gioco dell’azione distruttiva, dal riconoscimento della profonda tragedia che questa sottintende, dalla consapevolezza della forza dell’entusiasmo che riesce ad abbattere la ragnatela della morte. Non è una contrapposizione di orrore a orrore, di tragedia a tragedia, di morte a morte. Ma una contrapposizione tra gioia e orrore, tra gioia e tragedia, tra gioia e morte.
Uccidendo il poliziotto, non ci si veste della toga del giudice, affrettandosi a pulirla del sangue delle precedenti condanne. I tribunali e le sentenze sono sempre parte dello spettacolo del capitale, anche quando i rivoluzionari vi recitano la propria parte. Uccidendo un poliziotto, non si pesano le sue responsabilità, non si aritmetizza lo scontro di classe. Non ci si programma una visione del rapporto tra movimento rivoluzionario e sfruttatori. Si risponde, sul piano immediato, ad un’esigenza che si è venuta a strutturare all’interno del movimento rivoluzionario, un’esigenza che tutte le analisi e tutte le giustificazioni di questo mondo, da sole, non avrebbero mai potuto imporre.
Questa esigenza è l’attacco del nemico, dello sfruttatore, dei suoi servi. Essa matura lentamente nelle strutture del movimento. Solo quando esce allo scoperto, il movimento passa dalla fase difensiva a quella dell’attacco. L’analisi e la giustificazione morale sono a monte del tutto, non si trovano a valle, davanti ai piedi di chi scende in piazza, pronte a farlo inciampare. Si trovano nella violenza sistematica che da secoli il capitale esercita sugli sfruttati. Ma non devono necessariamente venire alla luce in forma compiuta e pronta per l’uso. Questa pretesa è un’ulteriore forma delle nostre intenzioni razionalizzanti, del nostro sogno di imporre alla realtà un modello che non le si attaglia.
Facciamoli discendere questi Cosacchi. Non sosteniamo il ruolo della reazione, un ruolo che non fa per noi. Non accettiamo l’equivoco invito del capitale. Invece di sparare sui nostri compagni e su noi stessi, è sempre meglio sparare sui poliziotti.
Ci sono momenti nella storia, in cui la scienza esiste nella coscienza di chi si batte. In questi momenti non occorrono interpreti della verità. Questa emerge dalle cose. È la realtà delle lotte che produce la teoria del movimento.
La nascita del mercato ha segnato la formazione del capitale, il passaggio dalla forma di produzione feudale a quella capitalista. L’entrata della produzione nella fase spettacolare ha reso necessaria l’estensione della forma mercantile a tutto ciò che esiste: amore, scienza, sentimenti, coscienza, ecc. Lo spettacolo si è ingrandito enormemente. Questa seconda fase non costituisce come affermano i marxisti, una corruzione della prima fase. È una fase diversa. Il capitale si mangia tutto, perfino la rivoluzione. Se questa non rompe con lo schema della produzione, se pretende d’imporre una produzione alternativa, il capitale l’inghiotte all’interno dello spettacolo mercantile.
Solo la lotta nella realtà dello scontro non può essere inghiottita. Alcune sue forme, cristallizzandosi in forme organizzative precise, possono venire inserite nello spettacolo. Ma quando rompono con il significato fondamentale che il capitale assegna alla produzione, questo inserimento è molto difficoltoso.
Il discorso aritmetico e quello della vendetta non hanno senso all’interno della seconda fase. Se vengono ribaditi, si trasferiscono in un significato metaforico.
Al gioco illusorio del capitale (spettacolo della merce) bisogna sostituire il gioco reale dell’attacco armato contro il capitale per la distruzione del fittizio e dello spettacolo.
IX
Fallo da te.
Manuale del bricoleur
È facile, puoi farlo da te. Da solo o con pochi compagni fidati. Non occorrono grandi mezzi. Nemmeno una grande preparazione tecnica.
Il capitale è vulnerabile. Basta essere decisi a farlo.
Un immensità di chiacchiere ci ha reso ottusi. Non è questione di paura. Non abbiamo paura, siamo solo stupidamente pieni di idee prefabbricate. Non riusciamo a liberarcene.
L’uomo che è determinato al suo gesto non è l’uomo coraggioso, è l’uomo che ha chiarito le sue idee, che si è reso conto dell’inutilità di tanti sforzi per recitare bene la propria parte nella rappresentazione assegnatagli dal capitale. Cosciente, quest’uomo attacca con freddezza e determinazione. E nel far ciò si realizza come uomo. Realizza se stesso nella gioia. Il regno della morte scompare davanti a lui. Anche se crea distruzione e terrore per i padroni, nel suo cuore, e nel cuore degli sfruttati, è la gioia e la tranquillità.
Le organizzazioni rivoluzionarie stentano a comprendere tutto ciò. Impongono un modello che riproduce la simulazione della realtà produttiva. Il destino quantitativo impedisce loro ogni spostamento qualitativo sul piano dell’estetica della gioia.
Anche l’attacco militare è vissuto, da queste organizzazioni, in chiave quantitativa. Gli obiettivi sono fissati sulla base dello scontro frontale.
Il capitale, in questo modo, controlla ogni emergenza. Può permettersi il lusso di accettare la contraddizione, di indicarne forme spettacolari contrapposte, di sfruttare gli effetti negativi sui produttori per costruire un allargamento dello spettacolo. Sul terreno quantitativo il capitale accetta lo scontro perché conosce tutte le risposte. È esso stesso a produrre le risposte, a disporre del monopolio del codice.
Al contrario, la gioia dell’atto rivoluzionario è contagiosa. Si estende a macchia d’olio. Il gioco produce il proprio significato sulla base dell’azione nella realtà. Ma questo senso non viene cristallizzato all’interno di un modello governato dall’alto. Si spezza in mille sensi, tutti produttivi e instabili. La connessione interna al gioco stesso si esaurisce nell’azione dell’attacco. Ma sopravvive il senso esterno, il significato che il gioco ha per coloro che ne restano tagliati fuori e che vogliono appropriarsene. Tra coloro che per primi accettano di giocare e quelli che “osservano” le conseguenze liberatorie del gioco sono essenziali al gioco stesso.
Si struttura così la comunità della gioia. Una forma spontanea di entrare in contatto, fondamentale per la realizzazione del significato più profondo del gioco. Giocare è un fatto comunitario. Raramente si presenta come azione isolata. Spesso, quando così si struttura, si porta dietro gli elementi negativi della rimozione psicologica. Non è un’accettazione positiva del gioco in quanto momento creativo di una realtà di lotta.
È il senso comunitario del gioco che impedisce l’arbitrarietà nella scelta dei significati del gioco stesso. In assenza del rapporto comunitario, il singolo potrebbe imporre al gioco regole e significati suoi, incomprensibili per tutti gli altri, causando così la ritrasformazione del gioco in una sospensione temporanea delle conseguenze negative del suo problema individuale (problema del lavoro, dell’alienazione, dello sfruttamento).
Nell’accordo comunitario il significato del gioco si arricchisce attraverso il flusso delle azioni reciproche. La creatività riceve più spazio dalla fantasia liberata e verificata reciprocamente. Ogni invenzione, ogni nuova possibilità può essere vissuta collettivamente, senza modelli precostituiti, ed avere una influenza vitale anche nel suo semplice porsi come momento creativo, anche se dovesse trovare mille difficoltà per la propria realizzazione.
Un’organizzazione rivoluzionaria tradizionale finisce per imporre i suoi tecnici. Non può evitare il pericolo tecnocratico. La grande importanza assegnata al momento strumentale dell’azione la condanna su questa strada.
Una struttura rivoluzionaria che ricerca il momento della gioia nell’azione rivoluzionaria diretta a distruggere il potere, considera gli strumenti con cui realizzare questa distruzione come strumenti, cioè come mezzi. Coloro che usano questi strumenti non devono diventarne schiavi. Come coloro che non sanno usarli non devono diventare gli schiavi di coloro che ne conoscono l’uso.
La dittatura dello strumento è la peggiore delle dittature.
L’arma più importante del rivoluzionario è la propria determinazione, la propria coscienza, la propria decisione di agire, la propria individualità. Le armi concrete sono strumenti e, in quanto tali, vanno sottoposte continuamente ad una valutazione critica. Occorre sviluppare una critica delle armi. Abbiamo visto troppe sacralizzazioni del mitra, troppe sacralizzazioni dell’efficientismo militare.
La lotta armata non è una faccenda che riguarda soltanto le armi. Queste non possono rappresentare, da sole, la dimensione rivoluzionaria. Ridurre la complessa realtà in una cosa singola è pericoloso. In effetti, il gioco ripresenta questo rischio, cioè quello di esaurire l’esperimento vitale nel giocattolo, rendendo quest’ultimo qualcosa di magico e assoluto. Non per nulla nei simboli di molte organizzazioni rivoluzionarie combattenti compare il mitra.
Occorre procedere oltre per meglio comprendere il senso profondo della lotta rivoluzionaria come gioia, per sfuggire alle illusioni e alle trappole di una ripresentazione dello spettacolo mercantile attraverso oggetti mitici o miticizzati.
Nell’affrontare la lotta armata, il capitale compie l’ultimo sforzo. S’impegna sull’ultima frontiera. Per contrapporsi su di un terreno dove non si sente tanto sicuro, ha bisogno della collaborazione dell’opinione pubblica. Da qui lo scatenarsi di una guerra psicologica che impiega le armi più raffinate della propaganda moderna.
In sostanza, il capitale, nella sua estensione fisica attuale, è vulnerabile da parte di una struttura rivoluzionaria che può decidere i tempi e i modi dell’attacco. Il capitale sa perfettamente questa debolezza e corre ai ripari. La polizia non gli basta. Nemmeno l’esercito. Ha bisogno di una vigilanza continua da parte della gente. Anche della più umile parte del proletariato. Per far ciò deve dividere il fronte di classe. Deve diffondere tra la povera gente il mito della pericolosità delle organizzazioni armate, il mito della santità dello Stato, il mito della moralità, della legge e così via.
Indirettamente, quindi, esso spinge l’organizzazione e i suoi militanti, ad assumere un ruolo. All’interno di un “ruolo” il giocare non ha più senso. Tutto diventa “serio”, quindi illusorio, quindi spettacolare e mercantile. La gioia si trasforma in “maschera”. La persona si anonimizza, vive nel ruolo, non è più in grado di distinguere tra realtà e apparenza.
Per spezzare il cerchio magico della drammaturgia mercantile, bisogna rifiutare il ruolo, anche quello di “rivoluzionario professionista”.
La lotta armata deve sfuggire alla “caratterizzazione” di professionalità, alla divisione del lavoro che il modulo esterno della produzione capitalista intende imporle.
“Fallo da te”. Non spezzare il contenuto globale del gioco con l’impoverimento che gli causa il ruolo. Difendi il tuo diritto di gioire della vita. Ostacola il progetto di morte del capitale. Questi può penetrare nel mondo della creatività del gioco soltanto a condizione di trasformare il giocante in giocatore, il vivente creatore nel morto che si illude di vivere.
Se il “mondo del gioco” viene organizzato in forma centralizzata, non ha più senso parlare di gioco. Proponendo il nostro discorso sulla “gioia armata”, dobbiamo anche prevedere la possibilità del capitale di riprendersi la proposta rivoluzionaria. E questo riprendersi può essere attuato attraverso la gestione esterna del mondo del gioco. Fissando il ruolo del giocatore, i ruoli della reciprocità della comunità del gioco, la mitologia del giocattolo.
Spezzando i vincoli della centralizzazione, del partito militare, si ottiene il risultato di confondere le idee del capitale, le quali sono sintonizzate sul codice della produttività spettacolare del mercato quantitativo. In questo modo l’azione coordinata dalla gioia, diventa enigmatica per il capitale. È un niente, un qualcosa privo di scopo, che non ha realtà. E ciò perché l’essere, lo scopo e la realtà del capitale sono illusori, mentre l’essere, lo scopo e la realtà della rivoluzione sono concretamente fissati.
Al codice del bisogno produttivo si sostituisce il codice del bisogno di comunismo. Le decisioni del singolo all’interno della comunità di gioco hanno significatività alla luce di questo nuovo bisogno. I modelli del passato, quelli della morte, vengono scoperti nella loro mancanza di realtà, nella loro sostanza illusoria.
La distruzione dei padroni è distruzione della merce, e la distruzione della merce è distruzione dei padroni.
X
Voli la civetta.
Proverbio ateniese
“Voli la civetta”. Che le azioni mal cominciate arrivino a buon fine. Che la rivoluzione, tanto allontanata dai rivoluzionari, si realizzi al di là dei loro residui desideri di pace sociale.
Il capitale darà l’ultima parola ai camici bianchi. Le prigioni non potranno durare a lungo. Vecchie fortezze del passato, di un passato che sopravvive solo nella fantasia esaltata di qualche reazionario in pensione, cadranno col cadere dell’ideologia che si basa sull’ortopedia sociale. Non ci saranno più condannati. La criminalizzazione, che il capitale attuerà nelle sue forme più razionali, passerà attraverso i manicomi.
Rifiutare lo spettacolo, significa essere fuori della realtà, quando tutta la realtà è spettacolare. Rifiutare le regole imposte dal codice mercantile, significa essere pazzi. Non inchinarsi davanti al dio della merce, costerà l’entrata in manicomio.
Qui la cura sarà radicale. Non più torture inquisitoriali e sangue sui muri: queste cose impressionano l’opinione pubblica, fanno intervenire i benpensanti borghesi, generano giustificazioni e riparazioni, causano perturbamenti nell’armonia spettacolare. L’annientamento totale della personalità, considerato come unica cura radicale per le menti malate, non disturba nessuno. Finché l’uomo della strada si sentirà circondato dall’imperturbabile atmosfera dello spettacolo capitalista, avrà l’impressione che la porta del manicomio non si chiuderà mai alle sue spalle. Il mondo della follia gli sarà estraneo, anche se c’è sempre un manicomio disponibile a fianco di ogni fabbrica, davanti ad ogni scuola, dietro ogni campagna, nel mezzo di ogni quartiere popolare.
Facciamo attenzione a non spianare la strada, con le nostre ottusità critiche, ai funzionari statali in camice bianco.
Il capitale sta programmando il codice interpretativo da mettere in circolazione a livello di massa. In base a questo codice, l’opinione pubblica verrà adeguata a vedere negli attentatori all’ordine delle cose padronali, nei rivoluzionari, praticamente dei pazzi. Da qui la necessità di aprire loro le porte dei manicomi. Anche le carceri attuali, razionalizzandosi sul modello tedesco, si stanno trasformando, dapprima in carceri speciali per rivoluzionari, poi in carceri modello, poi in veri e propri lager per la manipolazione del cervello, poi in manicomi definitivi.
Questo comportamento del capitale non è solo dettato dalla necessità di difendersi di fronte alle lotte degli sfruttati. È anche la sola risposta possibile sulla base della logica interna del codice della produzione mercantile.
Il manicomio è per il capitale un luogo fisico in cui si interrompe la globalità della funzione spettacolare. Il carcere cerca disperatamente di arrivare a questa interruzione globale, ma non può riuscirci, perché bloccato dalle pretese di fondo della sua ideologia ortopedica.
Il “luogo” del manicomio, invece, non ha inizio e non ha fine, non possiede storia, non ha la mutabilità dello spettacolo. Esso è il luogo del silenzio.
L’altro “luogo” del silenzio, il cimitero, ha, al contrario, la capacità di parlare, ad alta voce. I morti parlano. E i nostri morti parlano a voce altissima. I nostri morti possono essere pesanti, pesantissimi. Ecco perché il capitale cercherà di farne sempre di meno. Mentre, in corrispettivo, crescerà il numero degli “ospiti” nei manicomi. La “patria del socialismo”, in questo campo, ha molto da insegnare.
Il manicomio è la razionalizzazione terapeutica più perfetta del tempo libero. La sospensione del lavoro senza traumi per la struttura mercantile. La mancata produttività senza negazione della produttività. Il pazzo non può lavorare e, nel suo non lavorare, riconferma la saggezza del lavoro, come contrario della pazzia.
Quando diciamo: non è il momento dell’attacco armato contro lo Stato, spalanchiamo le porte del manicomio per i compagni che realizzano questo attacco; quando diciamo: non è il momento per la rivoluzione, stringiamo i legacci dei letti di contenzione; quando diciamo: queste azioni sono oggettivamente provocatorie, indossiamo il camice bianco dei torturatori.
Al tempo in cui era piccolo il numero degli oppositori la mitraglia funzionava bene. Dieci morti sono sopportabili. Trentamila, centomila, duecentomila, segnerebbero un punto fondamentale nella storia, un riferimento rivoluzionario di tale abbagliante luminosità da perturbare a lungo la pacata armonicità dello spettacolo mercantile. Per altro, il capitale si è fatto più astuto. Il farmaco ha una neutralità che il proiettile non possiede. Ha l’alibi terapeutico.
Che si getti in faccia al capitale il suo proprio statuto della pazzia. Che si capovolgano i termini della contrapposizione.
La neutralizzazione dell’individuo è pratica costante dell’insieme mercificato del capitale. La società è tutta un immenso manicomio. L’appiattimento delle opinioni è processo terapeutico, è macchina di morte. La produzione non può verificarsi nella forma spettacolare del capitalismo, in assenza di questo appiattimento. E se il rifiuto di tutto ciò, l’accettazione della gioia di fronte alla scelta della morte, è segno di pazzia, è il caso che tutti comincino a comprendere la trappola che, al di sotto di tutto ciò, è pronta a scattare.
Tutta la macchina della tradizione culturale dell’Occidente è una macchina di morte, una negazione della realtà, un regno del fittizio che ha accumulato ogni sorta di nefandezze e di soprusi, di sfruttamenti e di genocidi. Se il rifiuto di questa logica della produzione è condannato come follia, occorre spiegare la differenza tra follia e follia.
La gioia si arma. Il suo attacco è il superamento dell’allucinazione mercantile, della macchina e della merce, della vendetta e della guida, del partito e della quantità. La sua lotta rompe la linea della logica del profitto, l’architettura del mercato, il significato programmato della vita, il documento finale dell’archivio. La sua dirompente esplosione ribalta l’ordine delle dipendenze, la nomenclatura del positivo e del negativo, il codice dell’illusione mercantile.
Ma tutto questo deve potersi comunicare. Dal mondo della gioia a quello della morte il passaggio dei significati non è facile. I codici reciproci sono sfasati, finiscono per annullarsi a vicenda. Quello che nel mondo della gioia è considerato illusione, nel mondo della morte è la realtà, e viceversa. La stessa morte fisica, su cui tanto si piange nel mondo della morte, è meno mortale della morte che viene spacciata come vita.
Da qui la grande facilità, per il capitale, di mistificare i messaggi della gioia. Anche i rivoluzionari, dall’interno della logica del quantitativo, non sono capaci di leggere fino in fondo, il senso delle esperienze della gioia. Qualche volta balbettano approcci insignificanti. Qualche altra volta si lasciano andare a condanne che non suonano poi molto diverse da quelle lanciate dal capitale.
La nozione generale del significante, nello spettacolo mercantile, è la merce. L’elemento attivo di questa massa accumulata, è il lavoro. Al di là di questi elementi del quadro produttivo, non esistono segni che possano significare qualcosa di negativo e positivo nello stesso tempo. Esiste la possibilità di affermare il non-lavoro, ma non come negazione del lavoro, solo come sospensione per un certo periodo di tempo. Allo stesso modo esiste la possibilità di affermare la non-merce, cioè l’oggetto personalizzato, ma solo come reificazione del tempo libero, cioè di qualcosa che è prodotta come hobby, nei ritagli di tempo concessi dal ciclo produttivo. È chiaro che questi segni, non-lavoro e non-merce, sono funzionali, se intesi in questo modo, al modello generale della produzione.
Solo chiarificando i significati della gioia e i corrispettivi significati della morte, come elementi di due mondi contrapposti che si lottano a vicenda, possiamo comunicare alcuni elementi delle azioni della gioia, senza, per altro, illuderci di poterli comunicare tutti. Chi comincia ad avere esperienza della gioia, anche in prospettive non direttamente inerenti all’attacco del capitale, è più disponibile a cogliere i significati dell’attacco, almeno più di coloro che restano legati ad una visione arretrata dello scontro, una visione basata sull’illusione quantitativa.
In questo modo, è ancora possibile che si alzi in volo la civetta.
XI
Avanti tutti!
E con le braccia e il cuore,
la parola e la penna,
il pugnale e il fucile,
l’ironia e la bestemmia,
il furto, l’avvelenamento e l’incendio,
Facciamo.... la guerra alla società!...
Déjacque
Mettiamo da parte le attese, le titubanze, i sogni di pace sociale, i piccoli compromessi, le ingenuità. Tutto il ciarpame metaforico che ci viene fornito negli spacci del capitale. Mettiamo da parte le grandi analisi che tutto spiegano, fin nei minimi particolari, i libroni pieni di senno e di paura. Mettiamo da parte l’illusione democratica e borghese della discussione e del dialogo, del dibattito e dell’assemblea, delle capacità illuministiche dei capi mafia. Mettiamo da parte il senno e la saggezza che la morale borghese del lavoro ha scavato dentro i nostri cuori. Mettiamo da parte i secoli di cristianesimo che ci hanno educati al sacrificio e all’obbedienza. Mettiamo da parte i preti di ogni ordine e funzione, i padroni, le guide rivoluzionarie, quelle meno rivoluzionarie e quelle per niente rivoluzionarie. Mettiamo da parte il numero, le illusioni del quantitativo, le leggi del mercato, la domanda e l’offerta. Sediamoci un attimo sulle rovine della nostra storia di perseguitati e riflettiamo.
Il mondo non ci appartiene, se ha un padrone e questo padrone è tanto stupido da desiderarlo, così come si trova, che se lo prenda, che cominci a contare le rovine al posto dei palazzi, i cimiteri al posto delle città, il fango a posto dei fiumi, la melma infetta al posto dei mari.
Il più grande spettacolo illusionistico del mondo non ci incanta più.
Siamo certi che dalla nostra lotta, qui e subito, usciranno le comunità della gioia.
E per la prima volta, la vita trionferà sulla morte.