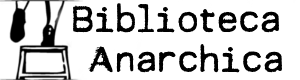Prima edizione: dicembre 1998
Seconda edizione: febbraio 1999
Terza edizione: aprile 2007
Quarta edizione: novembre 2013
Alfredo M. Bonanno
Io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi
Introduzione alla terza edizione
Introduzione alla prima edizione
Perché ingigantire le forze dell’avversario?
Una mattinata a Milano, tanti anni fa
È calato il silenzio sul terrorismo di Stato
Introduzione alla terza edizione
Due anni e mezzo di carcere sono trascorsi da poco. Alla mia età non sono pochi e c’è tempo per riflettere. Fra i tanti ricordi che mi sono passati per la testa, belli e brutti, c’è stata l’esperienza del funerale di Pinelli. Non erano pensieri pacifici, tranquillizzanti. La rabbia e l’insoddisfazione mi prendevano spesso alla gola, nelle lunghe passeggiate in circolo all’interno dell’eterno cortile in cemento.
Se devo essere sincero, come mi sembra necessario in questo momento, non era tanto del povero Pinelli, ormai polvere alla polvere, che mi preoccupavo, quanto del mio ideale. Sì, proprio di quello, mi preoccupavo, e mi preoccupo, dell’anarchia, di questo meraviglioso ideale che disgraziati individui continuano a inzaccherare. Pensando a Pinelli ecco che mi accadeva sempre di pensare a Calabresi, il binomio torna anche adesso spontaneo, avvicinati dalla morte, anarchico e sbirro, sembrano ancora oggi allacciati in una danza macabra, lo sembrano ovviamente nei miei pensieri, non lo sono mai stati nella realtà. Ma, in fondo, che me ne faccio della realtà, oggetti che confliggono fra loro continuamente, se non accetto che la realtà sono anche io con i miei pensieri cattivi, con i miei desideri anche peggiori, e tutto il resto? Dopo tutto, Calabresi faceva il proprio mestiere, e lo faceva senza volersi nascondere dietro il dito del poliziotto buono, dalla faccia pulita. Era uno sbirro fra i più duri e questo è un dire le cose come stanno. Sparargli è stata un’azione degna di nota, difatti sto ancora qui a connotarla.
E di tanti altri, sbirri anch’essi, che agiscono sotto l’ala del camuffamento? Ecco, su questo punto, i miei pensieri, in questi ultimi anni di carcere, andavano via per la tangente, scappavano e si trasformavano in fantasticherie di cui vorrei mettere a parte i pochi lettori che mi rimangono. I compromessi, più di quello che fa la religione, degradano, abbassano la vita, la propria vita, a mezzo e a prezzo di contrattazione. Se accetto i compromessi che mi vengono di volta in volta messi sotto il naso divento dipendente non di chi me li ha sottoposti, ma della mia stessa vigliaccheria. Si arriva così all’assurdo, che tanta gente che aveva per una certa parte della propria vita mostrato un interesse per molte cose ma non certo per l’anarchismo, si dichiara anarchico, per poi, di fronte a massicce dosi di carcere, tornare alle vecchie scelte, chiamandosi fuori dalle dichiarazioni strombazzate ai quattro venti non solo col piglio del neofita ma, quel che è più grave, con l’intransigenza dell’accusatore di nuova nomina. È legittimo cambiare opinione, non idee, che non di idee si è trattato quando si urlava dalla colonna dello stilita, ma sempre di raccogliticci scambi di chiacchiere. Per carità, è legittimo mettersi al riparo, per quanto si può, da una repressione che non ammette estremismi verbali e che pretende sempre interpretarli come una minaccia seria, anche quando si tratta, più o meno, di un gargarismo.
Molti ritengono di avere messa la propria coerenza in banca e si aspettano di ricevere gli interessi mensilmente, allo stesso modo in cui si taglia accuratamente la cedola delle proprie buone azioni. Ebbene, si sbagliano. La coerenza è un restare svegli quando tutti dormono, specialmente quando è la propria coscienza a sentirsi preda del sonno, svegli per non cadere vittime dei tanti allettamenti, delle accondiscendenze ma anche, a partire dalle più subdole, che sono proprio le rigidità.
Ma lasciamo questi argomenti al proprio destino, insisterò su di loro in altra occasione. Torniamo alle conseguenze sull’ideale, sulla pratica concreta dell’essere anarchici, sulla lotta e sui momenti che stiamo attraversando, tutti, nessuno escluso. Quando la piena è travolgente pure la melma viene sospinta a galla e vede la luce che mai si sarebbe sognata di vedere, quando il deflusso fa ristagnare le acque la melma pensa ancora di essere in alto e invece è tornata al suo posto naturale, nel fango, dove solo le rane e altri animali consimili fanno rari zompi. È nel deflusso che la melma sente il bisogno di farci conoscere le sue visioni del mondo, questa volta immaginate dall’alto e non come di consueto dal basso. Ora, ogni interpretazione della realtà, se affidata a chi ha in sé solo l’animo servizievole e miserrimo della melma non può che essere puzzolente e ciò per due motivi, primo perché ogni interpretazione porta dentro di sé la tabe della sudditanza, c’è sempre dove pescare le idee non disponendo che di opinioni mal digerite, secondo perché la melma ha esperienze, desideri e sogno di melma, anche se per caso si è venuta a trovare a contatto col cielo. Nei momenti di deflusso i giochi dovrebbero farsi più duri, quindi i duri diventano più duri ma, nello stesso tempo, i deboli diventano più deboli. Ora, il debole, vedendo il duro continuare dritto per la sua strada e non degnare le sue argomentazioni possibiliste neanche di uno sguardo critico, si sente ancora più debole. Il duro contro cui appoggiare la propria debolezza cercando di darsi le arie di una forza a buon mercato e a spese del muro ospitante, ora non lo guarda nemmeno, eccolo quindi diventare oggetto delle critiche meschine del debole, com’è logico che siano. Da persona incattivita dal proprio stato di meschinità viene fuori sempre melma, e il cerchio si chiude. Come si spiega che il primo contro cui indirizzare queste critiche da roditori con la coda lunga è sempre quell’idolatrato muro ideale a cui il debole si è appoggiato per tanto tempo? Che ne è dell’ideale quando l’unico compito che sembra restare in piedi è quello di ficcare i propri denti nella carne più a portata di mano?
Lasciamo andare i sorci dove li conduce la loro sorte di sorci.
L’animo dei puri non si può corrompere, anche se abili descrizioni possono mettere in cattiva luce il loro comportamento. Ma chi sono i puri? Chi può realmente definirsi tale? Nessuno. Ecco perché la buonafede è sempre in balia della menzogna e della calunnia, dell’imbecillità che accetta senza luce critica quello che l’imbroglione spende come moneta sua e che apre le porte della propria casa per farne spelonca da adibire alla circolazione di fanfaluche. Ma, anche se non ci sono puri, ci sono gli innamorati dell’ideale. Io mi sono innamorato dell’anarchia, molto meno degli anarchici, anche se nella mia vita ho amato molti anarchici il loro numero è di gran lunga troppo esiguo di fronte alla grande schiera di anarchici che ho dovuto subire come piattole d’inverno e che si sono approfittati di me come tanti macrò.
Senza un miscuglio di purezza e di sagacia critica non ci sarebbero anarchici degni di questo nome. Non solo sognatori, ma prima di tutto sognatori, non solo realizzatori, ma prima di tutto realizzatori. La denominazione qui ha un valore che può riassumersi in una sorta di indicazione di stato. L’essere anarchico è un modo di vedere la vita, una visione del mondo, non un’accozzaglia più o meno articolata di principi assoluti e di banalità politiche. Se acquisisco un valore, e quasi sempre questo valore per me è dato dalla mia capacità di capire la realtà, quindi di conoscerla, in altre parole pertanto se acquisisco una conoscenza, è per condividerla con gli altri. So, e questo sapere mio, ha un valore per me, se ne faccio dono agli altri e, restando per il momento nell’àmbito della mia esperienza personale, i veicoli privilegiati di questo dono sono stati, nel corso della mia vita, le mie azioni e le mie parole, dette o scritte. Bisogna che qui si faccia evidente qualcosa che di regola non appare di primo acchito. Io dono quello che per me ha qualità di dono, appunto le mie azioni e le mie parole, ma anche questi doni possono prendere un aspetto più terra terra, una modalità fattuale più immediata, possono cioè appartenere alla mia quotidianità banale. Non ho azioni da donare ma fatti da proporre, faccio e quindi non ho idee ma semplici opinioni che mi aiutano a modificare la realtà nella produzione del fare. Accompagno questo fare con le parole adeguate, tipiche della tecnica che utilizzo e che cerco di impiegare al meglio per sopravvivere, accetto lavori non impegnativi, cioè che non distruggano la mia individualità in breve tempo, scrivo tesi di laurea per conto terzi, discuto di quale prosciutto sia meno grasso per il mio colesterolo col salumiere e di quale dieta devo tenere per sopravvivere al mio diabete col medico. Non posso parlare di dono in questi casi, eppure, a un osservatore distratto, il mio comportamento apparirebbe lo stesso, sto facendo – l’osservatore smarrito potrebbe capire che sto agendo, sto parlando – lo stesso osservatore potrebbe capire che sto dicendo qualcosa d’importante.
L’uccisione del commissario Calabresi è stata un’azione non un semplice fare. Quindi è stata un dono che qualcuno ha fatto a tutti i compagni, in particolare a tutti gli anarchici, come dono ci ha resi tutti parimenti responsabili, in altre parole è come se tutti noi, che avevamo sentito l’uccisione di Pinelli come un’aggressione personale e una ferita inferta sul nostro cuore, avessimo fatto fuoco sul commissario finestra.
Alcuni lettori ipercritici, per la verità non molti, mi hanno fatto presente che l’Introduzione alla prima edizione del presente libretto era troppo indulgente con la retorica. Non mi scuso. Quella che forse era retorica per altri per me era soltanto un ricordo che continua a commuovermi anche adesso, allo stesso modo in cui mi commosse mentre sotterravano Pinelli. Le parole, questo è ben noto, possono essere intese in molti modi, anche se a un orecchio estraneo esse si limitano a produrre sempre lo stesso rumore.
Che queste, più dure e per orecchie più sorde, abbiano migliore sorte.
Trieste, 28 ottobre 2006
Alfredo M. Bonanno
Introduzione alla prima edizione
Io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi, il 17 maggio 1972, sotto casa sua, in via Cherubini 6, a Milano, alle nove e un quarto del mattino.
L’affermazione è grave, non per le implicazioni giudiziarie, per carità, delle quali non mi curo minimamente, ma per ben altri motivi, ed è di questi motivi che voglio mettere a parte i miei attenti lettori.
In fondo, se riflettiamo un poco, di che cosa possiamo essere sicuri? La mattina ci svegliamo, mettiamo i piedi fuori dal letto, facciamo colazione in fretta, voliamo verso la scuola, il lavoro, i più vicini giardinetti per trovare gli amici, insomma, ognuno verso le proprie faccende quotidiane. La sera, ritornando a porre le spalle sul lenzuolo, quasi sempre lo stesso della sera prima, di che possiamo dirci certi dell’insieme di fatti che abbiamo visto scorrere sotto i nostri occhi durante l’intera giornata? Non appena puntualizziamo un avvenimento, per quanto semplice, il caffè che abbiamo preso la mattina al bar, ecco che tutto il contorno si fa confuso, tende a sfocare nei suoi dettagli, e ogni aspetto scompare in un desiderio inappagato di precisione.
In definitiva, abbiamo una memoria di quello che ci è accaduto, di quello che abbiamo fatto, ma le nostre affermazioni, riguardo i singoli avvenimenti, sono tanto inadeguate da farci concludere che non possiamo dirci certi di niente.
Ma com’è possibile, direbbe qualcuno?
La risposta è semplice. Noi siamo certi, e sempre dentro limiti a volte consistenti e gravissimi, solo di quello che veramente ci interessa, di quello che si è talmente avvicinato ai nostri personali sentimenti, bisogni, desideri, sogni, progetti, da costituire pugno nello stomaco. Ricordiamo solo i pugni nello stomaco.
Di per sé, la vita non ci riserva molti pugni nello stomaco, e forse è meglio così.
Pensate cosa sarebbe una vita continuamente vissuta al limite della tensione emotiva, fin quasi a scoppiare sopraffatti dall’adrenalina. Un poco di calma, per carità.
Ma, poiché non siamo bestie da soma, ma uomini e donne ansiosi di viverla questa vita, ecco che la guardiamo in maniera selettiva. Filtriamo i fatti che ci accadono attorno, non solo quelli che vediamo direttamente con i nostri occhi, ma anche quelli che le grandi protesi moderne dei giornali e della televisione ci consentono di cogliere, fatti distanti migliaia di miglia, lontani nello spazio eppure così vicini come se accadessero nel cortile di casa nostra.
Abbiamo fatto l’abitudine a questi fatti, ma ce ne sono alcuni che si presentano in modo tale da colpirci profondamente.
Che vuol dire questo essere colpiti, per giunta in profondità? Vuol dire che restiamo a bocca aperta, mentre una sensazione di dolore, di ansia, di indignazione, di disgusto, oppure, il che fa lo stesso dal punto di vista dei meccanismi biologici che si scatenano nel nostro corpo, di gioia, di entusiasmo, di ebbrezza, ecc.
Questi accadimenti entrano in noi e vi si suggellano nella nostra certezza.
So bene che non c’è certezza alcuna, se la si considera in termini di oggettiva certezza valida per tutti, se la si pretende verificare con il bilancino del farmacista, ma quando il sangue ribolle nelle nostre vene per i quindici morti straziati dentro la sala centrale della Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, passassero cent’anni, ci sentiremmo lo stesso certi di un fatto indegno, che solo miserabili servitori dello Stato potevano compiere.
Ecco il genere di certezza di cui voglio parlare.
Tutte le volte che penso a Pinelli gettato dalla finestra della stanza del commissario Calabresi nel cortile interno della questura di via Fatebenefratelli a Milano, il sangue mi ribolle nelle vene.
Quindi anche di questo sono certo. Mille legulei organizzati insieme per spiegarmi le ragioni del povero commissario sbalordito dal poderoso colpo di reni di Pinelli per andare a volteggiare nell’aria notturna di Milano, non possono convincermi. Non ho nemmeno bisogno di leggere le testimonianze dei compagni presenti nelle altre stanze che udirono l’accalorarsi dell’interrogatorio, e le imprecazioni che precedettero e seguirono l’uccisione di Pinelli. Non aggiungono nulla alla mia certezza, queste testimonianze.
Allo stesso modo non tolgono nulla gli scagionamenti di tribunali, o le dichiarazioni filiali di giovani uomini cresciuti all’ombra della colpa paterna, o i ricordi sudaticci di una vedova per la quale non ho mai provato compassione.
Un uomo deciso, sicuro di sé, messo in caricatura perfino in un film, ma padrone della situazione. Era lui la punta di diamante della questura di Milano nel momento in cui scoppiano le bombe, era lui a darsi da fare sulla spinta degli avvenimenti, forse più grandi di lui, ma non di certo capaci di stornargli il cuore verso un moto di correttezza, prima di tutto verso se stesso. Ma di che correttezza può essere capace uno sbirro, e per giunta uno sbirro che vuole fare carriera a qualsiasi costo?
Nessuno parla più di questa persona in modo concreto, non potendo sembrare un mito, sembra almeno un fantasma. Gli anni passati hanno annacquato il personaggio, la morte sembra avere appiattito le caratteristiche in una iconografia da martire statale.
Il povero Calabresi, trentaquattro anni, un fiore di gentiluomo, con moglie incinta e due figlioletti. Un appartamentino al terzo piano del n. 6 di via Cherubini, una casa modesta. Dopo la morte, la moglie dovette attendere quasi un anno per avere 156.000 lire al mese di pensione. Che tristezza.
Ma il povero Calabresi vedeva la vita sotto un’altra prospettiva. Voleva essere un vincente, giocava sporco, ed era riuscito a costruire attorno a sé la fama di duro, di imbattibile. Dappertutto arrivava per primo, schiacciava tutta la concorrenza, i suoi collaboratori lo odiavano, i suoi superiori lo temevano. Uomo da karatè e da culto della forza, era talmente ipocrita con tutti da farsi passare per un sentimentale, per un cattolico praticante, per un timorato di Dio. In fondo, quest’insegnamento l’aveva appreso in America, dove era stato a lavorare con la Cia. Un’esperienza, all’epoca, fatta da pochi super poliziotti italiani.
In quei febbrili giorni del dopo strage a Milano tutti avevano paura di tutti. Il segno del terrore cominciava per la prima volta, seriamente, a penetrare l’aria provinciale e sempliciotta del nostro paese. Anche la città industriale per eccellenza, in fondo, non aveva mai vissuto un’epoca come quella che si accingeva a vivere. E la gente quasi lo sentiva nella pelle questo tragico discorso nuovo che stava per aprirsi.
Perché Pinelli? Perché non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Poteva toccare a un altro compagno. La prova di buttare giù qualcuno dalla medesima finestra dello studio di Calabresi era stata fatta mesi prima con Braschi, poteva essere lui a cadere rimbalzando sui cornicioni. Gli è andata bene. Il contesto degli attentati alla Fiera campionaria non era all’altezza di quello di Piazza Fontana.
Raffazzonare al meglio la tesi della pista anarchica era compito suo, era lui lo specialista degli anarchici milanesi, e degli altri che avevano rapporti con i compagni di Milano. Chi meglio di lui poteva raccogliere le fila del discorso di già iniziato da Ventura, con la pubblicazione dei testi anarchici fatta da una casa editrice dichiaratamente fascista e finanziata dal Ministero?
In fondo, la scelta degli anarchici era di già in corso da mesi, la prova generale era stata fatta con le bombe della Fiera campionaria. Molti i compagni in galera proprio in quel momento. E lì attorno, a girare ben bene le cose, il povero Calabresi, con il suo vestito stirato di fresco, il suo atteggiamento educato e duro, la sua cultura (si fa per dire, ma sempre qualcosa in prestito riusciva a prenderlo qua e là), la sua velocità nel prendere decisioni.
La velocità nelle decisioni. Un uomo che aveva lavorato per la Cia non poteva avere che la velocità degli uomini della Cia, spietati e freddi nell’esecuzione del loro lavoro. Solo tempi molto più vicini a noi hanno smontato questi luoghi comuni, facendo vedere come i Servizi Segreti, dalla Cia al MI5, al famigerato Mossad, altro non sono che bande di assassini prezzolati e garantiti dell’immunità statale, spesso anche un branco di incapaci e di sprovveduti, dotati di mezzi che a un certo punto li fanno più grandi e più forti di quello che veramente sono.
Ecco, il commissario Luigi Calabresi era uno di questi assassini prezzolati e garantiti. Attorno a lui si era creato il mito dell’imbattibilità, della forza decisionista che abbatte tutti gli ostacoli di fronte a sé.
Una prima incrinatura questo mito l’aveva avuto al processo contro “Lotta Continua”, dove Calabresi era apparso in difficoltà. Lo si accusava esattamente di quello che stiamo dicendo qui, di avere ucciso, o almeno partecipato all’uccisione di Pinelli. I balbettii di risposta sono ancora nel ricordo di tanti compagni.
Il 17 di maggio fu un giorno infausto per il grande commissario. Tutto sembrava dovesse andare come sempre, la solita routine della mattina: la colazione, il saluto alla moglie incinta, i due figlioletti, uno di due anni e uno di undici mesi, che scenetta familiare.
Anche il boia ha una famiglia. Non sembra possibile, ma è così. E la famiglia del boia vede il lavoro del boia come quello di un qualsiasi funzionario dello Stato, per giunta di un certo livello, richiedendo il lavoro di boia specializzazioni che non tutti possono assolvere. Dietro la maschera che nasconde il boia c’è posto anche per la prolifica moglie e la numerosa figliolanza.
Quell’infausto giorno, più o meno alle nove di mattina, il commissario Luigi Calabresi scende in strada. Lì lo aspetta il suo destino, esattamente alle nove e quindici minuti, sotto forma di due pallottole, una prima e una dopo.
Referto: discontinuazioni craniche, meningo-cerebrali, da proiettile da arma da fuoco (regione occipitale destra).
L’autoambulanza della Crocebianca di Vialba urla la sua urgenza per le strade della metropoli. Alle nove e trentasette minuti il commissario Luigi Calabresi muore all’ospedale S. Carlo.
L’autopsia sul cadavere di Pinelli fu eseguita dai professori Ludovi, Mangigli e Falzi. Chi sono costoro? Non lo so. Dei tagliaossa qualsiasi? Non credo, almeno uno di loro era un uomo dei Servizi, come è apparso in una nota marginale pubblicata dai giornali anni dopo.
Perché questa presenza? Perché, ancora una volta non si sentivano sicuri che tutto fosse stato fatto a dovere (troppa gente nella stanza di Calabresi?), e volevano chiudere al più presto, massacrando in fretta e furia quel che restava del nostro compagno.
Una cosa è certa, che se il lavoro di Calabresi fu un macabro pasticcio (all’improvviso risultò che Pinelli portava ai piedi tre scarpe), quello dei notomizzatori fu fatto alla perfezione. Dopo, nessuna controperizia fu possibile.
Calabresi, dopo essere uscito dal portone di casa, va verso il salvagente nel centro della via dove era parcheggiata la Cinquecento della moglie. Ai due lati una Primula e una Opel. Il primo colpo lo coglie alla spalla destra, cade, il secondo gli fa saltare parte del cranio. Lo spazio tra la Cinquecento e l’Opel si riempie a poco a poco di sangue.
La gente presente non accorre subito, quasi non si è accorta dei colpi d’arma da fuoco. Nell’aria primaverile sembravano scoppiettii d’una vecchia auto. Poi qualcuno scorge il corpo bocconi, il sangue che continua ad allargare la sua chiazza purpurea. Si chiama la polizia, i carabinieri, l’autoambulanza, insomma tutto quello che accade di solito in questi casi, accade, come in un vecchio copione abusato. Solo che stavolta accorrono anche gli alti vertici della polizia milanese. Guida ha gli occhi pieni di lacrime. Il vecchio custode dei penitenziari fascisti, sperimentato a tanti misfatti e a tante torture, si commuove nel vedere il corpo del fido collaboratore a terra, riverso nel proprio sangue.
Il funerale del commissario finestra è fastoso, moltissime corone di fiori. Il cadavere viene portato in chiesa. Il vescovo ausiliare di Milano celebra il rito funebre: “Fulgido esempio di dedizione al dovere”. È incredibile come questa gente non abbia il minimo senso di pudore.
Il cardinale Colombo, riferendosi ad una dichiarazione della signora Gemma Calabresi, afferma: “Il fiore più bello sbocciato sul sangue del commissario ucciso è il perdono della vedova”. Roba da non crederci.
Perdono. Che parola magica. Bisognerà aspettare degli anni per sentirla ripetere di nuovo, da altra gente, in altri contesti, ma sempre riguardo la morte di Calabresi.
Ma, andiamo con ordine.
Di quella mattinata di maggio qualcuno, dopo tanti anni, sembra ricordare qualcosa. Che splendido e meraviglioso meccanismo è la memoria. La memoria dei pentiti, poi, meriterebbe uno studio a parte. In quel di Massa c’è un tizio che vende crêpe, che ha un chiosco di crêpe, forse venderà anche cocacola e aranciate, non lo so, comunque ha tutta l’aria di un onesto bottegaio che tira a campare. E invece sotto il suo sguardo bonaccione si nasconde un pericoloso criminale.
In più, questo criminale pericoloso parla, racconta delle storie, narra di quello che fece la mattina di quel 17 maggio 1972 in via Cherubini, quando a bordo di una macchina aspettava, aspettava, aspettava.
Ma chi aspettava?
Il nostro amico fa un nome, poi ne fa altri due, indicando in questi ultimi i mandanti dell’uccisione di Calabresi.
Lui era solo l’assistente, l’autista dell’autore materiale del fatto.
Ma andiamo, mio caro amico pentito, possibile che i carabinieri abbiano soltanto un disco e che a tutti coloro che accettano per quattro soldi di indossare la casacca dell’infame facciano recitare sempre la solita storia?
Lo stesso per la ragazzina che nel processo di Roma contro gli anarchici (ancora in corso presso la Corte d’Assise), fra i continui “non ricordo”, ripete soltanto quello che ha imparato a memoria della relazione preparata dai carabinieri.
Ecco, c’è un fatto che i magistrati non sanno, che lo stesso pentito non sa, che nessuno sa, ed è il fatto che io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi, il 17 maggio 1972, sotto casa sua, in via Cherubini 6, a Milano, alle nove e un quarto del mattino. E questo taglia la testa al toro, definitivamente. Il faccione del pentito sta solo recitando un pessimo copione.
Ma, non anticipiamo i tempi.
Ad aspettare il commissario in via Cherubini, c’era la vendetta.
Un assoluto silenzio accolse il 20 dicembre del 1969 all’uscita dell’obitorio la salma di Pinelli. Erano le 15 e un quarto. Cominciava a piovere.
Ci indirizzammo verso via Preneste.
La moglie Licia aveva rilasciato un comunicato: “Desidero vivamente che i funerali di Pino Pinelli, pur aperti a tutti gli amici che vorranno prendervi parte, avvengano in forma dichiaratamente privata, senza la partecipazione di gruppi organizzati, di delegazioni o simboli”.
Non so perché lei ebbe a fare questa dichiarazione, non certo per i motivi per cui da solo, nel mio cuore, anch’io ero arrivato alle stesse conclusioni: simboli, striscioni dei gruppi, forse le stesse bandiere al vento, sarebbero stati fuori posto.
Una sola bandiera nera avrebbe dovuto essere presente, alla fine risultò che di bandiere ce n’erano più del necessario.
Una corona di fiori portava una piccola scritta: “Gli anarchici tutti non ti dimenticheranno”.
Mi chiesi se non avremmo dimenticato Pinelli, oppure quello che gli era stato fatto. Il dubbio rimase fino al Cimitero Maggiore.
Fossa 434, campo 76.
Qui non ebbi più dubbi. E, insieme a me, i mille compagni presenti non ebbero più dubbi.
Calabresi doveva essere ucciso.
Addio Lugano bella.
La vendetta è una questione di dignità. L’enormità del fatto non deve essere commisurata soltanto alla morte di Pinelli, e forse nemmeno alla stessa strage dei quindici morti e dei novanta feriti. Ciò costituirebbe una mera algebra giuridica, forse appena appena più corretta di quella che prevedono i codici. E, in questo senso, non mi interesserebbe.
La vendetta è un eccesso, di per sé, non nell’attacco che realizza. Quindi, vedendo il rapporto nel senso contrario, l’uccisione di Calabresi, questa non è stata una vendetta commisurata, commisurata ai morti di Piazza Fontana o alla morte di Pinelli. Anche vedendo le cose in questo modo si ricade nell’algebra giuridica di prima.
La vendetta è quindi un eccesso.
Non occhio per occhio, dente per dente, che di già nella formulazione biblica costituiva una razionalizzazione di precedenti comportamenti vendicativi imprevedibili, quindi un codice vero e proprio, mentre è parso ai più, erroneamente, una vendetta e basta.
L’eccesso che si racchiude nella vendetta spazza il campo di qualsiasi rapporto di equivalenza, di qualsiasi commisurazione. Non è vendetta se non si trabocca nell’immane, nella cancellazione barbara del nemico, nella sua eliminazione o, almeno, in un arrecargli un danno di tale portata da rendergli impossibile l’oblio.
Se la vendetta fosse commisurata, sarebbe il sistema sociale nel suo insieme ad impormela, ed eccomi quindi racchiuso in un codice, sia pure non scritto, ma sempre in un codice. L’ambiente mi obbligherebbe a vendicarmi, seguendo delle regole, in quanto in caso contrario sarei guardato male e male considerato se non mi vendicassi o se mi vendicassi in eccesso, dando origine a ripercussioni dannose per l’ambiente stesso.
Invece, se a sollecitarmi alla vendetta è la mia dignità offesa, è solo verso di essa che io sono responsabile, ed è con essa, quindi con la parte offesa di me stesso, con la mia coscienza, che devo fare i conti. E con me stesso non ci sono mezze misure, io costituisco con me stesso una totalità indissolubile, io sono il mondo, la totalità del mondo, e chi arreca offesa alla mia dignità cancella il mondo, mi distrugge come coscienza del mondo attraverso me stesso, e merita di essere tolto dal mondo.
Certo, sono pochi a cogliere il senso profondo della propria dignità. È questo il mistero di certi comportamenti che ci sembrano inspiegabili. Nietzsche si sente offeso nella propria dignità di uomo di fronte allo spettacolo di un vetturino che frusta il proprio cavallo e non potendo resistere davanti al proprio mondo ucciso da quel bruto insensibile, decide di cancellarlo quel mondo, di cancellare il proprio mondo, di cancellarsi nella pazzia. Per lo stesso motivo, altri compagni, di fronte alla propria dignità offesa cancellano il mondo in altro modo, si cancellano nel suicidio.
Questo modo di vedere la vita si sviluppa e finisce per diventare essenziale, man mano che ci si rende conto dell’assurdità delle regole formali che sanciscono la cosiddetta società, per non parlare delle leggi che fissano le condizioni di esistenza dello Stato. Leggi e comportamenti che a lungo andare appaiono non solo strumenti del nemico per asfissiare e rendere impossibile quel poco di libertà che anche in una società amministrata e controllata è possibile strappare, ma in se stessi, come vere storture, comportamenti aberranti anche quando appaiono intenzionati dalla migliore buona volontà.
La critica della vita quotidiana produce una coscienza che nel tempo si fa sempre più acuta e sensibile, sempre più alacre nello scoprire ulteriori terreni di desolazione e di isolamento. Tutto intorno cadono così i luoghi comuni del possibilismo democratico, le illusioni della politica, le positività del movimento storico, le concessioni istituzionali, l’asetticità di certi riconoscimenti. Si fa terreno bruciato, ed allora occorre decidersi. Se la propria coscienza è capace di penetrare dentro la realtà, se scopre la trama che costituisce il tessuto dei rapporti sociali, quella trama fine e quasi impalpabile che spesso è coperta dai colori appetitosi dell’offerta con cui si veste la miseria del dominio, se arriva a fare chiara questa notte senza tempo, allora si sente offesa, profondamente offesa.
È l’offesa dei millenni della schiavitù e dell’incarcerazione, dei millenni di sofferenze e genocidi, dei millenni di sottomissione a pochi gruppi dominatori. Nulla di quello che è stato il nostro passato merita di essere salvato, nulla mi è stato dato, e nulla sono riuscito a strappare al nemico, se non nell’ottica di una sua concorrenziale concessione diretta a farmi accedere al banchetto, sia pure per qualche briciola, per qualche riconoscimento di status del tutto marginale, per qualche striscia sul berretto, per qualche inchino da parte di imbecilli sornioni che si credono furbi.
E puoi anche riflettere per anni e anni su questi problemi, leggere e riflettere, fin quando ti senti stanco e triste, e non c’è nessuna pagina, nessuna parola, nessun gesto di uomo o di donna a te vicini che ti dica qualcosa di chiaro, definitivamente chiaro. Puoi remare nell’oscurità per anni, come i galeotti di un tempo, fino allo stremo, fino a quando cadi morto sul remo senza che gli altri se ne accorgano.
Invece, può accadere che un fatto ti illumini per un attimo il fondo della strada, che un fatto atroce ti faccia vedere in filigrana com’è veramente il nemico, di che pasta lo hanno messo al forno, da quale crogiolo infernale è uscita la sua anima. Se un tale avvenimento accade, se sei là anche tu, insieme a tanti altri come te, che sai che stanno vivendo la medesima esperienza traumatica, e li vedi, omoni grossi con le mani callose, ragazzini che cercano di darsi un atteggiamento, donne mature che corrono col pensiero agli anni della guerra, ai figli trucidati, fanciulle che vedono il loro amore, che avvertono come un segno di purezza del mondo, quasi sporcato da tanta protervia, e li vedi, tutti con le lacrime agli occhi, impotenti ma con i muscoli tesi, se un tale avvenimento accade con te dentro, non è più un qualsiasi accadimento, un fatto come gli altri (milioni di persone muoiono uccise barbaramente e vengono condotte al cimitero più o meno in fretta), ma quel fatto ha una carica diversa, porta con sé una tensione che non ti permette di avere tregua, ti svegli la notte sudato e, seduto sul letto, ti chiedi che stai facendo nel tuo letto, e se per caso non sei tu il morto che si gira nella tomba, mentre ad essere vivo, ben vivo, è proprio Pinelli, con la sua ingenua barba da operaio delle ferrovie.
Mi rendo conto che tutto questo potrà sembrare un elenco di sensazioni avvertite da un cervello esaltato, da me che, lo devo confessare, quella sera al Cimitero Maggiore, fossa 434, campo 76, mi sono messo a piangere senza ritegno. E sia, mettiamola così, si tratta di ricordi che risentono dello stato emotivo del momento, e spesso questi stati emotivi esaltati, non potendosi esprimere sull’istante in qualche cosa di fattivo (prendere a pugni un poliziotto, ad esempio), si traducono in una frustrazione che fa scoppiare in lacrime. E sia, sono d’accordo.
Ma così ragionando si perde qualcosa d’importante, riducendo tutto ad una somma di singole persone che vivono singoli stati d’animo, si mette da parte la cosa essenziale, quella forza eccezionalmente importante che viene fuori da molte persone che avvertendo le medesime sensazioni emotive, sollecitate da sentimenti molto simili (nessuno identico, per carità, lo so bene), si sentono attratti uno con l’altro a costituire un insieme omogeneo che non ha bisogno di patti o contratti scritti o detti per costituirsi. Improvvisamente, questa forza collettiva emerge ed è là, tangibile, posso toccarla, posso sentire la sua voce, posso lasciarmi prendere dalle sue suggestioni, indirizzare lo sguardo dove lei mi dice di guardare, vedere con i suoi occhi fatti di mille pupille quello che i miei poveri occhi miopi non vedono, ricordare ciò che la mia povera mente da sola non può ricordare.
Improvvisamente, come dalla testa di Zeus, di tutto punto armata, esce l’idea di giustizia. Ma è una ben strana idea, perché non si appoggia a nessun patto, a nessun ordinamento preferenziale. Non è un’idea che vuole rimettere le cose al loro posto, scambiare il cadavere di Pinelli con quello di Calabresi, non sono prodotti fungibili. Non è un’idea che vuole garantire all’azione rivoluzionaria, genericamente considerata, una legittimità di continuazione: che fiducia possono avere gli sfruttati in rivoluzionari che senza reagire si fanno gettare dalla finestra come una scatola di roba vecchia. No, nemmeno questo. Non è un’idea che vuole essere conosciuta, fatta propria dalla gente, tanto è vero che non ci saranno rivendicazioni o chiacchiere politiche da parte di organizzazioni specifiche di nessun genere, e dire che in quel torno di tempo strutture nascenti ce n’erano diverse. Non è un’idea che si alza più alta delle altre per richiamare all’ordine turbato dal comportamento fuori delle regole, dai misfatti compiuti da un certo commissario Calabresi, dopo tutto non è certo normale che un fermato in questura, durante un interrogatorio, venga buttato fuori dalla finestra.
Se questo mondo si basa sulla giustizia commisurata, sui calcoli numerici di un dare e un avere, di un punire per il torto fatto e di fare un torto per la pena subita, si tratta di un mondo che non ha niente a che fare con quell’idea di giustizia venuta fuori collettivamente in quel momento, quella sera, nel Cimitero Maggiore di Milano. Ecco quindi che quella sera, senza che nessuno lo volesse o lo sapesse, è venuta fuori un’idea di giustizia che prima non c’era, un’idea che travalica e rende risibile il singolo desiderio, la singola fantasia di sparare in bocca al buon commissario Calabresi, desiderio e fantasia coltivati senz’altro dalla quasi totalità dei presenti, ma come tutti i desideri e tutte le fantasie, poco dopo, col ritorno alla vita quotidiana, svaniti nel nulla.
Invece quest’idea di giustizia (che si potrebbe definire “proletaria” se, come giustamente è stato fatto notare, su questo termine non fosse piovuta la polvere dei millenni a renderlo inutilizzabile), che non sapendo come chiamare continueremo a chiamare così, semplicemente, giustizia, quest’idea di giustizia ha continuato il suo cammino in tutti noi, ci ha mantenuti tutti insieme uniti, compagni che non mi sono mai stati vicini, che erano presenti quella sera lì, che poi ho rivisto poche volte altrove, in tutt’altre faccende affaccendati, loro ed io, compagni per i quali, diciamolo chiaramente, nutro pochissima stima, se non proprio avversione e disprezzo, ebbene per il semplice fatto che anche loro fossero lì quella sera, tutte le volte che la voce lontana ma vivissima della giustizia mi chiama, mettendomi in subbuglio il cuore, anche quei compagni torno a sentirli vicini.
Ecco perché io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi, il 17 maggio 1972, sotto casa sua, in via Cherubini 6, a Milano, alle nove e un quarto del mattino.
Quei mille, e più, compagni presenti alla fossa 434, campo 76, del Cimitero Maggiore di Milano, abbiamo tutti premuto il grilletto.
Nessun perdono. Nessuna pietà.
Addio Lugano bella.
Catania, 12 luglio 1998
Alfredo M. Bonanno
Pinelli e la strage di Stato
Il 12 dicembre di ventotto anni fa, di pomeriggio, una persona entrava nella Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, lasciava una borsa e andava via. Pochi minuti dopo la borsa scoppiava causando quindici morti, se non ricordo male — che poi i morti col passare del tempo, sfumano nella memoria — e novanta feriti, aprendo una lacerazione nel tessuto sociale dell’epoca, insanabile e incomprensibile, sotto certi aspetti, fino ad oggi.
Questa sera, in questa piazza, ovviamente, non siamo in grado di chiarire fino in fondo che cosa condusse le forze dello Stato italiano, in quel momento così delicato della nostra storia, a mettere quella bomba, in quel posto, quella sera, causando quella strage.
Ma siamo in grado di ribadire, ancora una volta, quello che si disse immediatamente, pochi minuti dopo la strage, che quella strage l’avevano commessa gli organi dello Stato, l’aveva commessa lo Stato in prima persona, l’aveva portata a compimento un uomo dello Stato.
E occorre cercare di capire perché lo Stato, ad un certo punto, si determina ad un gesto del genere: per leggerezza, per pura ferocia, per stupidaggine forse? Oppure per bieco calcolo politico? Ecco, questa domanda ci ha tormentato per ventotto anni e continua a tormentare, non solo le coscienze dei rivoluzionari, ma le coscienze di ogni uomo dabbene, che vive nella società italiana, che ha vissuto questi ultimi ventotto anni e che continua a chiedersi: “Possibile che i disegni machiavellici di uno Stato criminale riescano ad arrivare fino a questo punto? Possibile che si corra il rischio di mettere a repentaglio la vita di decine, di centinaia di persone, per un disegno politico? E poi perché questo disegno politico? Che cosa aveva fatto tanta paura da spingere a quel passo?”.
E qui occorre fare una piccola riflessione, un piccolo passo indietro per cercare di cogliere le fila di quella che era la situazione in quel momento, dicembre 1969, per capire in che modo lo Stato funziona, per capire in che modo lo Stato, alcune parti dello Stato, quelle sostanzialmente più vicine alle massime decisioni di potere, agiscono, per capire cioè in che modo le strutture esecutive dello Stato funzionano, per evitare di farci imbrogliare, per evitare che si facciano passare per quello che non sono, presentandosi per espressione democratica delle forze della Nazione, quando invece sono soltanto l’espressione della forza più bieca, più repressiva, più criminale delle strutture di dominio.
Il 1969 è l’anno successivo ai successi del movimento studentesco che esplode nel 1968. Il 1969 è l’anno caratteristico, che porta ad una svolta la società italiana. Il ’69, particolarmente all’inizio dell’autunno, è l’anno delle lotte sindacali; è l’anno in cui la capacità di rapporto fra il movimento studentesco e le frange più avanzate di una certa critica della società riesce a creare un minimo di coordinamento con le strutture produttive sindacali e non sindacali delle fabbriche. È l’anno in cui il mondo produttivo è in ribellione e ribolle di energie diverse. Queste energie però non sono, come spesso ci viene raccontato, quelle che chiedono modificazioni strutturali, miglioramenti salariali, che premono su una struttura del capitale abbastanza lenta nelle proprie trasformazioni, nelle proprie ristrutturazioni, non sono soltanto questo. Queste energie sono capaci di autorganizzarsi. Ecco, secondo me, la parola chiave per capire che cosa è accaduto nel 1969, la si trova approfondendo il concetto di autorganizzazione. Le strutture produttive in quel momento non erano autorganizzate, come non lo sono adesso, questo è chiaro, ma lanciavano segnali di capacità autorganizzative. Questi segnali erano lanciati attraverso una critica radicale di certi atteggiamenti filogovernativi, manifestati dai sindacati, e facevano capire la presenza di una capacità di autorganizzarsi nelle lotte. Scoppiavano tantissimi scioperi autonomi e la repressione dello Stato non avveniva solo nelle grandi fabbriche del Nord, ma anche al Sud, ad Avola, dove la polizia spara sui braccianti, a Battipaglia, dove la polizia spara sui braccianti. Uccide ad Avola e uccide a Battipaglia.
Il 1969 è l’anno in cui lo Stato sa che sta giocando una partita radicale, importante, e questa partita non viene soltanto giocata sulla capacità di fronteggiare il nemico di sempre, il movimento operaio nel suo aspetto generico di domanda di miglioramenti, di modificazioni, ma anche qualcosa di oscuro, di non chiaro, su questo piano, vista la capacità dimostrata in diverse occasioni dalle masse operaie e produttrici di autorganizzarsi, anche in piccoli fatti, in piccoli aspetti apparentemente marginali.
Ora, io mi chiedo, compagni che mi ascoltate, questa capacità, da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico, chi la possiede da sempre? Essa è da sempre patrimonio del movimento anarchico, sono gli anarchici che hanno da sempre sostenuto la necessità di autorganizzarsi nella lotta, di impadronirsi delle strutture di lotta e di dare vita a movimenti combattivi, non restando legati a sindacati che non possono se non portare acqua al mulino del governo. Ecco perché gli anarchici, in quel momento, rappresentavano per lo Stato una spina nel fianco, e non solo in quel momento.
Ecco perché ci portano in carcere anche oggi, perché rappresentiamo il riferimento possibile di uno spazio autorganizzativo delle lotte. Non perché in questo momento, come nel 1969, questa forma autorganizzativa delle lotte è in corso di realizzazione, ma perché è in nuce nella piccola possibile idea che domani può diventare seme, dopodomani può diventare albero, poi può mettere rami e produrre i frutti rivoluzionari di sconvolgimento sociale. Ecco che cosa teme lo Stato. Ecco perché lo Stato punta gli occhi con attenzione sugli anarchici, ecco perché un uomo, quella notte, o meglio quella sera del 1969, con quella sua valigetta ventiquattro ore, ecco perché quella bomba, ecco perché quei morti, ecco perché la strage di Stato. Ecco perché si precostituiva una responsabilizzazione degli anarchici già prima del 12 dicembre di ventotto anni fa. Perché il 1969 non è soltanto il 1969 delle uccisioni della polizia ad Avola e a Battipaglia; è anche l’anno in cui ci sono centocinquanta attentati in tutta Italia, in diversi luoghi e in tante stazioni ferroviarie, dei piccoli attentati, che quasi sempre causano soltanto danni. E poi c’è l’esempio, la preparazione, la grande prova in vista di quello che si voleva fare il 12 dicembre: l’attentato del 25 aprile.
Le bombe della Fiera campionaria di Milano sono quindi la prova generale: scoppiano le bombe, pochi feriti, poteva essere una strage, potevano esserci dei morti. Vengono arrestati gli anarchici. Perché gli anarchici? I coniugi Corradini, che lavoravano nella redazione della Casa Editrice Feltrinelli, vengono arrestati insieme a loro altri quattro compagni anarchici molto giovani, si faranno quasi due anni di carcere per uscire poi assolti perché il fatto non sussisteva. Quel fatto non sussisteva, quelle bombe non le avevano messe gli anarchici, però lo scopo si era raggiunto. Era quello di costituire un punto di riferimento, un capro espiatorio. Attorno agli anarchici da tempo lo Stato lavorava nascostamente, non solo con le sue attenzioni che ci rivolge sempre (mentre parlo, in questa piazza, in questo momento ci sono rappresentanti in alta uniforme che stanno registrando quello che dico, che stanno fotografando quelli che siamo qua e così via), quindi non solo queste attenzioni, ma altre attenzioni, quelle dei Servizi Segreti, le attenzioni del Servizio Segreto che a quell’epoca dominava in Italia, cioè il Servizio Segreto americano, la CIA, le attenzioni dei fascisti, che si organizzavano per cercare di attirare verso gli anarchici il colpo repressivo durissimo.
Conoscete, ad esempio, e non possono non essere conosciuti, i nomi di Freda e di Ventura, notissimi fascisti che sono stati più volte accusati e assolti — non si sa mai — della strage di Stato, in alcuni di quei tanti processi che nel corso di questi ultimi anni ci sono stati su questo argomento. Ebbene quel Ventura, col look da compagno, con la barba e con l’eskimo, a differenza del suo socio Freda, che invece aveva un look tipicamente fascista, tipicamente ordinato, Ventura è l’editore di alcuni testi anarchici, ben prima del 12 dicembre del ’69. Ventura si dà da fare, contatta dei compagni, ad esempio contatta un compagno a Palermo per farsi fare l’introduzione a L’unico di Stirner, che pubblicherà subito dopo. Ma il compagno anarchico di Palermo rifiuta e lui se la fa fare da un altro compagno, non anarchico, che allora dirigeva la rivista “Che fare?” pubblicata, sempre da Feltrinelli, questo compagno è Roberto Di Marco che così firma, l’Introduzione a L’unico di Stirner. Sempre la casa editrice fascista di Ventura, pubblica un altro libro anarchico: Il mutuo appoggio, se non ricordo male o La conquista del pane di Kropotkin, ma credo Il mutuo appoggio di Kropotkin.
Perché i fascisti fanno tutto questo, ben prima del 12 dicembre 1969? perché ricevono finanziamenti dal Ministero degli Interni per fare questo? Per precostituire e pilotare, in tempi non sospetti, quindi nel 1968 e nei primi mesi del 1969, l’attenzione verso gli anarchici. Quindi, gli anarchici fanno paura. Fanno paura perché costituiscono il riferimento, il potenziale concreto di quella che è l’autorganizzazione delle lotte.
Ora io mi chiedo, se in qualcuno dei presenti ci sia il ricordo, magari non personale, per averlo sentito dire o per averlo letto sui libri, il ricordo di qualcosa che poteva far pensare, sul finire degli anni Sessanta, a una capacità delle organizzazioni rivoluzionarie dell’epoca, dei movimenti studenteschi o meno, dei partiti cosiddetti rivoluzionari, di costituire la forza propulsiva di una possibile autorganizzazione delle lotte? Escluso gli anarchici no, perché se voi le considerate una per una, quelle organizzazioni erano tutte strutture piramidali, strutture di partito. La stessa Lotta Continua era un’organizzazione capace di affascinare, sotto certi aspetti, piccole frange di compagni, per alcune sue caratteristiche libertarie, ma sostanzialmente restava una struttura piramidale, con un organigramma ben preciso, con delle strutture dirigenti di partito o di para-partito. Soltanto gli anarchici hanno da sempre avuto, come patrimonio personale di lotta, l’autorganizzazione delle lotte e quindi ecco perché lo Stato si indirizzò verso gli anarchici. Ecco perché qualche giorno dopo il 12 dicembre, viene arrestato Valpreda, ecco perché viene ucciso Pinelli.
Giuseppe Pinelli, un compagno che io ho conosciuto, un uomo interessante, non condividevamo probabilmente su tanti dettagli le stesse idee, specialmente sull’organizzazione, ma un compagno lontanissimo da un certo modo di concepire la lotta rivoluzionaria. Perché hanno scelto Pinelli? Perché una volta portato in questura hanno ucciso proprio lui? Perché su di lui si sono puntati gli interessi di questo super-poliziotto. Perché era l’ultimo tocco d’artista. Se un uomo conosciuto come Pinelli, una brava persona, si suicida, non potevano esserci più dubbi sulla colpevolezza degli anarchici. Era quasi una confessione in piena regola. Chi l’artefice di questo piano ingegnoso e orribile? Badate, stiamo parlando di Calabresi, di Luigi Calabresi.
Un giovane uomo di 36 anni, nemmeno molto avanti nella carriera, un semplice commissario. Eppure in quel momento, in tutte le piazze di Milano, era lui il poliziotto più significativo, più importante, quello che si permetteva di redigere a modo suo e di condurre a modo suo tutti gli interrogatori, a prescindere da quello che dicevano i suoi superiori, a prescindere dalla presenza o meno di un qualunque magistrato.
È lui che interroga i compagni arrestati il 25 aprile, è lui che porta i compagni Braschi e Faccioli in campagna e organizza la finta esecuzione di Braschi puntandogli la pistola alla testa e scaricandogli un caricatore vuoto, è lui che fa sedere il compagno Braschi sulla finestra da cui, mesi dopo, cadrà Pinelli, è lui che in questo modo si guadagna il titolo di “commissario finestra”. Quindi non è possibile quello che è stato sostenuto, per la verità con scarso pudore, e per poco tempo, del suicidio di Pinelli. Non sto a tediarvi sulle prove e su quello che è stato prodotto dai compagni come analisi per dimostrare l’impossibilità del suicidio di Pinelli. Sto per parlarvi di questa persona: del signor Calabresi.
Commissario di Pubblica Sicurezza. Su questa persona è stato fatto un film molto bello: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Veramente egli si considerava al di sopra di ogni sospetto, una persona che non poteva essere toccata. Un amante della forza, un amante della violenza gratuita, tipica degli strumenti più stupidi dello Stato. Su di lui si concentrava tutta la cura e tutta l’attenzione che lo Stato indirizza verso i suoi strumenti. Badate, Calabresi non era un poliziotto come tutti gli altri. Era stato in America, era stato educato alla scuola della CIA aveva un look diverso, che poteva ingannare, sotto certi aspetti, che ingannava con abilità. Vi parlo di una persona che mi ha fermato diverse volte, che ho conosciuto personalmente, che poteva ingannare chi perdeva di vista sia pure per un attimo il fatto di avere davanti un nemico, poteva sembrare una persona democraticamente disponibile, capace di citare i testi anarchici, ma, contemporaneamente, capace di sparare il caricatore vuoto di una pistola alla tempia di un compagno. Ecco perché ne stiamo parlando.
Questa persona è presente all’interrogatorio di Pinelli. È dimostrato che era nella stanza di Pinelli. Tutte le santificazioni che cercano adesso di recuperare le legittimità democratiche del povero Calabresi mi fanno ridere. Perché il povero Calabresi aveva una moglie che aspettava un bambino: ma anche i boia hanno famiglia, anche i boia devono dare da mangiare ai propri figli. Quindi non facciamoci impressionare: i boia restano boia, anche se sono padri di famiglia, anche se fanno il mestiere che fanno per dare da mangiare ai propri figli. Nessuna santificazione, per favore, almeno, da parte nostra, mai. Nessuna giustificazione, nemmeno quella del tempo, il tempo che passa e che fa dimenticare tante cose.
C’è una canzone che dice: “quel pomeriggio eravamo in tremila, in tremila al tuo funerale”, riferendosi al funerale di Pinelli, e forse eravamo più di tremila e tutti quanti, quel pomeriggio, accanto a quella bara, ognuno nel proprio cuore giurò di fare qualcosa, perché quel fatto orrendo, l’orrendo delitto della morte del nostro compagno, non passasse inosservato. Certo, nella stanza dove Pinelli venne interrogato noi non c’eravamo, io non c’ero. Certo, insieme a Calabresi nella stanza dove Pinelli venne interrogato e torturato c’erano altre persone: brigadieri di Pubblica Sicurezza, tenenti dei Carabinieri. Certo, non sappiamo quali gesti furono compiuti. Certo, non sappiamo con quali parole e su che cosa, e in che modo si cercò di incastrare il povero Pinelli. Certo, non sappiamo se la scarpa che rimase nelle mani di Panessa apparteneva alle tre scarpe indossate dal cadavere di Pinelli. Non lo possiamo sapere. Certo, non sappiamo perché l’autoambulanza che doveva portare via il povero Pinelli, ormai agonizzante, giù nel cortile della questura di Milano, venne chiamata, come di fatto risulta dal registro delle autoambulanze, tre minuti prima di quando i due cronisti de “L’Unità” che si trovavano a passare dal cortile della questura videro cadere quello che a loro sembrò uno scatolone per il modo in cui precipitava a piombo, dritto, sbattendo sui cornicioni dei vari piani della questura di Milano, in via Fatebenefratelli. Questo non lo sapremo mai.
Ma quella sera, quando andammo in tanti compagni, al cimitero maggiore di Milano per accompagnare la bara di Pinelli, tutti e non solo noi che eravamo in quell’occasione presenti, ma anche altrove, in tutte le città italiane, decine di migliaia di compagni avevano la coscienza, assoluta, certa, senza la quale non si può fare nulla di serio nella vita, coscienza perfettamente, rivoluzionariamente sicura di sé, che il responsabile di quella morte, della morte del nostro compagno, era il commissario Luigi Calabresi in carica alla questura di Milano, nell’anno 1969.
E il mito della forza, dell’imbattibile uomo d’acciaio, il mito di questo superuomo, cade in via Cherubini, davanti a casa sua, nel mese di maggio, il 17 maggio del 1972, sotto i colpi di rivoltella.
Una rivoltella che spara pone fine all’attività repressiva di questo personaggio e sarebbe giusto da parte degli anarchici, metterci — come si dice — una pietra sopra. Ma noi anarchici non siamo giusti, siamo ingiusti. Vogliamo continuare a parlare non solo dell’assassinio di Pinelli, del nostro compagno, da parte del commissario Calabresi, ma anche della morte di quest’ultimo, del perché è morto. Certo non possiamo dire chi lo ha ucciso, perché non lo sappiamo, e se lo sapessimo non lo diremmo. Certo, non possiamo fare le medesime illazioni che sono state fatte da parte di chi, con interesse, cercava di distogliere e continua a cercare di distogliere l’interesse rivoluzionario di questo gesto. Ad esempio, su quella tomba è stato detto: “ecco, non può essere stata che la CIA ad avere ucciso il commissario Calabresi, perché è la CIA che aveva interesse a farlo tacere, perché adesso che era incastrato nel processo di Lotta Continua, Calabresi avrebbe finito col fare delle ammissioni circa il complotto della strage di Stato”. Oddio, ognuno è liberissimo di pensare quello che vuole – e ci sono state degne persone che hanno sostenuto questa tesi. A noi questa tesi non interessa. Non ci interessano i magistrati e i poliziotti più o meno democratici.
Il fatto è che il mondo, nel frattempo, è cambiato. Le cose si sono evolute. Il capitale non ha più la necessità di salvaguardare le risposte temibili delle strutture di produzione, adesso ha altre necessità, di cui cercheremo di parlare. Il mondo è cambiato e quindi sono venuti su nuovi giudici, ragazzini più o meno cresciuti. Guardate che, ad esempio, uno di questi giudici faceva parte del movimento studentesco. Il P.M. Salvini era uno dei compagni che andavano per le strade con i bastoni e le bandiere, che facevano parte dei servizi d’ordine, e ha fatto arrestare tutti i suoi compagni del Collettivo di Medicina di Avanguardia Operaia di Milano per l’uccisione del fascista Ramelli.
Ma veniamo al pentito Marino, accusatore di Sofri, Bompressi e Pietrostefani per l’uccisione del commissario Calabresi. Che siano stati i Carabinieri a parlare con lui prima e a suggerirgli poi di andare dal prete per confessare di avere partecipato all’uccisione di Calabresi, a noi non interessa. Non ci interessa stabilire se è vera la versione di Marino o se è vera la discolpa di Sofri, di Bompressi, di Pietrostefani, i quali si dichiarano estranei all’omicidio di Calabresi. A noi interessa riconfermare questa tesi: comunque siano andate le cose Calabresi era un boia dello Stato e, in qualunque modo quella pistola ebbe a funzionare, pose fine alla carriera di un boia dello Stato. Ognuno nel suo cuore, ognuno di quei tremila compagni che in quella sera nuvolosa parteciparono a quella triste cerimonia nel Cimitero Maggiore di Milano, ognuno di quei compagni può rammaricarsi di una cosa sola: di non essere stato lui personalmente a premere quel grilletto.
Ma a parte questo rammarico personale non c’è più nulla da dire, mentre, a quanto pare, nel tentativo di scolparsi, qualcosa viene detto, principalmente da Sofri – a me non sembra di avere sentito qualcosa da Pietrostefani o da Bompressi, ma evidentemente, se so che parla a nome di tutti e tre ci deve essere un accordo fra di loro – e dai comitati per la liberazione di Sofri e compagni, e questo qualcosa è discutibile, perché ripesca una mentalità generalizzata in molti ambienti di ex combattenti.
Una volta c’erano le associazioni di ex combattenti, che raccoglievano quelli che avevano fatto la guerra e portavano tutti un distintivo, lo stesso distintivo, giocavano a carte insieme, facevano gite con i pullman, zeppi di ex combattenti.
Oggi non funziona così, ma sostanzialmente la mentalità è sempre quella, quella dei vecchietti di una volta che dicevano: “la guerra è finita e allora aspetta che ti racconto cosa ho fatto durante la guerra” (minimo, ognuno di loro, aveva ammazzato cinquanta tedeschi).
Ora, gli ex combattenti di oggi fanno sostanzialmente lo stesso discorso: “La guerra è finita, conseguentemente cerchiamo di fraternizzare con quello che era il nemico di ieri; così, una volta avevo ammazzato cinquanta tedeschi, ma quando vengono i turisti tedeschi, io che ho una bottega e vendo, chessò, cartoline illustrate, ho interesse a vendere cartoline illustrate ai tedeschi”. Capite il ragionamento? Allora io che sono ex combattente della guerra mai guerreggiata realmente, che ci ha accompagnato negli ultimi vent’anni e che ho desistito perché ho pensato: “Ma a me chi me lo fa fare, dopo tutto la guerra è finita, conseguentemente il mio interesse qual è? quello di vendere le mie cartoline al Signor Cossiga, ecco qual è il mio interesse di oggi, perché il Signor Cossiga mi viene incontro, compra le mie cartoline e mi dice: tu sei un ex combattente, non ti preoccupare, ormai la guerra è finita, siamo tutti fratelli, noi qui dobbiamo costruire i futuri destini della democrazia e dello Stato italiano, che deve migliorare”.
Ecco, questo è un ragionamento che non mi ha mai convinto. Personalmente, io e tanti compagni che condividono quest’idea, siamo contro la desistenza. Non è vero che la guerra è finita. La guerra non è mai stata dichiarata da nessuno, perché non c’è nessuna carta che abbiamo firmato per dichiarare guerra al nostro nemico che è lo Stato. Quindi non c’è nessuna carta che possiamo firmare per smettere di fare guerra allo Stato, perché lo Stato esiste da sempre e finché non riusciremo ad abbatterlo nelle sue realizzazioni storiche concrete, non riusciremo mai a poter dire che la guerra l’abbiamo finita. Per noi la fine della guerra sociale significa la società libera, l’anarchia. Se c’è un Cossiga qualsiasi che mi suggerisce di smetterla, perché tanto siamo tutti fratelli e possiamo tutti andare d’accordo, per cercare di migliorarla questa società, si può essere certi che la guerra non è finita.
I comitati di difesa di Sofri e tutte le organizzazioni che cercano di recuperare forze considerevolissime, che a loro dire vennero sprecate nella lotta armata che si realizzò negli ultimi vent’anni, negli anni Settanta per essere chiaro: ecco cosa dicono: “Se la guerra è finita, che vale continuare a lottare?”. Ma la vera conclusione qual è: io smetto, smetto come singolo compagno e finisco per diventare il servo di Craxi, anzi il servo dei servi di Craxi, cioè di Martelli, perché tanto non c’è più nulla da fare. Sono finiti i tempi in cui molti scrivevano “viva Lotta Continua”. Perché io faccio questo ragionamento? Perché chi mi ascolta possa dire: “Guarda, quello lì ha smesso, allora smetto pure io”. Questo ragionamento è chiarissimo perché questa gente non solo smette, ma fa smettere gli altri, desistendo da un impegno quotidiano, politico e sociale, di trasformazione della società. Quando parlo di impegno politico intendo dire di comprensione della società, perché il concetto fondamentale di politica è quello di capire cosa sta accadendo nella realtà, che cosa sta trasformandosi nella realtà, non di politica nel senso di politica governativa. Quindi, se smetto di interessarmi di questi problemi, e ritorno nella mia piccola questione individuale, cosa costruisco attorno a me? Un’atmosfera di desistenza, tutti i miei ex compagni che cosa farebbero assieme a me se non costituire una lobby che cerca, assieme a me, di sopravvivere garantendosi a vicenda, e di sopraffare le altre idee. Ecco che cosa accade a questi poveri ragazzi. Ieri illusi di potere conquistare il mondo, di scalare il cielo, oggi racchiusi all’interno di una dimensione asfittica che cerca di sopravvivere giustificando il passato in un modo ingiustificabile, cercando di riuscire ad avanzare all’interno di quelle che sono le strutture istituzionali dello Stato. Ecco perché Cossiga rivolge loro una mano, ecco perché cerca di recuperarli.
Però gli anarchici non sono d’accordo. Non sono d’accordo col fatto che la guerra sia finita, perché non è mai cominciata, non è mai stata dichiarata. La guerra esiste da sempre con il nostro nemico di classe, col nostro nemico radicale, storicamente immodificabile, che è lo Stato. Questa guerra vogliamo condurla alla nostra maniera ancora oggi, con tutte le forze che riusciamo a mettere in campo, come ventotto anni fa quando abbiamo denunciato, la stessa sera dello scoppio della bomba di Piazza Fontana, pochi minuti dopo, poche ore dopo, con un volantino che ancora oggi, a distanza di ventotto anni è sottoscrivibile da parte di tutti gli anarchici, abbiamo denunciato che quelle bombe le aveva messe lo Stato. Erano le bombe dei padroni, le aveva messe lo Stato. Ecco perché per noi, a prescindere dalle necessità di difesa all’interno del processo di Sofri e compagni, o del tentativo di farsi rivedere o riesaminare il processo, ecco perché per noi anarchici Sofri e i suoi compagni sbagliano.
Sbagliano non nel tentare di uscire dal carcere, sbagliano per il modo in cui scelgono di uscire dal carcere, un modo – badate bene – estremamente complesso ed estremamente difficile da valutare. Apparentemente scelgono una strada coerente, quella del rifiuto della richiesta della grazia, ma sostanzialmente dicono: “Che strano tenerci in galera in una condizione in cui non ci sono più gli elementi oggettivi per tenere i rivoluzionari in galera. Una società rappacificata, perché dovrebbe tenere i rivoluzionari in galera?”
Questo è il loro ragionamento ed è un ragionamento sbagliato, perché implicitamente è ancora più grave di quello di chiedere la grazia. Perché io posso dire – ed è legittimo che io possa dirlo – “un momento, fermi, io non ce la faccio più”. Anch’io, con tutta la mia militanza di 30 anni, con tutti i miei anni di galera, anch’io ho il diritto di dire: “Io ho 60 anni, non ce la faccio più compagni, mi dispiace”. È legittimo perché siamo uomini, non siamo superuomini, non siamo dèi. Io, in quanto anarchico, desidero andare avanti, ma in quanto uomo posso sentire, ad un certo punto, la necessità di chiedere una sospensione. Ma questo vale solo per me, devo essere solo io ad accettarne le conseguenze, principalmente io e la mia coscienza. Io che, guardandomi allo specchio, finisco per dirmi: “Sei uno stronzo, non ce la fai più fisicamente”.
D’accordo questo è ammissibile perché si è uomini. Ma non posso, non debbo, sarebbe delittuoso, cercare di giustificare questa carenza dell’uomo, questa debolezza della carne, questa impossibilità fisica, mascherandola come fatto oggettivo e dire: “Siccome la guerra è finita, siccome non c’è più contro chi combattere, che continuo a fare?”. Ed ecco che così vengo a giustificare me stesso, a mettere pace nella coscienza. Non chiedo la grazia, però faccio pressioni sullo Stato perché si renda conto che è inutile, in una condizione di pacificazione, tenere i rivoluzionari dentro. Gli anarchici non fanno questo ragionamento e non facendolo vengono arrestati e portati in galera.
L’ultimo discorso che vorrei farvi è questo. La nostra situazione, nel suo complesso, ha considerevoli caratteristiche di disgregazione, sociale e produttiva. È una situazione poco comprensibile. Una formazione politica che vediamo al governo, oggi, che si presenta con alcune caratteristiche di “seconda Repubblica”, che si presenta come un governo nuovo, con idee nuove, che si presenta come il governo che la società democratica italiana aspettava da quarant’anni, che si presenta come la forza politica che avrebbe dovuto mettere riparo ai guai di mezzo secolo di strapotere mafioso della Democrazia Cristiana, questa forza politica, man mano che passano i mesi, man mano che si avanza nel tempo, delude e si rivela incapace di dare una risposta concreta capace di trasformare questa società.
Questa è la situazione in cui viviamo, questa è la situazione in cui il capitale ha utilizzato fino in fondo le energie della trasformazione produttiva precedente, sfruttando al massimo le possibilità delle nuove tecnologie, le possibilità della cosiddetta mobilità nelle fabbriche, che quindi ha distrutto la struttura della fabbrica del passato riducendo di molto i costi di produzione e che quindi ora ha più forza per potersi organizzare come metodo indiretto di sfruttamento che sta spaccando i luoghi classici dell’orario di lavoro, della lotta salariale, di un certo modo di difendersi, possibilmente anche del salario garantito. Questo aspetto, questa società, porta in sé il germe di una possibile autorganizzazione delle lotte. Cioè a dire, più si va avanti in questa strada che il capitale stesso non può più modificare, perché si è messo in una strada senza ritorno, più disgrega la medesima struttura produttiva, più la allarga nel territorio, più rende possibile oggettivamente una formazione di nuovi nuclei, di nuove strutture, di nuove forme autogestite della lotta impensabili, o comunque realizzabili con grande difficoltà, in una società produttiva come quella del passato, fondata sulla fabbrica, concentrata nei luoghi di lavoro.
Ecco il nuovo concetto che deve cominciare a farsi spazio fra di noi, quello di una disgregazione apparente, perché per lo Stato non è disgregazione reale ma è ristrutturazione, ricompattazione sotto forma decentrata, formazione in maniera diversa del controllo produttivo. All’interno di questo controllo produttivo entreranno nei prossimi anni anche le forze del consumo, consumatori e produttori si uniranno insieme, saranno la stessa cosa. Ora, in questa realtà profondamente trasformata, in corso di veloce e sempre nuova trasformazione, sarà possibile la realizzazione di lotte autogestite, di lotte che hanno una caratteristica essenziale di autorganizzazione. Così gli anarchici tornano ad essere pericolosi un’altra volta.
Lo Stato ragiona in modo molto semplice: questo tipo di struttura, così come si va configurando, per come si svilupperà nei prossimi decenni, andrà ineluttabilmente a manifestare delle forze e delle forme autogestite. Vedete, dappertutto ce ne sono i segni: ad esempio i Cobas, sotto certi aspetti, manifestano e sono tentativi di recupero e di controllo di queste forze di autorganizzazione, che cercano di recuperare attraverso un tentativo di controllo periferico e marginale. Ma sono molti i modi attraverso i quali ci si può organizzare in maniera autogestita. Lo Stato lo sa, e sa anche che i depositari storici sono gli anarchici, sa che la memoria tradizionale che esiste da sempre all’interno della società è costituita dal movimento anarchico, è costituita dagli anarchici, i quali sono stati quelli che hanno realizzato nel pensiero e nella pratica questa autorganizzazione delle lotte.
Ecco perché gli anarchici tornano ad essere un’altra volta responsabili, ecco perché un anno fa siamo stati incriminati, cinquanta, sessanta o forse più compagni anarchici in tutta l’Italia. Ancora la maggior parte sono in carcere. Io sono uscito per una questione puramente burocratica, contrasto fra la Cassazione e la Pubblica Accusa, una questione di date che non so bene spiegarvi. Sono uscito sotto questa particolare condizione, non perché ritenuto innocente delle accuse che ci sono state rivolte.
Ma perché siamo al centro di questa attenzione, perché gli anarchici vengono arrestati anche adesso, non nel 1969 soltanto? Perché nel 1996 vengono ancora arrestati in massa? Perché continuano ancora a fare paura?
Continuano a fare paura perché costituiscono il punto di riferimento essenziale nel caso in cui gli sfruttati, spontaneamente, per i fatti propri, seguendo lo sviluppo di quelle contraddizioni produttive e sociali che possono svilupparsi al di fuori della prevedibilità del capitale, decidessero di insorgere autorganizzandosi. In quel caso noi saremmo fra loro, saremmo fra coloro che insorgendo danno vita a determinate realizzazioni di lotta provviste di una speciale capacità intrinseca, quella tipica del movimento autorganizzato, di esprimersi direttamente contro lo Stato, non di chiedere soltanto la banale riforma di un miglioramento salariale, di un miglioramento delle condizioni di lavoro, ma di chiedere questo e contemporaneamente tutto il resto in una volta, o di chiedere tutto e contemporaneamente la riforma parziale.
Per questa caratteristica particolare di autorganizzazione, che si incomincia nebulosamente a far vedere all’interno delle stesse contraddizioni che vengono fuori dalle ristrutturazioni del capitale, sono gli anarchici che possono costituire un punto di riferimento. Ecco perché gli anarchici fanno paura, ecco perché la società li considera elemento sovversivo per eccellenza.
Ecco perché siamo accusati di avere costituito una banda armata, una banda armata che non è mai esistita, perché non abbiamo costituito una banda armata secondo la caratteristica voluta dalla mentalità di regime, per come loro sono stati abituati a considerare le bande armate del passato – ricordiamo, per intenderci, per fare un esempio, la banda armata chiamata “Brigate Rosse”. Noi non abbiamo mai costituito una banda armata. Noi abbiamo costituito da sempre la coscienza armata contro lo Stato. Noi costituiamo, da sempre, la forza reale armata radicalmente, sovversivamente, in lotta contro lo Stato. Questo è il nostro essere “banda armata”, questo è il nostro essere “associazione sovversiva”, questo è il nostro essere associazione contro lo Stato. Ci associamo, ci mettiamo insieme, cerchiamo di conoscerci sulla base delle reciproche affinità, sulla reciproca conoscenza, sul reciproco approfondimento personale, per combattere contro lo Stato. Questo lo Stato lo sa ed è per questo che, a distanza di ventotto anni, con tutte le vicende che sono nel frattempo passate, con tutte le novità che si sono verificate all’interno delle strutture produttive del capitale, ci considera ancora oggi il suo nemico principale ed ecco perché continua ad arrestarci e a cercare di farci restare quanto più possibile in carcere.
Ma noi, ancora una volta, continuiamo a sviluppare il nostro ragionamento. Anarchismo vuol dire lotta per la libertà. Non per alcune libertà, non per la libertà di parola, per la libertà di locomozione, per la libertà di scelta del luogo dove abitare, ma per la libertà. Il concetto di libertà significa libertà assoluta, libertà totale, libertà senza alcun aggettivo. Noi non siamo quelle forze politiche che lottano per le libertà, non siamo esponenti di una società democratica che cerca di approfondire, di migliorare, di far crescere le libertà di cui la società gode. Noi siamo per la richiesta immediata dell’abolizione dello Stato, noi siamo per la libertà. Ecco perché facciamo paura.
[Comizio tenuto la sera del 12 dicembre 1997 in piazza delle Due torri a Bologna. Trascrizione della registrazione su nastro]
La faccenda Calabresi
I recenti arresti [1988] di ex di Lotta Continua imputati dell’uccisione del commissario Calabresi mi fanno ricordare quegli anni in cui quasi tutti i compagni furono toccati, in senso positivo, da quell’azione. Oggi molte cose sono cambiate. Sono pochi coloro che considerano quel fatto come una giusta e lodevole messa a punto.
Dopo sedici anni, ecco che la magistratura italiana, notoriamente poco solerte nei confronti dei grandi criminali di Stato e dei grandi mafiosi, tira fuori la carta vincente dichiarando di sapere chi ha ucciso Calabresi, e come è stato ucciso.
I compagni ricorderanno che nel maggio del 1972 qualcuno stese il “commissario Finestra” davanti al portone di casa sua. Adesso c’è un “pentito” che indica chi fu l’esecutore materiale del fatto e chi furono i mandanti.
Nell’ottica gerarchica della magistratura le cose collimano perfettamente. I mandanti non possono essere che coloro i quali, all’epoca, figuravano al vertice dell’organigramma dell’organizzazione politica che si chiamava “Lotta Continua”. Gli esecutori, non possono essere che compagni di rango meno elevato. Tutto ben congegnato. Il pentito di turno conferma – si badi bene solo dopo che sono passati esattamente gli anni necessari ad uscire per prescrizione di quanto poteva essergli addebitato – e non ha poi molta importanza che gli arrestati neghino tutto.
Ma chi scrive si ricorda benissimo del clima di quei momenti, quando si diffuse la notizia dell’uccisione del commissario. Anche in una piccola città del profondo Sud, dove mi trovavo, tutti i compagni furono, immediatamente e spontaneamente, contenti di apprendere la notizia che l’uccisore di Pinelli, finalmente, aveva trovato qualcuno che facesse al caso suo. Adesso, con il raddolcirsi dei cuori e il trascorrere del tempo, ci si sorprende di quella spontanea adesione, e se ne prova quasi vergogna. Veramente questa rapida (e meno rapida) conversione sulla via di Damasco non è valida per il sottoscritto, ma sento di non essere in numerosa compagnia.
Cosa volete, non so che farci. A distanza di tanti anni sono ancora oggi, fermamente, appassionatamente, convinto che chi ha ucciso Calabresi ha fatto una giusta e lodevole cosa.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 16, settembre 1988, p. 1]
Ma chi uccise Pinelli?
Non è certo una cosa eccezionale che negli uffici delle questure si usino metodi di convincimento talmente radicali da causare, non poche volte, il decesso di coloro che vi vengono sottoposti.
Recentemente [1988] a Padova, dove il triste rito si è ripetuto a distanza di pochi mesi, ed anche in altri posti, nelle caserme dei carabinieri.
Ciò non contando il sistematico impiego delle torture, di ogni grado, che allegramente vengono mantenute in piedi nella patria di Beccaria e Verri, mentre tutto il mondo dei pecoroni progressisti applaude alle riforme del codice e delle procedure.
In tale situazione, cosa c’è stato di particolare nel fatto che Pinelli sia stato ucciso il 16 dicembre del 1969, negli uffici della questura di Milano? Un caso fra i tanti.
Eppure quel caso ebbe qualcosa di particolare. Non perché si trattasse di un anarchico. Cosa potevano fare gli altri anarchici, quelli dissoltisi come neve al sole dopo la provocazione di piazza Fontana, e quei pochi rimasti? Non molto. Sì, fecero molto, poco dopo, coinvolgendosi in un movimento d’opinione che per interessi politici veniva sostenuto anche dai partiti della sinistra. Ma, quella sera, non costituivano di certo una preoccupazione per i responsabili milanesi dell’ordine pubblico.
Pinelli venne ucciso, quindi, e il suo suicidio montato con tanta premura da risultare assurdo e approssimativo, come sembra ormai certo, non tanto per la preoccupazione di quello che sarebbe successo dopo, quanto per coprire quello che era già successo. Occorreva indirizzare l’attenzione pubblica verso gli anarchici. I semplici arresti di Valpreda e compagni non bastavano, occorreva qualcosa di più. E Pinelli venne sacrificato, nella fretta del momento, a questa prospettiva indecorosa. Coprire i misfatti di già portati a compimento. Coprire i fascisti. Coprire i servizi segreti.
I progressisti di oggi, troveranno il coraggio e le attenuanti prodotte dal tempo, per arrivare ad un chiarimento, se non definitivo, almeno parziale? Ne dubitiamo.
Calabresi fece il suo lavoro. Lo chiamavano “commissario Finestra”, perché faceva sedere gli inquisiti sul davanzale della finestra della propria stanza – come ebbe a confermare Braschi più tardi (mesi prima della morte di Pinelli) – sollecitandoli a buttarsi di sotto. Si tratta di una esperienza non proprio facile da affrontare per chi si trova in una situazione di tortura fisica e psicologica che dura da giorni.
Non c’è dubbio che i poliziotti presenti, anche soltanto tramite gli esponenti dei servizi segreti, sapessero bene il pericolo che correvano per quanto era stato fatto a piazza Fontana. Ciò non può non averli consigliati malamente. Un cattivo consiglio che venne subito accettato dalla loro coscienza di assassini a pagamento.
Adesso, sull’onda degli arresti di Sofri, Pietrostefani e Bompressi si parla molto di Calabresi e dell’uccisione di Pinelli. Ma nessuno si chiede veramente perché venne ucciso e da chi. Ma gli imbrogli, le false dichiarazioni, i ricatti e le miserie che stanno a fondo di tutto l’affaire della strage di Milano, nessuno ha voglia di chiarirli e quindi tutti sono d’accordo a dimenticare Pinelli.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 16, settembre 1988, p. 1]
Un’auto a Milano
Nel sole caldissimo di un pomeriggio di metà agosto [1988], qualcuno ha lasciato in sosta sotto la Questura di Milano una macchina con un potente meccanismo esplosivo, tale che se tutto fosse funzionato a dovere – a detta degli stessi inquirenti – sarebbe venuto giù tutto il palazzo di via Fatebenefratelli che ospita la polizia.
Di tutto quello che si è letto nei giornali, si è ricavata l’impressione – e con noi devono essere stati in tanti ad averla – che la polizia e la magistratura non sanno dove andare. Ad ogni notizia è sempre corrisposta una smentita, o un silenzio imbarazzato, o una notizia antitetica che in sostanza negava la precedente. Si ha l’impressione che quella macchina sia andata da sola sotto il culo di Improta e consoci.
Non che la cosa ci faccia piangere per il pericolo corso dai nostri tanto amati tutori dell’ordine, ma resta il fatto, incredibile, che ciò possa accadere sotto il naso di quelle strutture che vengono presentate come efficienti al massimo e che invece fondano la propria efficienza soltanto sulle delazioni e sulla brutale violenza repressiva.
Fra le diverse rivendicazioni, per quello che dai giornali si è riuscito a capire, ne emerge una in cui si fa riferimento al caso Calabresi, agli arresti a questo collegati, a Pinelli e all’uccisione di quest’ultimo da parte di quei poliziotti che si trovavano allora nella stanza di Calabresi durante il cosiddetto interrogatorio di Pinelli. Questo documento, da quello che ci pare di capire (essendo costretti a ricavarne il senso dagli avari brani riportati dai giornalisti che, come sappiamo, non sono monumenti di correttezza nella pubblicazione di quello che non gradiscono), afferma che ad uccidere Calabresi è stata la coscienza collettiva di un gran numero di compagni.
Comunque siano andate le cose, e quali che siano le intenzioni degli estensori del documento, resta il fatto che qualcuno ha fatto passare dei brutti momenti ai responsabili della questura di Milano. Noi siamo sempre stati piuttosto restii ad avanzare ipotesi basate su quella scienza facile che è la dietrologia. Per questo motivo non sappiamo quanto ci sia di vero nelle dichiarazioni di Improta, che parla di servizi segreti, o in quelle di Parisi che parla di congiure a suo danno. Certo sarebbe molto strano se si scoprisse (ma quando mai in Italia si scoprono realmente le cose – Cirillo docet) che le lotte di palazzo adesso non si fanno più con i siluramenti e le dimissioni, con le bustarelle e i documenti trafugati, ma si fanno a colpi di bombe.
Quello che sappiamo per certo, al di là di ipotesi fantasiose e inutili, è che in un caldissimo pomeriggio di metà agosto, qualcuno ha lasciato in sosta sotto la Questura di Milano una macchina con un potente meccanismo esplosivo. E tanto basta.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 16, settembre 1988, p. 10]
Perché ingigantire le forze dell’avversario?
Subito dopo l’uccisione di Pinelli nei locali della Questura di Milano, e il suo volo dalla finestra della stanza del commissario Calabresi, si generalizzò nell’animo di molti compagni, non solo anarchici, la convinzione che lo Stato non sarebbe mai venuto a capo di una poco probabile ricerca dei colpevoli.
Ci si convinse subito che la morte di Pinelli sarebbe rimasta un altro misfatto dello Stato come a suo tempo lo fu quello di Salsedo in America, al di là dell’incredibile somiglianza dei fatti.
Qualche anno dopo, precisamente nel maggio del 1972, il commissario Calabresi venne ucciso davanti alla propria abitazione, a Milano, con alcuni colpi di pistola.
Questo fatto si collegò, nell’animo dei compagni, all’uccisione di Pinelli. Una giusta punizione per il maggiore responsabile di quella morte. Una cosa giusta, si pensò allora, ed in molti.
Poi cominciarono le chiacchiere. Si diffuse la mania dei distinguo, delle supposizioni politiche. Si pensò che potevano essere i servizi segreti, in quanto il commissario sapeva troppo sulla strage di Milano. Si pensò che potevano essere stati i fascisti.
Addirittura alcuni compagni dettagliarono moltissimo quest’ultima ipotesi, come Stuart Christie, che nel suo libro inglese su Stefano Delle Chiaie parla del fatto – dandolo come certo – che il commissario Calabresi venne ucciso dai fascisti.
In effetti noi non siamo certi che a stendere Calabresi siano stati i compagni. Quello che possiamo affermare con certezza è che al funerale di Pinelli c’erano moltissimi compagni e che tutti, in un modo più o meno cosciente, desiderarono in cuor loro la morte di Calabresi.
Si può naturalmente ammettere che è diverso il desiderare una cosa, dal poterla fare. Ed è vero, ma non bisogna troppo diminuire le possibilità del movimento rivoluzionario, accreditando tutte le forze alla reazione e allo Stato.
Anche i rivoluzionari possono fare qualcosa, e spesso la fanno. Purtroppo c’è in molti compagni la mania, quasi masochista, di ingigantire le forze avverse, di affermare che ormai la perfezione della macchina poliziesca e statale in genere è tale che le nostre possibilità sono rimaste davvero poche.
Contro questo modo di ingigantire il nemico bisogna affermare che se è giusto conoscere l’avversario, studiandone le possibilità e i mezzi, non bisogna per questo trasformarlo in una macchina onnipotente contro cui c’è ben poco da fare.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 16, settembre 1988, p. 5, come “Nota redazionale” all’articolo: “Pinelli è stato ucciso. Calabresi anche”, a firma Antonio Gizzo]
Una mattinata a Milano, tanti anni fa
Tre colpi di pistola, e Calabresi, il commissario dell’Ufficio politico della questura di Milano, responsabile della morte dell’anarchico Pinelli, viene ucciso all’uscita della propria abitazione.
Da quella mattinata di maggio di moltissimi anni fa, sono state fatte illazioni e ipotesi, si sono seguite piste e sono stati condotti processi. Pentiti più o meno fantasiosi si sono fatti avanti a dire la loro. Perfino un pentito col sigillo della verosimiglianza ci ha raccontato come lui stesso fosse presente all’appuntamento quella mattina nella via dove Calabresi ebbe a concludere la sua poco gloriosa carriera. Solo che questo signore non è risultato convincente, o almeno non è riuscito a convincere i giudici, che per ogni poliziotto, d’elezione o di professione, è lo scopo massimo da raggiungere nella vita.
Adesso [novembre 1994] la Corte di Cassazione ci riprova. Il processo torna alla terza Corte d’Appello di Milano, e la messa in scena continuerà. Ascolteremo ancora la “verità” di Marino, cui importa soltanto che i suoi ex compagni vengano condannati, le “proteste” della moglie del commissario, cui importa soltanto il buon nome del marito, le ricostruzioni tecniche di possibilità o impossibilità del fatto, per come emerge dalla ricostruzione del pentito, fatte da giudici e avvocati, cui importa, a seconda del rispettivo ruolo, che gli accusati vengano condannati o assolti.
E di Pinelli? E dell’uccisione a freddo nella stanza di Calabresi alla Questura centrale di Milano? E delle responsabilità di Calabresi e degli altri uomini d’ordine presenti in quella stanza? E del ruolo del capitano La Bruna, successivamente riconosciuto e condannato come golpista e piduista? E dello sport preferito del bravo commissario che anche ad un altro nostro compagno, qualche mese prima della fine di Pinelli, aveva fatto alla medesima finestra lo scherzo del davanzale?
Ci fanno veramente star male i tentativi, dopo ventidue anni, di rimettere in piedi la figura del bravo commissario ucciso mentre compiva il suo dovere. Calabresi era uno degli uomini più feroci e spietati che esercitavano il mestiere più schifoso del mondo. Aveva perfezionato il suo stile e le sue capacità professionali in America, in quei centri della CIA che tanti benefici hanno sparso dappertutto. All’epoca ce lo ricordiamo come il fiore all’occhiello della peggiore repressione. Il fascista Guida, uomo del passato regime, riciclato ma non troppo nell’àmbito delle protezioni democristiane, aveva voluto Calabresi con sé ad un posto di responsabilità, proprio per le idee politiche ultradestre di quest’ultimo e per la sua vasta esperienza delle strategie americane di tensione sociale. Di un uomo del genere, perfino il ricordo dovrebbe essere spiacevole per il potere. Ma i tempi cambiano e potremmo vedere canonizzazioni in altri momenti impossibili.
[Pubblicato su “Canenero” n. 2, 4 novembre 1994, p. 2]
“Giustizia proletaria”
Su “Provocazione” [n. 24, giugno 1990] è stato pubblicato un articolo dal titolo “Un atto di guerra sociale non abbisogna di giustificazione” (*) in cui un compagno sviluppa una critica approfondita del concetto e del termine “giustizia proletaria”, rifacendosi ad alcuni documenti di “Azione Rivoluzionaria” ripubblicati sul n. 22 [novembre 1989] dello stesso giornale a proposito del caso Mammoli e di alcune amenità pubblicate in una lettera dei compagni della Biblioteca Serantini di Pisa.
Non c’è da dire nulla sul fatto che il termine “giustizia proletaria” oltre che discutibile oggi appare anche datato. Infatti, io stesso nel riportare i documenti di “Azione Rivoluzionaria”, in un articolo pubblicato a fianco, a firma “un compagno siciliano”, avevo precisato di tenere conto del tempo passato dall’esperienza dei compagni di “Azione Rivoluzionaria” e delle posizioni espresse da questa organizzazione.
Comunque, pur con tutti i suoi limiti, a me sembra che il termine resta lo stesso utilizzabile, e ciò perché non corrisponde al concetto della pura e semplice vendetta.
Il concetto di “giustizia proletaria”, in merito al quale le maggiori perplessità vertono sul termine “proletaria” e non su quello di “giustizia”, contiene in sé, come una dimensione più piccola e quasi marginale, l’ipotesi della vendetta, giustamente sentimento umano di tutto valore. La giustizia proletaria è invece qualcosa di più ampio e che solo in condizioni non rivoluzionarie può essere mimata (e quindi in piccolissima parte realizzata) da organizzazioni specifiche o da singoli individui, finendo spesso per apparire vendetta compensativa e null’altro.
Io mi sono più volte affaticato nell’arco degli ultimi vent’anni nel cercare di spiegare questo concetto, col risultato non solo di non essere stato in grado di chiarirlo, ma di essere stato superato dalla critica ben più corrosiva del tempo, che ha finito per polverizzare i contenuti di cui una volta si vestiva il termine “proletario”.
Meglio così. Mi tocca tornare sull’argomento e lo faccio volentieri. Se si fosse trattato di dare un nome nuovo e magari ideologicamente protetto, non avrei mai fatto ricorso, come appunto un ventennio fa, al concetto di “giustizia proletaria”, bastava presentare il concetto di attacco contro i responsabili dello sfruttamento. Ma lo scopo era, e resta, più ambizioso. E, in un certo senso, alcuni critici hanno capito lo scopo, accusandomi di volere insinuare, all’interno di un’analisi antideterminista, quale è sempre stata la mia, un elemento determinista, cioè che cammina da solo. Naturalmente anche questa obiezione non ha fondamento.
Col concetto di “giustizia proletaria” si dovrebbe intendere, a mio avviso, e penso di esprimere il pensiero di non pochi compagni su questo argomento, l’insieme di quelle manifestazioni che in un determinato momento sociale cominciano ad assumere sviluppi via via sempre più consistenti, tutti omogeneamente diretti ad attaccare individui e cose responsabili dello sfruttamento. Solo quando queste azioni si sviluppano qualitativamente (scelta degli obiettivi) e quantitativamente (numero degli obiettivi raggiunti), esse riassumono al proprio interno anche le azioni realizzate da una minoranza agente, oppure da singoli individui, aventi medesimo scopo e identiche motivazioni. Si può vedere così, in atto, un movimento attivo che realizza azioni in un modo sempre più organico, anche senza darsi un’organizzazione specifica e senza aderire a precise identità ideologiche. C’è, in certi momenti storici e in determinate condizioni sociali ed economiche, un reciproco riconoscimento di cause ed effetti che va al di là della sigla o dello schieramento ideologico, per congiungersi nell’azione pratica contro individui e cose responsabili dello sfruttamento.
Quando dall’azione realizzata dall’organizzazione specifica o dal singolo individuo cosciente si passa a questo movimento capace di darsi un proprio autonomo contenuto, non è possibile dire. In genere è facile arrivare a conclusioni (esatte o sbagliate) solo a posteriori. Per cui ci si accorge che magari movimenti autonomi di “giustizia proletaria” sono realmente esistiti e non ce ne siamo accorti, mentre abbiamo sostenuto la presenza di movimenti del genere quando non c’erano altro che azioni (più o meno numerose) di individui singoli o organizzazioni specifiche.
Ciò è compreso nel rischio di chi si prospetta un progetto organizzativo rivoluzionario, sia nell’àmbito delle azioni minoritarie d’attacco, sia nell’àmbito di progetti aventi un più vasto raggio d’azione (indicazione pratica di possibili obiettivi di lotta, sabotaggi, attacchi a obiettivi differenziati, ad esempio produzione-informazione, ecc.). Si comincia pensando di contribuire a determinare un movimento, ma non si è mai sicuri del momento in cui questo movimento si mette in moto, anche perché è il movimento che una volta innestato trascina e sconvolge qualsiasi progetto rivoluzionario (fino a renderlo inintelligibile agli stessi realizzatori).
Francamente non so quanto dell’idea di giustizia (e ancor meno dell’idea di proletariato, che come identificazione di strato di classe è ancora più soggetta a modificazioni storiche) sia coglibile realmente nell’azione di singoli o gruppi organizzati in modo specifico. Si tratta di aspirazioni che ognuno concreta secondo le proprie idee, il proprio carattere, i propri desideri ed anche secondo i propri limiti. Si possono fissare i limiti al di là dei quali non si può andare senza sacrificare il concetto di giustizia al semplice piacere della soddisfazione personale (da cui la vendetta ovviamente non può dissociarsi), oppure senza far scomparire quella contrapposizione di classe che è sempre guida indispensabile per identificare i responsabili (uomini in carne e ossa) dello sfruttamento. I limiti e le valutazioni differiscono nel tempo, si modificano, così come le terminologie, ma le responsabilità e le appartenenze di classe restano. Ed è anche all’interno di queste fluttuazioni che si può cogliere il fondamento morale della giustizia proletaria, anche se oggi sarebbe forse meglio trovare un’altra definizione, purché con il problema linguistico non venga anche travolto il problema ben più solido dei contenuti.
Penso che ogni contributo in questa direzione sia accettabile, purché si faccia salvo lo scrupolo di sapere con esattezza di cosa si parla.
(*) Ecco la parte essenziale dell’articolo: “Un atto di guerra sociale non abbisogna di giustificazione”, pubblicato a p. 13 del citato numero di “Provocazione”, a firma: Un compagno.
«Ho sempre provato una forte antipatia per questo termine (tra l’altro, spero ne converrete, decisamente ambiguo) di “giustizia proletaria”, il cui senso mi è sempre sfuggito. O meglio, capisco benissimo il suo senso in bocca ad un comunista, meno bene quando a parlarne è un anarchico.
«Secondo il mio modesto avviso, definire il ferimento di Mammoli un atto di giustizia proletaria significa dare a questa azione una razionalizzazione di cui non ha bisogno e che non ha senso di esistere. Che degli sbirri uccidano un rivoluzionario e che la giustizia “borghese” non li “punisca”, sono cose che non dovrebbero coglierci di sorpresa, né farci traboccare di sdegno: sappiamo bene quali rischi corra un rivoluzionario. Non dovrebbe meravigliare nessuno neanche che dei compagni rispondano abbattendo dei poliziotti o, come nel caso di Serantini, ferendo Mammoli [il medico del carcere di Pisa, responsabile di avere lasciato morire Serantini dopo che quest’ultimo era stato picchiato a morte dalla polizia sul Lungarno]. In tutto ciò io non riesco a vedere da nessuna parte la giustizia proletaria, ma solo degli episodi di guerra sociale.
«In una guerra le due forze contrapposte combattono, attaccando e difendendosi, senza perdersi in disquisizioni sulla giustizia e sulla sua natura.
«Il mio timore è che l’uso del concetto di giustizia proletaria serva soprattutto come giustificazione (non necessaria, del resto) e come tentativo di esorcizzare lo spettro della vendetta, sentimento da tutti esecrato perché ritenuto “poco nobile” (ma tanto umano, aggiungerei io). Forse, che sparare alle gambe di Mammoli (o in testa a Calabresi) è un’azione che va approvata se fatta in nome della giustizia proletaria, e va rifiutata se compiuta assecondando un basso istinto di vendetta? O forse la giustizia proletaria si ha quando si ripara ad un “torto” subito? Ed il torto quale sarebbe, il fatto che Serantini fosse “innocente”?
«Forse che, nel caso Serantini fosse ancora in vita, Mammoli non si sarebbe “meritato” un buco nelle gambe? E Calabresi, lo odiamo solo perché responsabile della morte di Pinelli? Altrimenti non sarebbe stato che un normale commissario di polizia...
«Potrei andare avanti per un bel pezzo, ma rimarrei sempre con lo stesso interrogativo: cosa diavolo c’entra la “giustizia proletaria”?».
[Pubblicato su “Provocazione” n. 26, febbraio 1991, p. 16]
Unite nel dolore
Lo Stato ha istituito una giornata dedicata alla commemorazione dei caduti in servizio istituzionale. Noi non lo sapevamo. Lo abbiamo appreso solo ora in quanto le cronache riportano, con la compunzione del caso, il fatto che la sorella del giudice Falcone, ucciso dalla mafia con tutta la scorta, come ormai anche le pietre di Capaci sanno a memoria, è stata madrina della dodicesima edizione.
Il dolore della signora per la morte del fratello Giovanni, questa volta ha trovato conforto nell’altro dolore, quello della vedova del commissario Calabresi, Gemma Capra, la quale in occasione della suddetta giornata di commemorazione ha consegnato il premio “Luigi Calabresi” per il 1994. Questo premio, intestato al famoso commissario ucciso a Milano nel maggio del 1972, è stato creato per premiare atti di valore e sacrifici compiuti da funzionari dello Stato nell’assolvere al proprio dovere.
Questa volta la signora Gemma, insieme all’inconsolabile sorella del giudice Falcone, si sono unite per consegnare il premio all’agente di polizia Nicola Cinquepalmi il quale, fuori servizio, si era distinto arrestando dopo violenta e pericolosa colluttazione, un pericoloso pregiudicato armato di pistola.
Chissà se l’uccisione dell’anarchico Pinelli potrà essere vista, a distanza di tempo e di clamori ideologici, come un atto valoroso, tale da vedere assegnato questo premio alla memoria al commissario Calabresi? In questo modo, i soldi resterebbero in famiglia, cosa che oggi potrebbe tornare utile agli eredi del mai sufficientemente compianto commissario al di sopra di ogni sospetto.
[Pubblicato su “Canenero” n. 27, 19 maggio 1995, p. 9]
Peggio della polizia
Adriano Sofri da qualche mese [1995] è corrispondete di guerra per “L’Unità”.
Scrive da Sarajevo. Fin qui la notizia non desta nessun interesse. Come molti altri ex Lotta Continua, Sofri sta lavorando nel settore dell’informazione. Come Erri De Luca, come il direttore di Italia 1 di cui non mette conto citare il nome. E di lì, andando in giù, molti “continuisti” hanno continuato fornendo i loro apprezzati servigi un po’ dappertutto, per cui è possibile trovarli adesso dentro le industrie (non mancano, come Pietrostefani, direttori generali di questa specie), nelle banche, nei giornali e, com’è ovvio, nelle case editrici o nelle televisioni di Stato e no.
Ma Sofri è caso a sé. Non si limita a fare quello che fa e ci mette una pietra sopra. No, insiste nello spiegare ragioni e motivi che lo spingono a fare quello che fa oggi. Ecco: questa scelta, chiacchierona e querula, scelta di scuse non richieste, ci ricorda molto da vicino quella di tanti altri, della specie collaterale se non omologa dei “partito-armatisti” che spiegavano le proprie scelte disarmiste, col ritornello che la rivoluzione era finita, che quindi bisognava fare altro con altre armi.
Sofri raccoglie adesso i dolori e le sofferenze (queste reali) di un popolo che affronta uno dei momenti peggiori della propria storia, quello della guerra civile, e lo fa da “corrispondente di guerra”, cioè svolgendo uno dei mestieri più infami che sia possibile immaginare, parallelo, se non al di sotto (che riusciamo con difficoltà a immaginare qualcosa al di sotto) del mestiere del poliziotto. Acquattato all’interno della propria fede nelle parole, scrive di quelle sofferenze e di quei dolori, e invia le sue telefonate e i suoi fax ad un giornalaccio come “L’Unità”. Non che il suo collega Erri faccia di meglio, il “Corriere della sera” non è certo meno puzzolente, ma se non altro ha parlato da sempre la lingua dei padroni, mentre “L’Unità” continua a balbettare a favore di una nuova casta di padroni che non si decide a prendere il campo.
Ecco quindi che Veltroni gli consente tiratacce su che cosa oggi significa per l’Italia l’esperienza della Bosnia, o sul ruolo del nazional-comunismo dei Serbi, che magari Mieli gli avrebbe risparmiato.
Il pudore non è mai stato l’elemento forte degli sbrodoloni continuisti.
[Pubblicato su “Canenero” n. 28, 26 maggio 1995, p. 2]
La Uno bianca sempre più nera
Erano poliziotti i responsabili dei fatti che i giornali sinteticamente chiamano della “Uno bianca”. Uccisioni a sangue freddo caratterizzavano le loro imprese. Quando non uccidevano extracomunitari, ripiegavano su impiegati, benzinai e carabinieri. Adesso, dopo i primi arresti, che forse continueranno, i responsabili del Ministero e della direzione di Polizia fanno dichiarazioni per tranquillizzare la gente.
Molti infatti s’interrogano: ma com’è possibile? Com’è possibile che tutori dell’ordine, essi stessi, siano feroci assassini? Non dovrebbero invece essere scelti per la propria integerrima condotta e per il disinteresse che la professione richiede? Domande stupide, si potrebbe rispondere, ma che sono in tanti a porsi.
Adesso si profila l’ombra lunga dei servizi segreti. La “Falange armata”, più volte sentitasi in questi ultimi anni con rivendicazioni di destra, appare come possibile prolungamento “politico” di questa banda di poliziotti.
Poiché la vicenda è di notevole interesse e non sembra si possa considerare esaurita in quello che i giornali hanno scritto fino ad oggi [1994], per il momento ci limitiamo a poche considerazioni che però riteniamo importanti. Gli arrestati sono poliziotti. La polizia è violenta, per mestiere e per scelta, ma prima di tutto per ideologia. La quasi totalità dei poliziotti, specialmente la fascia più efficiente e determinata, sposa un’ideologia giustiziera di destra, si alimenta del mito dell’uomo salvatore della patria, non si veste che apparentemente dei panni democratici che le fasce più insignificanti della stessa struttura pensano reali e concreti. Non desta meraviglia che persone del genere, massacratori per gusto e passatempo, appartengano alla polizia. Nessuna dolce parolina del ministero potrà cancellare questa situazione.
I poliziotti sono al servizio delle autorità in carica. Se queste dovessero prendere la strada della dittatura fascista, come è accaduto in altri tempi e altri luoghi, non batterebbero ciglio: si limiterebbero a cambiare padrone. Gente del genere, non avendo una moralità propria, cioè derivante da una riflessione sulla propria realtà di vita e sulla propria funzione repressiva, raccoglie facilmente un’idealità fittizia com’è quella che la destra fabbrica a suo piacimento: idealità fondata sulla necessità del potere, sul mito del giustiziere che spara per primo e così via.
Per una volta, improvvisamente, la polizia ha scoperto il suo vero volto, lo stesso che è possibile vedere nei manuali interni dati in mano per studio agli allievi poliziotti.
Le cose potrebbero complicarsi. Potrebbero entrare nella faccenda i servizi segreti e altre strutture dello Stato, ma si tratterebbe dello stesso problema. La Polizia, nelle considerazioni che precedono, personifica le forze repressive in genere, e quindi le singole persone che le costituiscono. I carabinieri, i finanzieri, fino alla più ignota guardia campestre, albergano dentro di loro questa ideologia giustizialista. Se da un lato l’entrata di nuovi scenari (segreti, per il momento) potrebbe far divenire più succosa e interessante la vicenda della Uno bianca, da un altro non sposterebbe il problema. Abbiamo dei custodi. Chi ci garantirà contro di loro? Evidentemente nessuno, se non provvediamo da noi stessi.
[Pubblicato su “Canenero” n. 6, 2 dicembre 1994, p. 4]
È calato il silenzio sul terrorismo di Stato
Com’era prevedibile, non si parla più dei poliziotti della questura di Bologna, arrestati qualche settimana fa e accusati di omicidi e rapine. Il motivo dominante di questa banda di assassini in divisa è stato la costanza del ricorso alle sparatorie e alle uccisioni. Spesso, nei metodi impiegati, appariva chiaramente l’intenzione di fare paura, di diffondere il terrore. In maniera evidente, è apparso il vero volto terroristico, quello dello Stato, quello appunto che non riesce più a nascondersi nelle pratiche repressive indirette e si manifesta nella pura intenzione del terrore.
Di più. Questa volta il terrore è stato gestito ricorrendo ad azioni di minore dimensione, appartenenti ad una tipologia del “crimine” cui la gente comune ha ormai fatto l’abitudine. Non si è fatto ricorso alle bombe sui treni o nelle grandi banche, non ci troviamo davanti all’Italicus o a piazza Fontana, siamo nel centro proprio della vita quotidiana dell’uomo dabbene, del pensionato e dell’impiegato di banca. A costoro è stato proposto il più efficace modello del terrore, quello che colpisce per il semplice scopo di mettere paura, e colpisce non nella distanza siderale dell’atto clamoroso, ma nelle piccole situazioni di tutti i giorni.
Per la prima volta siamo di fronte al volto glaciale di veri terroristi, uomini della polizia che hanno scelto, o sono stati consigliati a scegliere, la strada del terrore, per ricacciare indietro i fantasmi dell’inquinamento razzista, del dilagare della promiscuità razziale (forse sono stati questi i simboli tristi suggeriti da occulti persuasori per spingerli ai loro atti di terrore). Per la prima volta abbiamo la prova fisica della nostra tesi di sempre, che il solo terrorista è lo Stato, tesi che adesso vediamo venire fuori dall’astrattezza dell’istituzione senza nome per identificarsi nella faccia senza espressione di uomini della legge e dell’ordine.
Forse per la prima volta, almeno in anni recenti, ci troviamo di fronte ad una strategia che lo Stato potrebbe sviluppare su larga scala nell’eventualità di disordini sociali. Il modello, storicamente identificabile con certezza, è di certo quello dell’OAS, agente per tutta la guerra d’Algeria e impiegato sistematicamente dai servizi segreti francesi. Altri progetti del genere sono stati impiegati per determinare lo scatenarsi della guerra civile nella ex Jugoslavia.
E, per realizzare progetti del genere, come si vede, gli uomini non mancano. Basta cercarli e coltivarli opportunamente. E i persuasori dello Stato sanno come fare.
[Pubblicato su “Canenero” n. 6, 2 dicembre 1994, p. 4]
L’ombra lunga del segreto
Con la costanza che gli viene dal desiderio di far carriera, e con il metodo ereditato dalla sua passata militanza nelle formazioni staliniste, il giudice di Milano Guido Salvini sta tratteggiando un quadro, quanto altri mai complesso, delle vicende italiane dell’ultimo quarto di secolo.
Un posto centrale è occupato in queste vicende dal ruolo dei servizi segreti. Dentro c’è di tutto: dalle bombe di piazza Fontana alla Gladio, dal ruolo dei neofascisti a quello di Andreotti, da Licio Gelli a Valerio Borghese. Che senso può avere questa “ricostruzione”? Penso che ne abbia ben poco, se si esclude quello di una esercitazione letteraria al limite tra cronaca e storia.
Ed è proprio da questo aspetto, marginale e poco importante, che si può trarre una piccola riflessione, forse utile. La posizione della Democrazia Cristiana, e in particolare dei suoi leader storici, a cominciare da Moro e finire con Andreotti, non sembra meno compromessa nei vari tentativi di golpe, quindi nelle stragi e nei massacri di questi ultimi decenni, dei neofascisti.
Quindi, almeno per quel che le carte sembrano adesso registrare con maggiore attenzione di quanta non ce ne sia stata in passato, lo Stato (dominato dal ruolo della DC, prima, e poi del PSI), era proprio quello che avevamo fin dalla stessa sera delle bombe della Banca dell’Agricoltura, indicato come mandante.
Come si vede, per arrivare a giuste conclusioni, non occorrono né decine di migliaia di pagine di istruttorie, né un quarto di secolo. Basta non avere nulla a che fare col potere, per ragionare correttamente.
[Pubblicato su “Canenero” n. 24, 21 aprile 1995, p. 3]
Le forbici quando si allargano non tagliano più
[…] 16 luglio 1984
Caro*, Caro**
Cosa volete che aggiunga a quanto ho già scritto su “Anarchismo”? Sapete che non ho due modi di vedere le cose (uno pubblico e uno privato). Capisco però che mi chiedete qualcosa di più, qualcosa di più personale, su di un problema tanto difficile (e doloroso) non solo per voi che siete “dentro”, ma per tutti i compagni (almeno a quanto credo di poter capire dai discorsi che vado recependo in giro).
Innanzi tutto per una mobilitazione – sia pure nell’àmbito delle nostre forze – a favore di una richiesta di amnistia, no. Il fatto che essa sia possibile (sotto forma di sanatoria o altro) non modifica le condizioni del mio modo di vedere, anzi le rende più stringenti. Io sono partito da questo punto di vista: in nessun caso dobbiamo controfirmare un documento che sancisca ufficialmente la sconfitta del progetto di lotta che – in un determinato momento – ha attraversato l’esperienza armata di un certo tipo. Questo progetto continua. Non sotto le forme precedenti, ma sotto altre forme, anch’esse armate o violente od organizzate – definiamole come vogliamo – ed anch’esse frutto e sviluppo delle esperienze del passato. Questo progetto è in corso di svolgimento, anche se al momento attuale non se ne vedono risultati tangibili ed anche se dappertutto (ad opera delle cariatidi del vecchio movimento) si assiste a solenni de profundis.
Non sono certo io a chiedere che a pagare questo nuovo progetto, che vede impegnate forze nuove e nuove analisi, siano i corpi dei compagni in prigione. Lo Stato ha di certo il suo interesse a sanzionare una sconfitta, per operare un taglio che renda impraticabile il contributo passato e, nel far ciò, potrebbe anche decidersi nel senso di un provvedimento sanatorio. Ma ciò dovrebbe essere visto come un recupero di margini di garantismo che la struttura democratica è obbligata a dare, nulla di più.
Non me ne volete. Questa mia non vuole essere la rigida filippica di un Bruto disposto a vendere il fratello. Saprete, o spero che sappiate, che non ho l’animo per questo modo di vedere. Solo non condivido la posizione di coloro che – anche dal di fuori – sostengono la concessione di un provvedimento del genere. Nel limite (inverosimilmente modesto) delle mie forze e possibilità d’intervento sto facendo tutto il possibile perché si apra un dibattito contro l’amnistia e non per un ricorso (o, peggio ancora, per un’attesa generica della prossima insurrezione) – come ingiustamente mi sembra vogliate farmi ammettere – ma per cercare di ricucire un progetto passato (che ci aveva sempre visto in posizione critica) con il progetto in corso che è propedeutico all’azione futura per cui siamo (penso) tutti qua – noi “fuori” e voi “dentro” – a continuare la nostra lotta. […].
Alfredo
Caro* e caro**,
io vedo moltissimi compagni nei miei spostamenti e constato che c’è tanta voglia di continuare. Niente è considerato “chiuso” sulla linea della “sconfitta”, resta solo un progetto politico che non c’è mai appartenuto. Molti compagni, anche non anarchici, riprendono proprio da questo punto. Molti altri, specie tra i giovanissimi, rivedono criticamente questo aspetto del progetto rivoluzionario complessivo. In tutto questo lavoro il problema carcere (e quindi il problema dei compagni in carcere) è uno degli aspetti, non la totalità. Diventa sempre più difficile mobilitare quelle poche forze residue del movimento cosiddetto ufficiale sul problema della repressione, e temo che da qui a poco questo settore diventerà il ghetto dell’attività di quei gruppi che non “vogliono” fare altro.
Io non so in che altro modo agire. Penso di andare nella giusta direzione. Non voletemene se da questo momento in poi le nostre opinioni su questo argomento dovessero divergere ancora più a fondo.
Per quanto riguarda un vostro intervento o quello dì altri compagni dell’area libertaria (se è legittima ancora questa distinzione, visto che manchiamo di dati concreti sulla posizione di molti compagni e sulle loro attuali decisioni), si può senz’altro pubblicare su “Anarchismo”. Si potrebbe anche studiare la pubblicazione di un “numero speciale” tutto dedicato a questi interventi. Si vedrebbe così in che modo la forbice sia divaricata o meno. Però vi ricordo una sola condizione che come vecchi lettori e collaboratori di “Anarchismo” sapete perfettamente: le cose inserite sulla rivista non devono essere anche inviate ad altre pubblicazioni. Non so se vi riesce possibile raggiungere altri compagni tra quelli detenuti, in questo caso potrebbe forse essere possibile pubblicare una serie di interventi. Cosa ne pensate?
Un ultimo argomento che viene sollevato da **, a cui tengo molto. Quello dei “ritardi, inadempienze, scarsa incisività”, ecc. del movimento esterno (in particolare quello anarchico e libertario) sul problema delle carceri, cosa che ha avuto il suo peso sulla scelta attuale e futura di alcuni compagni. Mi sembra che occorre meglio formulare questo concetto. Se è certo che le condizioni precarie o irrisorie del movimento esterno hanno un’influenza negativa sulla situazione personale dei compagni in carcere, occorre dire però che le condizioni cosiddette esterne non sono (solo) frutto di una decisione personale, ma anche il prodotto delle condizioni specifiche dello scontro di classe. Al contrario le decisioni dei compagni in carcere sono sempre (o almeno, quasi sempre) decisioni personali. Con ciò non ci si vuole assolutamente scaricare di eventuali manchevolezze, indecisioni, confusioni o altro che ci sono state. Ma la causa dell’arretramento delle lotte è stata primariamente la forte spinta di ristrutturazione che lo Stato ha saputo imporre alle condizioni dello scontro. In questa spinta è leggibile anche l’influenza negativa di coloro che avevano elaborato e tentato di realizzare un folle progetto stalinista di conquista del palazzo d’inverno, ma non è certo questa la causa scatenante. Occorre quindi – almeno mi pare – vedere che le condizioni di lotta sono quelle che sono e che chi opera “all’esterno” è obbligato a tenere conto di queste condizioni per agire in senso rivoluzionario reale e non solo per trastullarsi in modo velleitario. “All’interno” invece le condizioni che conducono ad accettare una soluzione anziché un’altra sono primariamente di ordine personale e solo come conseguenza risentono anche delle cause generali dell’abbassamento dello scontro di classe.
La défaillance non ha quindi una causa primaria, ma si inserisce come reazione più che logica e comprensibile, all’interno di una ristrutturazione dello scontro di classe che semina dappertutto la dissidenza e la demotivazione. Ricostruire, con pazienza e perseveranza, un progetto che resta immutato pur nelle sue profonde capacità di adattarsi alle mutate condizioni, costa pericoli e sacrifici che non hanno nulla da invidiare a chi sconta pericoli e sacrifici in galera, in questo momento.
È assolutamente fuori della realtà immaginarsi una condizione privilegiata in senso positivo per chi sta “fuori” e una condizione di intollerabilità in senso negativo per chi sta “dentro”. Questa dicotomia, anche se è stata presa recentemente a base del proprio modo di pensare da ex cavalieri senza macchia e senza paura, non ha senso, e certamente voi lo sapete benissimo.
Un fraterno abbraccio
Alfredo
[Due lettere pubblicate su “Anarchismo” n. 45, marzo 1985, pp. 26-27]
L’azione e la prudenza
Sollevato da alcuni compagni, esiste un problema delle conseguenze della lotta rivoluzionaria, dei possibili pericoli che un obiettivo, per quanto bene scelto e identificato, al momento di essere attaccato possa allargarsi a persone e cose del tutto estranee. Questo problema, che sembra tanto considerevole, non appena lo si considera più attentamente, dimostra i suoi limiti e, quindi, anche la sua infondatezza.
Non voglio con questo dire che tutto può allegramente andare per il suo verso, solo raccomandandosi alla buona sorte e non tenendo conto di tutte le variabili che la realtà dissemina su ogni percorso, voglio al contrario dire che questi problemi, di ordine strettamente morale, rischiano di diventare quello che in effetti sono, riflessioni astratte che non tengono conto della realtà dei fatti, della minuta realtà di tutti i giorni, per come la viviamo.
Senza voler essere catastroficamente estremista, nella vita che tutti noi conduciamo, in un modo o nell’altro, spesso in maniera dolorosamente uniforme, ci sono comportamenti – guidare un’automobile, accendere il gas, attraversare le strisce pedonali e molti altri fatti normalissimi – che potenzialmente possono produrre dei rischi per altre persone. La nostra prudente coscienza può certamente ridurre al minimo questi rischi, ad esempio evitando di cadere nell’equivoco di tanti suggerimenti pubblicitari in favore di una velocità di guida dissennata, ma non può mai cancellarli del tutto. Solo nella pratica concreta, nella ripetizione di gesti e di fatti, nell’abitudine che diventa capacità quasi automatica di realizzare gesti e compiere azioni, ci accorgiamo che quei pericoli, pur non scomparendo del tutto, possono ridursi ad un minimo che solo l’evento realmente imprevedibile e, in fondo, inevitabile, può tradurre in realtà. Chi non è mai salito su un’automobile, non ha mai usato il gas o non si è mai avventurato fuori dal villaggio natio, probabilmente al sentir parlare di cose del genere avverte una tremenda sensazione d’angoscia e quindi sente la necessità di porsi tutti i problemi che da questa sensazione vengono fuori, ma chi compie quelle azioni con una certa agevolezza, praticandole quotidianamente, si limita soltanto ad impiegare la prudenza che la sua sensibilità di uomo cosciente gli suggerisce.
Non voglio dire, con tutto ciò, che l’attività rivoluzionaria può raggiungere, in certi casi e per certi compagni, l’agevolezza rutiniera di certi comportamenti che il vivere quotidiano ci mette sotto gli occhi. Non sarà mai così e, in effetti, per certe azioni che richiedono impegno, determinazione, coscienza rivoluzionaria e coraggio, ci sarà sempre più tensione di quella che magari sarebbe auspicabile per una obiettiva valutazione delle cose da fare; ma, al contrario, voglio dire che i problemi non devono essere ingigantiti a causa della possibile (non dico sicura) lontananza dalla realtà di quei fatti.
Potrebbe infatti accadere, e di fatto è spesso accaduto, che molte discussioni del genere, come quelle ormai classiche sulla violenza rivoluzionaria, potrebbero trovare non dico una soluzione, che in queste cose non c’è una soluzione da trovare, ma almeno una più corretta e semplice impostazione, quindi senza tanti inutili giri di parole e tortuosità di formulazioni, solo che i compagni che le sviluppano, o semplicemente le suggeriscono, si prendessero la briga di verificare nei fatti le attività concrete cui quelle stesse discussioni fanno riferimento, e non invece dando per scontato che quest’ultime siano comunque importanti a prescindere da eventuali verifiche pratiche preventive.
Ciò porterebbe a scoprire che la realtà vissuta è sempre più semplice del fatto immaginato e, spesso, proprio perché si tratta di determinati fatti, rielaborato con la fantasia e consegnato a tutte le varianti che la moderna mitologia è tanto brava a realizzare. La realtà è sempre capace di fornire consigli pratici, insegnamenti e lezioni in grado non tanto di imbrigliare la fantasia, ma di indirizzarla verso quelle intuizioni e quelle immaginazioni che sono tanto belle e tanto interessanti, solo quando consentono di prevedere proprio quello che nella realtà ancora non esiste o, se esiste, è solo in embrione o in potenza. Nel caso in cui la fantasia s’intorbida nel tentativo, spesso banalmente involuto, di cercare giustificazioni o possibili equivoci all’interno di quello che la realtà di fatto consente di vedere in diversi dettagli, essa perde il suo slancio liberatorio e diventa ancella della prudenza e dell’incertezza.
L’azione rivoluzionaria ha problemi suoi, questo è certamente vero, e quindi anche risvolti morali attinenti a questi problemi. Nessuna azione umana è priva di risvolti morali, anzi si potrebbe dire che è azione dell’uomo proprio perché quest’ultimo nel compierla si pone giudizi di natura morale. Ma questi giudizi non devono diventare pregiudizi nella nostra testa, ostacoli allo sviluppo dell’azione, controlli che ci facciamo da noi stessi proprio perché in fondo abbiamo paura della libertà.
Nessuno ha il diritto o, se si preferisce, la libertà di giocare a cuor leggero con la vita degli altri. Ma questo incontrovertibile punto morale, innegabile per gli anarchici, non può far concludere che l’impossibilità di avere la certezza della non nocività immediata di un’azione rivoluzionaria equivalga alla sua irrealizzabilità. La pratica reale di quest’attività rivoluzionaria, il più delle volte, permette di trovare soluzioni che se anche non saranno moralmente ineccepibili in assoluto, sono di certo molto meno pericolose di quanto un’astratta formulazione del problema non suggerisca.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 67, maggio 1991, pp. 9-10]
Piazza Fontana, tanti anni dopo
Gli anni Sessanta, particolarmente l’ultimo scorcio, sono stati caratterizzati non soltanto dal progetto repressivo realizzato a piazza Fontana, a Milano, ma principalmente, a meno per quanto ho inteso io, da una grande esplosione di vitalità e di bellezza avvenuta a partire dal Sessantotto, dal Maggio francese. In effetti anche una persona come me che in quegli anni lavorava come dirigente industriale è stata sconvolta da un avvenimento tanto straordinario, da vedersi costretta in breve tempo ad abbandonare il lavoro e a vedere la realtà diversamente. Ma io non sono stato una eccezione. In tanti hanno avuto la stessa spinta a cambiare, specialmente i giovani. All’epoca io avevo più di trent’anni e quindi avvertivo con maggiore difficoltà questa aria di diversità che spirava dappertutto, per i giovani è stato certamente più facile lasciarsi affascinare da questa sconvolgente diversità.
In questo, in cui per la prima volta, dopo tanti decenni, si affacciava per lo Stato lo spettro dei processi autorganizzativi, assolutamente incomprensibili, e come tutte le cose incomprensibili foriero di paure di turbative del cosiddetto ordine pubblico, lo Stato interviene a modo suo, nell’unico modo in cui sa intervenire. Abbiamo in quell’epoca, per la prima volta, sentito parlare del termine “provocazione”. Tenete presente che alcune parole come “provocazione”, “strage di Stato”, sono state coniate in quel momento, in quei giorni. Lo Stato interviene attraverso il suo strumento tradizionalmente più a portata di mano, cioè le organizzazioni fasciste. Non è vero che l’iniziativa parte su due piedi, nel senso che qualcuno più subdolo degli altri incarica qualcuno di mettere la bomba, ma risale a parecchio tempo prima.
Il progetto di impiegare una grande operazione intimidatoria quale è stata quella di piazza Fontana, per bloccare i processi autorganizzativi non solo delle lotte studentesche ma principalmente anche operaie, il cosiddetto autunno caldo viaggia per tempo. Pensate che i fascisti si erano organizzati con la precisa determinazione di coinvolgere gli anarchici. Io sono sicuro anche anni prima, a partire dal Sessantasette, loro hanno cominciato a pubblicare dei testi anarchici, con le Edizioni NS, testi come L’unico di Stirner, Il mutuo appoggio di Kropotkin, ecc., per dimostrare come poteva essere possibile una commistione tra destra e sinistra. Questo progetto venne realizzato in maniera molto articolata.
Per quanto riguarda poi la collocazione specifica delle varie bombe, questa non comincia con piazza Fontana, comincia mesi prima, precisamente sempre a Milano con le bombe della Fiera. Diversi anarchici vengono arrestati restando in carcere più di un anno con l’accusa di tentata strage che poi cadrà nel nulla.
Ma perché lo Stato sente la necessità di ricorrere a certi strumenti particolari in certe occasioni, perché anche oggi può essere che ci sia da qualche parte, in qualche stanza del potere, qualche burocrate più sveglio degli altri che insieme ad altri suoi commilitoni stia organizzando un progetto diverso da quello che potremmo definire di normale repressione. È ovvio che anche nelle tecniche repressive c’è una evoluzione, una crescita di disponibilità tecniche e scientifiche. Può darsi che ciò sia in corso di realizzazione. Può darsi che tante notizie che leggiamo sui giornali, tanti fatti che vediamo riportati e commentati, siano la riproduzione, su modelli differenti, di quello che è accaduto nel Sessantanove. Siano cioè l’espressione di un modo di agire da parte del potere davanti al quale ogni volta restiamo sbalorditi. Dobbiamo capire che molti di noi, anarchici compresi, e dentro certi limiti, specialmente gli anarchici, che sono pronti a fronteggiare la realtà in un modo retto e sincero, in molti, non arrivano a capire come possano esistere persona di tale fatta, come possa esistere un individuo che lavora alla realizzazione di un progetto come quello di piazza Fontana, con più di quindici morti e decine e decine di feriti, la sera chiude il fascicolo che ha sul tavolo per tornare in famiglia, per accarezzare i propri bambini. Ecco noi, per fortuna, non riusciamo a capire una cosa del genere. E invece la deformazione professionale del poliziotto, del carabiniere, dell’uomo dei servizi, arriva a tanto. Definire questa situazione e questi individui, delle mostruosità, è superfluo, perché non spiega che cosa potremmo trovarci un’altra volta di fronte, come quella sera a Milano.
Ma i compagni che quella sera si trovavano a Milano, riunitisi in pochissimi, non più di tre o quattro, perché gli altri erano del tutto scomparsi, scrissero un volantino che anche oggi è condivisibile, non un volantino scritto tre anni dopo quando tutti sapevano ormai che si trattava di una trama tessuta dai fascisti e dallo Stato, ma poche ore dopo l’avvenimento. E in quel volantino c’è la frase “strage di Stato”, una strage voluta, realizzata, organizzata dallo Stato, e dai suoi servitori i fascisti.
Perché è stato pensato questo poche ore dopo lo scoppio della bomba nella Banca dell’Agricoltura a piazza Fontana? Perché quei compagni hanno capito subito che cosa significa da parte dello Stato trovarsi davanti a situazioni di paura, per lo Stato beninteso? Ebbene quei compagni avevano capito che sicuramente l’autunno caldo il 12 dicembre si trovava a una svolta. Il fronte sindacale aveva ceduto. Tenete presente che in quel momento io lavoravo nel settore dei chimici, ero dirigente di una industria farmaceutica del settore oculistico, sul mio tavolo c’era appunto il contratto approvato dal settore dei chimici che sanciva la rottura con le proposte, ancora non accettate, dal settore metalmeccanico. Questa frattura poteva determinare nel paese un contraccolpo durissimo, con conseguenze impensabili di ordine pubblico. Ecco perché collocano la bomba il 12 dicembre, una bomba che deve causare un sacco di morti e di feriti, non una bomba dimostrativa, ma una bomba in grado di gettare un paese intero nella paura.
Tenete presente che il ministro dell’Interno in questo momento è un socialista, tenete presente che il quotidiano dei socialisti, “L’Avanti!”, due giorni prima pubblica una lunghissima recensione di un mio trascurabile opuscolo dal titolo La distruzione necessaria, affidandone la stesura ad Alberto Jacometti che era il teorico del partito socialista in quel momento. Perché tanto spazio riservato a un opuscolo anarchico in un giornale non certo caritatevole nei riguardi degli anarchici, e appena due giorni prima della bomba che verrà attribuita subito agli anarchici? Questa domanda non è mia, forse per il mio modo di vedere le cose sono la persona meno indicata ad alimentare domande del genere, ma è dovuta ad alcuni militanti del PSIUP, organizzazione dell’epoca che forse qualcuno ricorderà, che pubblicano sul loro giornale questa domanda: perché mai il partito socialista si interessa di questo opuscolo due giorni prima della strage? Perché attira sugli anarchici e su di una particolare interpretazione dell’anarchismo, l’attenzione del grande pubblico?
Lo Stato ha la necessità di utilizzare lo strumento estremo: la bomba, la grande provocazione, la paura, ed ha anche la necessità di trovare un responsabile, perché nel caso in cui non fosse stato possibile da parte dello Stato attribuire immediatamente la colpa di questa mostruosità agli anarchici, in particolare a Valpreda, ci sarebbe stato un contraccolpo negativo contro se stesso in quanto non in grado di identificare i responsabili di quella enormità che per la prima volta sbalordisce e terrorizza la gran parte della popolazione italiana e non solo italiana. Quindi attribuisce questa mostruosa strage agli anarchici. Gli anarchici sono lo strumento da utilizzare direttamente come capro espiatorio. Per rendere credibile la mostruosità c’è il mostro. Ci sono i mostri.
Pensate a quello che sta accadendo in questi giorni [dicembre 2003], e che leggiamo su tutti i giornali, pensate alla questione dell’acqua minerale. Io non so che cosa c’è dietro alla questione dell’acqua minerale, so soltanto quello che sapete tutti, che tutti leggiamo sui giornali. Io ho un bambino piccolo, ed è chiaro che cerco di evitare di dargli l’acqua del rubinetto, e mettersi a controllare la bottiglia dell’acqua in tutti i suoi aspetti determina condizioni di paura, e come me milioni di persone in Italia stanno in questo momento capovolgendo la bottiglia di acqua minerale. Potrebbe esserci in corso un progetto di impaurire la gente. Io non so se quest’ultimo è gestito da una mente particolarmente acuta, da un progetto significativo, statale, o da qualche centrale del terrore.
Personalmente non credo che il livello oggi, le capacità organizzative dei livelli provocatori siano da parte dello Stato in grado di attingere questo apice di delicata e raffinatissima realizzazione. Mi voglio illudere che probabilmente la cosa sia dovuta a qualche dissennato imitatore di qualcun’altro non soltanto dissennato ma anche incapace di controllare i propri istinti distruttivi, indirizzandoli verso qualcosa che spezzi la monotonia della vita quotidiana che tutti affrontiamo. Io sono per questa seconda interpretazione, ma si tratta sempre di illazioni che una persona come me, lettore di giornali come tutti voi, fa senza possedere notizie concrete di prima mano.
Pensate alle reali capacità che lo Stato ha di sviluppare provocazioni per realizzare i suoi scopi. Pinelli è un compagno ferroviere, del gruppo di Milano, anarcosindacalista. Ha una moglie, dei bambini. È un compagno così aperto, così fiducioso da avere un buon rapporto con Calabresi. Si conoscono, si sono anche prestati dei libri, Pinelli gli ha dato dei libri sull’anarchia. Non sa il povero Pinelli il mostro che ha davanti, perché Calabresi è una macchina stupidamente perfezionata dalla CIA in America. Questo funzionario dello Stato, di cui un’ottima, splendida caricatura è stata fatta da Gian Maria Volonté nel film Un cittadino al di sopra di ogni sospetto, questo tizio, personifica la potenza, la tracotanza, l’efficienza della polizia. In fondo è un funzionario di modesto livello, è un vice commissario, chiamato a dirigere la squadra politica, come allora si chiamava la Digos, eppure questo vice commissario ha voce in capitolo, perché è stato in America, è stato allievo della CIA, conosce il karate, ha interrogato i compagni che sono stati inquisiti, che si trovavano in quel momento in carcere per la bomba alla Fiera di Milano, ha portato il povero Braschi, uno di questi compagni, in via Fatebenefratelli e lo ha fatto sedere sul davanzale della finestra che solo dopo diventerà famosa. Per questo motivo, ancora prima della morte di Pinelli, Calabresi a Milano aveva il soprannome di “commissario Finestra”.
Ma il povero Pinelli è fiducioso, Calabresi passa avanti con la macchina e lui lo segue col motorino. Cosa è successo non lo sappiamo. Se a buttare il povero Pinelli dalla finestra sia stato Calabresi non è materialmente possibile saperlo, però lui era là ed è stato responsabile certamente della morte del nostro compagno.
Nel 1972, il 17 maggio, in via Cherubini, mentre stava per salire sulla sua macchina, il commissario Calabresi finisce i suoi giorni, una pallottola lo centra alla spalla destra e una gli fa saltare metà del cranio. Cade e nessuno sente nemmeno i rumori degli spari, perché quella mattina, alla 9,30, pare che non ci fosse molta gente per strada. Il sangue comincia a formare una pozza vastissima, una vana corsa dell’autoambulanza all’ospedale, il funzionario dello Stato muore.
Io non sono mai riuscito a togliermi dagli occhi la sera in cui accompagnammo il cadavere di Pinelli al cimitero. La moglie che avete visto nel filmato trasmesso qui poco fa, così arcigna, un poco algida, una povera donna, però un poco fredda poverina, almeno a me ha dato sempre questa impressione, aveva detto niente bandiere, niente simboli. Ma ognuno la propria bandiera se la portava nel cuore e ognuno io penso, quella sera, desiderò che a Calabresi dovesse accadergli in futuro qualcosa non propriamente di buono.
Cosa volete, la vendetta non è un sentimento disdicevole, certo sarebbe meglio che a muoversi contro questa gestione del potere, dello Stato, dei servizi, della polizia, dei carabinieri, di questi eroi che ci sbandierano sotto il naso continuamente, che corrono pericoli da tutte le parti per salvaguardare la nostra tranquillità, sarebbe meglio che ad attaccare questa gente sia veramente la totalità delle persone per bene, per bene nel senso migliore del termine, e non che il singolo individuo venga raggiunto da un colpo di pistola sparato da un singolo che individualmente attua una giustizia effettiva, concreta. Certo, sempre meglio di niente, sempre meglio che il commissario Calabresi abbia trovato questa fine e che a ricordare la morte di Pinelli ci sia anche la morte di questo servitore dello Stato, del boia che lo ha ucciso.
Nella vicenda della repressione e delle provocazioni dello Stato non ci si può fermare a casi sporadici, perché man mano che si sviluppa la forma Stato in cui noi oggi viviamo, la rapportazione sociale in cui siamo tutti immersi, man mano che si trasforma il potere tradizionale dello Stato inteso nella sua forma di repressione e gestione, e diventa invece quello che oggi tutti abbiamo sotto gli occhi, una forma basata essenzialmente sulla gestione dell’opinione, sulla formazione dell’opinione, la repressione e le provocazioni assumono forme differenti. In effetti il potere oggi è basato non direttamente sulla repressione ma prima di tutto sulla formazione dell’opinione, per cui prima si costruisce l’opinione e poi, solo se ci sono delle sbavature, delle cose che non vanno come dovrebbero andare, si ricorre alla repressione.
Lo Stato oggi, come almeno sembra di capire, si basa essenzialmente sull’informazione, sulla gestione dell’informazione. Questo nuovo Stato ha bisogno di nuove capacità correttive, è in questa direzione che si avanzano nuove sperimentazioni da parte del potere, ed è in questa direzione che si possono probabilmente vedere anche faccende come quella dell’acqua minerale, probabilmente dico io, perché l’altra ipotesi quale potrebbe essere?, che la stessa costruzione dell’opinione, che ci fa tutti standardizzati, che ci fa sentire tutti prigionieri di una camicia di forza che viene continuamente perfezionata giorno dopo giorno in tutti i minimi particolari, proponga essa stessa di spezzare, anche nel peggiore dei modi, perché incontrollati e incontrollabili, proponga di spezzare la sua opera di coercizione. Ipotesi inammissibile ma pensabile. Anche essa possibile. Ciò non esclude che qualcuno in questo momento non stia cercando una pianificazione globale diretta a metterci a tacere per sempre. Gli anarchici sono un esempio di piccola minoranza irriducibile, che si appella continuamente alla necessità di autorganizzarsi, di pensare da soli, di cercare di gestire la propria vita in modo diverso, di conquistare degli spazi, di difenderli, di fronteggiare la repressione quando interviene per livellare tutto, per cancellare qualunque possibilità di respirare, di pensare diversamente, questo e ancora altro continua a fare paura.
Gli anarchici della fine degli anni Sessanta vennero indicati come responsabili di un processo repressivo costruito dallo Stato e dai fascisti, la bomba di piazza Fontana è probabilmente l’esempio più importante e più eclatante. Oggi gli anarchici, se leggete con attenzione i giornali, vengono spesso indicati, continuamente si parla di questi anarchici insurrezionalisti continuamente si parla delle teorie insurrezionaliste sostenute dagli anarchici. Oggi il ministro dell’Interno parla del pericolo di queste teorie e di questi anarchici insurrezionalisti, e quando le nostre teorie e le nostre parole vengono biascicate dalla bocca di un pesce morto, di un baccalà com’è il ministro dell’Interno, mi prende un brivido nella schiena.
Oggi si ripete continuamente del pericolo degli anarchici e ciò è molto simile al compito del tagliagole che la sera prima del suo lavoro lima con attenzione il proprio coltello in attesa dell’alba, quando colpirà. E mentre affila il suo strumento questo assassino pensa a come potrà colpire nel migliore del modi domani per portare a termine il proprio compito. In fondo non è difficile attaccare gli anarchici, in fondo sono pochi, sono disorganizzati, nessuno li difende, anche fra di loro non sono sempre d’accordo. Lo Stato sa bene che la difesa di Valpreda alla fine degli anni Sessanta fu possibile fino a quando la cosa tornò comoda al Partito Comunista, quando Valpreda, da dissennato poverino qual era, partecipò alla campagna elettorale del Manifesto, la sua difesa ebbe termine. Quindi nessuno difende gli anarchici, se non strumentalmente. Noi troviamo nei nostri processi, nella varie situazioni in cui ci troviamo incolpati di qualche reato, degli avvocati che ci difendono, qualche amico, ma sono legami personali, individuali. Io penso che anche oggi come allora ci può essere da parte del potere l’intenzione di utilizzare gli anarchici. Certo molti dei mezzi di cui disponiamo oggi, anche come anarchici, sono migliori di quelli di cui disponevamo nel 1969, se non altro le nostre esperienze personali sono di gran lunga più ampie e penosamente vaste, ma la cosa è sempre possibile. Oggi è certamente più difficile l’esistenza di un gruppo come quello di cui faceva parte Valpreda, pieno di infiltrati e di fascisti, per quanto non possiamo non ammettere che proprio oggi la superficialità e la faciloneria di almeno un compagno ha reso possibile a una collaboratrice dei carabinieri di fare condannare a decenni di carcere molti compagni.
Nel 1972 mi trovavo in galera, con una condanna a due anni e due mesi da scontare per un articolo pubblicato sul giornale “Sinistra libertaria” e non avevo alcuna possibilità di essere liberato perché avevo una condanna superiore a due anni, invece dopo qualche mese sono uscito perché nel frattempo era stata varata una legge che prese il nome di “legge Valpreda” con la quale diventava possibile essere liberato in attesa degli altri gradi di giudizio anche per chi aveva in primo grado avuto condanne superiori ai due anni. Si trattava di una soluzione giuridica approvata dal Parlamento per mettere fuori Valpreda e compagni, della cui estraneità ai fatti di piazza Fontana tutti erano ormai convinti.
Oggi la situazione è fortemente cambiata, oggi quello che si cerca di limitare è un possibile sviluppo della capacità autorganizzativa della gente. Due soli esempi: gli scioperi di Milano degli autotranvieri e i blocchi di Scanzano. Di fronte a questi fenomeni autorganizzativi lo Stato non ha strumenti collaudati, non ha la possibilità concreta di bloccare. L’unica cosa che può fare è quella di aggirare l’ostacolo se si dovesse creare un processo di generalizzazione di questo tipo di lotta, e aggirare l’ostacolo significa stornare l’attenzione, creare qualcosa che induca la gente a pensare ad altro posta di fronte ad un avvenimento talmente incomprensibile, talmente sorprendente, fuori del comune, da fare paura. E non c’è dubbio che i dissennati di cui parlavamo prima, potrebbero essere utilizzati. Fin dove? Non lo so.
Oppure un progetto estremamente raffinato, molto avanzato, senza paragoni con la bomba di Milano, non lo so, non so dare una risposta. Quello che so è che i progetti repressivi non conoscono limiti logici.
Quello che è possibile sapere è che nelle varie realizzazioni che lo Stato porta avanti, ad esempio la sua presenza, il suo intervento nella guerra in Iraq, la sua compartecipazione ai destini di conquista della nazione dominante, possono accadere dei fatti per intenderci come quello di Nassirya. A me mi ha fatto riflettere una questione marginale che può anche sembrare trascurabile. Due o tre giorni prima della morte di tanti carabinieri a Nassirya, la trasmissione televisiva “Striscia la notizia” aveva passato alcune immagini in cui si vedevano alcuni carabinieri operare una carica colpendo i manifestanti con il manico dei manganelli, cosa normale per un carabiniere, ma che ha sbalordito molti benpensanti fra il pubblico sollevando una critica piuttosto risentita da parte dei conduttori della trasmissione nel vedere la divisa del carabiniere, con tanto di imbecille dentro, colpire in questo modo irriguardoso delle regole. Dopo due giorni immediatamente quella stessa riflessione critica, quel modesto sbalordimento, quel senso di disgusto, dopo le morti di Nassirya, erano completamente scomparsi. Dopo tutti sono diventati patrioti, tutti d’accordo che bisogna fare qualcosa per difendere i “nostri ragazzi”. A Rovereto, mi dicono, che il 12 dicembre del 2003 avevano proposto di commemorare quei carabinieri morti al posto dei morti della Banca dell’Agricoltura. Questo è un modo, assai comune per lo Stato, di manipolare l’opinione e di stornare a proprio profitto qualsiasi situazione si presenti. La responsabilità dello Stato e dei fascisti riguardo l’eccidio di piazza Fontana viene in questo modo cancellata sovrapponendo a essa l’immagine di carabinieri uccisi in una guerra camuffata da operazione di pace. Certo, questa operazione è profondamente becera e, sotto certi aspetti può essere considerata marginale e periferica, ma fa parte lo stesso della gestione complessiva dell’opinione da parte del potere.
C’è poi la parte più avanzata del processo repressivo, che studia nuovi modelli di intervento, nuove tecnologie, che non si limita a operazioni di retroguardia o di ridipintura di vecchi sepolcri. Quando il ministro dell’Interno ha fatto il suo discorso alla camera sugli anarchici insurrezionalisti e sul pericolo da loro costituito, ha chiesto soldi, ha chiesto al governo un aumento del finanziamento alle forze dell’ordine per meglio realizzare il loro compito repressivo, repressivo e preventivo.
Concludendo, è sempre possibile che lo Stato si comporti in modo diverso da come le sue stessi leggi gli impongono di fare. A restare sbalorditi di fronte a questi comportamenti spesso siamo noi stessi anarchici, perché per una sorta di nostra coerenza interna siamo spesso portati ad accreditare al nemico una coerenza di comportamento che quello non ha la minima intenzione di mantenere. È la regola che lo Stato, e le sue varie componenti, non seguano le proprie regole. Ciò dipende dal fatto che tra gli scopi che vogliono raggiungere e le regole da rispettare si possono determinare dei contrasti, spesso impietosi. In questo caso, ad avere la meglio sono sempre gli scopi, mai le regole morali. Fra i cosiddetti uomini dell’ordine non ci sono beati in odore di santità. Posso dichiarare, per essere stato torturato tante volte, che non c’è una sede di questura o una stazione dei carabinieri e perfino il più remoto commissariato di polizia (non ho esperienza di guardie di finanza o guardie municipali e forestali), dove non esiste una stanza con alcuni più o meno rudimentali strumenti di tortura e dove questo alto servigio in nome delle democratiche virtù della nazione repubblicana uscita dalla Resistenza non venga regolarmente esercitato.
Dobbiamo renderci conto che lo Stato è tutto questo, è questa bestia, qualunque nefandezza per lo Stato è solo da porsi sulla bilancia delle convenienze, non su quella di un inesistente codice morale di comportamento.
Vi ringrazio.
[Conferenza tenuta l’11 dicembre 2003 presso la Facolta di Sociologia dell’Università di Trento. Trascrizione della registrazione su nastro]