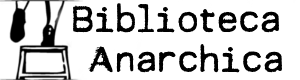Alfredo M. Bonanno
Esclusi e inclusi
Fine delle ideologie, ma non del tutto.
Nessun apparato politico ne potrà mai fare a meno completamente. Le trasformazioni sostanziali nella struttura produttiva del capitale, trasformazioni che, a livello mondiale, si sono verificate negli ultimi dieci anni, hanno improvvisamente svuotato di significato quasi tutte le coperture ideologiche esistenti. Con ciò non si può dire che la funzione politica, come azione gestionaria e repressiva dello Stato, sia diventata più aderente ai reali bisogni delle persone. Subito dietro i vecchi fantasmi ne sono sopraggiunti altri, dei quali non sembra agevole individuare le caratteristiche, essendo per altro coperture ideologiche ancora in formazione. Possiamo solo dire, allo stato attuale delle cose, che il loro obiettivo è quello di sempre, premere sui sentimenti e sugli istinti irrazionali, per sollecitare comportamenti favorevoli al mantenimento dell’ordine imposto dalla classe dominante.
Fra i movimenti più immediati, balzati subito al centro delle cronache, c’è il vecchio miraggio della libertà, imbalsamato nelle trappole logiche dell’antico liberalismo, e rispolverato in tutta fretta per dare fondamento alle più bieche operazioni di gestione dei nuovi mercati all’Est. Che ogni liberalismo si basi su di una discriminazione precisa tra due categorie di persone, quella che può godere dei diritti umani, politici in primo luogo, ma anche più immediatamente concreti come ad esempio quello alla vita, e quella che questi diritti li ha in maniera ridotta, quindi suscettibile di eventuale sospensione o soppressione.
Storicamente non occorre qui ricordare che Locke, paladino della libertà politica, doveva la sua fortuna privata agli investimenti fatti nelle compagnie inglesi che lavoravano da quasi un secolo nella tratta degli schiavi, e che la stessa rivoluzione inglese, da cui era nata l’idea di liberalismo politico, aveva considerato una grande conquista la vittoria sulla Spagna in quanto con la pace di Utrecht aveva ottenuto la distruzione del monopolio spagnolo della tratta degli schiavi e iniziato in proprio e su vasta scala questa lucrosa attività.
In realtà, osservando bene, la nuova copertura ideologica, così come sta per essere velocemente predisposta, alla meno peggio, dalle organizzazioni accademiche che se ne occupano, consiste in un innesto dell’antica ipocrisia liberale nel corpo sociale che oggi appare quanto mai disgregato. Di quelle antiche chiacchiere una sola cosa diventa importante, e di fatto lo è al di là di ogni dubbio. Gli uomini sono uguali solo in linea di principio, in pratica sono divisi in due categorie, quelli che hanno diritti e quelli che non ne hanno. Quando, per diritti qui s’intende la possibilità sostanziale di accedere alle fonti della ricchezza, di determinare movimenti trasformativi atti a ridurre le differenze nella distribuzione del reddito, in altre parole, tutto quello che permette di sperare in un avvenire migliore e meno difficile del presente.
Che questi nuovi movimenti politici, in pratica orientati a livello mondiale verso una fase di apertura gestionaria, definibile come possibile partecipazione degli strati inferiori alle condizioni di vita degli strati superiori, possano determinare una riduzione dell’apparato di potere complessivo degli Stati, resta da verificare, mentre per un altro verso è in atto l’effetto ideologico di questa prospettiva, effetto che contribuisce a creare le condizioni migliori per la strutturazione produttiva del mondo in una prospettiva postindustriale.
Il punto essenziale di questo processo è che soltanto una parte, e ben ristretta, dei produttori potrà accedere a condizioni di vita umane, intendendo per condizioni umane una sempre più ampia corrispondenza tra occasioni offerte dal sistema statale e capitalista nel suo insieme e possibilità di sfruttarle. Il resto, la grande maggioranza, dovrà trovare posto nella separazione, in quel lavoro “sporco” che gli antichi liberisti, come ad esempio Mandeville, accomunavano a quello degli schiavi. Non “sporco” nel senso dell’antico abbrutimento fisico, ma “sporco” nel senso vero e proprio del termine, nel senso cioè che sporca l’intelligenza, abbrutendola, abbassandola, riducendola a livello delle macchine, snaturandola della qualità più caratteristica dell’uomo, l’imprevedibilità.
In questo contesto, in cui l’ammodernamento ideologico cammina di pari passo con le profonde trasformazioni nella struttura produttiva, per cui ne viene fuori un sistema coordinato di processi reali e immaginari tutti basati, sincronicamente, sulla flessibilità, sull’adattamento, sulla discussione democratica e assembleare, e sul rifiuto critico di ogni autorità che non sia quella efficientista, l’antica funzione dello Stato, accentratore della gestione e della repressione, è destinata ad affievolirsi.
E questo affievolimento è nell’ordine delle cose, nello spirito dei tempi, se così vi piace.
Ma qui occorre chiedersi: È questo affievolimento un fatto positivo? La risposta, almeno per gli anarchici, dovrebbe essere positiva. E tale sarebbe stata se non fossero incorsi, in tempi recentissimi, riflessioni che ci pare utile sottolineare qui.
Cominciamo con gli aspetti positivi. Ogni riduzione nella potenza degli Stati è un movimento positivo che rende possibili maggiori spazi di libertà, sia pure ridotti, più consistenti movimenti di difesa, attese di tempi migliori, sopravvivenze se si preferisce, ma anche forme organizzative di lotta che i grandi colossi repressivi distruggono invece con facilità. Partecipare alle lotte che disgregano gli Stati è quindi un movimento positivo, e in questo ambito le lotte di liberazione nazionale sono state, purtroppo non sempre, occasioni per intaccare la monoliticità del potere e per proporre possibili linee di divergenza sociale, alternative in grado di dimostrare praticabili percorsi differenti. Spesso tutto ciò è stato travolto dal sopraggiungere di movimenti più consistenti, ristrutturazione capitalista in primo piano, sconvolgimenti imperialisti nella ripartizione del potere a livello mondiale, meccanismo dello sviluppo ineguale, ecc.
Allo stato attuale delle cose, altre considerazioni si sovrappongono alle precedenti. Non che queste siano tali da farci considerare in modo negativo le lotte di liberazione nazionale e tutti i movimenti che in un modo o nell’altro concorrono a disgregare gli Stati accentratori del passato, ma si tratta comunque di considerazioni che pongono il problema su altre basi, più adeguate ai tempi in cui viviamo.
Prima di tutto c’è da considerare i flussi internazionali che equilibrano i differenti apparati repressivi e produttivi dei singoli Stati all’interno di accordi che prevedono unioni più o meno intime, più o meno ibride, comunque sufficienti a garantire quella circolazione di dati su cui si basa, in definitiva, ogni struttura di controllo e di ordine interno. Queste superstrutture si allargheranno nei prossimi anni fino a ricostituire, su linee non tanto diverse dalle precedenti, divisioni del mondo che abbiamo già visto. Per quanto queste nuove forme divisorie si presentano imballate in carta ideologica del tutto diversa, assolvono al compito di riconsegnare l’antica potenza statale alle attuali forme in via di disgregazione. Si potrebbe ipotizzare, e non a torto, che l’elaborazione del nazionalismo come elemento ideologico connettivo di alcuni processi di disgregazione, sia uno strumento non tanto stupido messo in campo a bella posta per consentire modificazioni di struttura altrimenti impossibili. Non c’è dubbio che l’assetto produttivo mondiale oggi non tollera la presenza di grandi Stati accentrati, quindi troppo elefantiaci nei rapporti col capitale che invece guadagna sempre più in capacità di velocizzazione dei processi produttivi.
In secondo luogo, occorre tenere conto della necessità di adeguare lo strumento democratico di reperimento del consenso alle mutate condizioni produttive. Se quest’ultime producono un individuo dequalificato, che la salarizzazione precaria rende instabile non solo come capacità lavorativa ma come composizione psichica, intesa quest’ultima nel senso più largo del termine, se questo individuo, come elemento della società, della famiglia, della categoria lavorativa; dell’ambiente di svago cui appartiene, insomma in una parola, come elemento sociale, è mantenuto costantemente in condizioni di instabilità, non può poi essere obbligato a rapportarsi con una monolitica burocrazia statale che appare oggi più che mai roba d’altri tempi. Così, man mano che vengono sottratti al singolo, specialmente attraverso la scuola, gli strumenti di qualificazione culturale che avrebbero dovuto trasformarlo definitivamente da suddito in cittadino di uno Stato democratico, gli apparati statali si democraticizzano, chiamando il suddito – che tale comunque resta il cosiddetto cittadino dei diritti e delle libertà costituzionali – alla massima collaborazione. D’altro canto, non sarebbe stata possibile una ristruttura democratica degli Stati moderni senza un appiattimento qualitativo dei singoli individui, senza la rottura delle tradizionali forme organizzative del proletariato e, principalmente, senza l’annientamento di quell’unità di classe che in passato aveva dato frequenti segni di sé in movimenti se non proprio rivoluzionari, comunque capaci di frenare e disturbare i processi accumulativi del capitale.
Infine, occorre considerare il fatto che questi movimenti disgregativi operano a due livelli, di cui soltanto il secondo appare interessante da un punto di vista rivoluzionario. Il primo di questi livelli è quello ufficiale, promosso dalla classe media dei paesi più avanzati, avente lo scopo di ricostituire su basi più accettabili, in funzione dei nuovi processi produttivi del capitale, le vecchie strutture monolitiche degli Stati. E queste basi appaiono disgregate a confronto con le precedenti amministrazioni, anche perché devono per forza essere più smaliziate dal punto di vista ideologico. Questo movimento ufficiale di disgregazione degli Stati affonda le sue radici ben in profondità, muovendo da quella tesi regionalistica che faceva del decentramento amministrativo, e sotto certi aspetti anche politico, la chiave di volta di un sistema statale rigenerato e più efficiente. Il sostanziale fallimento del regionalismo, in Stati come l’Italia, buon esempio in questo campo, non deve fare illudere riguardo una inversione di tendenza. Le classi dominanti hanno bisogno di fare illusoriamente partecipare quelle dominate alla gestione della cosa pubblica. Si tratta di un bisogno vecchio quanto il mondo, ma che in questi ultimi decenni è diventato non solo una facciata spudoratamente e continuamente violata, ma una realtà imprescindibile. Il leghismo italiano, fenomeno che tanto interesse riscuote oggi non solo in Italia, deve ricondursi a questo indirizzo verso la disgregazione degli Stati monolitici del passato, e può quindi ritenersi l’erede e l’estremo razionalizzatore del vecchio regionalismo. Il passaggio tra questi due modi di gestire la cosa pubblica non è però continuo, nel senso che esiste una frattura, forse non molto importante dal punto di vista di chi considera gli Stati comunque e in ogni caso come il nemico da abbattere senza andare tanto per il sottile, ma importante per chi cerca di capire meglio la composizione del nemico per individuarne i punti deboli: e questa frattura si colloca proprio nell’innesto ideologico operato sulla semplice ed ovvia constatazione che le classi agiate delle regioni più ricche dal punto di vista economico avrebbero da guadagnare a gestire in proprio uno Stato in formato ridotto. D’altro canto, questo innesto ideologico si è rivelato, come sempre, indispensabile per coinvolgere la gente a livello emotivo, scaricando le frustrazioni delle grandi masse, che in ogni caso sono ben lontane dal benessere delle ristrette classi dominanti, sui classici simboli della diversità: il nero, l’ebreo, l’immigrato, il ladro, il violento, oppure costruendo miti nazionalistici che qualche volta rasentano il ridicolo. Ma in queste cose il ridicolo, lungi dall’essere elemento negativo, nella generalizzata assenza di luce critica, diventa elemento di coesione e di forza connettiva all’interno delle grandi masse.
Questo livello di disgregazione, pilotato e gestito dalle classi dominanti, le quali hanno tutto l’interesse a costruirsi zone privilegiate, possibili castelli teutonici all’interno dei quali arroccarsi per amministrare la loro condizione privilegiata di inclusi, tenendo a distanza e gestendo, con lo strumento principe dell’ignoranza, la costante pressione degli esclusi, si manifesta oggi a livello europeo e potrebbe domani assumere dimensioni mondiali. La disgregazione dell’impero sovietico ha determinato la più colossale spinta verso questo tipo di particolarismo, accentuandosi nelle regioni dove la specificità etnica non era stata cancellata in quarant’anni di comunanza forzata. Ed è questa specificità che si è fatta carico, quasi sempre, di sviluppare e adeguare alle condizioni del conflitto di classe in corso, l’elemento ideologico, fino a farlo pervenire alle esacerbazioni di ferocia e brutalità che è possibile vedere in atto nella ex Jugoslavia. Pur nelle diverse situazioni, e quindi malgrado l’estrema varietà dei comportamenti dei singoli Stati, emerge un andamento sufficientemente chiaro, che si può riassumere nell’ipotesi di disgregamento pilotato, oppure di passaggio dolce ad un altro tipo di gestione della cosa pubblica. La ricetta per questo passaggio è complessa ed in ogni caso, senza scendere troppo in particolari, si compone di un elemento amministrativo e di uno ideologico. Questi due elementi si compenetrano e si sostengono a vicenda, generandosi uno dall’altro, senza che né l’uno, né l’altro possano escludere eventuali ricorsi a strumenti repressivi e a gestioni temporanee del potere che oggettivamente potrebbero essere visti come un ritorno all’antico. Il pragmatismo politico non arretra davanti a piccolezze di questo genere.
Ma resta l’altro livello della disgregazione, quello che entra nella testa della gente, che opera a livelli individuali, e che lo Stato non può evitare perché obbligato a gestire la disgregazione stessa e impossibilitato a proporre modelli di comportamento e scale di valori del passato. L’unico limite che può opporre a questo venir meno del senso dello Stato è la segregazione culturale, molto più rigida ed efficace di quella fisica che siamo stati abituati a vedere in passato. Un apartheid senza precedenti, invalicabile perché fondato sull’assenza del desiderio, in quanto non si può desiderare quello che non si conosce. Ma, per il momento, e non è prevedibile fino a quando, questa disgregazione è in atto ed è parallela al venire meno del connettivo ideologico, positivo per i paesi dell’Est e negativo per il blocco occidentale, cosiddetto anticomunista. La funzione che l’internazionalismo proletario aveva nell’URSS o in Cina, faceva da contrappeso alla paura del comunismo alimentata dagli interessi padronali dell’Occidente. Scomparso tutto ciò, alle grandi illusioni subentrarono le piccole illusioni, fantasmi su scala ridotta che in qualche caso sono stati messi in opera, come per i diversi nazionalismi operanti di fatto sulla scena europea, e in qualche altro caso sono ancora in cantiere.
Non è priva d’importanza qualche riflessione sugli elementi che si trovano all’interno di questa erosione disgregativa dal basso, oggi operante negli Stati, non solo in quelli a capitalismo avanzato. Cominciamo con il tramonto dell’idea di progresso. Questo concetto, di origine illuminista, apparentemente, secondo le chiacchiere liberiste, doveva fondare lo Stato costituzionale prima e democratico poi, consentendo a tutti di contribuire al miglioramento della cosa pubblica. Solo che le illusioni del progresso, per usare il titolo di un famoso libro di Georges Sorel, servivano proprio ad alimentare le speranze di miglioramento, sia quelle a breve termine, di natura riformista, sia quelle a lungo termine, di natura rivoluzionaria. Abbracciati insieme nella medesima fantasticheria, rivoluzionari e politici riformisti condividevano l’attesa di un avvenire migliore, garantito dal movimento oggettivo della storia. Questa idea, lungi dall’essere vacua esercitazione di spiriti perdigiorno, alimentava in milioni di uomini sogni di futura abbondanza universale, di presa nel mucchio, mischiando nello stesso canestro utopia e pragmatismo gestionario. Tutto questo è finito, ed ha aggiunto tassello a tassello alla disgregazione in corso.
Su questo punto, le ideologie marxiste e liberiste si identificano. Ambedue promettevano abbondanza e lavoro per tutti, consumi generalizzati, anche se differenziati, e crescita economica esponenziale. Poi ci si accorse che la domanda non poteva sostenersi all’infinito e che i consumatori dovevano dividersi in due fasce, quella con accesso ai consumi e quella con una progressiva riduzione dei bisogni fino alla sopravvivenza. Ciò, a livello mondiale, raggiunge chiarezze allucinanti nelle condizioni dei paesi sottosviluppati, dove la gente muore di fame, di malattie, di pestilenze medievali, il tutto in contrapposizione con condizioni di vita privilegiate tipiche della classe dominante. E questi contrasti non sono soltanto lontani nello spazio, circoscritti dal deserto o dalle paludi, ma si trovano fianco a fianco nelle grandi metropoli, che rappresentano forse la prova più evidente del fallimento dell’ideologia progressista.
Nell’evolversi continuo delle condizioni sociali in questi ultimi anni si sono accentuati alcuni processi che si possono ormai considerare come veri e propri cambiamenti.
La struttura del dominio si è modificata da un rapporto netto di padroneggiamento a discrezione, in un rapporto fondato sull’aggiustamento e il compromesso. Ne è conseguito un aumento notevole della domanda di servizi nei confronti della domanda di beni tradizionali (ad esempio, quelli di consumo durevole). Ciò ha determinato l’accelerazione degli aspetti produttivi fondati sull’informatica e la relativa robotizzazione dei settori produttivi finendo per far prevalere il settore terziario (commercio, turismo, trasporti, credito, assicurazioni, pubblica amministrazione, ecc.) sugli altri settori (industria e agricoltura).
Tutto questo non significa che il settore industriale abbia perduto di consistenza o di significato produttivo, ma solo che percentualmente occuperà sempre meno lavoratori, pur restando o anche aumentando gli standard di produzione precedenti. Lo stesso discorso vale anche per l’agricoltura che vedrà una potente accelerazione dei processi di industrializzazione produttiva e che quindi potrà distinguersi dal settore industriale solo dal punto di vista statistico e non sociale.
In sostanza, la situazione si prospetta come quella di un “passaggio”, non netto e chiaro, ma come una linea di tendenza. Non esiste uno stacco tra periodo industriale e periodo postindustriale. La fase che attraversiamo è certamente quella dell’oltrepassamento di strutture produttive obsolete che si stanno ristrutturando, ma non è ancora quella della completa chiusura delle fabbriche e dell’instaurazione del regno della produzione computerizzata.
La tendenza verso la disgregazione delle unità produttive e verso la sollecitazione di piccoli nuclei indipendenti che applicano fino in fondo la logica dell’autosfruttamento all’interno del progetto produttivo industriale centralizzato, è certamente di già dominante; ma, come si conviene alle caute strategie del capitale, continuerà ad essere accompagnata da lenti aggiustamenti all’interno del settore industriale in senso tradizionale.
Questo discorso vale molto di più per una situazione come quella italiana che risulta più arretrata del modello giapponese o americano.
Strappati fuori dalle fabbriche, a poco a poco, in un processo lento e irreversibile, i lavoratori di ieri vengono proiettati in un’atmosfera di elevata competitività che cerca con ogni mezzo. di alzare la loro capacità produttiva, unico bene accettabile alla logica computerizzata dei centri produttivi.
La conflittualità capitalista polverizzata è quanto di più micidiale esista come elemento capace di spegnere l’altra conflittualità, quella rivoluzionaria, diretta a rendere irrecuperabile la contrapposizione di classe.
I maggiori guadagni degli abitanti delle “isole” produttive, la loro apparente maggiore “libertà”, la loro possibilità di autodeterminare l’orario di lavoro, le variazioni qualitative (pur sempre nella logica competitiva del mercato pilotato dai centri che forniscono le ordinazioni), tutto ciò produce il convincimento di essere arrivati alla terra promessa: il regno della felicità e del benessere. Guadagni sempre più alti e “creatività” sempre più esacerbata.
E queste isole della morte si circonderanno di barriere ideologiche e pratiche indirizzate, per prima cosa, a ricacciare indietro, nel mare tempestoso dell’impossibile sopravvivenza, tutti coloro che non ne fanno parte. Perciò il problema che si pone è proprio quello riguardante gli esclusi.
Dapprima coloro che resteranno al margine. Espulsi dal processo produttivo, penalizzati dalla loro incapacità di inserirsi nella nuova logica concorrenziale del capitale, spesso non disposti ad accettare livelli minimi di sopravvivenza assegnati da un assistenzialismo statale visto, per altro, sempre più come un rudere del passato in una situazione produttiva che tende ad esaltare le virtù dell’uomo che “si fa da sé”. Costoro non saranno soltanto le fasce etnicamente condannate a questo ruolo sociale, ma, con lo svilupparsi del cambiamento sociale di cui discutiamo, vi parteciperanno anche fasce sociali precedentemente avvolte nella soporifera salarizzazione ed ora proiettate in una situazione in veloce e radicale cambiamento. Anche i residui sostegni di cui queste fasce aggiuntive potranno godere (prepensionamento, cassa integrazione, assistenzialismi vari, ecc.), non potranno fare accettare una situazione che si farà sempre più discriminante, anche in termini qualitativi. Non dimentichiamo che il livello di consumo di queste fasce di esclusi non può essere nemmeno lontanamente paragonato con quello dei gruppi etnici mai inseriti nelle zone di salarizzazione. Ciò porterà sicuramente ad esplosioni di “malessere sociale” di tipo diverso che spetterà ai rivoluzionari raccordare con le spinte di ribellione più elementari.
Poi ci sono gli inclusi, quelli stessi che soffocheranno nelle “isole” del privilegio. Qui il discorso che minaccia di diventare più complicato si essenzializza solo se si è disposti a dare credito all’uomo e ai suoi reali bisogni di libertà. Saranno proprio i “ritornanti” da questo settore ad essere quasi sicuramente fra i più spietati esecutori della logica dell’attacco contro il capitale nel suo nuovo assetto. Andiamo incontro ad un periodo di sanguinosi scontri e di durissime repressioni. La pace sociale, sognata da un lato e temuta dall’altro, resta il mito più inaccessibile di quell’utopia del capitale che si credeva erede della logica “pacifica” del liberalismo, che puliva il salotto della poca polvere del giorno e massacrava in cucina, che si dava atteggiamenti assistenzialisti in patria e uccideva nelle colonie.
Le nuove opportunità di piccole, miserabili, oscene libertà quotidiane saranno pagate da una profonda, crudele e sistematica discriminazione nei confronti di vastissime fasce sociali. Ciò comporterà – prima o poi – all’interno delle stesse fasce privilegiate, la crescita di una coscienza dello sfruttamento che non potrà non causare ribellioni, anche se circoscritte a pochi individui, anche se limitate ai migliori. C’è da dire, infine, che manca nella nuova prospettiva capitalista un forte supporto ideologico come accadeva in passato, capace di dare sostegno agli sfruttatori, specialmente ai quadri intermedi. Il benessere per il benessere è troppo poco, specie per gruppi numerosi di individui che in un passato più o meno recente hanno sperimentato direttamente oppure semplicemente letto di utopie liberatrici, di sogni rivoluzionari e di tentativi (sia pure circoscritti e infelici) di progetti insurrezionali.
E questi ultimi non tarderanno a raggiungere i primi. Non tutti gli inclusi vivranno beatamente la felicità artificiale del capitale. Molti di loro si renderanno conto che la miseria di una parte della società avvelena il benessere della parte restante e fa della stessa libertà (circondata da filo spinato) una prigione reale.
Il progetto industriale ha assunto, in questi ultimi anni, alcune modificazioni di percorso, anche a seguito dell’innesto dei controlli statali e delle metodologie legate agli interessi politici di gestione del consenso.
Vedendo la cosa dal lato tecnico si può osservare come l’organizzazione produttiva sia in corso di trasformazione. Non è più centrale l’attività da svolgersi in un luogo preciso, ad esempio la fabbrica, ma diventa sempre più sviluppata la diffusione nel territorio, anche a notevole distanza. Ciò sta consentendo lo sviluppo di progetti industriali che tengono conto di una migliore ed equilibrata distribuzione delle unità produttive nel territorio, cancellando un aspetto degli squilibri sociali del passato: ghetti e super-concentrazioni industriali, zone ad alto inquinamento e sistematica distruzione degli ecosistemi. Il capitale guarda adesso ad un futuro ecologico, attingendo a piene mani nel grande calderone degli ambientalisti e facendosi propugnatore di una ideologia di salvaguardia delle risorse naturali che fa sembrare possibile la costruzione di una città del futuro dal “volto umano”, socialista o meno.
Il motivo reale che spinge il progetto capitalista verso queste lontane terre dell’utopia di ieri è molto semplice e niente affatto filantropico, esso si basa sulla necessità di ridurre al minimo il disagio di classe, smussando la contrapposizione effettiva dello scontro con un mieloso aggiustamento progressivo che si fonda sulla fiducia illimitata nella tecnologia.
È ovvio che le proposte più allettanti saranno fatte agli inclusi, anche per evitare – per quanto possibile – le defezioni, che saranno la vera spina nel fianco del domani capitalista in quanto i singoli soggetti che modificheranno la loro progettualità in senso rivoluzionario, se provenienti dall’ambito stesso del processo produttivo, avranno mezzi reali da mettere a disposizione della rivoluzione contro l’egemonia dello sfruttamento.
Ma questa speranza sansimonista di governare il mondo attraverso la tecnologia “buona” si rivela, fin da ora, infondata perché non prende in considerazione il problema delle dimensioni fisiche da assegnare al ghetto degli esclusi. Questi ultimi potranno essere riciclati all’interno del progetto-giardino in un miscuglio di felicità e sacrificio, ma fino ad un certo punto.
La tensione e le continue esplosioni di rabbia metteranno in serio pericolo l’utopia vogliosa degli sfruttatori. Si vedeva già da prima. I guai della concorrenza e del monopolismo minacciavano di coinvolgere le strutture produttive in una serie di “crisi” ricorrenti. Crisi di produzione, nella maggior parte dei casi. Era infatti essenziale, per la mentalità precedente, raggiungere le cosiddette “economie di scala”, e ciò era possibile solo lavorando volumi sempre maggiori di produzione riuscendo a ripartire al meglio i costi fissi. Da ciò derivava la standardizzazione dei processi produttivi; l’accumulazione in luoghi deputati delle unità produttive, caoticamente distribuite in base ad una logica colonizzatrice (a esempio le “cattedrali nel deserto” siciliane); l’uniformità del prodotto; la parcellizzazione del capitale e del lavoro; ecc.
Le prime correzioni sono venute dall’intervento massiccio dello Stato. Le opportunità aperte da questa presenza sono state diverse. Lo Stato, non più spettatore passivo, semplice “cassiere” del capitale, ma operatore attivo, “banchiere” e imprenditore.
In sostanza, diminuzione della produzione di valore d’uso e aumento della produzione di valore di scambio in termini di reperimento di pace sociale.
Il capitale ha trovato una soluzione parziale, mettendo fine al suo periodo concorrenziale. Lo Stato vi ha prestato mano, in vista di una totale trasformazione della produzione economica in produzione di pace sociale. Quest’ultimo progetto utopico è ovviamente inattingibile. Prima o poi la macchina si spezza.
Il nuovo processo produttivo – che è stato definito molte volte come postindustriale – consente un basso costo dei prodotti anche di fronte a lavorazioni di non elevati volumi produttivi; permette modifiche notevoli nella produzione, anche con nessun aumento di capitale; sviluppa possibilità mai viste prima di cambiamenti nella uniformità dei prodotti. Ciò apre orizzonti di “libertà” per le classi medie, per i quadri produttivi, per lo stesso dorato isolamento delle classi dirigenti, orizzonti che prima non erano concepibili. Ma ricorda molto la libertà del castello dei cavalieri teutonici di stampo nazista. Intorno alle mura del maniero, irto di armati, regna soltanto la pace dei cimiteri.
Nessuno dei facitori delle ideologie del neocapitalismo postindustriale si è chiesto cosa fare davanti al pericolo che verrà da quella parte.
Le future sommosse saranno sempre più sanguinose e terribili. E ancora di più lo saranno quando sapremo come trasformarle in insurrezioni di massa.
A produrre la selezione negativa nei confronti di coloro che resteranno esclusi dal castello dei cavalieri teutonici, sarà non solo la disoccupazione vera e propria, ma principalmente la mancanza della reale accessibilità ai dati. Il nuovo modello produttivo dovrà ridurre per forza la disponibilità di conoscenza dei dati. Ciò è solo in parte una conseguenza dell’informatizzazione della società. Maggiormente è una delle condizioni del nuovo dominio, programmate da almeno un ventennio e trovanti il loro culmine nella scuola di massa svuotata, da tempo, di strumenti culturali adeguati.
Come ai tempi della rivoluzione industriale l’avvento delle macchine determinò una riduzione delle capacità di autodeterminazione di grandi masse di lavoratori e quindi causò il loro intruppamento negli opifici, distruggendo la precedente cultura contadina e consegnando nelle mani del capitale una forza lavoro praticamente impossibilitata a “capire” il nuovo mondo meccanizzato che si andava profilando; così, adesso, la rivoluzione informatica innestata nel processo di aggiustamento delle contraddizioni capitaliste da parte dello Stato, sta per consegnare il proletariato di fabbrica nelle mani di un meccanismo di nuovo tipo, munito di un linguaggio che sarà comprensibile solo per una minoranza privilegiata. Il resto verrà ricacciato indietro ed obbligato a condividere le sorti del ghetto.
Il vecchio sapere, anche quello che era filtrato dagli intellettuali attraverso lo specchio deformante dell’ideologia, verrà codificato in linguaggio macchina e reso compatibile con le nuove necessità. Questa sarà una delle occasioni storiche per scoprire, fra l’altro, lo scarso contenuto reale delle balordaggini ideologiche che ci hanno propinato negli ultimi due secoli.
Il capitale tenderà ad abbandonare tutto quello che non sarà immediatamente traducibile in questo nuovo linguaggio generalizzato. I processi educativi tradizionali si svaluteranno sempre più di contenuti mettendo in mostra la loro reale (e selettiva) sostanza di merce.
In sostituzione del linguaggio verrà fornito un nuovo canone di comportamento formato da regole più o meno precise e, in linea di massima, costituito da quei vecchi processi di democratizzazione e funzionamento assembleari che il capitale ha di già imparato a controllare perfettamente. Ciò avrà la duplice utilità di mantenere occupati gli esclusi e di farli “partecipare” alla gestione della cosa pubblica.
La società computerizzata di domani potrebbe magari avere il mare pulito e una salvaguardia “quasi” perfetta delle limitate risorse dell’ambiente, ma sarebbe una giungla di divieti e di regole, con sommo raccapriccio, introiettata e trasformata in profonda decisione personale di partecipare al bene collettivo. Privi di un linguaggio di orientamento i ghettizzati non potranno più leggere tra le righe delle comunicazioni del potere e finiranno per non avere altro sbocco che la sommossa spontanea, irrazionale e distruttivamente fine a se stessa.
La stessa collaborazione degli inclusi disgustati della libertà fittizia del capitale, apportatori rivoluzionari di una sia pur piccola parte di quella tecnologia che saranno riusciti a strappare al capitale, non sarà sufficiente a costruire un ponte o a fornire un linguaggio su cui basare una sapiente e corretta controinformazione.
Il lavoro organizzativo delle future insurrezioni dovrà per forza risolvere questo problema, costruire – forse partendo da zero – i termini essenziali di una comunicazione che sta per essere interrotta e che proprio nel momento della chiusura, per reazione spontanea e incontrollata potrebbe dare vita a manifestazioni di una violenza tale che le esperienze del passato impallidirebbero facilmente.
Non si deve immaginare il ghetto come la bidonville del passato, manto di arlecchino dei rifiuti del superfluo gettato sulla sofferenza della privazione. Il nuovo ghetto, codificato dalle regole del nuovo linguaggio sarà fruitore – beninteso passivo – delle tecnologie del futuro, ed anche sarà in grado di possedere quelle rudimentali capacità manuali – ridotte all’osso – che consentono di far funzionare gli oggetti i quali più che soddisfare bisogni, sono essi stessi un grande e colossale bisogno.
Questi gesti, saranno talmente impoveriti da risultare perfettamente adeguati al complessivo impoverimento della qualità della vita nel ghetto.
Anche oggetti di notevole complessità produttiva potranno essere forniti a costi ragionevolmente bassi e pubblicizzati con quel senso panico di esclusività che coinvolge gli acquirenti ormai in preda ai progetti del capitale. Inoltre, mutate le condizioni produttive, non avremo più la ripetizione in serie dello stesso oggetto con notevoli difficoltà (specie in termini di costo) per modificazioni e sviluppi tecnologici, ma avremo (anche all’interno del ghetto) una riproduzione di processi articolati, flessibili, intercambiabili, capaci di utilizzare (a basso costo) le nuove idee di controllo e capaci in modo particolare di incidere sulla stessa domanda, orientandola e realizzando le condizioni essenziali della produzione di pace sociale.
Tale apparente semplificazione della vita, sia per gli inclusi che per gli esclusi, tale “libertà” tecnologica lascia sognare oggi gli economisti e i sociologi che – da brave persone quali sono sempre state – si lasciano andare a tratteggiare i lineamenti di una società interclassista, capace di “vivere bene” senza risvegliare i mostri della lotta di classe, del comunismo, dell’anarchia.
La caduta dell’interesse per i sindacati e lo svuotamento del significato riformista che queste organizzazioni hanno avuto in passato, il loro diventare semplice catena di trasmissione delle direttive padronali, vengono visti come prove della fine dello scontro di classe e dell’avvento della realtà interclassista, il tutto parallelamente all’avvento della società postindustriale. Ciò non ha senso per diversi motivi che vedremo più avanti. Il sindacalismo (di qualsiasi natura) ha perso il suo significato rivoluzionario (se mai lo ha avuto), ed anche quello riformista, non perché la lotta di classe sia finita, ma perché si sono profondamente modificate le condizioni dello scontro. In definitiva, siamo davanti ad una continuazione con contraddizioni sempre più elevate e irrisolvibili.
Schematicamente si possono ricostruire due fasi.
Nel periodo industriale prevale la concorrenza del capitale e un processo produttivo basato sulla fabbricazione. Il settore economico più significativo è quello secondario, il quale impiega come risorsa trasformatrice l’energia prodotta e come risorsa strategica il capitale finanziario. La tecnologia di questo periodo è essenzialmente quella meccanica e la figura del produttore di maggiore spicco sociale è quella dell’operaio. La metodologia impiegata nei progetti è quella empirica, la quale si basa sulla sperimentazione, mentre l’organizzazione del processo produttivo nel suo insieme è basata sulla crescita economica all’infinito.
Nel periodo postindustriale, verso cui ci avviamo, ma dentro cui non siamo ancora entrati del tutto, specialmente nella situazione italiana, lo Stato prevale sulla concorrenza capitalista ed impone i suoi sistemi di reperimento del consenso e di ordinamento della produzione essenzialmente a scopo di pace sociale. Al modo tecnico della fabbricazione si sostituisce l’elaborazione di dati e la trasformazione di servizi. Il settore economico preminente diventa quello terziario (servizi, appunto), quello quaternario (finanza specializzata), quello quinario (ricerca, tempo libero, educazione, amministrazione pubblica). La principale risorsa trasformatrice è l’informazione la quale risulta costituita da un sistema complesso di trasmissione dati mentre la principale risorsa strategica è data dalla conoscenza che si sostituisce lentamente al capitale finanziario. La tecnologia abbandona la componente meccanica e si trasferisce in quella intellettuale, il tipico elemento che impiega questa nuova tecnologia non è più l’operaio ma il tecnico, il professionista, lo scienziato. La metodologia impiegata nei progetti è fondata sulla teoria astratta e non più sulla sperimentazione, mentre l’organizzazione del processo produttivo è basata sulla codificazione della conoscenza teorica.
Tramonto della centralità operaia. Puntando l’attenzione sulla fase produttiva industriale il marxismo considerava fondamentale il contributo della classe operaia alla soluzione rivoluzionaria delle contraddizioni sociali. Da ciò derivava un profondo condizionamento della strategia del movimento rivoluzionario ispirato agli obiettivi della conquista del potere.
Alla base del ragionamento c’era l’equivoco hegeliano, alimentato da Marx, che la contrapposizione dialettica tra proletariato e borghesia fosse estremizzabile rafforzando indirettamente il proletariato attraverso il rafforzamento del capitale e dello Stato. In questo modo, ogni vittoria della repressione veniva letta come anticamera della futura vittoria proletaria. Il tutto in una progressiva visione – tipicamente illuminista – di costruibilità dello “spirito” nel mondo della materia.
Con modificazioni senza dubbio interessanti questa vecchia concezione dello scontro di classe è perdurata fino a ieri, almeno in alcuni sogni pieni di incubi che, di tanto in tanto, facevano i sopravvissuti ai vecchi progetti di gloria e di conquista. Sul piano teorico un’analisi critica seria di questa situazione puramente fantastica non è stata mai prodotta.
Si è solo convenuto, più o meno concordemente, che la centralità operaia è stata dislocata altrove. Dapprima, timidamente, nel senso di una diffusione della fabbrica nel territorio. Poi, più decisamente. nel senso di una progressiva sostituzione dei processi produttivi terziari al classico secondario.
Anche gli anarchici hanno avuto le loro illusioni, ed anche queste sono tramontate. Non hanno mai avuto, per la verità, quella della centralità operaia, però spesso hanno visto fondamentale il ruolo del lavoro, con una posizione trainante dell’industria nei confronti del settore primario (agricoltura). Ad alimentare queste illusioni era l’anarcosindacalismo.
Gli ultimi fuochi in questo senso si sono visti con la rinascita e il successivo spegnimento degli entusiasmi per la CNT spagnola risorgente dalle ceneri, e sono stati tanti, alimentati in modo particolare da coloro che oggi appaiono i più radicali intraprenditori delle nuove “vie” dell’anarchismo riformista.
La concezione di fondo, che alimentava questa forma di centralità operaia (diversa da quella dei marxisti, ma non tanto diversa quanto comunemente si crede), era l’ombra del partito. Il movimento anarchico, nella sua gran parte, ha agito per tanto tempo come organizzazione di sintesi, quindi con alcune delle pesantezze del partito. Certo, alcuni compagni potrebbero obiettare che queste affermazioni sono troppo generiche, ma non possono negare che la mentalità che regge il rapporto di sintesi che un’organizzazione anarchica specifica stabilisce con la realtà esterna di movimento sia un rapporto vicino a quello classico del “partito”.
Le buone intenzioni, da sole, non bastano.
Ecco, questa mentalità è tramontata. Non solo nei compagni più giovani che vogliono un rapporto aperto e informale col movimento rivoluzionario, ma, cosa più importante, è tramontata nella realtà sociale stessa.
Se le condizioni produttive tipiche dell’industria rendevano ragionevole una lotta sindacalista o una strategia impostata sull’organizzazione di sintesi, oggi, in una realtà profondamente modificata, in una prospettiva postindustriale, l’unica strategia possibile per gli anarchici è quella informale, cioè di gruppi di compagni che si uniscono con obiettivi precisi, in base a scelte di affinità, contribuiscono a creare nuclei di base diretti a raggiungere scopi intermedi e, nel frattempo, costruiscono le condizioni per trasformare le situazioni di sommossa in condizioni insurrezionali.
Il partito del marxismo è morto. L’organizzazione di sintesi degli anarchici pure. Quando leggo critiche come quella sviluppata dagli ecologisti sociali, i quali parlano della morte dell’anarchismo, mi rendo conto che si tratta di un equivoco linguistico, oltre che di una scarsa capacità di approfondire i problemi. Quello che è morto per loro – ed anche per me – è l’anarchismo che pensava di essere il punto di riferimento organizzativo della prossima rivoluzione, che vedeva se stesso come struttura di sintesi diretta a riassumere tutte le molteplici forme in cui si concretizza la creatività umana diretta a spezzare le strutture statali di consenso e repressione. Quello che è morto è l’anarchismo statico delle organizzazioni tradizionali, fondate sulle pretese rivendicative e quantitative. La speranza di vedere la rivoluzione sociale come qualcosa che deve necessariamente risultare dalle nostre lotte si è rivelata infondata. Essa può esserci e può anche non esserci.
È morto il determinismo, e la legge cieca di causa ed effetto è morta con esso. I mezzi rivoluzionari che impieghiamo, ivi compresa l’insurrezione, non conducono necessariamente alla rivoluzione sociale. Nella realtà non esiste il modello causale tanto caro ai positivisti del secolo scorso. Proprio per questo motivo la rivoluzione diventa possibile.
Riducendo i tempi di trasferimento dei dati si ottiene un’accelerazione nelle decisioni. Azzerando questi tempi (come avviene quando si parla di “tempo reale”), le decisioni programmatiche non vengono accelerate, ma trasformate. Sono qualcosa di diverso.
Modificando i progetti, anche gli elementi dell’investimento produttivo si modificano trasferendosi dal capitale tradizionale (principalmente finanziario) al capitale del futuro (principalmente intellettuale).
La gestione del diverso è uno degli elementi di base del tempo reale.
Ma il potere, perfezionando il rapporto tra politica ed economia, frenando le contraddizioni concorrenziali, organizzando il reperimento del consenso, e, cosa molto più importante, programmando tutto ciò in una prospettiva di tempo reale, taglia definitivamente fuori una grossa fetta della società: la parte degli esclusi.
La modificazione nella velocità delle operazioni produttive determinerà principalmente una modificazione culturale e linguistica. Ed è qui che si colloca il pericolo maggiore per i ghettizzati.
Per negare legittimità al potere e produrre “comportamenti diversificati” occorre avere una comunità di linguaggio, se non proprio di interessi. La stessa cosa faceva il partito e lo stesso facevano i sindacati. La comunità di linguaggio si traduceva in contrapposizione fittizia di schieramenti di classe, caratterizzati dalla richiesta di miglioramenti e dalla resistenza a darli.
Ma il chiedere qualcosa presuppone una “comunità” con chi detiene la cosa che si vuole chiedere. Adesso il progetto repressivo globale è diretto a recidere questa comunità. Non facendo ricorso necessariamente alle mura delle carceri speciali, ai quartieri ghetto, alle città satelliti, alle grandi zone industriali; ma, più semplicemente, decentrando la produzione, migliorando i servizi, ecologizzando la mentalità produttiva, pur nella più assoluta segregazione degli esclusi. E questa segregazione si otterrà privandoli progressivamente del linguaggio comune che fino ad oggi essi avevano con l’altra parte della società. Non si saprà più cosa chiedere.
Il reperimento del consenso era fondato, in un’epoca ancora definibile come industriale, su di una possibile partecipazione ai benefici produttivi. In un’epoca in cui le possibilità di modificazione del capitale sono praticamente infinite, proprio per realizzare al meglio questa prospettiva, il binomio capitale-Stato avrà bisogno di un linguaggio suo, separato da quello degli esclusi.
L’inaccessibilità al linguaggio dominante costituirà una segregazione ancora più efficace dei confini tradizionali del ghetto. La difficoltà sempre crescente di attingere il linguaggio dominante renderà quest’ultimo, via via, sempre più difficile, fino a farlo diventare assolutamente “altro”. Da quel momento esso sparirà dai desideri dell’escluso, rimanendo completamente ignorato. Da quel momento gli inclusi saranno “altro” per gli esclusi, e viceversa
Nel progetto repressivo questa estraneità è essenziale. I concetti fondamentali del passato, come quelli di solidarietà, di comunismo, di rivoluzione, di anarchia, trovavano un fondamento propositivo nella riconosciuta importanza del concetto di uguaglianza. Ma per i cavalieri teutonici abitanti del castello, gli esclusi non saranno uomini, ma semplici cose, oggetti allo stesso modo in cui per i nostri progenitori gli schiavi erano semplici cose che si acquistavano e si vendevano.
Noi non avvertiamo un sentimento di uguaglianza nei riguardi del cane, e ciò accade perché questo animale si limita ad abbaiare, cioè non “parla” il nostro linguaggio. Per tale motivo possiamo volergli bene, ma lo sentiamo per forza “altro” e non ci diamo molto pensiero della sua sorte, almeno non ce ne diamo a livello dell’insieme di tutti i cani, preferendo affezionarci al cane che ci fornisce i servizi la condiscendenza, l’affetto o la ferocia verso i nemici.
Lo stesso accade nei riguardi di tutti coloro che non hanno il nostro stesso linguaggio. Da notare che non bisogna qui confondere “linguaggio” con “lingua”. La nostra tradizione progressista e rivoluzionaria ci ha fatto capire che tutti gli uomini sono uguali, a prescindere dalle differenze di pelle e di lingua. Qui si tratta invece di un possibile svolgimento del progetto repressivo nel senso di sottrarre agli esclusi la possibilità stessa di comunicare con gli inclusi. Riducendo di molto la fruibilità della parola scritta, sostituendo via via i giornali e la carta stampata con la parola trasmessa via cavo, con le immagini, i colori e la musica, il potere di domani potrebbe costruire un linguaggio adatto solo agli esclusi, i quali, a loro volta, elaborerebbero diversi modi, anche creativi, di riproduzione linguistica, ma sempre all’interno del proprio codice, del tutto tagliati fuori da ogni contatto col codice degli inclusi, e quindi da ogni possibile comprensione del mondo di quest’ultimi. E dalla mancanza di comprensione al disinteresse e alla chiusura mentale, il tragitto è breve.
In questo senso il riformismo è sulla strada per morire. Non saranno possibili “rivendicazioni”, perché non si saprà cosa rivendicare di ciò che appartiene ad un mondo che ha cessato di interessarci o di dirci qualcosa di comprensibile. Tagliati fuori dal linguaggio degli inclusi, gli esclusi saranno di conseguenza tagliati fuori anche dalla tecnologia elaborata dai primi. Vivranno forse in un mondo migliore, più respirabile, con meno pericoli di conflitti apocalittici, con un progressivo affievolirsi delle tensioni su base economica, ma con un aumento delle tensioni su base irrazionale.
Dalle zone più periferiche del pianeta, dove la penetrazione del progetto di sfruttamento malgrado il suo “tempo reale” troverà sempre ostacoli di natura etnica e geografica; alle zone più centrali, dotate di un più avanzato grado di rigidità nella divisione di classe, ci si allontanerà dalla conflittualità su base economica verso una conflittualità di natura irrazionale.
Gli inclusi e i loro progetti di controllo potranno perseguire lo scopo di ottenere consenso riducendo le difficoltà economiche degli esclusi, potranno anche fornire loro linguaggi prefabbricati diretti all’utilizzo parziale e sclerotizzato di una parte della tecnologia dominante, potranno anche permettere una migliore qualità della vita, ma non potranno impedire gli scoppi di violenza irrazionale, quella che nasce dal sentirsi inutili, dalla noia e dalla mortale atmosfera del ghetto.
I movimenti di massa che tanto impressionano alcuni nostri compagni oggi, tenendoli desti per la loro pericolosità (e inutilità, a loro dire), indicano lo sviluppo più ragionevolmente prevedibile delle lotte di domani.
Molti giovani non sono più in grado – praticamente da adesso – di pervenire ad una valutazione critica della situazione in cui si trovano. Privati di quel minimo di cultura che una volta la scuola forniva, bombardati da messaggi fondati su contenuti di violenza gratuita e senza scopo, sono spinti in mille modi verso una ribellione inconsulta, irrazionale, spontanea e priva di quegli obiettivi “politici” che le generazioni precedenti credevano di vedere chiaramente.
I “luoghi” di queste esplosioni collettive e i modi sono molto diversi. Le occasioni anche. In ogni caso però è ripercorribile all’indietro un tragitto di insofferenza alla gestione di morte che l’accoppiata capitale-Stato vuole imporre.
È del tutto inutile spaventarsi davanti a simili manifestazioni perché mancanti di quelle chiavi di lettura che la tradizione ci aveva insegnato essere l’elemento indicatore delle istanze rivoluzionarle nei movimenti di massa.
Non si tratta di spaventarsi ma di passare all’azione prima che sia troppo tardi.