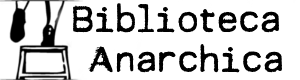Titolo originale: Abondance et dénuement dans les société primitives, in ‘La Guerre Sociale’, n. 1, aprile 1977.
Pubblicato su “Anarchismo” nn. 23-24 settembre-dicembre 1978, pp. 272-284
Prima edizione in volume: novembre 2013
La guerre sociale
Abbondanza e miseria nelle società primitive
Abbondanza e miseria nelle società primitive
Nutrimento, miseria e mobilità
Nota introduttiva
Ambedue presenti, l’abbondanza e la miseria, caratterizzano le società cosiddette primitive. Questo testo documenta agevolmente tale realtà, lontano dai fumi teorici di un’antropologia tutt’ora in corso di liberazione dalle iniziali ipoteche razziste.
Forse nulla di ciò, anche se osservato nelle sue pieghe più recondite, può essere veramente utile per la nostra futura, indispensabile, liberazione dalle catene della proprietà e dello sfruttamento. Eppure c’è una piccola luce, una capacità di cui non siamo nemmeno in grado di immaginare la portata liberatoria, quella di godere della propria vita, di non correre avanti e indietro come dissennati soddisfacendo impegni privi di senso, diretti solo a farci sopravvivere tra scadenze, promesse, illusioni e imbrogli. Vale la pena di essere vissuta una vita come la nostra? Una vita in cui non abbiamo fatto altro che andare dietro alla coda dell’asino che ci precede in quanto anche noi siamo legati con lo stesso basto alla stessa ruota per mandare avanti lo stesso mulino del cui prodotto ci viene dato quel tanto che basta per non morire?
In questo ci deve essere per forza qualcosa di sbagliato. E ciò lo devono ammettere non solo tutti quelli che sentono bruciare le proprie spalle sotto la sferza del padrone, ma perfino gli stessi padroni con il braccio dolorante per l’eccessivo uso della frusta.
Non è certo da un documento come questo che si può aspettare una luce su tanto groviglio di inveterati problemi, eppure la sua lettura produce lo stesso un senso di rabbia, di rabbia contro la nostra comodità e la nostra pigrizia.
Quando cesseremo di considerarci civilizzati?
Quando ci metteremo sotto i piedi le nostre sacrosante verità?
Trieste, 14 novembre 2011
Alfredo M. Bonanno
Abbondanza e miseria nelle società primitive
La storia dell’umanità è tradizionalmente concepita come un progresso più o meno continuo sul cammino del benessere e della produttività del lavoro. Il benessere e la produttività sono legati perché è dal rendimento del lavoro che scaturiscono la quantità dei beni prodotti e, anche, il tempo che si può liberare e consacrare alle attività del divertimento e della cultura. Man mano che – grazie alle scoperte – vedono la luce tecniche, utensili, macchine più efficaci, la sorte degli uomini migliora.
Così i tempi preistorici, in cui l’uomo si presenta nudo e disarmato davanti ad una natura ostile, non possono che essere un’epoca di terribile miseria. E se qualche volta ci troviamo a lamentarci delle contrarietà della vita moderna, un rapido colpo d’occhio al passato dell’umanità, dove – senza attardarci alle carestie e alle epidemie del medioevo, – ci immergiamo fino al fondo delle caverne in cui vivevano i nostri lontani antenati, e questo ci è sufficiente per ritornare al buon senso e farci meglio apprezzare le nostre ovattate condizioni di esistenza. Immaginiamo l’uomo della pietra. Egli è vicino a un fuocherello, lo stomaco vuoto e di cattivo umore, di ritorno da una giornata di caccia faticosa e infruttuosa. Un po’ più indietro, tremanti e terrorizzati, la sua donna e i figli. Se il nostro uomo – possiamo considerare questo bruto come un essere umano? – è tornato con le pive nel sacco, non bisogna meravigliarsene. Come immaginare che egli possa avere la meglio di fronte ai terribili mammuth, alle tigri feroci... Anche se ha avuto la fortuna di non imbattersi in quei giganteschi dinosauri che disseppelliamo dalle più antiche epoche, e a cui facciamo fare un salto di centinaia di milioni di anni per rendere lo scenario più vero e più terribile. Disgrazia dei deboli in quelle società dove a contare sono solo i rapporti di forza! Questi uomini che si terrorizzano reciprocamente, e che – spinti dalla fame – non esitano a divorarsi a vicenda, sono loro stessi terrorizzati dalla natura che li schiaccia. Ricorrono alla magia e ad altre pratiche infernali con le quali tentano di propiziarsi le forze ostili, e finiscono per rendere la loro sorte ancora più tragica.
Capiamo che hanno dispiegato le loro risorse di intelligenza per sfuggire a questo inferno. Anche se possiamo chiederci come poteva loro rimanere il tempo e le disponibilità di spirito per pensare.
Questa visione delle cose è delirante, sia che si presenti sotto la forma ingenua e figurata dei manuali scolastici e delle storie a fumetti, sia nel linguaggio disseccato dei sapienti. Questo mondo di carestia, questi uomini sopraffatti dalla necessità economica, questa giungla sociale, questo universo della magia, questa era della sopravvivenza, non si situa nella preistoria. Essa costituisce lo schermo nel quale la nostra società proietta la sua verità, verità che vorrebbe far passare per la natura umana stessa.
Di uomini preistorici ne esistono ancora nel Grande Nord, nella foresta amazzonica, nei deserti australiani. Il loro modo di vivere non corrisponde in nulla a questa rappresentazione classica dell’età della pietra. Spesso sono calmi e rilassati, hanno fiducia nella natura ed hanno il senso della comunità.
Può sembrare che sia stato facile, a partire dagli studi della realtà esistente e non più della ricostruzione sulla base di fragili indizi, farsi un’idea della realtà preistorica. Invece no. Osservazioni svariate e numerose di popoli primitivi ci hanno portato a controverità rappresentative soltanto dei pregiudizi dell’Occidente, non della realtà. Sovente le teorie più avevano pretese di scientificità più erano false. Le narrazioni più interessanti, più giuste e più divertenti, generalmente sono quelle dei missionari. Essi facevano la morale ai selvaggi ma non nascondevano di meravigliarsi della loro buona salute, dopo aver classificato come invivibili le loro condizioni di esistenza. Dopo un primo periodo in cui viaggiatori e pensatori scoprono e – qualche volta – si estasiano di fronte alle strane usanze, arriva il tempo della sufficienza e della debilità saccente. La realtà primitiva deve essere sacrificata sull’altare del culto del Progresso.
I pregiudizi non hanno il loro solo fondamento nella testa degli ideologi. Nascono anche dalle condizioni del contatto con i popoli primitivi. Quelli incontrati erano, spesso, già vittime della civilizzazione. Ci sono difficoltà grosse a stimare le risorse di queste contrade straniere e all’apparenza desertiche, dove generalmente evolvono solo i cacciatori. I contatti sono spesso brevi e superficiali. Poi vi sono le difficoltà del linguaggio. Per di più gli studiosi si accontentano di fare della teoria basandosi sulle narrazioni altrui, questo è durato fino alla guerra del 1914 e allo studio di Malinowsky. L’interesse era incentrato sui comportamenti magici e religiosi, sui miti piuttosto che sull’attività “produttiva” degli indigeni, e sul loro rapporto con la natura.
Gli umani non vivono più male perché sono appena usciti da un’epoca arretrata o perché dispongono di una tecnologia rudimentale. Possiamo persino essere tentati di pensare il contrario. Un esempio è significativo, quello dei Tasady: la popolazione più primitiva che sia mai stata osservata, scoperta recentemente quando viveva ancora isolata dal resto dell’umanità nella giungla delle Filippine. I Tasady ignorano persino la caccia, vivono semplicemente della raccolta e di una pesca rudimentale. I loro utensili non sono molto elaborati, visto che si contentano di montare pietre e bambù per farne delle asce.
Eppure questi super-primitivi sfidano la civilizzazione moderna con la loro felicità. Come scrive F. de Clozet commentando il rapporto degli antropologi: “...I Tasady presentano tutti i tratti della felicità. Non proprio di una felicità autenticamente umana quale noi potremmo pretendere, ma di un certo equilibrio così difficile da raggiungere nelle società industriali. Essi ignorano anche la gerarchia, l’inuguaglianza, la proprietà, l’insicurezza, la solitudine, le frustrazioni. Sono perfettamente integrati al loro ambiente naturale e possono ricavarne un nutrimento sufficiente lavorando solo qualche ora al giorno. La loro vita sociale sembra essere esente da antagonismi, tensioni e animosità. Passano la maggior parte del loro tempo a giocare, discutere o a fantasticare. Eppure questa felicità, più vicino all’animale che all’uomo, perviene a imporre il rispetto ai civilizzati.
“Le foto scattate dagli antropologi mostrano i Tasady che frantumano i cuori di palma, che dissotterrano i tuberi, che fanno bagni nelle acque, i bambini ridenti che giocano tra gli alberi. Tutti i visi appaiono sorridenti e distesi. Singolare contrasto con le facce chiuse dei parigini nel metrò, la fronte ansiosa dei disoccupati che leggono le inserzioni, l’andatura febbrile degli impiegati che scappano dagli uffici alle 17,30. In tutta coscienza, abbiamo il diritto di ‘civilizzare’ i Tasady?
“Come non rivoltarsi contro un tale sentimento? Come accettare che ogni progresso compiuto dopo il paleolitico non ci abbia apportato nessun vantaggio decisivo sul solo terreno che conta: la felicità?”.
Poiché la tecnica lo consente, vanno a raccogliere le immagini della “felicità” primitiva in elicottero, nel cuore della giungla, e le diffondono in technicolor. I rotocalchi come “Stern” forniscono ai loro lettori dalle “facce chiuse” e “dall’andatura frettolosa” questa felicità inaccessibile, con relativa documentazione fotografica.
Lo sguardo o la riflessione simpatica, nostalgica e certe volte colpevolizzata sui primitivi, sta diventando di moda. Per una comprensione sufficiente del loro modo di vivere, non basta considerare soltanto i suoi vantaggi e i suoi obblighi. Sono portatori di molti pregiudizi e finiscono per riallacciarsi alla mitologia del buon selvaggio, povero ma felice perché sa accontentarsi di ciò che dispone. La lezione è valida per i nostri insaziabili, e per ciò stesso, infelici proletari. Il primitivo è rappresentato come l’Altro, che l’uomo moderno amerebbe tanto essere, sebbene non è tanto possibile né – meno che mai – augurabile. Il paleolitico è visto come un modo di esistere differente e non come un momento della storia umana. D’altronde, le spiegazioni storiche si fanno rare. Non sono forse inficiate da razzismo visto che il selvaggio viene posto ad un gradino inferiore al nostro nella scala dell’evoluzione?
Quando l’ideologia e il modo di vita occidentali (ossia capitalisti) sono in crisi, quando la “natura” più è minacciata più si vende bene, giunge il momento che i primitivi, rimossi e distrutti, non disturbano più, e si può passare alla loro riabilitazione. Questo atteggiamento che accusa il macchinismo, il progresso, la storia, l’eccesso (o il loro cattivo uso), non fa che nascondere con le sue nostalgie il comunismo futuro.
Quel che ci interessa, non è il modo di vivere dei primitivi, l’immagine della felicità nella semplicità, l’innocenza, se non addirittura la povertà. Lo studio dei primitivi ci mostra quel che può essere una certa forma d’equilibrio e di armonia sociale, quel che può essere l’adattamento e l’utilizzazione dell’ambiente da parte dell’uomo, quel che può essere un’abbondanza che non sia la ricchezza borghese, quel che può essere un uomo che non sia l’uomo economico. Tutto questo, non può essere ricondotto ad una questione di livello tecnico più o meno ridotto, o a bisogni più o meno limitati. Il nostro punto di vista è soprattutto storico e vede nel comunismo primitivo, come nel comunismo superiore, due momenti distinti e apparentati dell’evoluzione umana. Vedremo come han bisogno l’uno dell’altro.
La caccia e il raccolto
Il modo fondamentale che differenzia l’attività produttiva del selvaggio dal salariato – e delle differenti categorie di schiavi che l’hanno preceduto – è che, per prima cosa, la ricerca della sussistenza – anche se ha le sue costrizioni – non è sentita come una condanna. Non è un modo fra i tanti di guadagnarsi la vita ma parte integrante della sua esistenza. La caccia è sia gioco che lavoro. Piacere o prova, non è un brutto momento a cui si tenta di sfuggire, o che si tenta di scaricare sugli altri.
Così per gli Indiani Guayaki: “La caccia non è mai subita come una corvée. Anche se è l’occupazione pressoché esclusiva degli uomini, il loro più serio impegno giornaliero, essa è sempre praticata come uno ‘sport’... La caccia è sempre un’avventura, a volte rischiosa, ma costantemente esaltante. Certo, è bello estrarre da un alveare il bel miele odorante, o fendere una palma e mettere a nudo il delizioso guchu depositato dagli scarabei. Ma, in questo caso, è tutto scontato, non c’è mistero, nulla d’imprevisto: la routine. Mentre braccare gli animali nella foresta, gareggiare in astuzia con loro, avvicinarglisi a portata d’arco senza lasciar presentire la propria presenza, sentire il sibilo della freccia che fende l’aria, poi il colpo secco al termine della traiettoria nel fianco della bestia: tutte queste, sono gioie conosciute, molte volte provate eppure ogni volta diverse, come se si trattasse della prima caccia. Gli Achè non abbandonano la bareka. Non si chiede loro altro, ed è la cosa che amano più di tutte. Sono così, e sotto questo aspetto, in pace con se stessi”.
La cosa più sorprendente, è che questi selvaggi consacrano poco del loro tempo alla ricerca del nutrimento. Così, non soltanto amano quel che fanno, ma sanno anche non abusarne.
Questo si concilia col punto di vista secondo il quale la storia si confonde con l’accrescersi dell’efficientismo produttivo. L’età dell’oro dei loisir sarebbe dietro di noi, alle nostre spalle. Se i primitivi non hanno inventato la civilizzazione e costruito le piramidi, non è perché mancava loro il tempo, ma più probabilmente perché non ne vedevano la necessità.
I loisir di cui dispongono i cacciatori assumono più rilievo quando si considera che vivono in regioni aride, quelle in cui il loro modo di produzione è stato rifiutato dagli agricoltori e dai colonizzatori.
La durata e l’intensità dell’attività di queste popolazioni dipendono evidentemente dall’ambiente e dalla sua ricchezza. Tuttavia sembra che non facciano eccezione alla regola quei cacciatori che abitano zone molto ostili all’uomo, per esempio gli esquimesi polari. J. Malaurie, che ha vissuto con gli esquimesi di Thulè, permeati della necessità di resistere e di forzare una natura difficile, può tuttavia scrivere:
“L’Esquimese dorme molto. Più durante l’inverno che in estate – egli si iberna, come gli orsi – ma sempre moltissimo, se si considera che passa metà della sua esistenza a dormire, e sonnecchiare. Se disponessi di cifre, direi che l’altra metà soltanto – e saremo stupiti di un tempo così ristretto per una popolazione che ci dipingono come molto attiva – si suddivide così: un terzo in polars (visite), un terzo in spostamenti verso i luoghi della caccia, un terzo soltanto in caccia vera e propria. Pigrizia, marchio della saggezza. È così che una società si protegge fisicamente contro i rigori di una vita dura.
“Solo i giovani fanno naturalmente eccezione a questo ritmo di vita equilibrato: una grossa parte del loro tempo è stagionalmente occupata a soddisfare i loro slanci sessuali; in primavera e in estate corrono dietro le ragazze, fanno loro la posta da un casolare all’altro, studiando i motivi più svariati: pretesti di cacciatori”.
Marshall Shalins in La Premiere société d’abondance, si propone di dimostrare l’efficacia dell’attività dei primitivi contro i pregiudizi correnti. Si basa soprattutto su due studi, uno sugli Australiani della Terra d’Arnhem, l’altro sulla sezione Dobe dei Boscimani Kung. Forniscono indicazioni sull’utilizzazione del tempo da parte delle rispettive popolazioni. E sono confermati da numerose altre osservazioni che dimostrano che i popoli più primitivi sono quelli che consacrano la maggior parte del loro tempo al rilassamento e al riposo. “Presso gli abitanti della Terra d’Arnhem, rifugiati nella foresta, la ricerca del nutrimento occupava un posto molto irregolare da un giorno all’altro. Vi si dedicano quattro o cinque ore a testa per procurarsi e per preparare il cibo; in altre parole, meno ore di fatica di quelle di un operaio dell’industria – quando è sindacalizzato. Il tempo consacrato ogni giorno ai loisir, vale a dire al sonno, smisurato... Oltre alla poca quantità di lavoro che è richiesta dalla produzione del nutrimento, bisogna anche sottolineare il suo carattere irregolare. La ricerca della sussistenza è discontinua. Si ferma quando hanno raccolto a sufficienza per le necessità del momento, e questo lascia loro molto tempo libero. Abbiamo a che fare con un’economia dagli obiettivi ben definiti, ottenuti in maniera irregolare, e che comporta un ordinamento del lavoro anch’esso irregolare. In ogni caso, anziché forzare fino ai limiti estremi le risorse naturali e le energie umane, sembra che questi Australiani restino al di qua delle loro possibilità economiche effettive...”. Aggiungiamo ancora che la caccia e il raccolto degli aborigeni della Terra di Arnhem non erano faticosi. Il giornale dell’esploratore indica che ognuno misurava i suoi sforzi; una volta soltanto, possiamo leggere che un cacciatore era “completamente esausto”. La gente stessa non considera affatto che il procacciamento del cibo sia una cosa pesante.
Non lo considerano affatto come un lavoro spiacevole di cui bisogna sbarazzarsi al più presto, né come un male necessario che si tenta di evitare fino all’ultimo momento; d’ altronde, certi Australiani, gli Yir-Yiront, utilizzano lo stesso termine per indicare sia il lavoro che il gioco...
Oltre al tempo dedicato ai rapporti sociali generali, chiacchierate, ciarle, ecc. (sovente tra il compimento di due attività ben definite, e durante la cottura dei cibi), si passa anche qualche ora della giornata a riposarsi e dormire. Quando gli uomini sono al campo, dormono in media – dopo il pranzo – un’ora, un’ora e mezza, e qualche volta anche di più.
Hanno anche l’abitudine di dormire al ritorno della pesca e della caccia, sia al loro arrivo che durante la cottura della cacciagione. A Hemple Bay, gli uomini dormono quando rientrano presto; fanno a meno di questo riposo se raggiungono il campo dopo le quattro del pomeriggio. Quando rimangono al campo tutto il giorno, dormono di tanto in tanto, senza dimenticare la siesta dopo pranzo. Quando le donne si dedicano al raccolto nella foresta, sembra che si riposano più frequentemente degli uomini se rimangono al campo tutto il giorno, dormono ugualmente di tanto in tanto, a volte assai a lungo.
Richard Lee, invece, in un eccellente studio, si è dedicato alla sezione Dobe dei Boscimani Kung, vicini dei Nyae Nyae, quegli stessi a proposito dei quali, Lorna Marshall ha manifestato riserve su ciò che concerne le loro risorse alimentari. I Dobe abitano una regione del Botswama in cui i Boscimani Kung si sono stabiliti da almeno un secolo, ma dove le forze della disgregazione solo ora cominciano a farsi sentire (il metallo è tuttavia conosciuto dai Dobe dal 1880-1890). Lo studio di Lee, durò quattro settimane, in luglio-agosto 1964, durante una stagione arida, in un campo in cui la popolazione ammontava al suo effettivo medio (41 individui). L’osservazione fu condotta in un momento in cui, nel ciclo alimentare annuale, le condizioni divengono meno buone, dunque dovrebbe fornirci indicazioni assai caratteristiche sulle difficoltà alimentari.
Malgrado deboli precipitazioni atmosferiche annuali (dai 15 ai 25 cm.), Lee trovò nella regione dei Dobe “una abbondanza di vegetazione sorprendente”. Egli annota che le risorse alimentari di questo popolo sono abbondanti e diversificate, in particolare i magettinut, di alto valore energetico, sono “così abbondanti, che ogni anno ne marcivano a milioni per terra, perché non potevano essere raccolti tutti”. Le informazioni relative al tempo dedicato al procacciamento dei cibi, somigliano sorprendentemente ai risultati osservati in Terra di Arnhem.
Presso i Boscimani Dobe, una giornata media di caccia e di raccolto può nutrire fino a quattro o cinque persone. Approssimativamente, il boscimano è un produttore di cibo efficiente quanto il contadino francese tra le due guerre, ed è più efficace del contadino americano di prima del 1900. Certo, un tale paragone può ingannare, ma in effetti è meno ingannatore che sorprendente. Sull’insieme della popolazione dei Boscimani liberi che Lee ha avvicinato, il 61,3% (152 su 248) sono effettivamente produttori di cibi, gli altri: o troppo giovani o troppo vecchi per poter contribuire efficacemente a questo lavoro. In tal modo, il rapporto fra produttori di cibo e popolazione globale è in effetti di 3 a 5, o di 2 a 3. Ma questo 65% della popolazione “lavorava 36% del tempo, e il 35% della popolazione non lavorava affatto!”.
L’adulto medio dobe passa solo 2 giorni e mezzo alla settimana per soddisfare i suoi bisogni alimentari e quelli delle persone a suo carico. Supponiamo – in mancanza di informazioni più dettagliate – che una giornata di lavoro dura dieci ore (ciò è senz’altro eccessivo per il lavoro propriamente detto, ma in questo modo teniamo conto del tempo dedicato alla cottura, alla riparazione delle armi, ecc.). Un boscimano adulto passerebbe dunque in media 25 ore alla settimana a produrre dei cibi. Questo significa: 3 ore e 34 minuti al giorno. Questa cifra è quasi simile ai risultati ottenuti per gli abitanti della Terra di Arnhem. Lee ha calcolato che la produzione alimentare giornaliera pro-capite, era di 3140 calorie durante il suo periodo d’osservazione. Notiamo che Lee valuta in 1975 calorie per persona il fabbisogno dei Boscimani, tenendo conto del peso medio dei Dobe, della natura delle loro occupazioni e della ripartizione della popolazione per età e per sesso. Una parte dei cibi eccedenti era destinata, probabilmente, ai cani che mangiavano i resti.
Questi dati indicano che gli sforzi, benché modesti, dei Boscimani Kung bastano ampiamente per soddisfare i loro fabbisogni alimentari. Possiamo concludere che i Boscimani non conducono – come correntemente si ritiene – una esistenza inferiore al livello normale, o addirittura ai limiti della carestia.
In Africa, presso gli Hadza – che per paura del lavoro preferiscono non passare all’agricoltura – “la maggior parte degli animali abbattuti è opera di una piccola percentuale di uomini particolarmente abili nella caccia. Parecchi adulti – io penso circa il 50% – ammazzano in media un solo aninale di grossa taglia per anno. La caccia non è praticata né regolarmente né metodicamente. Durante la stagione secca i giochi d’azzardo continuano, praticamente senza interruzione, per tutta la giornata, e non è raro che nessuno parta per la caccia. Durante la stagione umida, generalmente gli uomini partono tutti i giorni ma piuttosto per cacciare gli hypax che la grossa selvaggina (Woodburn)”.
Verso il 1840, un pioniere era giunto a porsi la domanda: “come faceva questa brava gente a passare il tempo prima che (la sua) spedizione arrivasse, e prima che avesse loro insegnato a fumare... Una volta appresa questa arte (...) tutti avevano una occupazione: dividevano le ore di loisir tra la preparazione e utilizzazione delle pipe e gli approcci per elemosinarmi del tabacco”.
Su un altro continente, padre Baird, nella sua relazione del 1616, descriveva così gli Indiani Micmac: “... Per godere bene questo loro appannaggio, i nostri silvicoli se ne vanno per questi luoghi, con il piacere della peregrinazione e della passeggiata, la qual cosa è facilitata perché hanno il mezzo di trasporto e la grande comoditò delle canoe, che sono piccole imbarcazioni... vanno così veloci con le pagaie, che con tutta comodità e piacere, in un giorno arrivano a fare trenta o quaranta leghe: tuttavia non è dato vedere questi selvaggi in agitazione poiché le loro giornate non sono altro che un bel passatempo. Non hanno mai fretta. Ben diversi da noi che non sapremmo mai fare nulla senza fretta e oppressione...”.
Nutrimento, miseria e mobilità
I risultati di questa attività ridotta o di questa vita indolente sono soddisfacenti? I primitivi non sono vittime della loro imprevidenza e della loro mancanza di coraggio? Non farebbero meglio a dedicare il loro tempo libero allo sviluppo del benessere materiale? Perché la loro vita non è tutta rose e fiori. La loro indigenza è conosciuta. Come si spiegano il cannibalismo, l’infanticidio, l’eliminazione dei vecchi, se non con l’impossibilità di nutrire normalmente tutte le bocche?
È probabile che se i primitivi dovessero scegliere, preferirebbero la morte a certe costrizioni sopportate dai civilizzati. L’idea che la vita è il bene supremo che bisogna proteggere a tutti i costi, è loro estranea. Ciò spiega certe pratiche che agli occhi degli occidentali possono apparire assolutamente barbare. Invece gli atteggiamenti dei civilizzati possono sembrare inaccettabili a questi selvaggi. Abbiamo visto degli indiani cannibali protestare contro le condizioni di schiavitù di certi prigionieri – che loro avevano destinato alla casseruola – ceduti poi (come prigionieri) a dei bianchi umanisti. Gruppi di primitivi preferiscono suicidarsi piuttosto che conformarsi alle condizioni di vita inaccettabili che vengono loro imposte.
Considerato il loro modo di vita, non si può proiettare sull’attività dei cacciatori una concezione dell’impiego del tempo e del rendimento che è loro estranea, e che sarebbe anche irrazionale. L’indolenza può rivelarsi un’attitudine efficace: “...questo comportamento apatico [degli aborigeni australiani] è in realtà un adattamento all’ambiente fisico. In tutti i casi questa ‘indolenza’ contribuisce a mantenerli in buona forma. In periodo normale, quando si spostano, raramente percorrono più di 13-19 Km al giorno, e effettuano queste marce senza fretta e senza affanno, evitano i misfatti del nervosismo e del calore, ed in particolare la sofferenza della sete, che presso gli europei è provocata non solo dall’attività fisica e dai grossi sforzi che si impongono ma anche – e soprattutto – dalla sensazione di una mancanza di sicurezza e dall’angoscia che ne deriva”. In più, si mettono alla ricerca del cibo e dell’acqua “senza affrettarsi e senza agitarsi, e questo prima ancora di averne bisogno”.
In questo modo, gli aborigeni si mantengono in buona salute in regioni dove gli esploratori occidentali del XIX secolo, malgrado il loro equipaggiamento, facevano difficoltà a sopravvivere. Da cui la meraviglia di incontrare uomini “belli, robusti, la maggior parte barbuti, [...] in buone condizioni fisiche, soprattutto se teniamo conto dell’esistenza miserevole e precaria, quale è la loro”.
I primitivi arrivano a risolvere il problema del nutrimento, ottenendo una certa abbondanza. Ecco cosa scrive Sir George Grey che all’inizio del XIX secolo ha percorso le regioni povere dell’Australia:
“Un errore che si commette molto spesso, a proposito degli indigeni australiani, consiste nell’immaginare che essi dispongono di mezzi di sussistenza ridotti, o che frequentemente sono seguiti da presso dalla mancanza di alimenti: potrei citare molti esempi – alcuni anche comici – di errori commessi a questo riguardo da molti viaggiatori. Nei loro giornali, si lamentano della sorte di questi infelici aborigeni, ridotti dalla fame all’ignobile necessità di sopravvivere mangiando certi tipi di alimenti raccolti in prossimità delle capanne; infatti, in molti casi, questi alimenti sono quelli di cui gli indigeni sono più golosi; e questi alimenti non sono né insipidi né privi di valore nutritivo... Il capitano Sturt [...] nei suoi Voyages (t. I, p. 118): ‘Tra le altre cose, abbiamo trovato un certo numero di bacinelle di corteccia colme di gomma di mimosa e, per terra, numerose focacce confezionate con questa gomma. È evidente che queste infelici creature essendosi ridotti agli espedienti, ed essendo incapaci di procurarsi altri alimenti, si sono visti costretti a raccogliere questo alimento mucillaginoso’. La gomma di mimosa, a cui egli fa riferimento in questi termini, è una sostanza che gli indigeni apprezzano molto. Quando arriva la stagione della mimosa, essi si radunano in gran numero in certe pianure di cui il capitano Sturt ci ha lasciato la descrizione, per approfittare della fortuna insperata. L’abbondare di questa gomma permette delle grandi adunanze impossibili in tempo normale; in effetti, siccome gli indigeni si nutrono con animali e piante selvatiche, questi raduni esigono che una pianta sia nella sua piena fioritura, o che una balena si areni... In generale, gli indigeni vivono bene; in qualche regione può succedere che in certi momenti dell’anno il nutrimento sia insufficiente, ma in questi casi la regione viene abbandonata. Però è assolutamente impossibile per un viaggiatore, e anche per un indigeno estraneo alla regione, valutare se quel luogo offre o meno una alimentazione abbondante... Se invece si tratta di una regione che conosce, l’indigeno sa esattamente quel che produce, quando arriva la stagione delle varie risorse, e come procurarsele più comodamente. A seconda delle circostanze, decide le spedizioni in questa o in quell’altra parte del suo territorio di caccia; e devo dire che ho sempre trovato una grande abbondanza di alimenti nelle loro capanne”.
Può accadere che la caccia sia infruttuosa. Questo modo di approvvigionamento ha i suoi inconvenienti. Ma l’agricoltura ha forse saputo evitare le carestie, superare i problemi che si presentano nel periodo tra due raccolti, e non dipendere dalle variazioni climatiche? Distaccandosi dalle condizioni naturali si aumentano i rischi dell’insicurezza. Anche nei momenti difficili, i cacciatori conservano la fiducia e non si abbandonano a fare previsioni.
Le Jeune parlando degli indiani montanari: “...Il male è che fanno troppo spesso festini tra la fame che dobbiamo sopportare; se il mio oste prendeva due, tre o quattro castori, fosse di giorno o di notte, si faceva festa per tutti i selvaggi del vicinato; e se anch’essi avevano preso qualcosa, facevano la stessa cosa contemporaneamente: così che uscendo da un festino si andava ad un altro, e qualche volta, anche ad un terzo e un quarto. Io dicevo loro che non facevano bene, e che bisognava riservare questi festini ai giorni successivi, e che facendo ciò si fronteggerebbe meglio la fame; loro ridevano di me, domani (mi dicevano) faremo ancora festa con quel che prenderemo; sì, il più delle volte non prendevano che freddo e vento...
“Nelle loro pene, nei loro lavori, li vedevo soffrire con allegria... Mi sono trovato con loro nel bel mezzo di pericoli che davano molto a soffrire, e mi dicevano: ‘Staremo qualche volta anche due o tre giorni senza mangiare, ma anziché demoralizzarti, prendi coraggio Chihiné, abbi l’animo forte, resisti alla pena e al lavoro, tieniti lontano dalla tristezza altrimenti ti ammalerai; guarda che noi non smettiamo di ridere, anche se mangiamo poco...’”.
A proposito degli esquimesi, Gessain scrive: “In un mondo in cui le forze del vento e del ghiaccio sono così possenti, in cui le forze della natura sono così determinanti, non è forse meglio vivere fiduciosamente? Non è predisponendo riserve che si ottengono doni. Troppe riserve non suonerebbero grave scorrettezza verso anime immortali che, in un eterno ritorno, offrono i loro corpi-animali?”.
Per ciò che concerne i beni non alimentari, i primitivi sembra che ne siano sprovvisti. Se ne lamentano? Non sembra. Trascurano anche quei pochi beni che si sono fabbricati o che sono stati offerti. Sono sprovvisti del senso della proprietà. Gusinde, a proposito degli Indiani Yahgan: “Non sanno prendersi cura dei beni. Nessuno mette ordine, li piega, li asciuga o li lava, o ancora li riunisce con ordine. Se cercano in particolare qualche oggetto, mettono sottosopra i già confusi cestini. Gli oggetti più voluminosi formano un gran mucchio nella capanna: li spostano da tutte le parti, senza preoccuparsi dei possibili danneggiamenti. L’osservatore europeo ha la sensazione che questi indiani non attribuiscono la minima importanza ai loro utensili, e che abbiano dimenticato la fatica che è costato produrli. A dire il vero, nessuno tiene ai pochi beni che possiede: li perdono spesso e facilmente; e li sostituiscono con la stessa facilità. Dappertutto il problema più importante e pressoché esclusivo di ciascuno, è di preservare la propria vita, di proteggersi nella misura del possibile contro gli elementi e di calmare la propria fame. Queste sono le preoccupazioni essenziali, e relegano all’ultimo posto il problema di proteggere i beni materiali di cui l’indiano non si tormenta affatto, anche se non richiede alcuno sforzo. Un europeo sarebbe sbalordito di fronte all’indifferenza con cui questa gente trascina oggetti nuovi fiammanti, o abiti preziosi, provvigioni fresche e altre cose di valore... nel fango più spesso, o li abbandona ai bambini e ai cani...
“Riescono ad affezionarsi solo per poche ore, e per curiosità, agli oggetti preziosi che vengono loro offerti, dopo di che, sbadatamente li lasciano deteriorare nel fango e nell’umidità, senza più preoccuparsene. Meno posseggono e più riescono a viaggiare comodamente, sostituendo all’occorrenza ciò che è sciupato. Si può dunque dire che sono totalmente indifferenti alla proprietà materiale”.
I Tasady delle Filippine, lungi dallo stupirsi di fronte alle meraviglie tecniche che facciamo loro scoprire, manifestano invece scetticismo. Rifiutano le stoffe, gli archi offertigli, prendono solo i machete, più utili per l’abbattimento delle palme. Accettano soltanto quel che può aumentare la loro efficienza senza però che sconvolga le loro abitudini. Quando un primo gruppo di Tasady si vede offrire una pila elettrica, la rifiuta, perché dicono che non è utile per accendere un fuoco. Spieghiamo che serve per vedere durante la notte. Fanno: “oh-oh-oh-oh”, poi precisano che di notte dormono. Definiscono il registratore “macchina che ci ruba la voce”, senza manifestare timori o animosità, piuttosto divertimento. Nella loro grotta comune, le riserve e gli utensili per 24 persone, sono: tre tubi di bambù riempiti d’acqua, e tre asce di pietra. Accettano gli accendini perché permettono di evitare di dover strofinare due pezzi di legno nel muschio secco per infiammarlo. Imparano a fare delle trappole per prendere gli animali ma quando vogliamo spiegare i principi dell’agricoltura, si meravigliano di tali procedimenti e rispondono che hanno di che mangiare sempre in abbondanza. Se scarseggia il cibo, danno la precedenza ai bambini. Il loro massimo piacere, sembra essere quello di sentire la pioggia scorrere sulla pelle.
Così i nostri selvaggi sarebbero poveri ma contenti della loro sorte. Poveri, ma perché, poi, poveri? Non rinunciano a nulla. L’ambiente naturale offre il cibo di cui hanno bisogno, permettendo di costruirsi facilmente e con pochi sforzi oggetti che abbandonano con la stessa facilità. Non vivono nell’indigenza. Come dice Marshall Sahlins, la loro società è la prima società dell’abbondanza. Se non predispongono delle scorte, è perché la natura rappresenta un granaio inesauribile e facilmente accessibile.
Il merito di Sahlins è di cercare una spiegazione che sia materialista e globale, senza fermarsi ai sentimenti di sazietà e di fiducia dei primitivi. A cosa corrispondono questi atteggiamenti, qual è la loro razionalità più profonda?
La ricchezza del cacciatore è fondata sulla sua mobilità. È la mobilità a permettergli di combattere la tendenza “ai rendimenti decrescenti”, spostandosi sempre verso nuovi territori di caccia. In questa ottica, è possibile comprendere la necessità della miseria del cacciatore. Il possesso di numerosi oggetti gli sarebbe di intralcio. Sarebbe la stessa cosa se istituisse depositi. Il risparmio non sarebbe più o meno utile, ma del tutto nocivo perché impedirebbe la libertà di movimento.
Gli oggetti più apprezzati sono quelli facilmente trasportabili. “Il senso di proprietà dei Murngin è pochissimo sviluppato; questo appare collegato allo scarso interesse che hanno per lo sviluppo dell’equipaggiamento tecnologico. Queste due caratteristiche sembrano trovare origine nel desiderio di essere affrancati dal fardello e dalla responsabilità di oggetti che limiterebbero l’esistenza itinerante della società... Il principio che regge la scelta degli oggetti che saranno conservati dal loro proprietario, è la facilità con cui possono essere trasportati in spalla dall’uomo in piroga. Per i Murngin, la quantità di lavoro richiesta per produrre un oggetto, contribuisce – in una certa misura – a fissarne il valore in quanto proprietà personale, come pure il grado di rarità che un oggetto ha in natura o negli scambi interviene nella determinazione dei valori economici Murngin; ma il criterio decisivo resta la facilità di trasporto dell’oggetto, perché questa società non ha addomesticato nessuna bestia da soma. I recipienti metallici avuti dai missionari per mezzo di scambi, sono estremamente rari e ben guardati; tuttavia, se sono di grandi dimensioni, vengono offerti a qualcuno che resta al campo o sezionati per destinarli ad altri usi. Il valore supremo è la libertà di movimento”. (Wagner).
Un viaggiatore, Van Der Post, constata: “Eravamo mortificati di avvederci che non potevamo offrire granché ai Boscimani. Sembrava che quasi tutto contribuiva a rendere la loro vita più difficile, appesantendo i loro spostamenti quotidiani. Non possedevano grandi beni personali: una cintura, una coperta di pelle e una sacca di cuoio. In un istante potevano raccogliere tutti i loro beni, avvolgerli nella coperta, e trasportarli in spalla per più di 1500 chilometri. Non avevano il senso della proprietà”.
La spiegazione con la necessità di essere mobili è lampante. Non bisogna però considerare questa necessità come una oggettiva costrizione che imbriglierebbe un sentimento soggettivo di possesso e di accumulazione. Invece non fa che confermare un atteggiamento spontaneo. I Tasady, così poco interessati all’acquisto di nuovi utensili, non si spostavano mai oltre i tre chilometri dalla loro residenza stabile.
La prima condizione affinché la caccia e il raccolto funzionino, è una scarsa densità umana. L’America pre-colombiana era abitata solamente da qualche milione di Indiani. La popolazione degli aborigeni australiani, nel XVIII secolo è stata valutata intorno alle trecentomila persone. In una forma o in un’altra, le società paleolitiche obbediscono a forti restrizioni demografiche. La consistenza dei gruppi deve essere limitata, e generalmente si spostano e utilizzano un vasto territorio. Bisogna situare in questo contesto i ricorrenti costumi dell’infanticidio e dell’eliminazione dei vecchi. Lo stesso dicasi per le pratiche restrittive della sessualità, della poliandria frequente, legata all’infanticidio delle femmine.
Secondo Sahlins, si tratta delle stesse costrizioni che orientano l’atteggiamento nei riguardi degli uomini e degli oggetti: “Se noi diciamo che si sbarazzano degli individui che “sono un peso”, bisogna intendere che non vogliono sottrarsi all’obbligo di nutrirli ma a quello di trasportarli”.
Questi comportamenti non sono conseguenza della miseria. Rappresentano il prezzo da pagare per mantenere l’efficacia e, quindi, l’abbondanza nel gruppo. Sono il risultato di una concezione del vivere che vede la vera ricchezza nella salute e nella capacità di vivere attraverso le attività necessarie alla sussistenza del gruppo. Ritirarsi o essere uccisi quando non se ne è più capaci, è cosa normale. Questa durezza nei confronti degli inutili, non deriva dall’egoismo di chi è ancora in piena forza. Lo smentiscono molti atti di solidarietà tra cacciatori o nei riguardi del gruppo.
II primitivo sa sacrificare la propria vita come pure quella degli altri. È pronto a rischiarla, e di fatto la rischia quotidianamente, perché il suo gruppo possa vivere. Per l’individuo della società borghese, e in primo luogo il proletario, certe pratiche dei primitivi sembrano di una barbarie innominabile. Preferisce relegare i suoi vecchi ormai impotenti all’ospizio, piuttosto che abbandonarli al gelo e alla morte come usano fare gli esquimesi. È che per lui la vita è un bene, bene supremo! Ci tiene tanto anche se è incapace di viverla, anche se gli sfugge. Dal fondo del suo frigorifero, guarda con orrore i popoli cannibali senza rendersi conto che anch’egli è divorato dall’economia antropofaga.
Dalla caccia all’agricoltura
Se è vero che questi gruppi di cacciatori costituiscono per davvero le prime società dell’abbondanza, perché non sono rimasti a questo stadio? Perché l’umanità ha preso il cammino dell’agricoltura e della divisione in classi? Perché dover aspettare per millenni “una reviviscenza (anche sotto una forma superiore) della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità delle antiche genti?”. (Morgan).
Per prima cosa l’umanità non sceglie di intraprendere questo o quel tipo di sviluppo. La storia non si sviluppa a partire dalla ragione. La spiegazione con una sorta di tendenza – insita nel profondo – che spinge al progresso, all’innovazione, non regge. C’è la spiegazione “marxista” con il “surplus”. Il progresso della divisione del lavoro e della produttività implica la comparsa del surplus: produzione di beni superiori allo stretto necessario per chi li crea. Questa produzione eccedente diviene una posta e la divisione sociale del lavoro contiene in germe la suddivisione in classi. Una relativa abbondanza è dunque necessaria, un preliminare al sorgere delle classi.
Così, senza alcun dubbio, i nostri cacciatori, avendo acquisito un po’ di loisir, tempo di riflettere e di fabbricare utensili più sofisticati, sarebbero passati all’agricoltura che consente uno sfruttamento più intensivo dell’ambiente, quindi una più alta produttività. A partire da qui, i miglioramenti tecnici provocano e rinforzano la dominazione di classe che ha potuto sorgere. Non rimane che attendere il momento in cui la ricchezza usurpata sarà così considerevole che potrà essere rimessa in comune.
Disgraziatamente per i pensatori e felicemente per i selvaggi, a questi non manca nutrimento e ancora meno i loisir. Essi non ne approfittano per accumulare un surplus, per perfezionare le loro conoscenze tecniche, o leggere manuali moscoviti sulla concezione materialista della storia.
Il passaggio all’agricoltura può spiegarsi solo con un difetto del paleolitico, come prodotto delle sue contraddizioni o con l’impetuoso sviluppo delle forze produttive che scombussolano i rapporti di produzione. Non è accaduto sotto l’effetto di qualche scoperta o grazie alle rivelazioni dei passeggeri o di quegli UFO tanto cari a “Invariance”. Attualmente, molti gruppi di cacciatori coesistono con popoli di agricoltori, e non fanno nulla per impadronirsi delle loro conoscenze.
L’abbandono della caccia e del raccolto come unica risorsa è dovuto a cause fortuite: variazioni climatiche, abbassamento del rendimento della caccia causato dalla crescita demografica o per forzate restrizioni del territorio di caccia...
L’avvento dell’agricoltura è riconducibile al caso? È un fatto privo di importanza? Evidentemente no. Se le condizioni che hanno spinto questo o quel gruppo verso la coltura o l’allevamento sono fortuite, significa che il caso diviene il cammino della necessità. Consente alle capacità delle specie di apparire, di affermarsi e di vincere. Il problema non è quello dell’origine, delle condizioni immediate che hanno suscitato una tale rottura; rottura che non è certamente avvertita come tale. Dal momento che le capacità esistevano, che le conoscenze necessarie sorgevano dalle stesse vecchie condizioni di esistenza, era ineluttabile che nel corso di migliaia d’anni e tra migliaia di gruppi umani si producesse il passaggio all’agricoltura. Il problema è di sapere perché questa ha sussistito e perché si è affermata. Si concepirà che non si tratta di superiorità di un modo di vita su un altro, ma di rapporti di forza.
Non si può ricondurre tutto all’opposizione tra caccia e agricoltura. La transizione non è stata forzatamente brusca. Le prime forme di agricoltura sono estensive e potevano conciliarsi col nomadismo. Più tardi nella storia la caccia e il raccolto continuano a fornire una parte importante della sussistenza degli agricoltori: in caso di cattivo raccolto, costituiscono delle attività di ripiego.
L’agricoltura e l’emergere delle classi
Per milioni di anni, gli ominidi, pitecantropi e uomini di Neanderthal, hanno praticato la caccia e il raccolto con strumenti rudimentali simili a quelli che continuano ad usare i “moderni” Tasady. Le prime tracce di focolari datano a 700.000 anni. Il passaggio all’agricoltura è molto recente – qualche migliaio d’anni – ed è quindi legato alle capacità specifiche della specie homo sapiens (apparsa circa 40.000 anni fa, all’inizio del Paleolitico superiore) che è oggi la sola specie umana dopo la distruzione-integrazione dell’uomo di Neanderthal.
L’agricoltura porta con sé in germe lo sviluppo che era impossibile sulla base della caccia e del raccolto, essa rappresenta la necessità e la possibilità di fare delle riserve, di prevedere... Essa favorisce una permanenza nell’habitat che permette una grande stabilità nei rapporti sociali, si esce dal “dilettantismo”.
Perché le società agricole hanno potuto soppiantare le società dei cacciatori? Diciamo subito che hanno impiegato molto tempo. Non sono stati gli agricoltori primitivi a minacciare seriamente i cacciatori-raccoglitori, sono state invece le grandi società di classe imperialiste antiche ad averli distrutti o respinti e – solo qualche secolo fa – la spinta del capitalismo ha definitivamente completato la loro cancellazione.
L’agricoltura permette uno sfruttamento più intensivo dell’ambiente, quindi non è lecito parlare di una migliore produttività per persona, ma di un più gran numero di persone su di uno stesso territorio, la costituzione di agglomerati sociali più importanti e stabili, il fatto che l’agricoltura consente l’apparizione d’un prodotto realmente conservabile, immagazzinabile, trasportabile, suscita la comparsa storica degli sfruttatori. Questa è favorita dalla divisione che tende a instaurarsi tra l’agricoltore – che cessa automaticamente di essere anche guerriero come il cacciatore – e coloro che si industriano per derubarlo o “difenderlo”.
La relazione tra la natura di ciò che si produce e lo sviluppo delle società di classe non è priva di importanza. I cereali sono i pilastri dei grandi imperi: grano nel bacino mediterraneo, riso per la Cina, mais per l’impero Inca. Quest’ultimo ha imposto la coltura del mais al posto di quella della patata dolce nelle regioni che erano meno indicate. Il ruolo dei cereali è legato da una parte al fatto che sono misurabili, stoccabili..., e dall’altra parte ai metodi e alle infrastrutture culturali sofisticate che richiedono.
La disfatta dei cacciatori era ineluttabile. E corrisponde alla vittoria dello sviluppo delle forze produttive e delle potenzialità della specie. Ma questo determinismo non è un determinismo interno alle società; non corrisponde ad un vantaggio immediato.
La storia e le forme sociali che si succedono possono spiegarsi con una tendenza spontanea ad aumentare la produttività del lavoro che si utilizzerebbe a partire dalle divisioni interne della società. Come scrisse Marx, il lavoro è esso stesso un prodotto storico elaborato: “II lavoro sembra essere una categoria semplice [...], tuttavia [...] il lavoro è una categoria altrettanto moderna dei rapporti sociali generati da questa semplice astrazione”. (Contributo alla critica dell’economia politica, 1858-1859). Il rapporto dell’uomo col suo ambiente naturale non può – non più del movimento della storia – essere ridotto al lavoro, all’evoluzione della sua produttività, al benessere che si manifesta con l’aumento del surplus che è sempre ingiustamente confiscato. È una visione tratta dalla realtà del capitalismo e che è proiettata su un’epoca anteriore.
Da un comunismo all’altro
Lo studio di Shalins, che ha il merito di non esaurirsi nello studio del vissuto, dell’effettivo, della realtà, alla concezione del selvaggio per il quale il lavoro è privo di spessore reale, mostra che la ricchezza del primitivo non è il risultato, il coronamento della sua attività “produttiva”.
Ciò che determina la produttività della caccia e del raccolto, il lavoro del primitivo stesso, è il rapporto globale che mantiene col suo ambiente naturale: mobilità, dispersione, coesione sociale, controllo demografico. Il (prei)storico T. Jacob, che dissotterra dei pitecantropi a Giava, dopo aver evocato una possibile proibizione dell’incesto mirante a rafforzare la coesione sociale, scrive: “... può darsi che le famiglie dei pitecantropi abbiano praticato la “pianificazione familiare” con infanticidio e geronticidio al fine di risolvere i loro problemi ecologici. Questa ipotesi deve essere considerata, anche se noi preferiamo pensare che siamo stati gli inventori dei programmi di controllo della popolazione mondiale”. Questo rapporto dell’uomo col suo ambiente non è riducibile forzatamente ad una semplice utilizzazione senza trasformazione né restaurazione. Gli Esquimesi si occupano di non distruggere troppo la selvaggina. Così, anche dopo l’introduzione del fucile, essi tirano ad una bestia solo dopo averla preventivamente arpionata. La grande e ricca prateria nord-americana dove pascolavano i bisonti sarebbe il risultato dell’attività ancestrale degli Indiani per estenderla. Non si può pretendere che il cacciatore abbia un rapporto con l’ambiente di tipo animale. Egli fabbrica e utilizza degli utensili con grande abilità. Abilità che gli potrebbero invidiare anche gli operai taylorizzati e gli intellettuali transistorizzati.
Soprattutto, ha una conoscenza straordinaria e amorosa del suo ambiente: “Questa è la mia terra. La mia terra mi conosce”.
Ciò che lo distingue dall’animale, sono alcune sue doti intellettuali, la sua capacità di concepire un oggetto per fabbricarlo. Elkim scrive, dopo aver descritto gli aborigeni australiani, che fabbricavano i loro utensili di pietra: “Gli oggetti creati dagli aborigeni testimoniano dell’abilità di questi uomini a realizzare in modo perfetto, fino al più piccolo dettaglio, i modelli-tipi che si rappresentano chiaramente col pensiero. La loro arte fornisce a loro stessi la prova di questa attitudine mentale [...], i piccoli indigeni – essi pure – tendono ad eseguire in questo modo gli acquerelli che si domanda loro di fare. È una cosa interessante da osservare. Al posto di tracciare i diversi contorni del paesaggio che ha scelto di rappresentare – montagna, vallata, alberi – e di completare questo schizzo colorando ognuna delle parti dell’insieme, il ragazzo esegue di getto, d’un sol colpo, i dettagli e i colori, così bene che la raffigurazione prende forma istantaneamente da un lato all’altro della pagina come se – in qualche modo – la si srotolasse; è questo, in effetti, che aveva nell’occhio e nello spirito prima di cominciare. L’aborigeno, che vive delle risorse che gli offre la terra, si trova in contatto diretto e permanente con essa così bene che l’aspetto e i rilievi del sito che lo circondano gli sono familiari, a tal punto che ne ha una conoscenza “fotografica” – ci è quasi impossibile farci un’idea di ciò, perché le nostre condizioni di vita artificiale si oppongono a questo tipo di percezione delle cose”.
Certo, la rappresentazione può essere nemica dell’immaginazione, la sicurezza nemica del brancolamento e quindi della sperimentazione, ma siamo ben lontani dall’animale in questo mondo dove si esercita una vera e propria capacità d’astrazione che si manifesta anche in una mitologia e in sistemi di parentela complessi. Questo modo di essere, questo rapporto intellettuale sensibile all’ambiente, prende il sopravvento con l’abilità tecnica. È essa a costituire la forza del cacciatore e gli permette di mantenersi in vita.
Possiamo parlare di comunismo primitivo? Alcuni hanno contestato il termine, temendo di confondere l’esistenza della proprietà comune, del matrimonio di gruppo originali cari ad Engels. In certe società primitive si sono scoperti rapporti di sfruttamento tra vecchi e giovani, maggiorenni e minori; senza essere società di classi, sono comuniste?
Non si può essere puristi e cercare frontiere assolute tra società comuniste e società di sfruttamento. Si fa presto a scovare rapporti di sfruttamento e di dominazione più o meno affermati, più o meno permanenti. Il cannibale sfrutta colui che viene divorato, consumando “il lavoro” accumulato nei grassi del suo festino: “buono, plus-valore!”. Allo stesso modo, nelle forme di circolazione dei beni tra i selvaggi, si può trovare l’origine dello scambio e persino delle forme embrionali di moneta. Questo però non vuol significare che sono state queste forme a generare l’economia mercantile, come pure l’industria moderna non è uscita dalle manifatture di tessuti incas.
L’esistenza della proprietà comune, del matrimonio di gruppo? È mitologia. Una sorta di punto zero della proprietà privata e della famiglia. Uno stato di indifferenziazione che precederebbe la differenziazione, la natura originale prima della civilizzazione. Comunismo non significa proprietà comune in opposizione alla proprietà privata ma abolizione della proprietà. E questa abolizione non vuole assolutamente dire: rapporti indifferenziati in cui tutto apparterrebbe indistintamente a tutti. Questo è valido sia per il comunismo moderno come per quello passato. Tra i cacciatori, le regole di ripartizione, di attribuzione dei prodotti della caccia, sono rigorose e non lasciano nulla al caso. Si basano sui rapporti di parentela e proibiscono eventualmente ai cacciatori quel che essi stessi hanno ucciso.
Lo stesso dicasi per le regole che proibiscono o favoriscano le unioni sessuali.
Il comunismo futuro ritroverà, al di là del lavoro e della produzione, il rapporto globale dei primitivi con l’ambiente. Supera la tappa dell’homo faber, dell’uomo che fabbrica.
L’abbondanza tra l’umanità primitiva si basava sul mantenimento di una bassa densità di popolazione. Piccoli raggruppamenti umani utilizzavano il loro ambiente senza trasformarlo in profondità. L’umanità futura sarà numerosa e tecnicamente efficiente. Sbarazzatasi della concorrenza e degli antagonismi che la attraversano e la animano, essa non addizionerà una moltitudine di processi produttivi separati, che si traducono in una incontrollata evoluzione, improvvisa e disastrosa. Ogni trasformazione particolare avverrà in funzione di una evoluzione e di un equilibrio globali.
Non si tratterà tanto di produrre quanto di partecipare al miglioramento e all’arricchimento dell’ambiente umano. Ogni individuo parteciperà agli sforzi e alle gioie senza volere, e senza aver bisogno d’accaparrare una parte del patrimonio comune. Potrà condurre una vita da nomade, perché dappertutto si sentirà a casa propria. Perderà il senso della proprietà, non si attaccherà agli oggetti, perché avrà timore di non averne; non si guasterà, così, né il corpo né lo spirito. Non si può esser liberi, sicuri, disponibili, ricchi di desiderio e di possibilità senza una certa privazione personale. Povero borghese che porta la sua ricchezza come una corazza sulle spalle! E ancor più infelice il proletario che non possiede né l’aereo né lo yacht per trasportare se stesso e i congiunti!
Non si tratta di confondere passato e futuro. Il ritorno al paleolitico non è possibile se si esclude l’ipotesi della liquidazione della quasi totalità dell’umanità e della civilizzazione, per esempio con una guerra nucleare. Non è augurabile. I costumi delle società di cacciatori-raccoglitori possono sembrarci crudeli, le condizioni di vita poco confortevoli, tuttavia ciò che veramente distingue quell’epoca dalle aspirazioni che ha prodotto il mondo moderno, è il suo carattere limitato. I cacciatori si accontentano di ciò che hanno e si accontentano di poco. Le possibilità sono ridotte, l’orizzonte limitato, le preoccupazioni terra-terra. Questo modo di vita si rivela piuttosto insipido. Le feste, le stravaganze sessuali sono soprattutto frutto dell’immaginazione degli esploratori: preti, sapienti, commercianti che – avendo poche possibilità di comparazione – si montano subito la testa. La vita sessuale degli Esquimesi appariva piuttosto saggia e misurata, anche se a qualcuno fra di essi è accaduto di fracassare il cranio di qualche prete che non voleva fare la cortesia di scopare le loro donne.
Il passaggio all’agricoltura, alla società di classe, al capitalismo, sono stati il mezzo doloroso perché si sviluppassero le possibilità della specie; la disumanizzazione del lavoro, il mezzo per accedere ad una attività veramente umana.
È tempo di uscire dalla preistoria.